Sardegna Centrale Energia Sostenibile
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ambito Di Paesaggio N. 14 "Bassa Valle Del Fiume Tirso"
Ambito di Paesaggio PPR Nuova individuazione Ambito di Paesaggio n. 14 "Bassa Valle del Fiume Tirso" Cabras, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Santa Giusta, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Solarussa, Villanova Truschedu, Zerfaliu ELEMENTI STRUTTURA PERCETTIVA SARDEGNA NUOVE IDEE TAVOLO 2 “IL PROGETTO DEI PAESAGGI” Ambiente Incontri preliminari quaderno di lavoro - la parte settentrionale del Golfo di Oristano, che si estende con un ampio arco ellittico, dalla foce dello stagno di Mardini, a nord, fino a quella di s’Ena Arrubia a sud. Il litorale è caratterizzato da costa bassa e prevalentemente sabbiosa nella quale si sviluppa la spiaggia di Torre Grande. La continuità del cordone litoraneo è interrotta dalla presenza AMBITO n. 14 “BASSA VALLE DEL FIUME TIRSO” della foce fluviale del Fiume Tirso e dai numerosi canali lagunari attraverso cui le acque marine del golfo si connettono col sistema umido di Santa COMUNI COINVOLTI DESCRIZIONE Giusta; Cabras, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Santa Giusta, Siamaggiore, L’Ambito comprende il Golfo di Oristano dalla foce dello stagno di - i versanti occidentali del Monte Arci, caratterizzati dalle falde pedemontane Siamanna, Siapiccia, Simaxis, Solarussa, Villanova Truschedu, Zerfaliu Mardini a quella di S’Ena Arrubia. e segnati dall’articolata rete di canali drenanti naturali che alimentano i La sua struttura è articolata sul sistema idrografico del Tirso: tale INQUADRAMENTO TERRITORIALE corpi idrici superficiali e sotterranei della pianura di Oristano-Terralba; sistema, così definito, richiede necessariamente una gestione - la copertura vegetale delle aree non agricole, che è rappresentata da unitaria delle acque, da un punto di vista idraulico e qualitativo, il formazioni boschive, arbustive, a gariga, e in aree circoscritte, da biotopi controllo del loro utilizzo e prelievo per garantire gli apporti, la naturali, riscontrabili anche negli ambienti acquatici dei rii, degli stagni, gestione delle relazioni tra usi agricoli e risorse idriche. -
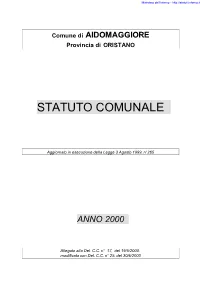
Statuto Comunale
Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it Comune di AIDOMAGGIORE Provincia di ORISTANO STATUTO COMUNALE Aggiornato in esecuzione della Legge 3 Agosto 1999, n°265 ANNO 2000 Allegato alla Del. C.C. n° 17, del 19/5/2000, modificata con Del. C.C. n° 25, del 30/6/2000 Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it Indice TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1 - Definizione pag. 4 Art. 2 - Finalità " Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione " Art. 4 - Territorio e sede comunale 5 Art. 5 - Albo Pretorio " Art. 6 - Stemma e gonfalone " TITOLO II - ORGANI ELETTIVI CAPO I - ORGANI DEL COMUNE Art. 7 - Organi pag. 6 2 Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it CAPO II - CONSIGLIO COMUNALE Art. 8 - Consiglio Comunale pag. 6 Art. 9 - Composizione e durata in carica " Art. 10 - Insediamento del Consiglio Comunale " Art. 11 - I consiglieri " Art. 12 - Dimissioni dei Consiglieri 7 Art. 13 - Prerogative e diritti dei Consiglieri " Art. 14 - Linee Programmatiche di mandato " Art. 15 - Gruppi consiliari 8 Art. 16 - Conferenza dei capigruppo " Art. 17 - Commissioni consiliari " Art. 18 - Forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze " Art. 19 - Convocazione del Consiglio 3 Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it " Art. 20 - Validità delle sedute e delle deliberazioni " Art. 21 - Pubblicità delle sedute 9 Art. 22 - Votazioni " Art. 23 - Mozione di sfiducia " Art. 24 - Scioglimento del Consiglio Comunale " CAPO III - GIUNTA COMUNALE Art. 25 - Giunta comunale pag. 10 Art. 26 - Composizione e nomina " Art. 27 - Cause di incompatibilità ed ineleggibilità " Art. 28 - Revoca, dimissioni, decadenza " Art. 29 - Funzionamento della Giunta pag. 11 Art. -

GIS-Based Landscape Analysis of Megalithic Graves in the Island of Sardinia (Italy) Riccardo Cicilloni 1, Marco Cabras 2
GIS-based landscape analysis of megalithic graves in the Island of Sardinia (Italy) Riccardo Cicilloni 1, Marco Cabras 2 1. Department of History, Cultural Heritage and Territory, University of Cagliari. Via Is Mirrionis 1, 09123 Cagliari, Italy. Email: [email protected] 2. Ph.D. Candidate, Doctorado en Historia y Artes – Arquelogía y Cultura Material, Universidad de Granada. Via Is Mirrionis 119, 09121 Cagliari, Italy. Email: [email protected] Abstract: One of the most important megalithic groups in Western Europe in terms of number and characteristics is the group of over 200 monuments of various types in Sardinia. It now seems to be confirmed that the rise of the megalithic phenomenon was during the culture of San Michele of Ozieri (Late Neolithic, 4000-3300 B.C.E.). The Sardinian dolmen graves, however, had a maximum distribution during the Chalcolithic, as evidenced by most of the finds from excavations. The phenomenon also shows a close relationship beyond Sardinia and especially with the monuments of Catalonia, Pyrenees, non-coastal departments of French-midi, Corsica and Puglia. About 90 dolmen graves of various types have been investigated, namely the simple type, “corridor” type, “allée couverte” type, and others of uncertain attribution, located in central-western Sardinia, and particularly in a significant area of ca. 3500 km2 coinciding with the historical regions of Marghine-Planargia, Middle Valley of Tirso and Montiferru. This includes some 40% of all Sardinian dolmens. Locational trends and relationships with regard to landscape elements were studied with the aid of GIS methodologies such as viewshed and cost surface analysis. -

(SAD) Approvato Dal Consiglio Comunale
PLUS Ambito Distretto di Oristano Comprendente i Comuni di: Allai-Baratili S.Pietro-Bauladu-Cabras-Milis-Narbolia-Nurachi-Ollastra-Oristano- Palmas Arborea-Riola Sardo-Samugheo-S.Vero MIlis-Santa Giusta-Siamaggiore- Siamanna-Siapiccia-Simaxis-Solarussa-Tramatza-Villanova Truschedu- Villaurbana-Zeddiani-Zerfaliu Provincia di Oristano – Azienda ASL n. 5 Oristano Comune capofila: Oristano Piazza Eleonora d’Arborea – tel. 0783 7911 Ufficio di Programmazione e Gestione REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E AIUTO ALLA PERSONA PREMESSA Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente e secondo quanto indicato nel Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona (PLUS) dell’ambito del Distretto di Oristano, l’attività di “Assistenza domiciliare e aiuto alla persona” a favore dei residenti nel Comune di Oristano e dei Comuni territorialmente appartenenti alle seguenti quattro unioni: - Unione dei Fenici: Cabras, Palmas Arborea, Riola Sardo, Santa Giusta e Villaurbana; - Unione Sinis Montiferru: Baratili San Pietro, Bauladu, Milis, Narbolia, Nurachi, San Vero Milis, Tramatza e Zeddiani; - Bassa Valle del Tirso e del Grighine: Allai, Ollastra, Siamanna, Siamaggiore, Siapiccia, Simaxis, Solarussa, Villanova Truschedu e Zerfaliu. - Barigadu: Samugheo Inoltre, ne disciplina l’organizzazione, le modalità di accesso, il percorso di attivazione, la compartecipazione dell’utenza alla spesa, le cause di cessazione o sospensione del buono servizio, gli impegni degli utenti. Art. 1. DEFINIZIONE E FINALITA’ DEL SERVIZIO La finalità del Servizio di ASSISTENZA DOMICILIARE E AIUTO ALLA PERSONA è quella di prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno e disagio, favorire l’integrazione familiare e sociale, evitare l’allontanamento dell’utente dal proprio ambiente di vita supportandolo in relazione alle difficoltà insite nella sua condizione, onde evitare/ridurre le esigenze di ricorso all’inserimento in struttura. -

C.C. N° 22 Del 23.09.2020 Adesione All
COMUNE DI AIDOMAGGIORE (PROVINCIA DI ORISTANO) www.comuneaidomaggiore.it DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA N° 22 del 23/09/2020 ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE DI COMUNI DELL' ITINERARIO DEL ROMANICO IN SARDEGNA PER LA OGGETTO: CONSERVAZIONE, PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E MESSA IN RETE DEL BENE CULTURALE DEL ROMANICO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. L'anno Duemilaventi addì Ventitre del mese di Settembre , alle ore 19:30, in Aidomaggiore, in modalità telematica (videoconferenza, tramite whatsapp) convocato con avvisi contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, regolarmente consegnati ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di 1ª convocazione, con l'intervento dei Sigg.ri Consiglieri: Cognome e Nome Presente Assente 1) Salaris Mariano X 2) Atzori Giovanni Antonio X 3) Barranca Antonella X 4) Carboni Mario X 5) Marras Massimo X 6) Masia Maria Lussoria X 7) Pala Maria Lourdes X 8) Virdis Simone X 9) Ziulu Raffaele X Assegnati N. 9 Presenti N. 6 Assenti N. 3 Assiste alla seduta il Segretario Comunale – Dott.ssa Isabella Miscali, la quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a) del D.Lgs. 18.8.2000, N. 267. Il Sindaco Dott. Ing. MARIANO SALARIS , assume la presidenza e, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto; Apre la seduta il Sindaco, il quale illustra la proposta di Deliberazione N° 74 del 21/09/2020 redatta -

Ambito Di Paesaggio N. 16 "Montiferru"
Ambito di Paesaggio PPR Nuova individuazione Ambito di Paesaggio n. 16 "Montiferru" Cuglieri, Narbolia, Santu Lussurgiu, Scano Montiferro, Seneghe, Sennariolo ELEMENTI STRUTTURA PERCETTIVA SARDEGNA NUOVE IDEE TAVOLO 2 “IL PROGETTO DEI PAESAGGI” Ambiente Incontri preliminari quaderno di lavoro - L’articolato sistema costiero delle baie di Santa Caterina di Pittinurri e di s’Archittu, delimitato dallo sviluppo irregolare di archi rocciosi, falesie e scogliere scolpite su arenarie e calcareniti biancastre del terziario; AMBITO n. 16 “MONTIFERRU” - il complesso orografico vulcanico del Montiferru e le formazioni boschive che caratterizzano i versanti che si presentano in un mosaico di comunità COMUNI COINVOLTI DESCRIZIONE vegetali diverse, rappresentate da una maestosa foresta composta da Cuglieri, Narbolia, Santu Lussurgiu, Scano Montiferro, Seneghe, Sennariolo La struttura dell'Ambito è definita dalla dominante ambientale del lecci, querce caducifoglie, tasso, agrifoglio, acero minore e la copertura massiccio del Montiferru. La denominazione è derivante dal che doveva caratterizzare anche i versanti che, dopo i tagli e gli incendi, INQUADRAMENTO TERRITORIALE filone di ferro presente presso il Monte alle spalle della piana di sono stati trasformati parzialmente in aree di pascolo; Cornus. L'Ambito corrisponde all'esteso territorio che incorpora il - la valle del Rio S'Abba Lughida, nel versante occidentale, regno della fitta profilo del cono vulcanico del Montiferru, con la maggiore lecceta associata all'agrifoglio, alla roverella e al corbezzolo; -

COMUNE DI GHILARZA Provincia Di Oristano
Allegato alla determinazione Settore Servizi alla persona – Ufficio di PLUS n°130 del 31.07.2013 COMUNE DI GHILARZA Provincia di Oristano CAPITOLATO D’APPALTO APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E INTERVENTI NELL’AREA DELLA NON AUTOSUFFICIENZA DEL PLUS GHILARZA-BOSA (CIG 5267262A19). Articolo 1 – Oggetto L’appalto ha per oggetto l’affidamento dell’incarico per la gestione degli interventi nell’area della non autosufficienza. Articolo 2 - Luogo di prestazione del Servizio L’attività dovrà interessare il territorio dei 32 Comuni afferenti al Distretto Ghilarza-Bosa (Abbasanta, Aidomaggiore, Ardauli, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Bosa, Busachi, Cuglieri, Flussio, Fordongianus, Ghilarza, Magomadas, Modolo, Montresta, Neoneli, Norbello, Nughedu S. Vittoria, Paulilatino, Sagama, Santu Lussurgiu, Scano Montiferro, Sedilo, Seneghe, Sennariolo, Soddì, Suni, Sorradile, Tadasuni, Tinnura, Tresnuraghes, Ulatirso). Articolo 3 –Descrizione del servizio e prestazioni richieste L’incarico prevede il consolidamento di un servizio a cui è affidato il compito di avviare e rafforzare, in stretta collaborazione con gli operatori del PLUS e della ASL n°5, distretto di Ghilarza-Bosa, le azioni relative all'integrazione socio-sanitaria tra i servizi del territorio rivolti agli anziani, ai disabili minori e adulti, e in generale alle persone che presentano problematiche socio-sanitarie complesse con cause multifattoriali. Si intendono ampliare e rendere organici gli interventi di integrazione socio-sanitaria finora attuati dal PLUS, in particolare il potenziamento PUA e il Registro degli assistenti familiari - demandati al PLUS dalla Regione Sardegna. L’obiettivo che ci si propone è quello di costruire un modello di intervento articolato che integra le competenze professionali e istituzionali dei servizi sociali e sanitari, in un approccio che tiene conto dell'unicità della persona. -

COMUNE DI NORBELLO Provincia Di Oristano N° 30
COPIA COMUNE DI NORBELLO Provincia di Oristano N° 30 DEL 20.10.2014 Oggetto: Adesione in qualità di socio fondatore “ accomodante “alla costituenda “ Shardana Energia ” S.a.p.a.. - L’anno duemilaquattordici , il giorno venti, del mese di ottobre , alle ore 18.00, nella sala consiliare del Comune di Norbello, appositamente convocato con avvisi scritti, contenenti lʹelenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli consiglieri, in data 16/10/2014, con avviso prot. n° 3104, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco, con lʹintervento dei Sigg.: Cognome Nome Presenti Assenti 1. Arca Monica x 2. Antinucci Paola x 3. Cau Gianpiero x 4. Ginnasi Carlo x 5. Medde Antonio x 6. Mele Angelo x x 7. Mele Assunta 8. Mele Ignazio x x 9. Mura Pietro Paolo 10. Puddu Maria Bonaria x x 11. Sanna William 12. Scarpa Fabio x TOTALE 9 3 Constatata la legalità dellʹadunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente, Dott. Antonio Pinna , nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. – Il Consiglio Comunale Premesso che, a partire dal 2008, la Comunità Europea ha promosso il cosiddetto Patto dei Sindaci, con il quale i Comuni firmatari s’impegnano alla riduzione, in misura ulteriore rispetto agli obiettivi fissati dall’Unione Europea, delle emissioni di anidride carbonica - CO2 - nell’atmosfera, con l’adozione di politiche di efficienza energetica rinnovabili; Richiamata la precedente Del. -

Curriculum Vitae Europeo Sandra Pili.Docx
Curriculum vitae europeo Cognome/Nome Pili Sandra Indirizzo Via Luigi Garau n. 30, 09096 Santa Giusta (OR) Telefono E-mail Ciadinanza Italiana Luogo e data di Oristano, 10.10.1972 nascita Sesso F Esperienza Dal 01/02/2021 Provincia di Oristano professionale Dirigente finanziario a tempo pieno e indeterminato Dal 24/12/2010 al 31/01/2021 Comune di Milis ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT. D2 . Vincitrice di selezione per istruore direvo contabile, cat. D1, a tempo indeterminato pieno, presso il Comune di Milis. In servizio presso l’Ente dal 24/12/2010. Dal 01.01.2011 al 31/01/2021 tolare di Posizione Organizzava, Responsabile del Servi- zio Finanziario, Personale e Tribu. Nel periodo dal 05.10.2011 al 31.12.2011 Responsabile del Servizio Finanziario, Persona- le e Tribu, in convenzione, fra i Comuni di Milis e Ollastra. Nel periodo dal 15/07/2019 al 31/10/2019 Responsabile del Servizio Finanziario, in con- venzione, fra il Comune di Milis e l’Unione dei Comuni Fenici. Nel periodo dal 29/01/2019 al 31/01/2021 Responsabile del Servizio Finanziario, Tribu e personale (traamento economico) presso il Comune di San Vero Milis in collaborazio- ne ai sensi art. 1 comma 557 L. 311/2004. Dal 31/12/2004 al 18/06/2008 e dal 16/11/2008 al 23/12/2010 Comune di Ollastra ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT. D1 . Vincitrice di selezione per istruore direvo contabile, cat D1, a tempo indeterminato pieno, presso il Comune di Ollastra. In servizio presso l’Ente dal 31.12.2004 al 18.06.2008 e dal 16.11.2008 al 23.12.2010. -

OSPEDALE SAN MARTINO DI ORISTANO Viale Rockefeller
OSPEDALE SAN MARTINO DI ORISTANO Viale Rockefeller CENTRALINO PRENOTAZIONE CUP PRONTO SOCCORSO 0783 3171 1533 0783 320110 Da cellulare 0783 317293 SERVIZI OSPEDALIERI Anatomia Patologica...........................................................................0783 317253 Oncologia........................................................................0783 317240-317360/65 Anestesia e Rianimazione............................................................0783 320155/152 Ortopedia e Traumatologia..........................................................0783 317292/54 Cardiologia.....................................................................................0783 317209/95 Ostetricia e Ginecologia....................................................................0783 317205 . Centro Talassemie..............................................................................0783 317313 Pediatria............................................................................................0783 320060 Chirurgia Generale.........................................................................0783 317233/42 Psichiatria.....................................................................................0783 320026/28 Diabetologia...................................................................................0783 317298/97 Radiologia.........................................................................................0783 320135 Endoscopia....................................................................................0783 320081/82 Farmacia -

Analisi Dei Dati
Analisi dei dati Carta geologica Costruzione ed imp ortazione nel GIS La carta geologica fornita dal Dipartimento di Ingegneria del Territorio dellUniversitadi Cagliari in formato CAD e scala e stata elab orata con ArcInfo p er la correzione degli errori e successiva costruzione della top ologia In Fig e si rip ortano i risultati di tali elab orazioni ritagliati sullarea GIS e sullarea mo dello risp ettivamente cos come denite nel rapp orto In Fig si rip orta la legenda valida p er ambedue le mapp e Descrizione ed inquadramento geologico La piana di Oristano e imp ostata su un Grab en Movimenti crustali risalenti al Terziario crearono una zona di rifting tra il continente francoib erico e la placca sardocorsa La stessa si distacco e successivamente 0 rototrasloin senso anti orario di circa La fossa tettonica Sarda diretta NS rappresenta il braccio pi u orientale del rift Susseguentemente ad un intenso vulcanismo a carattere calcoalcalino ed al dep osito di sedimenti marini e continentali la fossa fu completamente colmata Il Grab en si formop er la riattivazione di alcune faglie della fossa tettonica Sarda risalente al PlioPleisto cene Per quanto riguarda dep ositi risalenti al p erio do Terziario si puo dire che nella zona studiata sono presenti aoramenti cenozoici rappresentati da vulcaniti andesitiche Queste si p ossono trovare anche lungo la strada statale tra il km e il km Sedimenti mio cenici marini aorano ai piedi del monte Palla Presso il nuraghe SArgara sono visibili facies marnosearenacee Questi sedimenti risalgono -

Provincia Di Oristano
Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Misura 215 - Annualità 2014 Pagamenti per il miglioramento del benessere degli animali 4° anno di impegno: 15 settembre 2014 - 14 settembre 2015 Calendario corsi di formazione obbligatoria provincia di Oristano Agenzia Laore Sardegna – Dipartimento Produzioni zootecniche Servizio Produzioni zootecniche - Via Caprera n. 8, 09123 – Cagliari www.sardegnaagricoltura.it Psr 2007–2013 - Misura 215 - Annualità 2014 Calendario corsi di formazione obbligatoria provincia Ogliastra DATA CORSO SEDE CORSO BENEFICIARI COMUNI DI: SUT LAORE DI RIFERIMENTO Abbasanta Guilcer-Barigadu (Ghilarza) 19–20-22 gennaio 2015 Sala Agorà Abbasanta Coordinatore Rita Olivieri Tel: 0785/54103-3482363171 Montiferru-Planargia (Cuglieri- Bosa) Seneghe 19-20-21 gennaio 2015 Seneghe Coordinatore Bruno Tidu Casa aragonese Tel: 0785/369001/372068 - 3666241482 Montiferru-Planargia (Cuglieri- Bosa) 26-27-28 gennaio 2015 Bosa Locali Parrocchiali Bosa - Modolo - Montresta Coordinatore Bruno Tidu Tel: 0785/369001/372068 - 3666241482 Busachi Guilcer-Barigadu (Ghilarza) 02–03 –05 febbraio 2015 Locale Comunale Busachi – Ula Tirso Coordinatore Rita Olivieri Tel: 0785/54103-3482363171 Montiferru-Planargia (Cuglieri- Bosa) Suni 02-03-04 febbraio 2015 Suni - Sagama - Tinnura Coordinatore Bruno Tidu Centro sociale Tel: 0785/369001/372068 - 3666241482 Genoni Alta Marmilla (Ales - Laconi) 03-04-05 febbraio 2015 Centro Sociale Genoni -Assolo - Senis Coordinatore Carla Melosu Tel: 338/5356435 0783/91612 0782/869023 Siamaggiore (Pardu Nou) 1 Sinis (Siamaggiore) 04-05-06 febbraio 2015 Ufficio LAORE - Via Santa Maria,22 Bauladu - Milis - Tramatza Coordinatore Luigi Prina Tel: 0783/34122 – 3482363174 Paulilatino Guilcer-Barigadu (Ghilarza) 09–10–12 febbraio 2015 Locale Comunale Paulilatino Coordinatore Rita Olivieri Tel: 0785/54103-3482363171 Marrubiu Campidano di Oristano (Arborea) 09-10-11 febbraio 2015 Consorzio Bonifica – SS.