Novembre 2003
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

L'unificazione Italiana
ISTITVTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI L’UNIFICAZIONE ITALIANA Volume pubblicato con il contributo di ASPEN INSTITUTE ITALIA Capitoli scelti per il sito di Aspen Institute Italia SEZIONE III LE ISTITUZIONI E LA CLASSE DIRIGENTE Capitolo “Governo e Parlamento” di Paolo Pombeni Capitolo “L’Amministrazione centrale” di Guido Melis Capitolo “Partiti e movimenti” di Fulvio Cammarano © riproduzione vietata. Tutti i diritti riservati. Paolo Pombeni Governo e Parlamento Se accettiamo che la forza attrattiva del Piemonte, o meglio del Regno di Sardegna, nel porsi come perno del processo di unificazione nazionale risiedesse in parte non piccola nel suo essere di fatto l’unico Stato della penisola retto su un «modello costituzionale», non possiamo fare a meno di partire, nella nostra riflessione, dallo spazio che si era conquista- ta nell’opinione pubblica italiana quella autentica ideologia della modernità che in politi- ca era il costituzionalismo. Il problema della rappresentanza nella gestione della cosa pubblica e nella legittimazio- ne delle decisioni che venivano prese dagli organi dirigenti non era ovviamente questione ristretta a ciò che il costituzionalismo avrebbe rappresentato dopo la canonizzazione che ne fece in Europa l’esportazione dei principi rivoluzionari francesi sulle baionette napoleoni- che e la conseguente reazione a cui furono costretti i sistemi politici che vollero resistere a quella invasione. Anche i sistemi di antico regime avevano proprie forme di partecipazione e di rappresentanza, certo complicate in Italia dall’intersecarsi di dimensioni locali e dimen- sioni che chiamavano in causa i rapporti dei territori con i sistemi imperiali in cui si trova- vano a volta a volta inseriti (Spagna, Impero asburgico). -
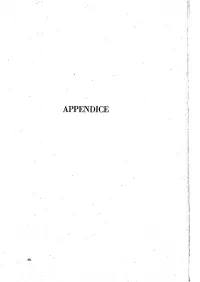
APPENDICE I - ' ' ' -Il
vi APPENDICE I - ' ' ' -il PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA ENRICO DE NICOLA, Capo prov visorio dello Stato dal 28 giugno 1946 al 24 giugno 1947 dal 25 giugno al 31 dicembre 1947 ENRICO DE NICOLA, Presidente della Repubblica ; dal 1° gennaio 1948 all'11 maggio 1948 LUIGI EINAUDI, Presidente della Repubblica dall'll maggio 1948 >"..". r ?.-.' V-r^v;*-"^"^ - •«• « ***•••>*• , . :ir.'-.•.:••.• L T • ~ i : ~ . ..' -» "• »-1 -?. ' *- / >^1 • - A •; li ENRICO DE NICOLA 82. • ' ? LUIGI EINAUDI PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI GIOVANNI GRONCHI. dall'8 maggio 1948 PRESIDÈNTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA IVANOE BONOMI dall'8 maggio 1948 GIOVANNI GRONCHI -J-Ì IVANOE BONOMI PRESIDENTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DALLA I ALLA XXVI LEGISLATURA VINCENZO GIOBERTI dall'8 maggio al 20 luglio 1848 e dal 16 ott. 30 die. 1848 IL . LORENZO PARETO dal 1° febbr. al 30 marzo 1849 III. LORENZO PARETO dal 30 luglio al 20* nov. 1849 IV . PIER DIONIGI PINELLI dal 20 die. 1849 al 25 aprile 1852 UHBANO RATTAZZI dall'll maggio 1852 al 27 ott. 1853 CARLO BON-COMPAGNI dal 16 al 21 nov. 1853 V ... CARLO BON-COMPAGNI. dal 19 die. 1853 al 16 giugno 1856 CARLO CADORNA.. dal 7 genn. al 16 luglio 1857 VI .. CARLO CADORNA. dal 14 die. 1857 al 14 luglio 1858 URBANO RATTAZZI. dal 10 genn. 1859 al 21 genn. 1860 VII . GIOVANNI LANZA dal 2 aprile al 28 die. 1860 VIII URBANO RATTAZZI. dal 18 febbr. 1861 al 2 marzo 1862 SEBASTIANO TECCHIO dal 22 marzo 1862 al 21 magg. 1863 GIOVANNI BATTISTA CASSINIS dal 25 maggio 1863 al 7 sett. 1865 IX. -

Il Risorgimento E L'europa
Commissione Italiana Storia Militareilitare SOCIETÀ ITALIANA MINISTEROINISTERO DELLA DIFESAIFESA DI STORIA MI L I TA R E QUADERNO 2010 L'anno di Teano Atti del Convegno Nazionale CISM-SISM su Il Risorgimento e l'Europa Società Italiana di Storia Militare PROPRIETÀ LETTERARIA tutti i diritti riservati: Vietata anche la riproduzione parziale senza autorizzazione A cura di: Contramm. (r) Paolo ALBERINI S. Ten. Elena BIGONGIARI Hanno contribuito alla realizzazione del Convegno Nazionale CISM 2010: Col. Matteo PAESANO Presidente della CISM e Capo Ufficio Storico dello SMD Ten. Col. Cosimo SCHINAIA Capo Sezione Documentazione Storica e Coordinamento dell’Ufficio Storico di SMD Ten. Col. Fabrizio RIZZI Capo Sezione Archivio Storico dell’Ufficio Storico di SMD Cap. Freg. Fabio SERRA. Addetto alla Sezione Documentazione Storica e Coordinamento dell’Ufficio Storico di SMD Primo Mar. Giuseppe TRINCHESE Capo Segreteria dell’Ufficio Storico di SMD Mar. Ord. Francesco D’AURIA Addetto alla Sezione Archivio Storico dell’Ufficio Storico di SMD 3 Presentazione Italia si prepara a ricordare i 150 anni dalla proclamazione dell’Unità e il dibattito sul Risorgimento italiano riemerge, con notevole attualità, dalleL’ pieghe della storia. È certo innegabile come tale processo abbia creato un senso di appartenenza nazionale e popolare vivo fino ad oggi, ma è anche vero che il processo di trasformazione, condotto dalle classi dirigenti politiche post- unitarie, di questo sentimento in elemento fondante di un’identità nazionale, sia rimasto incompiuto e non pienamente in grado di resistere a sistemi politici diversi e alle crisi di carattere economico-sociale. È un problema, dunque, po- litico piuttosto che culturale, tuttavia il Risorgimento fu il primo movimento ad avere successo nell’Italia geopoliticamente frammentata. -

Parte Ii Da Vittorio Emanuele Ii a Umberto I
FEDERICO BONA STEMMI DEI CAVALIERI DELL’ANNUNZIATA DA CARLO EMANUELE IV A UMBERTO II **** PARTE II DA VITTORIO EMANUELE II A UMBERTO I (1849 – 1900) LUGLIO 2012 Vittorio Emanuele II XXIV Gran Maestro dell’Ordine 1849 1849 1849 Napoleone III Francesco d’Assisi Ferdinando II imperatore dei Francesi re di Spagna re del Portogallo 1850 1850 1850 1850 Giovanni Federico Augusto di Federico di Prussia3 Carlo Maffei di Boglio Nepomuceno Sassonia2 di Sassonia1 1850 1850 1850 1850 Federico Guglielmo Carlo Giuseppe Pietro Vivaldi Pasqua Angelo Michele Crotti di Prussia4 Beraudo di Pralormo di Costigliole 1853 1853 Carlo Ferrero Roberto Saluzzo di Masserano di Monesiglio 1 poi Giovanni, re di Sassonia. 2 poi Alberto re di Sassonia. 3 poi Federico III, imperatore di Germania e re di Prussia. 4 poi Guglielmo I, re di Prussia e imperatore di Germania. 14 (segue Vittorio Emanuele II) 1855 1855 1855 1855 Giuseppe Sanjust di Leopoldo del Belgio Pietro V Luigi di Portogallo San Lorenzo principe reale del Belgio5 re di Portogallo duca di Oporto6 1855 1855 1856 Napoleone Gerolamo Napoleone Camillo Benso di 7 Giuseppe Carlo Bonaparte Cavour Bonaparte 1857 1857 Michele Costantino granduca di Russia granduca di Russia 1858 1858 1858 Ettore de Gerbaix Cesare Alfieri di Alfonso Ferrero della de Sonnaz Sostegno Marmora 5 Poi Leopoldo II, re dei Belgi. 6 Poi Luigi I, re di Portogallo. 7 Già re di Westfalia. 15 (segue Vittorio Emanuele II) 1859 1859 1859 1859 Umberto di Savoia Napoleone Giuseppe Nicola Alberto Edoardo principe di Piemonte8 Bonaparte granduca ereditario di principe di Gran principe imperiale di Russia Bretagna e Irlanda9 Francia 1859 1859 1859 1859 Giovanni Battista Enrico Morozzo della Alessandro Colonna Achille Baraguay Vaillant Rocca Waleski d'Hilliers 1859 1859 1859 1859 Francesco Certain Augusto Michele Edmondo Maurizio di Adolfo Niel Canrobert Regnault Mac Mahon10 di Saint-Jean d'Angély 1859 1859 Alessandro Giacomo Luigi Gortshakoff Randon 8 Poi Umberto I, re d’Italia. -

Archivio Jacini
Archivio di Stato di Cremona Archivio Jacini Titolo I Famiglia Jacini Revisione 2019 a cura di Silvia Rigato con la collaborazione dei volontari del Servizio Civile Nazionale anno 2017-2018 II L’archivio Jacini è stato depositato in Archivio di Stato nel 2016. Si presentava sostanzialmente già ordinato e corredato da inventari manoscritti redatti a metà Novecento da Francesco Forte, archivista presso l’Archivio di Stato Milano, su incarico di Stefano Jacini. Le carte sono state suddivise da Forte in cinque titoli: Famiglia, Fondi e case, Amministrazione, Ditta Jacini, Miscellanea. In questa sede si propone la trascrizione del primo titolo, diviso a sua volta in gruppi, ciascuno dei quali corrispondente a un membro della famiglia. Nel lavoro di trascrizione e revisione degli inventari, si è cercato il più possibile di rispettare l’ordinamento di Francesco Forte, salvo che per i gruppi 28 e 33, in cui erano state aggiunte a posteriori delle buste in coda a quelle già riordinate ed erano stati scambiati o modificati (aggiunti o sottratti) i contenuti di numerosi fascicoli. In questi casi si è optato per il riordino complessivo del gruppo: rimandiamo pertanto alle note introduttive di queste sezioni per i dettagli. Ove possibile, inoltre, è stata riunita in un unico fascicolo la corrispondenza di uno stesso mittente al fine di alleggerire la descrizione che, pur essendo ancora molto analitica, è ora meno ripetitiva. A fronte dei cambiamenti apportati, il presente inventario riporta sia la nuova fascicolazione, sia le precedenti segnature assegnate da Francesco Forte; in tal modo rimane la possibilità di operare un riscontro con gli inventari manoscritti e al contempo non si perde traccia della loro posizione originaria. -

Indice Generale TITOLO I - DISPOSIZIONI
Indice generale TITOLO I - DISPOSIZIONI......................................................................................................................................3 1.1 Oggeo del lavoro....................................................................................................................................3 1.2 Organizzazione del lavori.........................................................................................................................3 1.3 Responsabili delle a vit"........................................................................................................................3 TITOLO II - ATTIVIT% OGGETTO DELL( AFFIDAMENTO.........................................................................................4 2.1 Interven, puntuali di ripris,no .unzionale e messa in sicurezza viabilit" terra.erma.............................4 2.1.1 Descrizione indica,va......................................................................................................................4 2.1.2 Modalit" di controllo.......................................................................................................................4 2.1.3 Penali................................................................................................................................................4 2.2 Interven, di manutenzione programmata di media e modesta en,t"...................................................1 2.1.1 Descrizione indica,va......................................................................................................................1 -

Religion and Opera in Liberal Italy from Unification to the First World War
1 Opera avanti a Dio! Religion and Opera in Liberal Italy from Unification to the First World War Andrew James Holden Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements of the award of Doctor of Philosophy Oxford Brookes University 25 February 2019 2 Opera avanti a Dio! Religion and Opera in Liberal Italy from Unification to the First World War Contents Abstract ..................................................................................................................... 4 List of Tables and Images ....................................................................................... 5 Acknowledgements .................................................................................................. 7 Introduction .............................................................................................................. 9 Chapter I – Adapting religion in the operatic libretto .......................................... 38 Introduction ......................................................................................................... 38 Verdian adaptations of religion after Unification ............................................. 48 Adapting History and Realism – Don Carlos .................................................... 54 Boito and Boito/Verdi ......................................................................................... 59 Sanctity and anticlericalism in Cristoforo Colombo ........................................ 63 Giving space to religion in contemporary drama ........................................... -

UOMINI CHE DECIDONO PER LE DONNE. IL SUFFRAGIO FEMMINILE NEL DIBATTITO PARLAMENTARE DELL’ITALIA POST UNITARIA (1861-1920) Loredana GARLATI*
UOMINI CHE DECIDONO PER LE DONNE. IL SUFFRAGIO FEMMINILE NEL DIBATTITO PARLAMENTARE DELL’ITALIA POST UNITARIA (1861-1920) Loredana GARLATI* Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato: Loredana Garlati (2015): «Uomini che decidono per le donne. Il suffragio femminile nel dibattito parlamentare dell‘Italia post unitaria (1861-1920)», en Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, nº 9 (diciembre 2015). Puede leerse este artículo en línea en: http://www.eumed.net/rev/rehipip/09/suffragio-femminile.html. RIASSUNTO: Lo spunto di questo saggio è offerto da un lavoro di Maurice Duverger, risalente agli anni Cinquanta. In cui l‘autore, su invito dell‘Unesco, esaminava l‘influenza del voto politico delle donne in quatro paesi europei, al fine de verificare, come recita il titolo stesso dell‘opera, ―La participation des femmes à la vie politique‖. Negli anni in cui Duverger dava alle stampe la sua analisi, le donne italiane avevano da poco meno di un decennio visti riconosciuti il loro diritti politici e, per la prima volta dall‘Unità, avevano partecipato alle elezioni indette dopo la seconda guerra mondiale. Il percorso per giungere a tale conquista fu lungo e tormentato, sebbene il tema del suffragio femminile si era posto come una delle priorità del neonato Stato italiano. Attraverso il dibattito che dal 1861 si trascinò stancamente in Parlamento fino agli anni Venti del Novecento, è possibile ricostruire il clima non solo politico, ma anche culturale dell‘Italia del tempo. Le aule parlamentari, al cui interno giungeva l‘eco del mutato quadro socio-economico che vedeva le donne accompagnare al tradizionale ruolo di moglie e di madre, quello di lavoratrici, rimasero tuttavia sorde ad ogni istanza di cambiamento, sia con riferimento alla concessione del voto amministrativo che di quello politico. -

00 NUMERAZIONE ROMANA 1-06-2011 17:31 Pagina Iii
00 NUMERAZIONE ROMANA 1-06-2011 17:31 Pagina iii DALLO SCRANNO PIÙ ALTO DISCORSI DI INSEDIAMENTO DEI PRESIDENTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (1861-2008) In appendice: Discorsi di insediamento dei Presidenti della Camera dei deputati del Regno di Sardegna (1848-1860) CAMERA DEI DEPUTATI 00 NUMERAZIONE ROMANA 1-06-2011 17:31 Pagina iv Il presente volume è diviso in due parti, dedicate rispettivamente ai discorsi d’insediamento dei Presidenti della Camera dei deputa- ti e ai loro profili biografici. In particolare, la prima parte si com- pone di tre sezioni che corrispondono alle scansioni della storia co- stituzionale italiana (monarchia: il Regno d’Italia dal 1861 al 1939, con l’esclusione della XXX legislatura, relativa alla Camera dei fasci e delle corporazioni; ordinamento transitorio: l’Assemblea co- stituente; Repubblica: dalla I alla corrente legislatura). Segue un’appendice contenente i discorsi di insediamento dei Presidenti della Camera del Regno di Sardegna (1848-1860). Ciascun discor- so è inquadrato nel momento storico in cui è stato pronunciato e corredato da elementi informativi che danno conto delle modalità di formazione della rappresentanza elettiva e del quadro politico generale. Non sono stati inclusi i discorsi relativi alla Camera dei fasci e delle corporazioni, in ragione della mutata natura di tale organo e del suo carattere non elettivo. La seconda parte è dedi- cata, invece, ai profili biografici dei Presidenti, presentati in ordi- ne alfabetico e corredati, per il periodo regio, dal ritratto esposto nella Galleria dei Presidenti al piano Aula di Palazzo Montecito- rio e, per il periodo repubblicano, dall’immagine fotografica che li ritrae mentre pronunziano il discorso nella seduta di insediamen- to. -

I Beni Degli Esuli. I Sequestri Austriaci in Veneto Tra Controllo Politico E Prassi Burocratica (1848-1861)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO Dipartimento di Studi storici Corso di Dottorato Storia, cultura e teorie della società e delle istituzioni – XXXI ciclo I beni degli esuli. I sequestri austriaci in Veneto tra controllo politico e prassi burocratica (1848-1861) DOTTORANDO Giacomo GIRARDI TUTOR Prof.ssa Catherine BRICE (Université Paris-Est Créteil) Prof. Antonino DE FRANCESCO (Università degli Studi di Milano) COORDINATRICE DEL DOTTORATO Prof.ssa Daniela SARESELLA A. A. 2017/2018 2 Indice INTRODUZIONE 8 1. L’esilio tra fuga e opportunità: una riflessione storiografica e alcuni spunti di ricerca 8 1.1. Un “Risorgimento internazionale” 9 1.2. 1848-1849: un nuovo esilio 13 2. Nuovi percorsi post-quarantotteschi: il binomio esilio-innovazione e la geografia dell’emigrazione 14 2.1. Esilio e innovazione 15 2.2. La geografia dell’esilio 16 3. Vivere l’esilio. Confische e sequestri, il perché di una ricerca 21 3.1. Le conseguenze dell’esilio 21 3.2. L’impatto del sequestro dei beni sui patrioti lombardo-veneti 25 3.3. Esilio, confische e sequestri nel Veneto ottocentesco 27 CAPITOLO I 34 SEQUESTRI E CONFISCHE NEL REGNO LOMBARDO-VENETO: ORIGINI, PERCORSI E PROFILI STORICO-NORMATIVI 34 1. Le confische dalle origini al Settecento: pratiche e lineamenti 37 2. La confisca nella tradizione giuridica lombarda e veneta tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo 42 2.1. Le confische nella Milano austriaca (XVIII sec.) 43 2.2. Confische e illuminismo 44 2.3. Il diritto veneto 48 3. Le confische nella Venezia democratica (1797) 52 3.1. La Commissione alle confische ed indennizzazioni 53 3 3.2. -

Massoneria E Irredentismo Il Circolo Garibaldi Di Trieste Tra Ottocento E Novecento
Università degli Studi di Trieste XXVI Ciclo del dottorato di ricerca in Scienze Umanistiche, Indirizzo Storico, Storico-artistico Massoneria e irredentismo Il Circolo Garibaldi di Trieste tra Ottocento e Novecento M-STO/04 Storia contemporanea Dottorando Luca Giuseppe Manenti Coordinatore chiar.ma prof.ssa Elisabetta Vezzosi Supervisore di tesi char.ma prof.ssa Tullia Catalan Anno Accademico 2012-2013 Indice Abbreviazioni p. 5 I. I fondamenti 1 Premesse storiografiche p. 9 1.1 Nascita, significato e sviluppi del lemma “irredentismo” p. 9 1.2 Unità o espansione? Una periodizzazione dell'irredentismo p. 13 1.3 La storiografia sulla massoneria e sull'irredentismo p. 18 1.4 Il Circolo Garibaldi di Trieste. Lo stato degli studi p. 20 1.5 Obiettivi e fonti p. 23 1.6 Il Circolo e le categorie storiografiche p. 26 2 Le origini p. 36 2.1. I primi fondatori p. 36 2.2 Il diario di prigionia di Raimondo Battera p. 42 2.3 Gli esuli triestini tra irredentismo e massoneria p. 56 2.4 Aurelio Saffi e la gioventù irredentista p. 62 II. Nord 3 Lombardia p. 67 3.1 Milano p. 67 3.1.1 Le logge ambrosiane e il Circolo Garibaldi p. 67 3.1.2 Crispi, Lemmi e l'irredentismo massonico p. 73 3.1.3 Intransigenti e moderati p. 78 3.2 Como. Società ginniche, anti-clericalismo e massoneria p. 86 3.3 Brescia. Patriottismo, mazzinianesimo ed esoterismo massonico p. 88 3.4 Pavia. Sotto le volte della «Giuseppe Pedotti» p. 95 3.5 Mantova. Rocco Tamburlini: dalla fuga via Ancona al Circolo mantovano p. -

IL Risorgiμevto
Commissione Italiana Storia Militareilitare IL RISORGIMENTO MINISTEROINISTERO DELLA DIFESAIFESA E L’EUROPA. Attori e protagonisti dell’Unità d’Italia nel 150° anniversario CONVEGNO NAZIONALE Roma, 9 - 10 NovembreCISM 2010 Centro Alti Studi per la Difesa (CASD) Palazzo Salviati ATTI DEL CONVEGNO Celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia PROPRIETÀ LETTERARIA tutti i diritti riservati: Vietata anche la riproduzione parziale senza autorizzazione © 2011 • Ministero della Difesa CISM - Commissione Italiana di Storia Militare Salita S. Nicola da Tolentino, 1/B - Roma [email protected] A cura di: Contramm. (r) Paolo ALBERINI S. Ten. Elena BIGONGIARI Hanno contribuito alla realizzazione del Convegno Nazionale CISM 2010: Col. Matteo PAESANO Presidente della CISM e Capo Ufficio Storico dello SMD Ten. Col. Cosimo SCHINAIA Capo Sezione Documentazione Storica e Coordinamento dell’Ufficio Storico di SMD Ten. Col. Fabrizio RIZZI Capo Sezione Archivio Storico dell’Ufficio Storico di SMD Cap. Freg. Fabio SERRA. Addetto alla Sezione Documentazione Storica e Coordinamento dell’Ufficio Storico di SMD Primo Mar. Giuseppe TRINCHESE Capo Segreteria dell’Ufficio Storico di SMD Mar. Ord. Francesco D’AURIA Addetto alla Sezione Archivio Storico dell’Ufficio Storico di SMD 3 Presentazione Italia si prepara a ricordare i 150 anni dalla proclamazione dell’Unità e il dibattito sul Risorgimento italiano riemerge, con notevole attualità, dalleL’ pieghe della storia. È certo innegabile come tale processo abbia creato un senso di appartenenza nazionale e popolare vivo fino ad oggi, ma è anche vero che il processo di trasformazione, condotto dalle classi dirigenti politiche post- unitarie, di questo sentimento in elemento fondante di un’identità nazionale, sia rimasto incompiuto e non pienamente in grado di resistere a sistemi politici diversi e alle crisi di carattere economico-sociale.