Archivio Di Stato Di Venezia
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
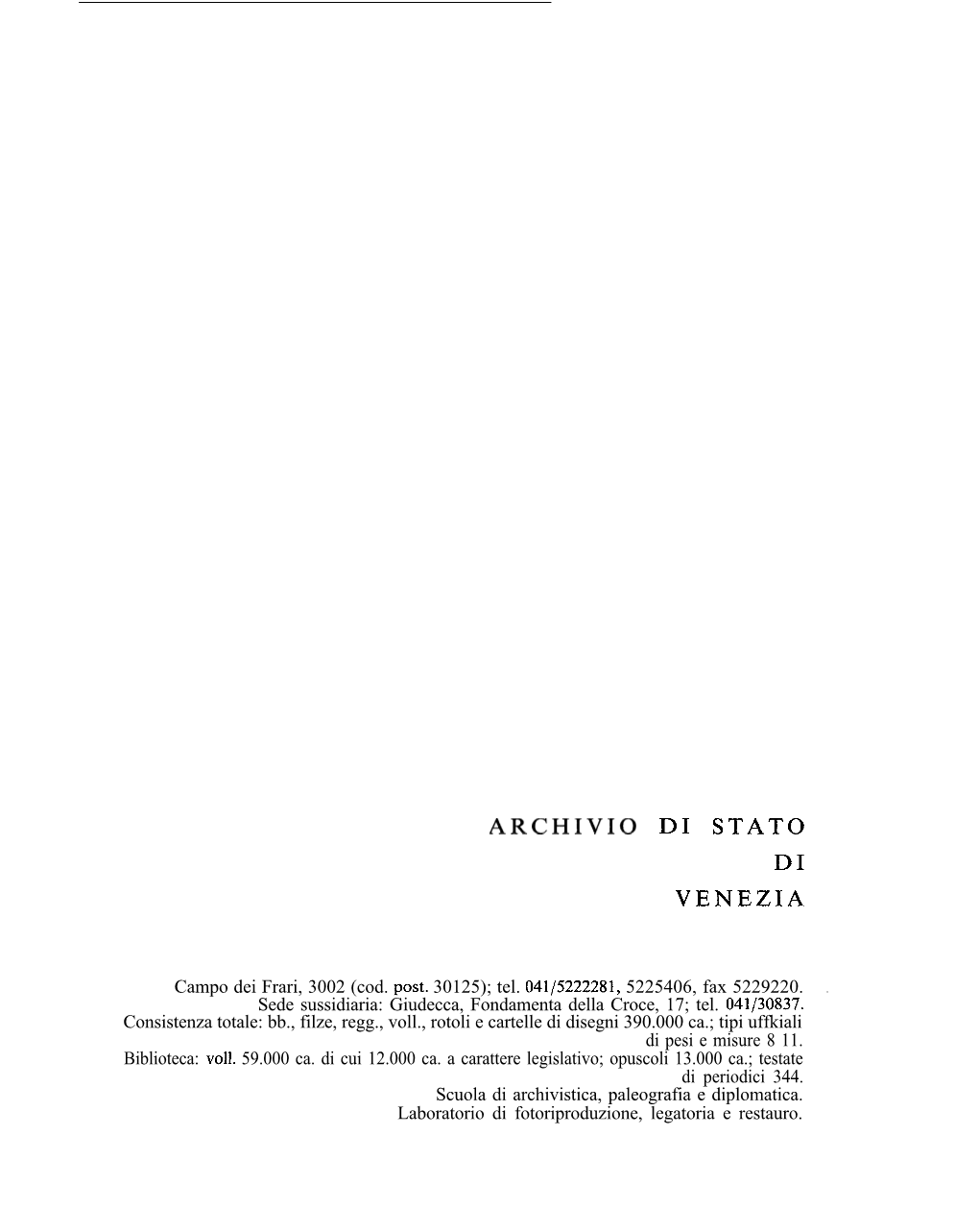
Load more
Recommended publications
-

Archivio Veneto
Anno CXLVI VI serie n. 10 ARCHIVIO DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA VENETO PER LE VENEZIE • ARCHIVIO VENETO VI Serie N. 15 • VENEZIA ISSN 0392-0291 2018 2015 ARCHIVIO VENETO SESTA SERIE - n. 10 (2015) comitato scientifico Piero Del Negro, presidente Dieter Girgensohn - Giuseppe Gullino - Jean-Claude Hocquet Sergej Pavlovic Karpov - Gherardo Ortalli - Maria Francesca Tiepolo Gian Maria Varanini - Wolfgang Wolters Questo numero è stato curato da Giuseppe Gullino comitato di redazione Eurigio Tonetti, coordinatore Michael Knapton - Antonio Lazzarini - Andrea Pelizza - Franco Rossi La rivista efettua il referaggio anonimo e indipendente issn 0392-0291 stampato da cierre grafica - verona 2015 DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LE VENEZIE ARCHIVIO VENETO VENEZIA 2015 DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LE VENEZIE S. Croce, Calle del Tintor 1583 - 30135 VENEZIA Tel. 041 5241009 - Fax 041 5240487 www.veneziastoria.it - e-mail: [email protected] Bianca Strina Lanfranchi1 (27 settembre 1932 - 1° ottobre 2015) In memoriam Bianca Strina nasce a Venezia il 27 settembre 1932. Si laurea in giurispru- denza all’Università degli Studi di Padova l’8 novembre 1955 con una tesi dal titolo La nullità dell’atto costitutivo della società per azioni (relatore: Giorgio Oppo, a. acc. 1954-55). Entra nell’amministrazione archivistica il 1° ottobre 1958, iniziando la sua carriera all’Archivio di Stato di Venezia. In quella prestigiosa sede continua la collaborazione, già iniziata in precedenza, con il Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia, in particolare con Luigi Lanfranchi con cui realizza non solo alcuni volumi ma anche una operosa sintonia scientifca sfociata qualche anno più tardi in un felice matrimonio. -

Do the Adaptations of Venice and Miami to Sea Level Rise Offer Lessons for Other Vulnerable Coastal Cities?
Environmental Management https://doi.org/10.1007/s00267-019-01198-z Do the Adaptations of Venice and Miami to Sea Level Rise Offer Lessons for Other Vulnerable Coastal Cities? 1 2 3 Emanuela Molinaroli ● Stefano Guerzoni ● Daniel Suman Received: 5 February 2019 / Accepted: 29 July 2019 © Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2019 Abstract Both Venice and Miami are high-density coastal cities that are extremely vulnerable to rising sea levels and climate change. Aside from their sea-level location, they are both characterized by large populations, valuable infrastructure and real estate, and economic dependence on tourism, as well as the availability of advanced scientific data and technological expertize. Yet their responses have been quite different. We examine the biophysical environments of the two cities, as well as their socio- economic features, administrative arrangements vulnerabilities, and responses to sea level rise and flooding. Our study uses a qualitative approach to illustrate how adaptation policies have emerged in these two coastal cities. Based on this information, we critically compare the different adaptive responses of Venice and Miami and suggest what each city may learn from the 1234567890();,: 1234567890();,: other, as well as offer lessons for other vulnerable coastal cities. In the two cases presented here it would seem that adaptation to SLR has not yet led to a reformulation of the problem or a structural transformation of the relevant institutions. Decision-makers must address the complex issue of rising seas with a combination of scientific knowledge, socio-economic expertize, and good governance. In this regard, the “hi-tech” approach of Venice has generated problems of its own (as did the flood control projects in South Florida over half a century ago), while the increasing public mobilization in Miami appears more promising. -

Andrea Mozzato “Rulers of Venice (1332-1524)”. Alcune Osservazioni Sulla Schedatura Dei Registri Del Segretario Alle Voci
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Reti Medievali Open Archive Andrea Mozzato “Rulers of Venice (1332-1524)”. Alcune osservazioni sulla schedatura dei registri del Segretario alle Voci Estratto da Reti Medievali Rivista, VI - 2005/2 (luglio-dicembre) <http://www.dssg.unifi .it/_RM/rivista/saggi/Mozzato.htm> RetiR MedievaliM Firenze University Press Reti Medievali Rivista, VI - 2005/2 (luglio-dicembre) <http://www.dssg.unifi .it/_RM/rivista/saggi/Mozzato.htm> RetiR MedievaliM ISSN 1593-2214 © 2005 Firenze University Press “Rulers of Venice (1332-1524)”. Alcune osservazioni sulla schedatura dei registri del Segretario alle Voci di Andrea Mozzato Questo articolo si pone tre obiettivi: presentare il progetto “Rulers of Venice, 1332-1524”, mostrare come è stata costruita una parte dell’omonima banca dati evidenziando i problemi e le soluzioni adottate, mettere in luce le possibilità che essa offre mediante alcuni case studies. Il lavoro, ideato nel 2001 da Benjamin G. Kohl e da lui realizzato con la partecipazione di Monique O’Connell e di chi scrive, consiste nella schedatura degli uffi ci veneziani e dei loro titolari fra il tardo Medioevo e la prima età mo- derna. Il fi ne è quello di avere a disposizione in un’unica risorsa informatica consultabile in rete il maggior numero possibile di nomi della classe dirigente ed i loro incarichi. La banca dati è composta da oltre 60.000 records, circa 600 uffi ci, consigli e reggimenti del territorio veneziano; approssimativamente vi compaiono 9.000 nobili. La realizzazione tecnica è stata affi data a Ronald G. -

Archivio Veneto
Anno CXLV VI serie n. 7 ARCHIVIO DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA VENETO PER LE VENEZIE • ARCHIVIO VENETO VI Serie N. 15 • VENEZIA ISSN 0392-0291 2018 2014 ARCHIVIO VENETO SESTA SERIE - n. 7 (2014) comitato scientifico Gherardo Ortalli, presidente Pietro Del Negro - Dieter Girgensohn - Giuseppe Gullino Jean-Claude Hocquet - Sergej Pavlovic Karpov Maria Francesca Tiepolo - Gian Maria Varanini - Wolfgang Wolters Questo numero è stato curato da Eurigio Tonetti comitato di redazione Eurigio Tonetti, coordinatore Michael Knapton - Antonio Lazzarini - Franco Rossi La rivista effettua il referaggio anonimo e indipendente issn 0392-0291 stampato da cierre grafica - verona 2014 DEPUtaZIONE DI storia patria per LE VENEZIE ARCHIVIO VENETO VENEZIA 2014 Questa pubblicazione si è avvalsa del contributo della DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LE VENEZIE S. Croce, Calle del Tintor 1583 - 30135 VENEZIA Tel. 041 5241009 - Fax 041 5240487 www.veneziastoria.it - e-mail: [email protected] Filippo Boscolo ATTI DI evergeTISMO Nella ViceNZA del II secolo D.C.* La città di Vicetia diede i natali a Caius Salonius Matidius Patruinus, un personaggio di rango senatorio del quale sappiamo che aveva fatto parte del collegio sacerdotale dei fratres Arvales, essendone stato il presidente nel 78 d.C., come risulta dagli Atti dei fratelli Arvali di quell’anno1. La sua famiglia era entrata a far parte dell’ordine senatorio con il padre, che era stato ammesso in senato nel 48 d.C. dall’imperatore Claudio nelle vesti di censore. Questo dato si ricava dalla seguente iscrizione: [- Salonio? - f(ilio) Men(enia)] / Ma[tid]io [---] / a Ti(berio) Claudio Caesare / Augus[t]o Germanico / censor(e) [a]dlecto in / senatum et inter / tribunicios re- lato / ab eodem, adscito in / numerum Saliorum, / Salonia mater / filio piissimo / viva fecit2. -

Sacred Scripture / Sacred Space
Sacred Scripture / Sacred Space Unauthenticated Download Date | 2/4/19 9:22 AM Materiale Textkulturen Schriftenreihe des Sonderforschungsbereichs 933 Herausgegeben von Ludger Lieb Wissenschaftlicher Beirat: Jan Christian Gertz, Markus Hilgert, Hanna Liss, Bernd Schneidmüller, Melanie Trede und Christian Witschel Band 23 Unauthenticated Download Date | 2/4/19 9:22 AM Sacred Scripture / Sacred Space The Interlacing of Real Places and Conceptual Spaces in Medieval Art and Architecture Edited by Tobias Frese, Wilfried E. Keil and Kristina Krüger Unauthenticated Download Date | 2/4/19 9:22 AM ISBN 978-3-11-062913-2 e-ISBN (PDF) 978-3-11-062915-6 e-ISBN (EPUB) 978-3-11-063347-4 ISSN 2198-6932 This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License. For details go to http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. Library of Congress Control Number: 2018964345 Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available on the Internet at http://dnb.dnb.de. © 2019 Frese et al., published by Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston This book is published in open access at www.degruyter.com. Cover Images: Florenz, San Pancrazio, Capella Rucellai, facade. Photo: Miguel Hermoso Cuesta, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0). Typesetting: Sonderforschungsbereich 933 (Nicolai Schmitt), Heidelberg Printing and binding: Hubert & Co. GmbH & Co. KG, Göttingen www.degruyter.com Unauthenticated Download Date | 2/4/19 9:22 AM Contents Acknowledgements V Tobias Frese, Kristina Krüger Sacred Scripture / Sacred Space The Interlacing of Real Places and Conceptual Spaces in Medieval Art and Architecture. -

“Talk” on Albanian Territories (1392–1402)
Doctoral Dissertation A Model to Decode Venetian Senate Deliberations: Pregadi “Talk” on Albanian Territories (1392–1402) By: Grabiela Rojas Molina Supervisors: Gerhard Jaritz and Katalin Szende Submitted to the Medieval Studies Department Central European University, Budapest In partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Medieval Studies, Budapest, Hungary 2020 CEU eTD Collection To my parents CEU eTD Collection Table of Contents Acknowledgments .................................................................................................................................. 1 List of Maps, Charts and Tables .......................................................................................................... 2 Introduction ............................................................................................................................................ 3 A Survey of the Scholarship ........................................................................................................................... 8 a) The Myth of Venice ........................................................................................................................... 8 b) The Humanistic Outlook .................................................................................................................. 11 c) Chronicles, Histories and Diaries ..................................................................................................... 14 d) Albania as a Field of Study ............................................................................................................. -

The Ottoman-Venetian Border (15Th-18Th Centuries)
Hilâl. Studi turchi e ottomani 5 — The Ottoman-Venetian Border (15th-18th Centuries) Maria Pia Pedani Edizioni Ca’Foscari The Ottoman-Venetian Border (15th-18th Centuries) Hilâl Studi turchi e ottomani Collana diretta da Maria Pia Pedani Elisabetta Ragagnin 5 Edizioni Ca’Foscari Hilâl Studi turchi e ottomani Direttori | General editors Maria Pia Pedani (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Elisabetta Ragagnin (Freie Universität, Berlin) Comitato scientifico | Advisory board Bülent Arı (TBMM Milli Saraylar, Müzecilik ve Tanıtım BaŞkanı, İstanbul, Türkiye) Önder Bayır (TC BaŞbakanlık Devlet ArŞivi Daire Başkanlığı, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, İstanbul, Türkiye) Dejanirah Couto (École Pratique des Hautes Études «EPHE», Paris, France) Mehmet Yavuz Erler (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Türkiye) Fabio Grassi ( «La Sapienza» Università di Roma, Italia) Figen Güner Dilek (Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye) Stefan Hanß (University of Cambridge, UK) Baiarma Khabtagaeva (Szegedi Tudományegyetem, Magyarország) Nicola Melis (Università degli Studi di Cagliari, Italia) Melek Özyetgin (Yildiz Üniversitesi, İstanbul, Türkiye) Cristina Tonghini (Università Ca’ Foscari Venezia, Italia) Direzione e redazione Università Ca’ Foscari Venezia Dipartimento di Studi sull’Asia sull’Africa mediterranea Sezione Asia Orientale e Antropologia Palazzo Vendramin dei Carmini Dorsoduro 3462 30123 Venezia http://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/collane/hilal/ The Ottoman-Venetian Border (15th-18th Centuries) Maria Pia Pedani translated by Mariateresa Sala Venezia Edizioni Ca’ Foscari - Digital Publishing 2017 The Ottoman-Venetian Border (15th-18th Centuries) Maria Pia Pedani © 2017 Maria Pia Pedani for the text © 2017 Mariateresa Sala for the translation © 2017 Edizioni Ca’ Foscari - Digital Publishing for the present edition Qualunque parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di recupero dati o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, senza autorizzazione, a condizione che se ne citi la fonte. -

The Relations of the Republic Of
Aleksandra V. Chirkova, Daria A. Ageeva , Evgeny A. Khvalkov THE RELATIONS OF THE REPUBLIC OF VENICE AND THE MARQUISES D’ESTE IN THE MID-FOURTEENTH TO MID-FIFTEENTH CENTURY BASED ON THE LETTERE DUCALI FROM THE WESTERN EUROPEAN SECTION OF THE HISTORICAL ARCHIVE OF THE SAINT PETERSBURG INSTITUTE OF HISTORY OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES BASIC RESEARCH PROGRAM WORKING PAPERS SERIES: HUMANITIES WP BRP 174/HUM/2018 This Working Paper is an output of a research project implemented at the National Research University Higher School of Economics (HSE). Any opinions or claims contained in this Working Paper do not necessarily reflect the views of HSE Aleksandra V. Chirkova1,2 Daria A. Ageeva3, Evgeny A. Khvalkov45 THE RELATIONS OF THE REPUBLIC OF VENICE AND THE MARQUISES D’ESTE IN THE MID-FOURTEENTH TO MID- FIFTEENTH CENTURY BASED ON THE LETTERE DUCALI FROM THE WESTERN EUROPEAN SECTION OF THE HISTORICAL ARCHIVE OF THE SAINT PETERSBURG INSTITUTE OF HISTORY OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES6 The present study is devoted to the research into a set of the Venetian lettere ducali to the Marquises d’Este of the fourteenth and fifteenth centuries collected by N.P. Likhachev (1862- 1936), Member of the Academy of Sciences of the USSR, stored in the Western European section of the Saint Petersburg Institute of History of the Russian Academy of Sciences and the preparation of their full-text critical publication. The lettere ducali are an excellent source to study the Serenissima and its continental and overseas domains. The source material of the Venetian lettere ducali have long and not without reason been considered and actively investigated by researchers as one of the most important sources on the economic, social, political, legal, environmental, cultural, and ethnic history of Venice. -

Venice's Ceremonial Treatment of the Ottoman and Safavid Envoys In
OTAM, 48 /Güz 2020, 85-109 Venice’s Ceremonial Treatment of the Ottoman and Safavid Envoys in Comparative Perspective Osmanlı Ve Safevî Elçilerinin Venedik'te Kabul Törenleri Karşılaştırmalı Perspektifte Ahmad GULIYEV Abstract Taking a comparative perspective and drawing on the documents from the Venetian State Archives, the paper attempts to examine a ceremonial treatment of the Ottoman and Safavid diplomats in Venice. Both the Ottoman and Safavid envoys usually were graciously received in Venice. However, the degree of the Venetian hospitality was subject to changes and varied in accordance to the importance of the incoming mission and overall nature of its relations with the Ottomans and Safavids. It appears from the receptions of the Ottoman and Safavid diplomats in Venice that during the sixteenth and early seventeenth centuries, the ceremonial positions of the sultan’s envoys were equal or mostly above that of the Qızılbaş representatives. As it is evident from the Safavid Asad bey’s case in 1600, in its treatment of the Safavid envoys, Venetian government pursued a cautious policy and tried not to antagonize the Ottomans. Furthermore, the Ottoman factor had enduring impact both on the nature and on the dynamics of the Safavid-Venetian relations. Key words: Safavid-Venetian relations, Ottoman-Venetian relations, Safavid envoys, early modern diplomacy, diplomatic ceremonial. The paper was written within a research project titled “SAFVEN-West meets East in Venice: Cross-cultural interactions and reciprocal influences between the Safavids and Venetians” financed from the support of European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowship grant agreement No 789632. -

La Campagna Del 1796 Nel Veneto Parte I (La Decadenza Militare Della Serenissima
Eugenio Barbarich La Campagna del 1796 nel Veneto Parte I (la decadenza militare della serenissima. Uomini ed armi) www.liberliber.it Questo e-book è stato realizzato anche grazie al sostegno di: E-text Editoria, Web design, Multimedia http://www.e-text.it/ QUESTO E-BOOK: TITOLO: La Campagna del 1796 nel Veneto : Parte I (la decadenza militare della serenissima. Uomini ed armi) AUTORE: Barbarich, Eugenio TRADUTTORE: CURATORE: NOTE: Realizzato in collaborazione con il Project Gutenberg (http://www.gutenberg.net/) tramite Distributed Proofreaders Europe (http://dp.rastko.net) Il testo è tratto da una copia in formato immagine presente sul sito "Gallica, bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France" (http://gallica.bnf.fr). DIRITTI D'AUTORE: no LICENZA: questo testo è distribuito con la licenza specificata al seguente indirizzo Internet: http://www.liberliber.it/biblioteca/licenze/ TRATTO DA: La Campagna del 1796 nel Veneto : Parte I (la decadenza militare della serenissima. Uomini ed armi) di Eugenio Barbarich; Tip. E. Voghera; Roma, 1910 CODICE ISBN: informazione non disponibile 1a EDIZIONE ELETTRONICA DEL: 28 febbraio 2004 INDICE DI AFFIDABILITA': 1 0: affidabilità bassa 1: affidabilità media 2: affidabilità buona 3: affidabilità ottima ALLA EDIZIONE ELETTRONICA HANNO CONTRIBUITO: Distributed Proofreaders Europe, http://dp.rastko.net REVISIONE: Claudio Paganelli, [email protected] Carlo Traverso, [email protected],it PUBBLICATO DA: Claudio Paganelli, [email protected] Alberto Barberi, [email protected] Informazioni sul "progetto Manuzio" Il "progetto Manuzio" è una iniziativa dell'associazione culturale Liber Liber. Aperto a chiunque voglia collaborare, si pone come scopo la pubblicazione e la diffusione gratuita di opere letterarie in formato elettronico. -

Patrician Lawyers in Quattrocento Venice
_________________________________________________________________________Swansea University E-Theses Servants of the Republic: Patrician lawyers in Quattrocento Venice. Jones, Scott Lee How to cite: _________________________________________________________________________ Jones, Scott Lee (2010) Servants of the Republic: Patrician lawyers in Quattrocento Venice.. thesis, Swansea University. http://cronfa.swan.ac.uk/Record/cronfa42517 Use policy: _________________________________________________________________________ This item is brought to you by Swansea University. Any person downloading material is agreeing to abide by the terms of the repository licence: copies of full text items may be used or reproduced in any format or medium, without prior permission for personal research or study, educational or non-commercial purposes only. The copyright for any work remains with the original author unless otherwise specified. The full-text must not be sold in any format or medium without the formal permission of the copyright holder. Permission for multiple reproductions should be obtained from the original author. Authors are personally responsible for adhering to copyright and publisher restrictions when uploading content to the repository. Please link to the metadata record in the Swansea University repository, Cronfa (link given in the citation reference above.) http://www.swansea.ac.uk/library/researchsupport/ris-support/ Swansea University Prifysgol Abertawe Servants of the Republic: Patrician Lawyers inQuattrocento Venice Scott Lee Jones Submitted to the University of Wales in fulfillment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy 2010 ProQuest Number: 10805266 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a com plete manuscript and there are missing pages, these will be noted. -

00 Prelims 1630
02 Howard 1630 13/11/08 11:01 Page 29 ITALIAN LECTURE Architectural Politics in Renaissance Venice DEBORAH HOWARD St John’s College, Cambridge WHATISTHE ROLE OF ARCHITECTURE in the self-definition of a political regime? To what extent are the ideologies of state communicated in public space? Can public confidence be sustained by extravagant building initiatives—or be sapped by their failures? These issues are, of course,as relevant today as they were in the Renaissance.Venice,in particular,seems closer to our own times than most other Early Modern states because of its relatively ‘democratic’ constitution, at least within the ranks of the rul- ing oligarchy. It was a democracy only for noblemen, since voting rights and eligibility for important committees and councils were limited to members (men only, numbering about 2,000) of a closed, hereditary caste. Nevertheless,many of the problems over decision-making ring true to modern ears.Indeed, it could be argued that the continual revision of public building projects during their execution is an essential characteristic of the democratic process. It has been claimed by architectural historians over the past few decades that ambitious programmes of building patronage in Renaissance Venice helped to communicate political ideals to the public.1 Read at the Academy 10 May 2007. 1 See,for example,Manfredo Tafuri, Jacopo Sansovino (Padua, 1969; 2nd edn., 1972); Deborah Howard, Jacopo Sansovino: Architecture and Patronage in Renaissance Venice (New Haven & London, 1975; rev.edn., 1987); Manfredo Tafuri, ‘“Renovatio urbis Venetiarum”: il problema storiografico’, in M. Tafuri (ed.), ‘Renovatio urbis’: Venezia nell’età di Andrea Gritti (1523–1538) (Rome,1984), pp.9–55; Manfredo Tafuri, Venezia e il Rinascimento (Turin, 1985; English edn., trans.Jessica Levine,Cambridge,MA and London, 1989).