PCC Ugento VIARCH Relazio
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Puglia, Alberobello & Lecce
VBT Itinerary by VBT www.vbt.com Italy: Puglia, Alberobello & Lecce Bike Vacation + Air Package Cycle Puglia the Italian way during our Self-Guided Bicycle Vacation. As you pedal your way past the breathtaking seaside views of Italy’s heel, you’ll have time to linger at waterfront cafés, pause to admire the vistas at sweeping overlooks, and savor every timeless olive grove, swim-worthy seaside cove, ancient watchtower, and dramatic, chalk-white cliff. Your scenic route along the Ionian and Adriatic Seas links stunning historic towns—the island of Gallipoli, seaside Santa Maria di Leuca, and Baroque Lecce. You’ll relax as you spend your restful nights at former palaces, modern hotels, and a historic, restored dry- stone trullo house. Savor Puglia on your own timetable with VBT! 1 / 10 VBT Itinerary by VBT www.vbt.com Cultural Highlights Stay overnight in the dry-stone trulli dwellings of Alberobello, a UNESCO World Heritage site Cycle the Ionian and Adriatic coastlines at your own pace, stopping to explore whatever and whenever you wish Stay in seaside Gallipoli, Santa Maria di Leuca, and Otranto, rich in ancient history and legend Enjoy ample opportunities to swim at sandy beaches and Mediterranean coves tucked under limestone cliffs 2 / 10 VBT Itinerary by VBT www.vbt.com Pedal through timeless villages into the ancient fortified city of Acaya Ride into Lecce, known as the “Florence of the South” for its exuberant Baroque architecture What to Expect This tour offers a combination of easy terrain and moderate hills and is ideal for beginner and experienced cyclists. -

From Capo D'otranto to S. Maria Di Leuca (Apulia, Southern Italy)
l di Paleontologia e Stratigrafia Dicembre 1999 STRATIGRAPHIC ARCHITECTURE OF THE SALENTO COAST FROM CAPO D'OTRANTO TO S. MARIA DI LEUCA (APULIA, SOUTHERN ITALY) ALFONSO BOSELLINI'I, FRANCESCA R. BOSELLINI'i", MARIA LUISA COLALONGO', MARIANO PARENTE"", ANTONIO RUSSo't'r 8. ALESSANDRO VESCOGNI'r'l Receioed Jwne 14, 1999; accepted September 6, 1999 Key words: Southern Italy, Apulia, Tertiary Messinian, coral thrust belts. During the last 60 m.y., the horst carapace was consranr- reefs, carbonate sedimentology. ly near sea level and sediments were mainly accommodated and pre- served on the deep margin and slope of the platform. Riassunto. Lungo la cosra orienrale della Penisola Salentina, da Capo d'Otranto a S.Maria di Leuca, esiste un'architerrura srrarigrafica assai particolare dovuta al fatto che diversi sistemi carbonatici, di età Introduciion. compresa tra il Cretaceo superiore e il Quaternario, sono disposri lar- eralmente e variamente "incascrati" l'uno rispetto all'altro. Così, men- tre al centro della Penisola Salentina, cioè sul carapace della Piattafor- Studies on carbonare platforms normally focus on ma Apula, 1a successione post-creracea è ridotta a poche decine di piatf orm-top archirecrure, defining sequence bound- metrr e suddivisa da importanti inconformità e lacune, sul margine e aries, facies distrib.ution, cycliciry, aggradarion and sullo siope di tale piattaforma molti sistemi carbonatici sono srari progradation geomerries, etc. It is also a common norion preservati, anche con spessori considerevoli. that platforms grow upward, Il nostro studio dimostra anche che alcuni di quesri sisremi car- i.e. aggrade, owing to rela- bonatici sono in realtì degli slope clinostratificati, associati a scogliere tive sea-level rise (tectonic subsidence and eustasy). -

Albo Medici 30.12.2020.Wrm
Albo DEI MEDICI E CHIRURGHI DI MODENA Nr.Iscriz. Cognome Nome Laurea, Data e Università (LD) Libera Docenza Data Iscriz. Comune Residenza Abilitazione, Anno Università, (S) Specialità Prov. data 1°Iscriz. Luogo di Nascita sessione (ES) Elenchi speciali Nr.4159 ABBATI GIANLUCA Medicina e Chirurgia (S) GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOP.DIGEST. del 28/05/1988 MODENA 18/03/1988 - UNIVERSITA' MODENA E (S) MEDICINA INTERNA REGGIO EMILIA BOLOGNA (BO) 1988 - UNIVERSITA' MODENA E REGGIO EMILIA Nr.7062 ABBORETTI FRANCESCO Medicina e Chirurgia del 10/02/2016 MODENA 15/07/2015 - MODENA - REGGIO EMILIA MODENA (MO) 2015 - UNIVERSITA' MODENA E REGGIO EMILIA - II Nr.7405 ABOMO ANGO BERTHE ALINE Medicina e Chirurgia del 17/04/2018 MODENA 13/02/2017 - BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" EBOLOWA (CAMERUN) 2017 - BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - II Nr.7311 ABOU MERHI ANDREA AHMAD Medicina e Chirurgia del 25/02/2018 MIRANDOLA 17/10/2017 - MODENA - REGGIO EMILIA MODENA (MO) 2017 - MODENA E REGGIO EMILIA - II Nr.3697 ABOU MERHI MAHMOUD Medicina e Chirurgia (S) OTORINOLARINGOIATRIA E PAT.CERV.FACCIALE del 15/02/1985 MODENA 20/10/1984 - BOLOGNA "ALMA MATER (S) IDROLOGIA MEDICA STUDIORUM" MAZRAA (LIBANO) 1984 - BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" Nr.4235 ABOU MERHI SAMIR Medicina e Chirurgia (S) ANESTESIA E RIANIMAZ.IND.TER.ANTALGICA del 25/01/1989 MIRANDOLA 22/07/1988 - BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" BEIRUT (LIBANO) 1988 - BOLOGNA "ALMA MATER STUDIORUM" - 2^ Nr.1873 ABOUMOUSSA SAMI Medicina e Chirurgia (S) PEDIATRIA del 11/02/1971 CAMPOGALLIANO 22/07/1970 - BOLOGNA "ALMA MATER -

Avvisi Ai Naviganti ( P E R I O D I C O Q U I N D I C I N a L E )
I.I. 3146 I S T I T U T O I D R O G R A F I C O D E L L A M A R I N A AVVISI AI NAVIGANTI ( P E R I O D I C O Q U I N D I C I N A L E ) 6 Mercoledì 20 marzo 2013 CONTENUTO DEL FASCICOLO ABBREVIAZIONI E SIMBOLI SEZIONE A - Avviso di fonte italiana 1 - Indice degli Avvisi (P) - Avviso preliminare 2 - Comunicazioni e varie (T) - Avviso temporaneo 3 - Annullamento AA.NN. (G) - Avviso generale (R) - Avviso di rettifica A.N. - Avviso ai Naviganti SEZIONE B I.N. - Informazione Nautica 1 - Avvisi per le CARTE 2 - Avvisi per i PORTOLANI NOTE 3 - Avvisi per i RADIOSERVIZI Per il razionale impiego del presente fascicolo consultare la 4 - Avvisi di CARATTERE GENERALE "Premessa agli Avvisi ai Naviganti". 5 - Avvisi per i CATALOGHI Gli Avvisi urgenti vengono radiodiffusi dalle stazioni costiere italiane (vedi Radioservizi, Parte I). 6 - Avvisi per L'ELENCO FARI Gli Avvisi importanti di fonte italiana vengono segnalati direttamente ai principali servizi idrografici del mondo per la SEZIONE C loro rapida diffusione. I rilevamenti sono veri e contati da 000° a 360°; essi sono dati 1 - INFORMAZIONI NAUTICHE dal largo per i limiti dei settori di luce e per le istruzioni di 2 - AVVISI NTM III navigazione; sono dati da punti fissi a terra per la definizione di posizioni. Chiunque trovi inesattezze o lacune negli avvisi del presente fascicolo o possa fornire notizie che interessino la navigazione è pregato di darne sollecita comunicazione a: Istituto Idrografico della Marina – Sezione Avvisi ai Naviganti/Informazioni Nautiche - 16100 Genova - Telefono 0102443281 - Telefax 010261400 - e-mail [email protected] Direttore Responsabile Andrea Liaci Registrazione presso il Tribunale di Genova N. -

Integrated Analysis of Geological and Geophysical Data for the Detection of Underground Man-Made Caves in an Area in Southern Italy
S. Negri, S. Margiotta, T.A.M. Quarta, G. Castiello, M. Fedi, G. Florio – Integrated analysis of geological and geophysical data for the detection of underground man-made caves in an area in southern Italy. Journal of Cave and Karst Studies, v. 77, no. 1, p. 52–62. DOI: 10.4311/2014ES0107 INTEGRATED ANALYSIS OF GEOLOGICAL AND GEOPHYSICAL DATA FOR THE DETECTION OF UNDERGROUND MAN-MADE CAVES IN AN AREA IN SOUTHERN ITALY SERGIO NEGRI1,2*,STEFANO MARGIOTTA1,2,TATIANA ANNA MARIA QUARTA1,GABRIELLA CASTIELLO3, MAURIZIO FEDI3, AND GIOVANNI FLORIO3 Abstract: In Cutrofiano, in the southern part of the Salento Peninsula, Apulia, Italy, a Pleistocene calcarenitic sequence was quarried by digging extensive networks of galleries along the geological succession most suitable for the quarrying activity. These caves represent a potential hazard for the built-up environment due to the occurrence of underground instability that may propagate upward and eventually reach the surface, causing sinkholes. In this work we propose integrated interdisciplinary methods for cavities detection. The methodology was applied at a test area located along a major road near Cutrofiano using geological and electrical-resistivity tomography and microgravity geophysical methods. INTRODUCTION (2013), and Kotyrba and Schmidt (2014). In these more complex cases, we propose the application of integrated Natural and anthropogenic caves represent potential interdisciplinary methods that consist of creating a concep- hazards for the built-up environment because local in- tual hydrostratigraphical model using geological data like stability may propagate upward and eventually cause the quarry plans and boreholes, selection of geophysical formation of sinkholes. The effects at the ground surface methods appropriate to the physical parameters of the may be severe when the caves are at shallow depth. -

1A Colonna = Toponimi Costieri
Carta nautica del Mediterraneo e del Mar Nero, fine sec. XIV Biblioteca Marciana, Ms. It. IV, 1912 (=10057) Trascrizione dei toponimi Cfr.: Piero Falchetta, Manuscript No.10057 in the Biblioteca Marciana, Venice. A possible source for the Catalan Atlas?, in "Imago Mundi. The International Journal for the History of Cartography" (London), n. 46, 1994, pp. 19-28 Legenda V = Pietro Vesconte 1318 D = Angelino Dulcert 1339 AC = Atlante Catalano ca. 1375 A = Carta maghrebina della Biblioteca Ambrosiana, inizio XV secolo FMV = Mappamondo di Fra Mauro toponimi costieri / place names along the coast line isole minori e interni / minor islands and place name in the interior toponimi in rosso / place names in red toponimi con vedute / place names with small views COSTA IBERICA ATLANTICA (Cedeira - Tarifa) - cedera (D: cedera; AAC: cedera) = Cedeira - nevia (D: neuia; AAC: neuia) = Navia - betanca (D: betanzo; AC: betanzo) = Betanzos - crogna (D: crogna; AC: coru.na) = La Coruña - auaricio (D: auaricio; AC: auorcio) - cermes (D: cormes; AC: cormes) - mongia (D: mo[n]gia; AC: mongia) - sea (D: [s]ea; AC: sea) - tourignana (D: torignana; AC: torignana) = Cabo Tourinan - finistera (D: finis tera; AC: finistera) = Cabo Finisterre - muros (D: muros; AC: muras) = Muros - noya (D: noya; AC: noya) = Noya - San Jachom de gallicia (D: Sam Jame de Galicia) = Santiago - corouedro (D: cato vedro; AC: corouedre) - leperrom (D: lopeyron; AC: lopeyrom) = Padrón - punta uedra (D: po[n]ta uedra; AC: puntauedr.) = Pontevedra - redondela (D: redondela; AC: radond...) = Redondela - baona de migno (D: baona de migno; AC: baona de mjnor) = Bayona - mignor (D: mignor; AC: mignor) = Minho - viena (D: viena; AC: viena) = Viana do Castelo - villa de condi (D: villa de co[n]di; AC: villa d. -

Deliverable T2.1.1 Collection of Primary and Secondary Data
“Development of an innovative network for the promotion of extroversion of agro-food companies in Adriatic – Ionian Area” Collection of Primary and Secondary Data This report was prepared for and submitted to the “INNOVAGRO” Project by: “This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the document is the sole responsibility of the Technical University of Crete and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or ADRION Programme authorities”. © Copyright by the “Innovagro” project Collection of Primary and Secondary Data The “INNOVAGRO” partnership consists of: Name Role Country Chania Chamber of Commerce and Industry Lead Partner Greece Region of Crete Partner 2 Greece Technical University of Crete Partner 3 Greece Network of the Insular Chamber of Commerce Partner 4 Greece and Industry of the European Union Province of Potenza Partner 5 Italy E-institute, institute for comprehensive Partner 6 Slovenia development solutions Italian Confederation of Agriculture Partner 7 Italy Union of Chambers of Commerce and Industry of Partner 8 Albania Albania Chamber of Commerce and Industry of Serbia Partner 9 Serbia University of Basilicata Partner 10 Italy History Changes Version Date of Issue Document Title Author(s) Controller Number 1.0 23/7/2019 E. Grigoroudis T. Tsimrikidis ©INNOVAGRO Page 1 Collection of Primary and Secondary Data Table of Contents List of Abbreviations ........................................................................................................ -

Pubblicazioni Scientifiche
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE di Antonio Marsella 1.Teoria e politica dei servizi sociali, Adriatica Editrice Salentina,1988 L’opera appare ispirata dalla prospettiva contrattualistica di JohnRawls, che vede la nozione di società caratterizzata dalla simultanea presenza di identità e differenza cooperazione e conflitto. L’autore se ne interessa perché tematizza la possibilità di una mutua compatibilità e tensione, che è il segno di una società complessa, quale era già quella italiana, come si cominciava ad intravedere da parte degli studiosi più avvertiti e meno ideologicamente segnati. 2. Servizi sociali, teoria e prassi. Dall’analisi del processo sociale alla formazione dell’operatore professionale, Capone editore, 1990. Il testo si basa sull’assunto della necessità di fondare un nuovo legame tra operatori e realtà sociale, tra istituzioni e territorio in un tentativo di circolarità delle conoscenze e delle verifiche. Organizza la materia prendendo in esame i processi di aiuto relativamente alle specificità costituite dagli anziani, dagli handicappati e dai tossicodipendenti. 3. La terza età, come risorsa sociale, Media2000, Melpignano 1992. 4. Il “nuovo” tossicomane tra emarginazione ed integrazione, in “Generazioni”, n. 47, luglio-settembre 1993, Schena editore, Fasano; 5. Guida operativa per le attività di servizio sociale, Pensa Multimedia, Lecce 1994. 6. Educare allo sviluppo psicoaffettivo e sessuale, in “Generazioni”, n. 54-55, aprile-settembre 1995, Schena, Fasano 7. Hans-Georg Gadamer, Dove si nasconde la salute, Cortina editore, Milano 1994, recensione, in “Segni e Comprensione” n. 27, 1996; 8. Cercasi medico dal volto umano, Media2000, Melpignano 1996 . 9. Per una medicina dal volto umano, Amaltea, Castrignano dei Greci,1997 10. Handicap e società: quale integrazione?, in “Galoppando verso l’integrazione”, Atti Convegno di Studi, Gagliano del Capo 16-18 maggio 1997, Istituto Centro di Riabilitazione Padri Trinitari, Gagliano del Capo, 1998; 11. -

(Apulia, Italy) Threatened by Xylella Fastidiosa Subsp. Pauca: a Working Possibility of Restoration
sustainability Perspective The Multi-Millennial Olive Agroecosystem of Salento (Apulia, Italy) Threatened by Xylella Fastidiosa Subsp. Pauca: A Working Possibility of Restoration Marco Scortichini CREA-Council for Agricultural Research and Economics, Research Centre for Olive, Fruit and Citrus Crops, Via di Fioranello 52, I-00134 Roma, Italy; [email protected] Received: 3 July 2020; Accepted: 12 August 2020; Published: 19 August 2020 Abstract: In Salento, the olive agro-ecosystem has lasted more than 4000 years, and represents an invaluable local heritage for landscape, trade, and social traditions. The quarantine bacterium Xylella fastidiosa subsp. pauca was introduced in the area from abroad and has been widely threatening olive groves in the area. The successful eradication of quarantine phytopathogens requires a prompt identification of the causative agent at the new site, a restricted infected area, a highly effective local organization for crop uprooting and biological features of the micro-organism that would guarantee its complete elimination. However, at the time of the first record, these criteria were not met. Interdisciplinary studies showed that a zinc-copper-citric acid biocomplex allowed a consistent reduction of field symptoms and pathogen cell concentration within infected olive trees. In this perspective article, it is briefly described the implementation of control strategies in some olive farms of Salento. The protocol includes spray treatment with the biocomplex during spring and summer, regular pruning of the trees and mowing of soil between February and April to reduce the juvenile of the insect vector(s). Thus far, more than 500 ha have begun to follow this eco-friendly strategy within the “infected” and “containment” areas of Salento. -

Masserie E Dimore Storiche Nel Salento Tour
Masserie e Dimore storiche nel Salento Tour Accomodation: Masseria Chicco Rizzo - Palazzo Castriota. Tenuta Masseria ChiccoRizzo is located in the center of “Grecia Salentina” an area with still a strong presence of an ancient past. The Masseria was born in 1700 as a "post office" for the change of horses linked to the old routes, which connected the Roman Traiana-Calabra roads to Sallentina. Once through the door of the estate, the charm of the past introduces you in an unforgettable experience: the deafening noise of everyday life turns into silence and ... everything regains the right time! Tenuta Masseria ChiccoRizzo (Sternatia) 2 Palazzo Castriota is a historic residence of high value, an ancient palace built between the end of the 1700s and the early 1800s, by Luigi Castriota and his wife, who, in love with rural lifestyle, decided to renew this palace immersed in the Apulian countryside, decorating the large hall with rural life scenes. The property also has a spa suite with chromotherapy ideal for a romantic getaway in total relaxation. Dimora Storica Palazzo Castriota (Alezio) “Home is the place where, when you have to go there, they have to take you in ” (Robert Frost) 3 Tour Proposal: “Salento, history, culture and beautiful landscape” Salento: Sternatìa - Alezio 4 nights/ 5 days (with 1 night extension option) April - October 2020 Experience Legenda: - Nature Active Experience (April - June / September - October) - Local Authentic Experience Culture (April - June / September - October) - Sea lovers (July - August) Day 01. Arrival. Tenuta Masseria ChiccoRizzo (Sternatìa) Pick up from the airport with private car or 9-seater van with driver. -
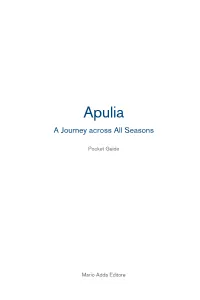
Apulia a Journey Across All Seasons
Apulia A Journey across All Seasons Pocket Guide Mario Adda Editore Regione Puglia AreA Politiche Per lA Promozione del territorio, dei sAPeri e dei tAlenti Servizio Turismo – Corso Sonnino, 177 – cap 70121 Bari Tel. +39 080.5404765 – Fax +39 080.5404721 e-mail: [email protected] www.viaggiareinpuglia.it Text: Stefania Mola Translation: Christina Jenkner Photographs: Nicola Amato and Sergio Leonardi Drawings: Saverio Romito Layout: Vincenzo Valerio ISBN 9788880829362 © Copyright 2011 Mario Adda Editore via Tanzi, 59 - Bari Tel. e fax +39 080 5539502 www.addaeditore.it [email protected] Contents A Journey across All Seasons ....................................................pag. 7 A History ............................................................................................ 9 Buried Treasures ....................................................................................... 11 Taranto’s Treasure ........................................................................ 12 Egnazia ....................................................................................... 12 The Bronzes of Brindisi ............................................................... 13 The Vases of Ruvo ....................................................................... 13 Between Legend and Reality on the Hill of Cannae ....................... 14 Ostuni – Pre-Classical Civilizations ............................................... 14 Caves and Prayers ....................................................................... -

Classifica Soleto
II° SOLETO IN CORSA LOCALITA': SOLETO (Le) ORGANIZZAZIONE: PODISTICA SOLETUM DATA: 10/05/2009 2° prova SALENTO FACE SPORT Gen. Cl.Cat. Cat. Cognome e Nome Società 1 1 MM35 SPAGNOLO GIOVANNI SPORT RUNNING VEGLIE 2 2 MM35 APOLLONIO ALESSANDRO ARATLETICA ARADEO 3 3 MM35 CALIGNANO ANTONIO SPORT RUNNING PORTO SELVAGGIO 4 1 TM CONTE ANDREA ATLETICA SURBO 5 1 MM50 SPANO VINCENZO ATL. GALLIPOLI 6 1 MM40 GRECO ANTONIO PODISTICA GALLIPOLI 7 4 MM35 CAPUTO ANTONIO ATLETICA TRICASE 8 2 MM40 TRAMACERE FABRIZIO SALENTO FREE RUNNER LEVERANO 9 1 MM45 FINO GIOVANNI ATL. CAPO DI LEUCA 10 3 MM40 URSO IPPAZIO POLISPORTIVA TAURISANO 11 4 MM40 STAPANE TIZIANO POD. TUGLIE 12 2 TM LILLO PASQUALE G.S.D. ESERCITO 13 5 MM40 MICCOLI PIERO PODISTICA COPERTINO 14 2 MM45 AGOSTO GIUSEPPE ATLETICA TRICASE 15 6 MM40 MICCOLI DONATO SARACENATLETICA COLLEPASSO 16 7 MM40 BELLO ANTONIO ATL. CAPO DI LEUCA 17 5 MM35 SCHIRINZI LUCIANO ATLETICA TRICASE 18 3 TM DELL'ASSUNTA SAMUELE SPORT RUNNING PORTO SELVAGGIO 19 4 TM GIUSTIZIERO CESARE PODISTICA SOLETUM 20 6 MM35 PALUMBO GIUSEPPE CLUB CORRERE GALATINA 21 3 MM45 CIURLIA ROMEO A13 ALBA TAURISANO 22 5 TM SARCINELLA ALESSANDRO SARACENATLETICA COLLEPASSO 23 7 MM35 RIA GIUSEPPE SARACENATLETICA COLLEPASSO 24 2 MM50 D'AVERSA DAMIANO ATLETICA SALENTINA LECCE 25 8 MM40 COLONA STEFANO POD. UNIONE DEI COMUNI 26 8 MM35 BELLO MARIO ATL. CAPO DI LEUCA 27 4 MM45 SCARLINO GIANCARLO ATL. SALENTO ARADEO 28 9 MM40 MELCHIONNA GIUSEPPE ATL. SALENTO ARADEO 29 3 MM50 VERRI ORONZO ARATLETICA ARADEO 30 9 MM35 DE PASCALI EMILIO POD.