Anales Arqueologia Cordobesa
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
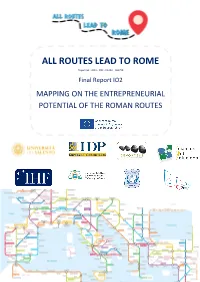
Download IO2 Final Report
ALL ROUTES LEAD TO ROME Project ref.: 2019 - IT02 - KA203 – 062798 Final Report IO2 MAPPING ON THE ENTREPRENEURIAL POTENTIAL OF THE ROMAN ROUTES a a a With the support of the Erasmus+ programme of the European Union. This document and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Content Content..................................................................................................................................... 2 1. Introduction ...................................................................................................................... 6 1.1. Grounding: Secondary Research ................................................................................ 6 1.2. Involvement: Primary Research ................................................................................. 7 2. The Sample ....................................................................................................................... 8 2.1. Descriptives ............................................................................................................... 8 2.2. The Roman Routes Questionnaire ............................................................................ 11 2.3. Results ..................................................................................................................... 12 2.4. Conclusions ............................................................................................................ -

Verona-E-Le-Sue-Strade Primepp.Pdf
A Peter Hudson, che per primo ha tracciato le strade dell’archeo logia urbana a Verona Gli autori Patrizia Basso (Università di Verona) Giovanna Battista (Sabap Vr, Ro, Vi) Raffaella Bortolin (archeo loga professionista) Brunella Bruno (Sabap Vr, Ro, Vi) Giuliana Cavalieri Manasse (già Soprintendenza per i beni archeo logici del Veneto) Claudia Cenci (Sabap Vr, Ro, Vi) Andrea Checchi (archeo logo professionista) Gianni de Zuccato (Sabap Vr, Ro, Vi) Giovanna Falezza (Segretariato regionale del Mibac per il Veneto) Paola Fresco (archeo loga professionista) Federica Gonzato (Polo Museale del Veneto) Valeria Grazioli (Università di Verona) Piergiovanna Grossi (Università di Verona) Saverio Giulio Malatesta (Università “La Sapienza” di Roma) Francesca Meloni (archeo loga professionista) Silvia Nuvolari (archeo loga professionista) Rita Paris (già Parco Archeologico dell’Appia Antica) Giulia Pelucchini (Sabap per la città dell’Aquila e i comuni del Cratere) Francesca Veronese (Musei Civici di Padova) Coordinamento redazionale: Claudia Cenci Crediti per le immagini Segreteria amministrativa: Rosanna Dorizzi, Provvidenza Figg. 1 p. 82; 1 p. 105; 1 p. 116; 13 p. 123; 12 p. 139: elabora- Occhipinti, Florindo Romano, Manuela Trevisani zioni su foto aeree REALVISTA 1.0 (http://www.realvista. it/), di e-geos spa (licenzaCC-BY-SA4.0 Internazionale) Fig. 1 pp. 18-19; 1 p. 36; 2 p. 37: elaborazioni su car- isbn 978-88-8314-976-4 tografia OpenStreetMap (www.openstreetmap.org) (©OpenStreetMapcontributors) Figg. 4 e 5 p. 22: elaborazioni fax simile WikimediaCom- © 2019 Cierre edizioni mons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tabula_ via Ciro Ferrari 5 Peutingeriana-nc.tif ). 37066 Sommacampagna (VR) Fig. 3 p. -

LE VIE TRANSALPINE (Completo)
LE VIE TRANSALPINE (completo) …”Alpes e regione ea quae proxima est Hadriano mari ad Tuscum pacificavi nulli bello per iniuriam inlato”… (Res gestae Divi Augusti, XXVI, III) Introduzione: Le Alpi sono costituite da un corrugamento della superficie terrestre a forma di semicerchio che a partire dal Colle di Cadibona, a ridosso del Mar Ligure, corre verso ovest quindi si incurva verso nord e poi verso est fino ad attenuarsi con i Carpazi e le Alpi Dinariche nelle pianure orientali dell'Europa e nei Balcani. Questo grande corrugamento è caratterizzato da serie di valli trasversali, coronate da picchi rocciosi di notevole altezza, le comunicazioni dalla penisola italiana verso l'Europa, in qualsiasi direzione esse siano rivolte, devono negoziare queste creste rocciose. Il punto più stretto della catena alpina, verso il nord ovest della Pianura Padana, è il punto più facile da traversare e il più prossimo il linea d'aria al Mare del Nord, per questo motivi è qui che esistono i passi stradali più antichi della catena alpina: il passo dell'Alpis Graia (o Piccolo San Bernardo) e quello dell'Alpis Poenina (o Gran San Bernardo). Quelle che sono ovvie conclusioni risultanti da semplici osservazioni di carte geografiche, vengono ora confermate da recenti ricerche e studi di materiali archeologici effettuati nella Francia occidentale, nella valle del Rodano della Svizzera e nella Valle d'Aosta. Regolari comunicazioni attraverso questo settore della barriera alpina sembrano attestate almeno fin dal III millennio. Addirittura si parla di "una remota via di colonizzazione e di trasmissione di elementi culturali ed economici" (R.Mollo Mezzena, 1991). -

Garda.142 Sq Mi of Nature, Food, History, and Culture Published on Iitaly.Org (
Garda.142 sq mi of Nature, Food, History, and Culture Published on iItaly.org (http://www.iitaly.org) Garda.142 sq mi of Nature, Food, History, and Culture Goffredo Palmerini (May 18, 2019) Spanning 142 square miles, Garda—the largest lake in Italy—is a massive triangle of water measuring 32 miles long, from its northern tip at the spur of the Alps to its southern base in the Veneto region. Our journey will touch places of stunning beauty and deep history, where locals and tourists alike know how to enjoy nature, gorgeous food and incomparable wines. Heading down the “Serenissima” Highway out of Verona in the direction of Milan, we hardly expect to find a trove of wonders in under twenty minutes. Yet there is the sign for Peschiera del Garda [2], signaling how close we are to the largest lake in Italy. A couple minutes later, we pass the lake’s main outlet, Mincio, which skirts Mantua before reaching the confluence of the Po and flowing gently into the delta. The natural world suddenly looks lusher. Surrounded by an enormous body of water, the area enjoys mild temperatures that allow for the active cultivation of grapes and olives, as well as cedar, orange and lemon trees—trees otherwise nonexistent at such latitudes. Spanning 142 square miles, Garda is a massive triangle of water measuring 32 miles long, from its northern tip at the spur of the Alps—Adamello and Brenta—to its southern base, where we began our journey. The 346-meter-deep lake was formed during the Quaternary Period, when retreating ice sheets Page 1 of 4 Garda.142 sq mi of Nature, Food, History, and Culture Published on iItaly.org (http://www.iitaly.org) deposited large rocks to create the incomparable beauty of its western coast. -

Sighisoara Vs. Verona
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Dragulanescu, Irina-Virginia; Stanciulescu, Gabriela Cecilia; Andrei, Ion; Stan, Timea-Anca Article European Cultural and Touristic Heritage: Sighisoara vs. Verona Amfiteatru Economic Journal Provided in Cooperation with: The Bucharest University of Economic Studies Suggested Citation: Dragulanescu, Irina-Virginia; Stanciulescu, Gabriela Cecilia; Andrei, Ion; Stan, Timea-Anca (2014) : European Cultural and Touristic Heritage: Sighisoara vs. Verona, Amfiteatru Economic Journal, ISSN 2247-9104, The Bucharest University of Economic Studies, Bucharest, Vol. 16, Iss. Special No. 8, pp. 1160-1177 This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/168884 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. may exercise further usage rights as specified in the indicated licence. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ www.econstor.eu European cultural and touristic heritage: AE Sighișoara vs. -

26 Maggio 2017
Soprintendenza Archeologia, 26 maggio 2017 Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Soprintendenza Archeologia, Belle Vicenza Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza Sala Gazzola, Chiostro San Fermo, piazza San Fermo 3a, Verona CURA SCIENTIFICA Dipartimento Culture e Civiltà, Brunella Bruno (SABAP VR-RO-VI), Università degli studi di Patrizia Basso (Dip. CuCi UniVR) Verona SEGRETERIA E CONTATTI Claudia Cenci (SABAP VR-RO-VI) c [email protected] Piergiovanna Grossi (Dip. CuCi UniVR) [email protected] Comuni della Valpolicella SITO WEB Dolcè https://initinere2017.wordpress.com/ IN ITINERE. VERONA E LE Fumane SUE STRADE: LE Marano di Valpolicella NUOVE SCOPERTE SI RINGRAZIANO Negrar Pescantina San Pietro in Cariano Giornata di studi Sant'Ambrogio di Valpolicella Sant'Anna di Alfaedo 26 maggio 2017 Programma Gianni de Zuccato (SABAP VR-RO-VI), Raffaella Bortolin (archeologa, libera Andrea Checchi (archeologo, Multiart) professionista) Valorizzazione della Una strada da Grezzana: dati recenti strada (via Claudia Augusta?) di Brentino Belluno 9.30 INIZIO LAVORI PAUSA CAFFE' Davide Comunale (Università di Roma ”Tor Vergata”) Magna Via Francigena di Sicilia: dai codici diplomatici al progetto Saluti Strade nell’agro di sviluppo del territorio Fabrizio Magani, Soprintendente Patrizia Basso, Valeria Grazioli, Marcella Giovanna Battista (SABAP VR-RO-VI) I Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per Pavoni, Marina Scalzeri, Elisa Zentilini Tratturi, le Vie Verdi. Tutela e le province di Verona, -

The Postumia Road Classe 3 CL Liceo “G
The Postumia Road classe 3 CL Liceo “G. Fracastoro” Verona LENGTH AND STAGES The Via Postumia is a Roman consular road, built in 148 BC by the Roman consul Postumius Albinus in the territories of today's Po Valley, mainly for military purposes. Not very well known, but undoubtedly beautiful, the Via Postumia is a route of more than 900 km through northern Italy and its beautiful cities of art, from Aquileia to Genova. The Via Postumia under Corso Cavour in Verona LONGITUD Y ETAPAS La Vía Postumia es una vía consular romana, construida en el año 148 a.C., por el cónsul romano Postumius Albinus en los territorios del actual valle del Po, principalmente con fines militares. No muy conocida, pero sin duda hermosa, la Vía Postumia es una ruta de más de 900 km a través del norte de Italia y sus hermosas ciudades de arte, desde Aquileia hasta Génova. La Vía Postumia bajo Corso Cavour en Verona LONGUEUR ET ÉTAPES La Via Postumia est une route consulaire romaine, construite en 148 avant JC par le consul romain Postumius Albinus dans les territoires de la vallée actuelle du Pô, principalement à des fins militaires. Peu connue, mais sans doute très belle, la Via Postumia est un itinéraire de plus de 900 km à travers l’Italie du Nord et ses belles villes d’art, d’Aquilée à Gênes. La Via Postumia sous Corso Cavour à Vérone The route covers 40 stops, which can be divided into three main sections: From Aquileia to Vicenza: 330 km in 12 stops On this stretch of road, plains are the absolute protagonists of the first section of the Via Postumia. -

RA Sonav2 CC .Pdf
2 INDICE 1. PREMESSA ................................................................................................................................................. 7 2. VERIFICA E AGGIORNAMENTO DEL QUADRO AMBIENTALE - ANALISI E DEFINIZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI ........................................................................................................... 8 2.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE ............................................................................................................ 8 2.2 MATRICE ARIA ......................................................................................................................................11 2.2.1 Qualità dell’aria ..............................................................................................................................18 2.2.2 Emissioni comunali..........................................................................................................................27 2.3 MATRICE CLIMA ....................................................................................................................................32 2.3.1 Temperatura ....................................................................................................................................34 2.3.2 Precipitazioni ..................................................................................................................................36 2.3.3 Direzione e velocità dei venti...........................................................................................................38 -

Verso Santiago Sulla Via Postumia
1 PAESI LUNGO LA VIA POSTUMIA – REGIONE FIULI VERSO SANTIAGO SULLA Aquileia – Terzo d’ Aquileia – Cervignano del Friuli (FS) – Strassoldo – Aiello del Friuli – Palmanova - VIA POSTUMIA Bagnara Arsa – Porpetto – San Giorgio di Nogaro (FS) – Carlino (10 Km senza paesi) – Palazzolo dello Oltre 900 km da Aquileia a Genova Stella (FS) – Precenicco – Gorgo – Latisana (FS). di Andrea Vitiello ideatore del progetto PAESI LUNGO LA VIA POSTUMIA – REGIONE Questa guida nasce per dare le informazioni VENETO necessarie a percorrere a piedi e in bicicletta il San Michele al Tagliamento – Giussago – “Cammino Via Postumia”, attraversando il Nord Concordia Sagittaria – San Stino di Livenza (FS) – Italia da Est (Aquileia) a Ovest (Genova). Il Lorenzaga – Motta di Livenza – Gorgo al cammino ha una lunghezza pari a 932 Km circa e si Monticano – Fratta di Oderzo – Oderzo (FS) – snoda lungo 6 regioni (Friuli Venezia Giulia – Rustignè – Levada di Ponte di Piave – Ponte di Veneto – Lombardia - Emilia Romagna – Piemonte Piave – Viganovo – Salgareda – Romanziol – - Liguria). Ricordiamo sempre per coloro che Noventa di Piave – Fossalta di Piave – Croce – vorranno camminare sulla Via Postumia che è Musile di Piave – Caposile – Portegrandi – Quarto completamente tracciata da Aquileia a Genova d’Altino – Casale sul Sile – Lughignano – Casier – talvolta con frecce gialle, adesivi, paletti in legno, Treviso (FS) – Quinto di Treviso – Santa Cristina frecce in plastica. Percorribile anche a piccole (Oasi di Cervara) – Badoere – San Marco di Resana porzioni, ecco alcuni -

Sirmione Testo Ingl
SPAS: TOTAL WELLNESS IN THE ITALIAN TRADITION SIRMIONE SPA C u l t u re, wellness and relaxation come together in the breathtaking natural scenery of S i r m i o n e, a triangular peninsula stretching out into Lake Gard a i r mione is a tourist thermal centre situated along the southern coast of Lake Garda, on the elegant penin- sula with the same name, separating the gulfs of Desenzano and Peschiera. It is triangular in shape with Sthree hills: Cortine, San Pietro in Mavinas and Grotte di Catullo. More than a century ago, when it wa s still a small fishing village, Sirmione discovered its vocation for tourism as well as for the exploitation of the t h e r mal waters of the Boiola spring. Important for its development, the natural beauty of the land and the mild climate combined with its historic evidences: this richness has supported the local entrepreneurs and has tur- ned Sirmione into a leading holiday resort. To d ay, high quality accommodation is provided for 8000 people, in addition to restaurants, shops, sports and bathing equipment. The name of the town is also linked to the soprano Maria Callas, who spent about 10 years here. To her has been dedicated the old Town Hall (now a cen- tre for exhibitions and other events) and a ye a r ly interesting celebration of classic music and opera. The wa t e r qualities, the clean beaches and the ex c l u s ive hospitality have granted Sirmione the Bandiera Blu, continuou- s ly since the year 2000, also thanks to the environmental politics of the Commune in support of tourism. -

River Navigation from the Adige to the Po in Shakespeare's Italy
Catching the Flood: River Navigation from the Adige to the Po in Shakespeare’s Italy by Catherine Hatinguais Lance, away, away! Aboard! Thy master is shipped, and thou art to post after with oars. What’s the matter? Why weep’st thou, man? Away, ass, you’ll lose the tide, if you tarry any longer. (…) Tut, man, I mean thou’lt lose the flood, and, in losing the flood, lose thy voyage, and, in losing thy voyage, lose thy master, and, in losing thy master, lose thy service, and, in losing thy service— The Two Gentlemen of Verona (II.3.31–34, 39–42) antino’s outburst in Act II scene 3 of The Two Gentlemen of Verona, where he scolds Lance for missing the boat taking Proteus from Verona to Milan, has often been cited by Stratfordian commentators, P 1 from Sidney Lee in 1907 to Andrew Dickson in 2016 as a “geographical howler” (Dickson’s words), evidence of Shakespeare’s ignorance of Italy. Both cities are landlocked and it is therefore ludicrous to have characters in the play sailing from one to the other—and there are no tides in Verona! When confronted with the conclusions of other researchers,2 who have shown that Shakespeare must have known the country first-hand and been aware of the prevalence of river navigation in Northern Italy, orthodox com- mentators change tack and dismiss those findings as irrelevant and superflu- THE OXFORDIAN Volume 21 2019 95 Catching the Flood: River Navigation from the Adige to the Po ous since Shakespeare’s Italy is purely imaginary anyway, a setting adopted for “mere creative convenience” (Dickson). -

Giovanni U Ggeri LA NA VIGAZIONE INTERN a DELLA CISALPINA in ETA ROMANA I Precedenti Un Vago Ricordo Di Navigazioni Rnterne Attr
Giovanni Uggeri LA NAVIGAZIONE INTERNA DELLA CISALPINA IN ETA ROMANA I precedenti Un vago ricordo di navigazioni rnterne attraverso le grandi pianure continentali affiora talora nella tradizione antica, suggestio nata soprattutto dal mito degli Argonauti. Apollonio Rodio aveva fatto di Giasone l'esploratore per eccellenza delle vie fluviali del l'Europa; partendo dal mar Nero, l'eroe avrebbe risalito il Danu bio, ridiscendendone il mitico corso istriano fino all'Adriatico; avrebbe quindi risalito il corso dell'Eridano, attraversando le Alpi e ridiscendendo al Mediterraneo attraverso il Rodano (1). Dall'eta mitica affiora anche il ricordo di opere artificiali di ca nalizzazione, intraprese per facilitate queste navigazioni interne op pure a semplice scopo di bonifica. In questa sfera mitica rientra il canale navigabile tracciato attraverso i laghi costieri e il piatto Ta voliere della Daunia alle spalle del Gargano da Diomede (2), il miti co esploratore dell'Adriatico, che - procedendo a ritroso rispetto a Giasone - si era spinto fino al porto alle foci del Timavo, dov'e attestato il suo culto (3). Cogliamo in queste narrazioni l'eco delle esplorazioni, dei commerci e forse di una forma di precolonizzazio ne di eta micenea fino alle foci del mitico Eridano, dove ci si anda- (1) AP. RHOD. IV 627-28. E. DELAGE, La Geographie dans Jes Argonautiques d' A pollonios de Rhodes, Bordeaux 1930, p. 195 sgg.; J. BERARD, La Colonisation grecqtte, Paris 1957, pp. 387-89; H. FRANKEL, Noten zu den Argona11tika des Apollonios, Miin chen 1968; E. LrvREA, Apollonii Rhodii Argonauticon liber quartus, Firenze 1973, p. 180 sg.; L. BRACCESI, Grecitd adriatica2, Bologna 1977, pp.