Volume 1 Parte 1
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

23 Gennaio 1998
PRESIDENTE: Buongiorno, vediamo i presenti. Bagarella? IMPUTATO Bagarella: (voce fuori microfono) Presente. PRESIDENTE: Avvocato Ceolan, avvocato Cianferoni; è presente l’avvocato Ceolan. Barranca Giuseppe. AVV. Cianferoni: (voce fuori microfono) Sì, Presidente, è presente anche l’avvocato Cianferoni. PRESIDENTE: Ah, c’è anche lei, grazie. SEGR. D’UDIENZA: (voce fuori microfono) Rinunciante. PRESIDENTE: Avvocato Barone e avvocato Cianferoni, che è presente. Benigno Salvatore. SEGR. D’UDIENZA: (voce fuori microfono) Rinunciante. PRESIDENTE: Rinunciante. Avvocato Farina e avvocato Maffei, è sostituito dall’avvocato Ceolan. Brusca Giovanni: ora entrerà. Avvocato Li Gotti e avvocato Falciani. E’ presente l’avvocato Li Gotti. Calabrò Gioacchino. IMPUTATO Calabrò: (voce fuori microfono) Presente. PRESIDENTE: Avvocato Gandolfi, Fiorentini e Cianferoni, che è presente. Cannella Cristoforo. SEGR. D’UDIENZA: (voce fuori microfono) E’ rinunciante. PRESIDENTE: Avvocato Di Peri e avvocato Rocchi, sostituito dall’avvocato Cianferoni. Carra Pietro: libero, assente. Avvocato Cosmai e avvocato Batacchi… E’ presente l’avvocato… AVVOCATO Falciani: Falciani, Presidente.. PRESIDENTE: …Falciani in sostituzione. Di Natale Emanuele: contumace. Avvocato Gentile, Di Russo, Falciani, che è presente. Ferro Giuseppe: rinunciante. Avvocato Miniati Paoli, sostituito dall’avvocato Falciani. Ferro Vincenzo: libero, assente. Avvocato Traversi e avvocato Gennai… AVVOCATO Traversi: E’ presente PRESIDENTE: E’ presente l’avvocato Traversi. Frabetti Aldo. IMPUTATO Frabetti: (voce fuori microfono) Presente. PRESIDENTE: Avvocato Monaco, Usai, Roggero, sostituiti dall’avvocato Pepi. Giacalone Luigi. SEGR. D’UDIENZA: (voce fuori microfono) Rinunciante. PRESIDENTE: Avvocato Priola, avvocato Florio, sostituito dall’avvocato Pepi. Giuliano Francesco. IMPUTATO Giuliano: (voce fuori microfono) Presente. PRESIDENTE: Avvocato Farina e avvocato Pepi, che è presente. Graviano Filippo: rinunciante. Avvocato Oddo, avvocato Gramigni, sostituito dall’avvocato Cianferoni. -

Mafia Carini Capaci Isola Delle Femmine E Dintorni
Mafia Carini Capaci Isola delle Femmine e dintorni Comuni sciolti per mafia 25 09 09 Uploaded by isolapulita . - News videos from around the world. Figura 1 Cipriano Santo Inzerillo Gianni SIINO dichiara: DI MAGGIO Salvatore Emanuele Io l’ho conosciuto all’interno della fattoria di Bellolampo intorno alla fine degli anni ’70. I DI MAGGIO hanno avuto varie vicissitudini in negativo all’interno dell’organizzazione mafiosa, perché messi da parte. L’ho rivisto insieme ad un DI MAGGIO detto “u’ figghiu da za’ lena” che mi venne indicato come capo della famiglia di Torretta. I due vennero a raccomandare un imprenditore di Torretta al quale ho fatto aggiudicare, perché loro me lo avevano chiesto, la scuola media di Isola delle Femmine. (Ordinanza di Custodia cautelare Operazione Oldbridge N. 11059/06 R. mod. 21 D.D.A.) Copacabana Di Trapani Isola delle Femmine ............. 1 Copacabana Di Trapani Isola delle Femmine ............. …… Ed è un dato ormai processualmente acquisito che, fino a quando il suo capo indiscusso, Gaetano BADALAMENTI, non fu espulso da Cosa Nostra, la famiglia di Cinisi costituiva uno dei più importanti mandamenti della provincia di Palermo, ricomprendendo, oltre al circondario di Cinisi e Terrasini , anche i territori di Balestrate, Carini, Capaci e Isola delle Femmine (cfr. BUSCETTA, MARINO MANNOIA e MUTOLO, nonché DI MATTEO Mario Santo). Successivamente, il mandamento venne sciolto e la famiglia aggregata al mandamento di Partinico, mentre i territori che ne avevano fatto parte furono divisi tra lo stesso mandamento di Partinico e (dopo il 1982) il neo- mandamento di San Lorenzo , dopo la ristrutturazione seguita alla conclusione della sanguinosa guerra di mafia dei primi anni ’80. -
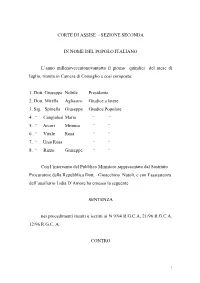
Processo Lima
CORTE DI ASSISE - SEZIONE SECONDA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L’anno millenovecentonovantotto il giorno quindici del mese di luglio, riunita in Camera di Consiglio e così composta: 1. Dott. Giuseppe Nobile Presidente 2. Dott. Mirella Agliastro Giudice a latere 3. Sig. Spinella Giuseppe Giudice Popolare 4. “ Cangialosi Maria “ “ 5. “ Arceri Mimma “ “ 6. “ Vitale Rosa “ “ 7. “ Urso Rosa “ “ 8. “ Rizzo Giuseppe “ “ Con l’intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Gioacchino Natoli, e con l’assisstenza dell’ausiliario Lidia D’Amore ha emesso la seguente SENTENZA nei procedimenti riuniti e iscritti ai N 9/94 R.G.C.A, 21/96 R.G.C.A. 12/96 R.G.C. A. CONTRO 1 1) RIINA Salvatore n. Corleone il 16.11.1930 Arrestato il 18.01.1993 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO- Detenuto per altro - Assente per rinunzia Assistito e difeso Avv. Cristoforo Fileccia Avv. Mario Grillo 2) MADONIA Francesco n. Palermo il 31.03.1924 Arrestato il 21.04.1995 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Giovanni Anania Avv. Nicolò Amato del foro di Roma 3) BRUSCA Bernardo n. San Giuseppe Jato il 09.09.1929 Arrestato il 21.10.1992 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Ernesto D’Angelo 4) BRUSCA Giovanni n. San Giuseppe Jato il 20.02.1957 Arrestato il 23.05.1996 - Scarcerato il 10.04.1998 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Luigi Li Gotti del foro di Roma Avv. -

Privatizzazioni, Si Comincia Con Le Poste
Non dobbiamo consentire che gli ucraini facciano guerra agli ucraini. È una terribile assurdità. Ma la situazione sembra aver preso una piega tale che senza un aiuto potrebbe esserci una catastrofe. Gorbaciov lettera a Putin e Obama 1,30 Anno 91 n. 22 Venerdì 24 Gennaio 2014 Giovanni Moro Se l’ufficio diventa Calatrava e il ritorno conquista dell’attivismo un luogo di poesia il Vaticano U: Almagisti Zanon pag. 18 Francini pag. 17 Barilli pag. 20 Letta: ora conflitto d’interessi ● Il premier: vado avanti e nel patto di governo ci sarà la norma ● «Legge elettorale, i cittadini devono poter scegliere» ● Renzi: sì a modifiche con il consenso di tutti. «Se la riforma salta finisce la legislatura» «Sono deciso ad andare avanti». Enri- co Letta anticipa i contenuti del piano L’INTERVISTA del governo, che comprenderà il con- flitto d’interessi. Sull’Italicum esprime dubbi sulle liste bloccate. Renzi apre a Epifani: subito modifiche, ma solo se condivise, «se no salta tutto». Anche la legislatura. ANDRIOLO FRULLETTI A PAG. 2-3 un vero rilancio Se si batte del governo il tempo insieme MASSIMO ADINOLFI MA IL GOVERNO: CHE FINE FA? L’ac- ● cordo raggiunto da Renzi con Ber- lusconi sulla legge elettorale non risol- ve il problema, ma anzi lo pone. E non si tratta di alimentare nuovamente so- spetti sulle reali intenzioni di Renzi. Il segretario ha tagliato corto: mi accusa- vate di voler far cadere il governo per andare subito alle elezioni, e magari «Serve un’azione di governo forte a avrei pure avuto il mio tornaconto, e partire del lavoro», dice Epifani. -

Senato Della Repubblica Camera Dei Deputati – 609 – Seppure Richiesto
Senato della Repubblica– 609 – Camera dei deputati XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI seppure richiesto, non aveva dato alcuna spiegazione al riguardo «No, per- che`, uno non si puo` vestire cosı`? ...Oggi mi andava di vestirmi cosı` emi sono vestito cosı`»; che egli aveva, invece, intuito che proprio quel giorno si era svolto l’incontro, anche se Di Maggio aveva ritenuto di non dirgli alcunche´. Anche con riferimento al contenuto di tale, secondo colloquio, do- veva sottolinearsi un primo dato che confliggeva insanabilmente con la tesi principale della accusa: posto che il PM sosteneva che l’incontro era avvenuto quasi certamente il 20 settembre 1987 – una domenica – in occasione della presenza del senatore Andreotti a Palermo per la Festa dell’Amicizia della D.C., Brusca aveva invece riferito di avere sentito il proprio fratello parlare del casuale incontro con Di Maggio «vestito da ce- rimonia» in un giorno lavorativo». Una ulteriore, rilevante divergenza tra le dichiarazioni del Brusca al PM e la versione dibattimentale concerneva l’atteggiamento assunto dal Di Maggio in occasione del casuale incontro con Emanuele Brusca. Al PM, infatti, Enzo Salvatore Brusca aveva riferito di avere sentito dal fratello Emanuele che Di Maggio, alla richiesta dei motivi per i quali era vestito elegantemente, aveva replicato dicendo che gli avevano detto di «mettersi il vestito» e di «andare a Palermo» («Dici unni stai ennu, nientri mi rissiru i mittirimi u vistitu (inc.), di vistirimi elegante e ghiri in Palermo, non so dove»). Al dibattimento, per contro, Brusca aveva mutato versione affer- mando di aver sentito che Di Maggio, in quell’occasione, aveva eluso la domanda del fratello Emanuele, affermando che non vi era una ragione particolare. -
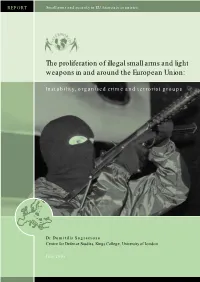
The Proliferation of Illegal Small Arms and Light Weapons in and Around the European Union
REPORT Small arms and security in EU Associate countries The proliferation of illegal small arms and light weapons in and around the European Union: Instability, organised crime and terrorist groups Dr Domitilla Sagramoso Centre for Defence Studies, Kings College, University of London July 2001 The proliferation of illegal small arms and light weapons in and around the European Union: Instability, organised crime and terrorist groups Dr Domitilla Sagramoso Centre for Defence Studies, Kings College, University of London SAFERWORLD · CENTRE FOR DEFENCE STUDIES JUNE 2001 Contents Acknowledgements 4 1. Introduction 5 2. Main findings 6 3. Recommendations 8 4. Methodology and sources 9 5. SALW in the European Union: country studies 12 United Kingdom The Netherlands Germany Italy Italian organised crime 6. SALW in EU Candidate Countries: country studies 27 Czech Republic Bulgaria 7. SALW among terrorist groups in Europe 32 Separatist movements Northern Ireland The Basque Country Corsica Right- and left-wing terrorism 8. Assessment of external sources of illegal 45 SALW in the European Union 9. Conclusions 48 Acknowledgements This report is being published as part of Saferworld’s small arms project in Central and Eastern Europe. Saferworld is grateful to the Department for International Development (DFID), UK for funding this project. Author’s acknowledgements The research was undertaken and written up by Dr Domitilla Sagramoso as part of the Centre for Defence Studies’ small arms and light weapons project funded by the Ploughshares Fund and Dulverton Trust, and conducted under the direction of Dr Chris Smith, Senior Research Fellow at the Centre for Defence Studies. The author would like to thank all those officials and journalists who helped during her various interviews in the UK, Germany, Italy, Holland, Spain, Bulgaria and the Czech Republic. -

La Commissione Regionale
LA COMMISSIONE REGIONALE Alla stregua delle convergenti dichiarazioni dei collaboranti analizzate diffusamente dai primi giudici, è emerso un quadro probatorio che ha consentito di tratteggiare l’evoluzione storica della Commissione regionale, istituita nel lontano 1975, dopo la crisi degli anni ’60 che aveva posto in rilievo l’esigenza di un effettivo coordinamento delle iniziative delle varie famiglie di Cosa Nostra. Su tale tema – per come già evidenziato nel libro I – in via di estrema sintesi deve convenirsi con i primi giudici che l’esigenza di un organismo di vertice, in linea con la struttura piramidale di Cosa Nostra, era stata avvertita non solo all’interno della provincia di Palermo, dove erano stati costituiti dapprima un triunvirato (nell’attesa che si completasse la ricostituzione di tutte le famiglie nei territori delle province, e poi la nuova Commissione provinciale), ma anche da parte delle altre province della Sicilia in cui esistevano analoghe strutture di Cosa Nostra che avevano anch’esse risentito dell’efficace azione repressiva dell’apparato statale nei primi anni successivi alle eclatanti attività criminali poste in essere dalla cosca di Michele Cavataio e dei suoi alleati. Le coerenti, puntuali e convergenti dichiarazioni rese da Buscetta e Calderone, la cui attendibilità in materia era stata accertata nell’ambito del primo maxiprocesso di Palermo, avevano trovato conferma anche in quelle rese da Di Carlo, il cui apporto probatorio costituisce un valido ulteriore riscontro alle predette propalazioni e la cui autonomia appare evidente, attesa la novità delle circostanze che in questo quadro unitario il dichiarante era stato in grado di inserire in modo armo- nico; novità che si giustificano con il fatto che provenivano da affiliato che, a differenza dei primi due, aveva a lungo operato a fianco del Riina e quindi nell’ambito dello schieramento corleonese, del quale il Buscetta ed il Calderone erano, invece, avversari. -

1 Dipartimento Di Scienze Politiche Cattedra Storia Dei Partiti E Dei
1 Dipartimento di Scienze Politiche Cattedra Storia dei partiti e dei movimenti politici Salvatore Riina: vita criminale e organizzazione mafiosa RELATORE Prof. Andrea Ungari CANDIDATO Priscilla Roscioli Matr. 073562 ANNO ACCADEMICO 2015-2016 2 SOMMARIO Introduzione ......................................................................................................................................... 3 Cosa si intende per il termine “Mafia”? ............................................................................................... 5 ANALISI BIOGRAFICA .................................................................................................................... 8 Infanzia ................................................................................................................................................ 8 Adolescenza: i primi reati .................................................................................................................... 9 Guerra tra Corleonesi ....................................................................................................................... 10 Verso Palermo ................................................................................................................................... 11 Struttura e organizzazione di Cosa Nostra ................................................................................................. 12 Il “sacco di Palermo” ................................................................................................................................ -

Il Pentito Di Maggio Ordinava Omicidi Arrestato L'uomo Che Fece Prendere
15INT01A1510 ZALLCALL 11 22:31:29 10/14/97 LE CRONACHE l’Unità 13 Mercoledì 15 ottobre 1997 A ordinarne la cattura sono stati gli stessi pm palermitani. Lo hanno scoperto grazie a un nuovo collaboratore Non voleva trasferimento La protesta 15INT01AF03 Il pentito Di Maggio ordinava omicidi 1.0 di Pulvirenti 7.0 Arrestato l’uomo che fece prendere Riina che ingoia Caselli: «Ma rimane un teste credibile, ha fatto ammissioni piene» una lametta Dalla Prima PALERMO. Prima Ferone, poi Avo- CATANIA. Ha ingoiato una lamet- la e Samperi e poi, ancora, Totuc- taperprotestarecontrountrasferi- cio Contorno. Adesso tocca a lui, mento «a rischio» che lo avrebbe a Baldassare Di Maggio, il pentito che ha fatto finire in carcere dopo riportato a Catania. Giuseppe Pul- 23 anni di serena latitanza Salva- virenti, «u malpassotu», boss pen- tore Riina, il capo dei capi, l’uomo tito ieri mattina ha improvvisato Procura di Palermo, non chiude- al quale aveva giurato fedeltà per la protesta, davanti agli agenti che re neanche un solo occhio di fron- la vita, in quella campagna di San lo avrebbero dovutoaccompagna- te ai comportamenti criminali di Giusepe Jato, dove lo avevano condotto per la «pungitina» dopo re, anche con la forza, per deporre uno dei testimoni più significativi in un processo che si sta celebrano del cosiddetto «processo del seco- il suo primo omicidio. Un pentito lo». Intendiamoci. L’arresto di un che per Cosa nostra è stato come a Catania e che vede alla sbarra pentito non è una novità. Non ab- un terremoto. Balsassare Di Mag- suoi affiliati accusati di associazio- biamo dimenticato Salvatore «To- gio da martedì notte è in una cella ne mafiosa e delitti avvenuti negli dell’Ucciardone perchè, secondo i tuccio» Contorno che spacciava magistrati di Palermo, avrebbe ri- anni scorsi a Catania. -

Repubblica Italiana Tribunale Di Palermo Corte Di Assise Sezione Prima
Proc. n. 18/96 R.G.C.Assise N. 22/01 Sent. REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI PALERMO CORTE DI ASSISE SEZIONE PRIMA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L’anno duemilauno, il giorno sedici del mese di novembre, la Corte di Assise così composta: 1. Dott. Claudio Dall’Acqua Presidente 2. Dott. Roberto Binenti Giudice a latere 3. Sig. Maria Rosa Piraino Giudice Popolare 4. “ Elisabetta Liparoto “ “ 5. “ Giuseppe Bondì “ “ 6. “ Rosario Salvatore Priolo “ “ 7. “ Maria Pollina “ “ 8. “ Maria Di Blasi “ “ con l’intervento del Pubblico Ministero rappresentato dai Sostituti Procuratori della Repubblica Dott.ssa Marzia Sabella e Dott. Egidio La Neve e con l’assistenza della Dott.ssa Anna Maria Giunta, ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento penale CONTRO 1. ADELFIO Francesco nato Palermo il 24.03.1941 Arrestato il 26.04.95 - Scarcerato il 12.04.99 (O.C.C. 1427/95) Assistito e difeso di fiducia da: Avv. C. Fileccia Avv. D. La Blasca Libero – residente in Palermo Via Starrabba n. 19 Assente 2. AGLIERI Pietro nato a Palermo il 09.06.1959 Arrestato il 09.06.97 - Scarcerato il 22.11.00 (O.C.C. 1427/95) Assistito e difeso di fiducia da: Avv. R. Di Gregorio Detenuto c/o Casa Circondariale Roma Rebibbia Presente in videocollegamento 3. AGRIGENTO Giuseppe nato San Cipirello il 25.11.1941 Arrestato 03.02.98 (O.C.C. 6416/97) Assistito e difeso di fiducia da: Avv. S. Priola Detenuto c/o Istituto Penitenziario di Parma Presente in video collegamento 4. ALFANO Paolo nato a Palermo 12/04/1953 Arrestato il 09.05.96 - Scarcerato il 18.05.99 (O.C.C. -

L'ultimo Golpe Di Massimiliano Paoli
L'ultimo golpe di Massimiliano Paoli "L'esistenza di eventuali, quanto non improbabili mandanti occulti, che restano sullo sfondo di questa vicenda, costituisce il principale enigma a cui questo processo non ha dato una convincente ed esaustiva risposta. [...] Appare necessario indagare nelle opportune direzioni per individuare gli eventuali convergenti interessi di chi a quell'epoca era in rapporto reciproco di scambio con i vertici di Cosa nostra e approfondire, se e in che misura, sussista un collegamento tra le indagini di Tangentopoli e la campagna stragista, e, infine, per meglio sviscerare i collegamenti e le reciproche influenze con gli eventi politico-istituzionali che si verificarono in quegli anni". Estratto dalla motivazione dei giudici della Corte d'assise d'appello di Caltanissetta per il processo inerente alla strage di Capaci. "Mandanti occulti". Quante volte abbiamo letto o sentito queste due parole apparentemente vaghe, inafferrabili, quasi dietrologiche ? Molte, forse troppe volte. Troppe perché per lunghi anni, per molte stragi italiane, quelle due parole sono spesso andate a braccetto col termine impunità. Due parole che trasudano verità indicibili. Verità indicibili che si sanciscono sul grande scacchiere della politica internazionale: un'inevitabile partita a scacchi giocata tra stati e lobby sulla pelle di tanti, di troppi. Una partita che ha tolto al nostro paese eccellenze sul fronte morale e professionale, ma soprattutto ha privato esseri umani del calore dei propri cari e viceversa. La più tragica delle banalità. La nostra storia però di banale ha ben poco. La nostra storia comincia con le dichiarazioni del vecchio boss di Altofonte (da tempo collaboratore di giustizia) Francesco Di Carlo. -

C) BERNARDO BRUSCA I Motivi
• .4i!'.! .1 c) BERNARDO BRUSCA I motivi ;diimpugnazione ,concernenti Ja-posizione l'rocessualedi questo imputato possono essere suddivisi;in due parti: una, comune al Calò, .cheafiTonta temigenerali,-'Iuali j .criteri di valutazione della prova, con particolare riferimento a quelli -previsti 1ler la chiamata .in correità e leregole sul concorso di.persone-nel reato, dei qualila Corte di primo grado, ad avviso del difensore, avrebbe -fatto malgoverno, ed un'altra che riguarda, più da vicino, la .posizione processuale nel • Brusca, quale sostituto di Salamone Antonino. Quanto al primo dei due ordirri ài censure,-rileva il Collegio che la questione ha avuto abbondante trattazione, sia nella-parte generale, che nelle precedenti posizioni processuali, sicché appare .superfluo ripetere quanto, in altre seài, già detto. Giova, comunque, ricordare che .al Tilievo concernente Ja -causale asseritamente, in maniera apodittica, Tiportata dalla Corte di primo grado a contrasti del Reina con Cianciminoe i suoi alleati '~corleonesi", nonostante le propalazioni del Mutolo fossero .rimaste .sostanzialmente • smentite dal D'Alia, il Collegio ha già risposto nel corso dell'~same della posizione processuale del Greco, mentre il -rilievo concernente l'omicidio in danno deII' Onorevole La Torre sarà trattato inqueIIa sede. Del tutto pnva, poi, di reale significato si palesa l'osservazione difensiva, secondo la quale le modalità di esecuzione .deldelitto in esame consentirebbero di ricondurre, in maniera certa, l'omicidio ad 143 organizzazioni terroristiche in quel periodo operanti (peraltro :non risulta, anzi la storia giudiziaria ci dice il contrario, che in quel periodo operassero in Sicilia propagginidi .gruppi orerroristiciaventimatrice polit.ica, sicuramente costituiti in altre partiàel territorio :nazionale).