Psr Resilient Buone Pratiche Per La Salvaguardia E La
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Diapositiva 1
FERROVIE DELLA VALTELLINA RACCOLTA FOTOGRAFICA A CURA DI GUIDO MAGENTA FOTOGRAFIE STORICHE PROVENIENTI DA: • PUBBLICAZIONI D’EPOCA • ARCHIVIO GIOVANNI CORNOLO’ • ARCHIVIO SERGIO VIGANO’ DA COLICO A SONDRIO COLICO ESTERNO DELLA STAZIONE COLICO LINEE PER CHIAVENNA E PER SONDRIO (1910 circa) STAZIONE DI COSIO TRAONA TRENO MERCI NEGLI ANNI 10 MORBEGNO ESTERNO DELLA STAZIONE (anni 30) IL PONTE DI DESCO (1904) FOTO DI CANTIERE IL PONTE APPENA TERMINATO ARDENNO 1895: “bombola” per lubrificanti in dotazione alla Stazione di Ardenno. TRENO SPECIALE PER LA GITA DEL CLUB ALPINO ITALIANO AL PASSO DI ZOCCA (1911) CASTIONE ANDEVENNO ELETTROMOTRICI Ale803 (2005) SONDRIO PIAZZA DELLA STAZIONE (ANNI 20) DA COLICO A CHIAVENNA FUENTES (1945) PONTE PROVVISORIO IN LEGNO DELLA FERROVIA COLICO-CHIAVENNA FERROVIA COLICO CHIAVENNA PONTE SULL’ADDA (1986) FERROVIA COLICO CHIAVENNA CONVOGLIO DI ELETTROMOTRICI AL PIAN DI SPAGNA (1986) NOVATE MEZZOLA (29 agosto 1934) LA FRANA DEL TORRENTE VALLONE INVADE LA FERROVIA CHIAVENNA (1800) INTERNO DELLA STAZIONE NEI PRIMI GIORNI DI ESERCIZIO CHIAVENNA PIAZZA DELLA STAZIONE (1920) CHIAVENNA (1919) AUTOBUS CHIAVENNA-CAMPODOLCINO-MADESIMO-SPLUGA DA SONDRIO A TIRANO FERROVIA ALTA VALTELLINA 1902 – IL TRENO INAUGURALE DA SONDRIO GIUNGE A TIRANO FERROVIA ALTA VALTELLINA LOCOMOTIVA “T3” VALTELLINA TIRANO LOCOMOTIVA “T3” RESTAURATA FERROVIA ALTA VALTELLINA VETTURA A DUE ASSI DI INIZIO SECOLO STAZIONE DI TIRANO LOCOMOTIVA F.A.V. CON SPARTINEVE TRESENDA CONVOGLIO F.A.V. (1967) FERROVIA ALTA VALTELLINA FERMATA DI SAN GIACOMO (1967) TIRANO TRENO DIRETTO PER MILANO (1967) SONDRIO (SETTEMBRE 1960) ESONDAZIONE SULLA STATALE E SULLA FERROVIA IN USCITA DA SONDRIO SCALO DI TIRANO TRASBORDO DEL CEMENTO PER LE DIGHE DI CANCANO TIRANO STAZIONE F.A.V. -

L'istituto Autonomo Per Le Case Popolari (IACP)
L’Istituto Autonomo per le Case Popolari (I.A.C.P.) della provincia di Sondrio venne costituito il 7/12/1937 ed eretto in «Ente Morale» con Decreto Reale del 3 marzo 1938; soci fondatori furono la Provincia ed il Comune. L’attività dell’ente prende subito avvio, ma la guerra, che tormenterà l’Europa dal 1939 al 1945, non permetterà all’Istituto di iniziare una attività edilizia seria in quanto tutto il Paese e quindi la sua economia erano allo sbando e tutti gli sforzi concentrati nella produzione bellica. Nei suoi primi dieci anni di vita, l’Istituto realizza solo 36 appartamenti e l’ente non riesce a definire un suo ruolo autonomo e propulsivo. È dal 1949, con la nascita dell’INA-CASA che è destinataria di ingenti finanziamenti posti a carico e trattenuti dalla busta paga di tutti i lavoratori dipendenti, che allo l.A.C.P. viene demandato il compito di realizzare buona parte dei piani edilizi che interessano la provincia di Sondrio. Inizia così una attività impegnata ed operosa, che permetterà all’Istituto di divenire, negli anni 60 e 70, il protagonista del grande sviluppo edilizio della Valtellina e della Valchiavenna nel campo della realizzazione della prima casa e di darecosi un apporto determinante alla trasformazione e modernizzazione della nostra provincia. L’Istituto è attivo in questo periodo cooperando alla creazione delle premesse all’esodo dei cittadini dalle zone disagiate di montagna verso i comprensori della pianura, ove si erano formate intanto maggiori possibilità di lavoro ed ove esistevano le scuole superiori e la ferrovia, magari per andare a lavorare lontano. -

Nr. Cl 46/2 Publikatieblad Van De Europese Gemeenschappen 17.6.81 I.V».—"• — —
Nr. Cl 46/2 Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen 17.6.81 i.v».—"• — — Verlening van bijstand door de afdeling Oriëntatie van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw Verordening (EEG) nr. 1362/78 Ie serie 1981 Overeenkomstig de richtlijnen van artikel 10, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1362/78 van de Raad van 19 juni 1978 inzake versnelde uitvoering en oriëntering van de collec tieve irrigatiewerkzaamheden in de Mezzogiorno ('), is een bedrag van 260 miljoen ERE voorzien voor een periode van vijf jaar. De bijzondere programma's dienen binnen een kaderprogramma te vallen. Het door de Italiaanse overheid ingediende kaderprogramma werd op 29 november 1979 door de Commissie goedgekeurd (2). Na het Comité van het Fonds over de financiële aspecten en met name over de beschik bare financiële middelen te hebben geraadpleegd en het advies van het Permanent Comité voor de landbouw te hebben ingewonnen, heeft de Commissie besloten bijstand ter waarde van 26 266 148 ERE te verlenen. Het bijzondere programma waarop deze aanvraag betrekking heeft, is in overeenstem ming met de belangen van de Gemeenschap. Overeenkomstig artikel 9, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1362/78 is de beschikking van de Commissie betreffende de verlening van bijstand door het EOGFL voor bedoeld bijzonder programma ter kennis gebracht van de Italiaanse overheid en van de voor de uitvoering ervan verantwoordelijke organisatie. O PB nr. L 166 van 29. 6. 1978, blz. 11. O PB nr. L 322 van 18. 12. 1979, blz. 30. Verlening van bijstand door de afdeling Oriëntatie van het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw Verordening (EEG) nr. -
For Hikers Along the Via Spluga from Thusis to Chiavenna
FOR HIKERS ALONG THE VIA SPLUGA FROM THUSIS TO CHIAVENNA Comunità Montana Valchiavenna CONTENTS pag. 4 General information 9 Parking 10 Luggage Transport 12 Left Luggage and informative pubblications 14 Emergency telephone numbers 15 Shopping 16 Returning from Chiavenna 18 Bus timetable Isola-Madesimo-Chiavenna 20 Map of Thusis 21 Map of Andeer and Splügen 23 Map of Chiavenna 2 GENERAL INFORMATION THE HIKING ROUTE Duration of the Walks The viaSpluga is a classic hiking path amid the mountains and Times indicated for each stage are a rough guide and do not in- some stretches require a level of experience and physical condi- clude breaks and visits. Obviously an individual’s natural rhythm tion for anyone undertaking it. Appropriate clothing and equip- of walking will mean that times vary. We also recommend that ment for the prevailing conditions are obviously recommended. when calculating the timing for each stage you allow for oppor- After heavy rainfall and / or unforeseen (rain or snow) weather tunities to explore all that the route has to offer along the way. conditions it is advisable to enquire on the current state of the route at tourist information offices or at your hotel. 1st day: Thusis/Sils – Zillis or Andeer Each person on the route must accept responsibility for himself, and the Tourist Office cannot accept any liability. Excursions are Itinerary Thusis – Verlorenes Loch – Zillis, 9.5 km, not guided. height differential +850/–590, around 4 h Itinerary Thusis/Sils – Traversina – Zillis, 11.5 km, height differential +990/–730, -

REPORT SULLA RETE CICLABILE DI VALTELLINA E VALCHIAVENNA Relazione Generale
REPORT SULLA RETE CICLABILE DI VALTELLINA E VALCHIAVENNA Relazione generale 1 INDICE 1. Introduzione e obiettivi della ricerca 5 2. Il ciclismo e il cicloturismo in Italia 7 2.1. Alcuni dati per confermare la giusta scelta in Valtellina e Valchiavenna 7 2.2 L’impatto economico del cicloturismo 9 2.3 Tante tipologie per un solo obiettivo: la sicurezza 11 2.4. Le tribù dei ciclisti e degli utilizzatori di piste ciclabili 12 3. La pianificazione e lo stato di fatto 15 3.1. Il Piano regionale della Mobilità Ciclistica e altri piani direttori 15 3.2. Per la costruzione di una Rete ciclabile provinciale 15 3.3. Sentiero Valtellina e ciclabile della Valchiavenna. I dati essenziali. 17 3.4. Sentiero Valtellina e ciclabile della Valchiavenna. Il paesaggio attraversato 19 3.5. I progetti in essere e le realizzazione collaterali 21 4. Criteri per una verifica di qualità della rete ciclabile provinciale 23 4.1. La riconoscibilità 23 4.2. L’agibilità 24 4.3. La scorrevolezza 24 4.4. La sicurezza e la separazione dal traffico motorizzato 25 4.5. L’intermodalità con il trasporto pubblico locale 28 4.6. La prossimità ai ricettori d’utenza e la dotazione di servizi 30 4.7. La valenza turistica e trasportistica dell’itinerario 32 4. 8. L’alta qualità formale ed estetica dell’intervento 33 4.9. Valutazione sintetica del grado di qualità e funzionalità della rete ciclabile provinciale, divisa in tratte omogenee 35 5. Alcune realizzazioni comparabili in Italia e all’estero 39 5.1 La rete ciclabile della Provincia di Trento 39 5.2. -

Spezzoni I Grado
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO “PAESI RETICI” Via DonLucchinetti, 3 – 23100 SONDRIO ANNO SCOLASTICO 2014/2015 Classi di concorso SPEZZONI PARI O INFERIORI A 6 ORE Scuola secondaria I grado AG77 - flauto 6 ore PONTE IN VALTELLINA AJ77 - pianoforte 6 ore BORMIO “Anzi 2 ore BERBENNO DI VALTELLINA A028 - Arte e immagine 2 ore VALFURVA 2 ore VILLA DI CHIAVENNA 2 ore CHIAVENNA “Garibaldi” 2 ore GORDONA 6 ore CAMPODOLCINO 4 ore CHIESA IN VALMALENCO 2 ore DELEBIO 2 ore DUBINO 4 ore GROSOTTO 6 ore LIVIGNO 6 ore MORBEGNO “Vanoni” 2 ore SAMOLACO 6 ore PONTE IN VALTELLINA 4 ore SONDRIO “Ligari” 6 ore ALBOSAGGIA 6 ore SONDRIO “Torelli” 2 ore SONDRIO “Piazzi” 2 ore TIRANO 2 ore TRAONA 2 ore BERBENNO DI VALTELLINA A030 – Scienze motorie e sportive 2 ore VILLA DI CHIAVENNA 2 ore CHIAVENNA “Garibaldi” 2 ore GORDONA 6 ore CAMPODOLCINO 4 ore DUBINO 6 ore LIVIGNO 2 ore SAMOLACO 6 ore PONTE IN VALTELLINA 2 ore SONDRIO “Sassi” 6 ore APRICA 6 ore BOR MIO A032 - Musica 2 ore VALFURVA 2 ore VILLA DI CHIAVENNA 2 ore CHIAVENNA “Garibaldi” 6 ore CAMPODOLCINO 6 ore LIVIGNO 4 ore NOVATE MEZZOLA 2 ore SONDRIO “Sassi” 4 ore ALBOSAGGIA 6 ore APRICA 2 ore VAL FURVA A033 - Tecnologia 2 ore CHIAVENNA “Bertacchi” 4 ore VILLA DI CHIAVENNA 2 ore CHIAVENNA “Garibaldi” 6 ore CAMPODOLCINO 6 ore LIVIGNO 6 ore MORBEGNO “Damiani” 2 ore SAMOLACO 6 ore PONTE IN VALTELLINA 6 ore APRICA 6 ore VALDI DENTRO A043 - Italiano, storia e geografia nella scuola 4 ore VALFURVA secondaria di I grado 2 ore VILLA DI CHIAVENNA 6 ore GORDONA 2 ore GROSOTTO 2 ore SAMOLACO 3 ore PONTE IN VALTELLINA 6 ore TEGLIO 4 ore VILLA DI TIRANO 2 ore DELEBIO C.T.P. -

COMUNE DI CASPOGGIO Prov
COMUNE DI CASPOGGIO Prov. di SONDRIO PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 3 DEL 22.05.2014 A FIRMA DEL SEGRETARIO ADOZIONE con Deliberazione del COMMISSARIO N° 13 del 18.12.2013 STRAORDINARIO con i poteri del Consiglio Comunale PUBBLICAZIONE AI SENSI DI LEGGE: dal 15.01.2014 al 16.03.2014 TERMINE ACCOGLIMENTO OSSERVAZIONI SCADUTO IL: 16.03.2014 ----------------- OSSERVAZIONI esaminate con Deliberazione del COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri del Consiglio N° 3 del 22.05.2014 Comunale APPROVATO con Deliberazione del COMMISSARIO N° 3 del 22.05.2014 STRAORDINARIO con i poteri del Consiglio Comunale STUDIO TECNICO ASSOCIATO Arch. MAURO DE GIOVANNI - Ing. VIRGILIO SCALCO Via Nazionale, 123 – 23030 Villa di Tirano (SO) tel. 0342/703098 – fax. 0342/704290 Componente Geologica, idrogeologica e sismica: Dott. Geologo Angelo Tuia, Chiesa in Valmalenco (SO), aprile 2009 – gennaio 2010 Consulente per gli aspetti geologici: Dott. Geologo Conforto Gaetano, Sondrio, giugno 2013 – settembre 2014 Collaborazione per gli aspetti paesaggistici: Dott. Architetto Dario Benetti, Sondrio Altri collaboratori: Dott. Gianni Menicatti; Dott. Pianificatore Territoriale Massimo Spinelli, Sondrio DOCUMENTO DI PIANO (Legge Regione Lombardia 11 marzo 2005 N° 12) Tavola: RELAZIONE DPR Scala: 1 : Data: Settembre 2014 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE Comune di Caspoggio Piano di Governo del Territorio INDICE PARTE I .......................................................................................................................... -

Publication of the Amended Single Document Following the Approval Of
22.6.2020 EN Offi cial Jour nal of the European Union C 208/13 Publication of the amended single document following the approval of a minor amendment pursuant to the second subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012 (2020/C 208/06) The European Commission has approved this minor amendment in accordance with the third subparagraph of Article 6(2) of Commission Delegated Regulation (EU) No 664/2014 (1). The application for approval of this minor amendment can be consulted in the Commission’s eAmbrosia database. SINGLE DOCUMENT ‘MELA DI VALTELLINA’ EU No: PGI-IT-0574-AM01 – 17.2.2020 PDO ( ) PGI (X) 1. Name(s) ‘Mela di Valtellina’ 2. Member State or third country Italy 3. Description of the agricultural product or foodstuff 3.1. Type of product Class 1.6 – Fruit, vegetables and cereals, fresh or processed. 3.2. Description of product to which the name in (1) applies The following varieties are used for the production of ‘Mela di Valtellina’: ‘Red Delicious’ – ‘Golden Delicious’ – ‘Gala’. When released for consumption, they have the following characteristics: Red Delicious: thick, non-waxy epicarp of a brilliant, intense red colour, with the dominant colour covering more than 80 % of the surface, smooth, with no russeting or greasiness, resistant to handling. Oblong truncated cone shape with five lobes and a pentagonal equatorial plane. Minimum diameter of 65 mm. Minimum sugar content of more than 10° Brix. Flesh: white with apple aroma of medium intensity. Intense honey, jasmine and apricot aromas. Very crunchy and juicy. Dominant sweet flavour with appreciable acidity and aroma of medium intensity. -

Elezioni U.P.S. 2020
ELEZIONI U.P.S. 2020 ELENCO ALFABETICO PESCATORI RESIDENTI IN PROVINCIA DI SONDRIO - VOTANTI/ELEGGIBILI Abela Sebastiano Sondrio Acquistapace Abele Piantedo Acquistapace Adriano Morbegno Acquistapace Andrea Piantedo Acquistapace Armando Piantedo Acquistapace Elia Samolaco Acquistapace Eraldo Piantedo Acquistapace Ezio Piantedo Acquistapace Marco Morbegno Acquistapace Marino Cosio Valtellino Acquistapace Maurizio Campodolcino Acquistapace Maurizio Piantedo Acquistapace Paolo Delebio Acquistapace Stefano Cosio Valtellino Acquistapace Stefano Delebio Acquistapace Thomas Cosio Valtellino Agnelli Andrea Caspoggio Agosti Gabriele Samolaco Agostinelli Franco Villa Di Tirano Aili Maurizio Berbenno Di Valtellina Aili Stefano Sondrio Albareda Ivan Chiesa In Valmalenco Albareda Mattia Chiesa In Valmalenco Albertazzi Rino Postalesio Alberti Edoardo Rasura Alberti Ottavio Ardenno ALBINI NICOLA Delebio ALBINIANO Luca Campodolcino Alessi Giuseppe Aprica Aloisio Paolo Samolaco Ambrosetti Remo Morbegno Ambrosetti Rocco Cosio Valtellino Ambrosini Attilio Aprica AMBROSINI CRISTIAN Dubino ambrosini daniele Cercino Ambrosini Fabio Ardenno Ambrosini Filippo Dubino Ambrosini Giuliano Delebio Ambrosini Lina Sondrio Ambrosini Valerio Dubino Ambrosini Valter Cercino Ambrosioni Luca Tresivio Amonini Antonello Castello Dell'acqua Amorini G.carlo Talamona Ancona Samuele Livigno Andreola Mattia Sondrio ANDREOLI ANDREA Mese Andreoli Giuliano Samolaco Andreoli Luca Tresivio ANDREOLI STEFANO Samolaco Andreotta Arnaldo Villa Di Tirano andreu caparros tamara Grosio Angelini -

Mandamento Di Morbegno Calendario Eventi 2019
2019 Calendario EVENTI Mandamento di Morbegno Informazioni i Campi estivi i INFO VALGEROLA Nel presente Calendario Eventi 2019 sono Bus navetta riportate le manifestazioni segnalate entro il CREO, IMPARO E MI DIVERTO 15 maggio 2019. Gli appuntamenti potranno Dal 02/07 al 10/08 subire variazioni o annullamenti. MORBEGNO Giornate di gioco, didattica e creatività VAL DI MELLO Per aggiornamenti, ulteriori dettagli e iniziative organizzate successivamente, consulta: Dal 01 al 05 luglio CONSORZIO TURISTICO ORARI PARTENZE WWW.VALTELLINAMORBEGNO.IT BAKE OFF - sforniamo i prodotti da forno VALTELLINA DI MORBEGNO più originali e buoni. S. Martino Val di Mello Piazza Bossi 7/8 ORARI DI APertURA: Dal 08 al 12 luglio 09.00 – 10.00 – 11.00 23017 Morbegno -SO- dal 13/09 al 31/12 ARIA, ACQUA, TERRA E FUOCO - i 4 14.00 – 15.00 – 16.00 – 17.00 – 18.00 Tel. 0342 601140 dal 10/06 al 12/09 lun-ven 08.00-12.30 lun-ven 08.30-13.10 elementi per giocare, scoprire e divertirsi. [email protected] Val di Mello S. Martino 14.00-18.10 14.00-18.10 Dal 15 al 19 luglio www.valtellinamorbegno.it sab 08.00-12.30 sab 08.30-13.10 CARTOON - tecniche di animazione, set 09.30 – 10.30 – 11.30 fotografici, supereroi… 14.30 – 15.30 – 16.30 – 17.30 – 18.30 Dal 22 al 26 luglio UNA SETTIMANA DA PAURA - mostri e COSTI A CORSA draghi, esplosioni e pozioni, magie… € 2,00 giovani e adulti Dal 29 luglio al 02 agosto € 1,00 bambini (0-12 anni) IN VIAGGIO NEL TEMPO - Re e regine, Sono ammessi cani di piccola taglia senza egizi e greci, indiani e cow boy… supplemento Dal 05 al 09 agosto MISSION IMPOSSIBILE - investigatori e PERIODO squadre speciali per missioni segrete. -
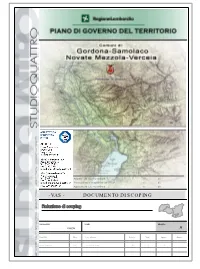
Vas - Documento Di Scoping
Adottato dal C.C. con delibera n° ______ del _________ Provvedimento di compatibilità con il PTCP n° ______ del _________ Approvato dal C.C. con delibera n° ______ del _________ - VAS - DOCUMENTO DI SCOPING Relazione di scoping commessa: scala: allegato: 298/CH A Nome File: Data: Fase di lavoro: Redatto: Verif.: Approv.: Bozza: Relazione di scoping.doc Feb.09 VAS- documento di scoping MCG VB SM 1 Comuni Valchiavenna –Redazione P.G.T. INDICE DOCUMENTO DI SCOPING ........................................................................... 2 1. PREMESSA ....................................................................................................................................2 1.1. Definizione ........................................................................................................................2 1.2. Normativa di riferimento Comunitaria ..............................................................................3 2 - PROPOSTA METODOLOGICA ORGANIZZATIVA.................................................................5 2.1. Il Piano di Governo del Territorio .....................................................................................5 2.2. Procedura...........................................................................................................................9 3 – LA VAS DEI COMUNI DI NOVATE MEZZOLA-SAMOLACO-VERCEIA –GORDONA....10 4 – SINTESI DELLE PROBLEMATICHE EMERGENTI DALLA LETTURA DEL QUADRO CONOSCITIVO.................................................................................................................................11 -

Sintesi Non Tecnica
- APPROVATO - Progettista: Sindaco: Segretario: Adottato dal C.C. con delibera n° 39 del 11/12/2012 Provvedimento di compatibilità con il PTCP n° 41 del 18/03/2013 Approvato dal C.C. con delibera n° 08 del 14/05/2013 - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL DOCUMENTO DI PIANO - SINTESI NON TECNICA commessa: scala: allegato: 379/CH V2 Nome File: Data: Fase di lavoro: Redatto: Verif.: Approv.: Rev.: Copertine_Vas.mxd Novembre '12 ADOZIONE SM SM SM 0 Copertine_Vas.mxd Maggio '13 APPROVAZIONE SM SM SM 1 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA SINTESI NON TECNICA Parte Generale Valutazione Ambientale Strategica redatta in collaborazione con: GRUPPO DI LAVORO: Prof. Valeria Mezzanotte Dott. Alessandro Bisceglie 1. INQUADRAMENTO GENERALE Il comune di Villa di Chiavenna è situato a Nord-Ovest della provincia di Sondrio, in Val Bregaglia e ha un’estensione totale di 32,72 Km2. La sua quota media è di 633 m s.l.m., ma l’escursione altimetrica complessiva all’interno del territorio comunale è di 2599 m, essendo la quota minima a 508 m s.l.m. e la massima a 3.107. Il comune fa parte della Comunità Montana della Val Chiavenna, ed è composto, oltre al centro abitato principale situato sul versante settentrionale, da distinte frazioni,: Giavera, Pian del Cà, Canete, San Barnaba, Chete, Dogana. In base ai dati ISTAT, dal 2001 ad oggi la popolazione risulta diminuita del 5,6%, in linea con l’andamento rilevato nei comuni nelle vicinanze (Campodolcino -2,4% San Giacomo Filippo -8,5% Madesimo -3,5%) in controtendenza rispetto a Piuro che però rappresenta un’eccezione (+3,2%) ed ai dati medi della provincia di Sondrio (+3,4%) e della Lombardia (+8,8%).