Roma in Transizione
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Deliberazione N. 49 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'assemblea CAPITOLINA
Protocollo RC n. 37739/2018 Deliberazione n. 49 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA Anno 2019 VERBALE N. 40 Seduta Pubblica del 25 giugno 2019 Presidenza: STEFÀNO L’anno 2019, il giorno di martedì 25 del mese di giugno, alle ore 14,05 nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 14 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi. Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Generale, dott. Pietro Paolo MILETI. Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Vice Presidente Vicario Enrico STEFÀNO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all’appello dei Consiglieri. (OMISSIS) Eseguito l’appello, il Vice Presidente Vicario comunica che sono presenti i sottoriportati n. 25 Consiglieri: Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, Bordoni Davide, Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, Chiossi Carlo Maria, Coia Andrea, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Guadagno Eleonora, Iorio Donatella, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna Carola, Seccia Sara, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco e Zotta Teresa Maria. 2 ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri: Baglio Valeria, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, Giachetti Roberto, Grancio Cristina, Guerrini Gemma, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Montella Monica, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia, Vivarelli Valentina e Zannola Giovanni. Il Vice Presidente Vicario, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che la Consigliera Guerrini ha giustificato la propria assenza. -

Municipio II/04.Qxd 02-03-2007 12:07 Pagina 1
Municipio II/04.qxd 02-03-2007 12:07 Pagina 1 Cronaca, Informazione, Sport e Spettacolo • GRATIS Sito web: www.lavocedelmunicipio.it Anno II n. 4 • 02 Marzo 2007 QUARTO MUNICIPIO TRUFFATORI Nel giro di un mese si sono verificati tre episodi, molto somiglianti tra loro, ai danni di signore di una certa età. A pagina 4 PIAZZA SEMPIONE Dalle ore 19 in poi si riempie di veicoli che sono talmente tanti da straripare nell’opposta carreggiata. A pagina 5 PARCO DELLE BETULLE La discarica completamente ignorata dagli amministratori. Detriti di ignota natura forse anche pericolosi per la salute A pagina 7 APAGINA 6 MERCATO Inaugurata la copertura Marchionne, presidente della Approvata in Quarto la Commissione Con un corteo hanno commemorato del mercato rionale Commissione Ambiente e Urbanistica Speciale per la Sicurezza la figura di Valerio Verbano di Via Franco Sacchetti che nei mesi estivi “...abbiamo cercato di coinvolgere i Il IV^ Municipio è l’unico a Roma con L’inchiesta bloccata dal ritrovamento mantiene la temperatura cittadini nelle scelte che li una struttura politico-ammininistrativa del verbale di distruzione dei reperti più bassa riguarderanno da vicino”.Impegno nella dedicata a questa vera e propria trovati appena dopo il delitto realizzazione dei progetti. (PAGINA 3) emergenza. (PAGINA 5) (PAGINA 8) A pagina 11 Municipio II/04.qxd 02-03-2007 12:07 Pagina 2 pagina 2 Venerdì 02 Marzo 2007 Ecco i voti dopo l’analisi fatta dal 18 settembre al 7 dicembre 2006 dall’Agenzia dei Servizi Pubblici Locali In viaggio sull’autobus che non c’è Il sondaggio e i dati al 18 settembre al delle vetture è tanto affol- tato libero da impedimen- neggiamenti (dal 12,8 al te, il 97% rispetta la pre- comunicati da Atac 7 dicembre 2006 lato da impedire la salita ti alla salita e discesa dai 9,6%), meno scritte sulle notazione di fermata, qua- D l’Agen- mezzi; nel pre- carrozzerie (dal 10,1 si il 90% apre e chiude le danno un quadro zia dei Servizi cedente rappor- all’8,9 %) e meno porte porte a regola d’arte quasi idilliaco del Pubblici Locali to era il 70%, guaste. -

Il Consumo Di Suolo Di Roma Capitale
Roma Capitale Dipartimento Trasformazione Digitale UO Statistica – Open Data Via della Greca, 5 – 00186 Roma www.comune.roma.it ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma www.isprambiente.gov.it Riproduzione autorizzata citando la fonte Curatori Michele Munafò ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale [email protected] Fabio Cesetti Roma Capitale – Dipartimento Trasformazione digitale - UO Statistica-Open Data [email protected] Autori Marialuigia De Stefano – Servizio Civile Universale Daniele Giustozzi – Servizio Civile Universale Miranda Lippolis – Servizio Civile Universale Alice Cavalli – Università degli Studi della Tuscia Supporto tecnico Alice Cavalli – Università degli Studi della Tuscia Fotointerpretazione, classificazione, produzione cartografica Marialuigia De Stefano Daniele Giustozzi Miranda Lippolis Le attività di elaborazione dei dati e di preparazione del rapporto sono state realizzate nell’ambito di un progetto sviluppato per il Servizio Civile Universale ed inserito nel Piano statistico nazionale vigente Dati e cartografia www.isprambiente.gov.it www.comune.roma.it Ringraziamenti Si ringraziano per il contributo tecnico e scientifico: Roma Capitale: Mario Carbone - Dipartimento Trasformazione Digitale UO Statistica-Open Data Gino Casale – Dipartimento Trasformazione Digitale UO Statistica-Open Data Fabio Cesetti - Dipartimento Trasformazione Digitale UO Statistica-Open Data Maria Ciuffreda - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica Gianluca Ferri - Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile Roma Capitale Giulio Rauco - Dipartimento Trasformazione digitale UO Statistica-Open Data Claudio Succhiarelli – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ISPRA: Luca Congedo Chiara Giuliani Ines Marinosci La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. -

Programma Integra and Rome Reception System
Programma integra and Rome reception system Valentina Fabbri Programma integra STUDY VISIT ABOUT US Programma integra is an integrated social cooperative founded in 2005 and dealing with innovative projects for social inclusion of migrants and refugees. Its activities cover the design and implementation of social inclusion paths and the Community development. Between 2005 and 2016 Programma integra has assisted 4,946 beneficiaries (migrants, refugees and asylum seekers, migrant/unaccompanied minors). The center for migration, asylum and social integration The Civic Center for Migration, asylum and social integration of Roma Capitale is a multifunctional space dedicated to the themes of migration, international protection, social inclusion and acceptance. It was established in 2005 by the Department of Social Policy with the aim of uniting the inside activities and services for citizens in social marginality conditions to facilitate the integration processes in the territory. The center: The Immigration Office of Roma Capitale in charge of coordinating the reception of immigrants, asylum seekers and refugees, and provides assistance Italians who decide to return home from abroad. The reception center for homeless' M. Teresa of Calcutta '. The center is part of the reception circuit in emergency adult homeless capital of Rome and accommodates 80 people. Services for immigrants and refugees - legal, job orientation, counseling, social mediation in the field of housing - made by Programma integra. 1 conference room, 1 meeting room, 1 exhibition space managed by the PI for the organization of training courses, conferences and initiatives on social issues and available for the territory. Management of the information website programmaintegra.it SERVICES TO MIGRANTS AND REFUGEES Social and legal counseling: it provides information and support in relation to legislation and administrative procedures on asylum and immigration; locally available orientation services and access to social benefits. -

Roma Strategia Di Resilienza
MA Roma Strategia di Resilienza Roma Strategia di Resilienza PREFAZIONE Roma è stata selezionata nel dicembre del 2013 tra il primo gruppo di 32 città per far parte della rete di città 100RC. II progetto “100 Resilient Cities” (100 Città Resilienti), avviato da Rockefeller Foundation (100RC), si prefigge di aiutare le città di tutto il mondo a diventare più resilienti di fronte alle sfide ambientali, sociali ed economiche in rapida evoluzione nel XXI secolo. Il Programma promuove la resilienza delle città attraverso la nomina di un Chief Resilience Officer (CRO), la creazione di una Strategia di Resilienza e la condivisione delle conoscenze e di casi studio, tramite la rete globale di città 100RC e l’accesso ad una piattaforma di partner. 100RC affronta il tema della resilienza con un approccio olistico che coinvolge una vasta gamma di soggetti interessati e consente alle città di costruire la propria capacità di adattamento e miglioramento preparandosi al crescente numero di shock e stress cronici cui sono sottoposte (eventi traumatici come terremoti, inondazioni, epidemie ecc. ed eventi stressanti che indeboliscono il tessuto di una città). Roma ha iniziato questo percorso il 4 dicembre 2013. Dopo una prima fase di analisi, è stata pubblicata la “Valutazione Preliminare di Resilienza” nella quale sono elencati e descritti i punti di forza e di debolezza, gli shock e gli stress nonché le azioni in essere della città. La Strategia è il risultato di una stretta collaborazione tra l’Amministrazione Capitolina, 100 Resilient Cities e i loro partner strategici. Durante l’esecuzione dei lavori sono stati individuati e coinvolti numerosi stakeholder interni ed esterni all’Amministrazione Capitolina. -

1. Urban Growth and Suburbanization
T U R A S TRANSITIONING TOWARDS URBAN RESILIENCE AND SUSTAINABILITY FORMS OF URBAN G R O W T H I N SOUTHEAST EUROPE: T R A N S I T I O N I N G TOWARDS URBAN R E S I L I E N C E A N D S U S T A I N A B I L I T Y VOLUME 1 Edited by Atanas Kovachev Aleksandar D. Slaev Diliana Daskalova Varna Free University “Chernorizets Hrabar” Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia 1 T U R A S TRANSITIONING TOWARDS URBAN RESILIENCE AND SUSTAINABILITY This book has been prepared and published with the financial support by the European Union FP7-ENV.2011.2.1.5-1 (TURAS Project) Grant Agreement no. 282834. Information about the TURAS Project is available on the Internet at http://www.turas-cities.org/ Edited by Atanas Kovachev, Aleksandar D. Slaev and Diliana Daskalova Copiright: Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged. Citation Kovachev, A., A.D. Slaev, and D. Daskalova, 2016. Forms of Urban Growth in Southeast Europe: Transitioning Towards Urban Resilience and Sustainability. Varna: Varna Free University. Published by Varna Free University “Chernorizets Hrabar” KK “Chaika”, Varna 9007, Bulgaria in cooperation with Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia Bulevar Kralja Aleksandra 73/II, 11000 Belgrade, Serbia Printed by Reklama consult EOOD 18 “Zhelezni vrata” St, Stara Zagora, Bulgaria ISBN 978-954-305-428-2 2 T U R A S TRANSITIONING TOWARDS URBAN RESILIENCE AND SUSTAINABILITY Content Foreword .................................................................................................................... 7 1. Urban Growth and Urbanization on Sofiа, Belgrade and Rome: the Interaction between Urban Planning and the Market – A. -
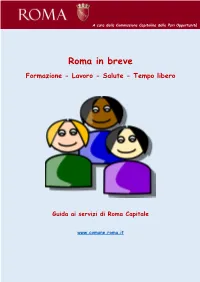
Opuscolo Roma in Breve.Pdf
A cura della Commissione Capitolina delle Pari Opportunità Roma in breve Formazione - Lavoro - Salute - Tempo libero Guida ai servizi di Roma Capitale www.comune.roma.it A cura della Commissione Capitolina delle Pari Opportunità INDICE Introduzione 3 Servizi di Roma Capitale. Iniziamo dal sito 4 Iscrizione anagrafica 5 o Gli uffici anagrafici nei Municipi 5 Punti Roma Facile 6 o Sedi Punti Roma Facile 6 Centri di Formazione Professionale - CFP 9 Scuole d’Arte e Mestieri 10 Centri per l’Istruzione e la formazione degli Adulti 11 Rete dei Centri di Orientamento al Lavoro 12 o Sedi C.O.L. 12 La tua salute è importante 13 Farmacie Comunali 14 o Elenco delle farmacie comunali 14 o Elenco dei presidi sociali e punti RECUP Lazio 15 Persone fragili e con disabilità 16 Salute al femminile 16 o Consultori a Roma 17 Violenza e maltrattamenti 18 o Lo sai che la legge italiana è dalla tua parte? 18 Se sei vittima di abusi chiedi aiuto! Come? 19 o Centri Anti Violenza – CAV 19 Sistema Bibliotecario 22 Sistema Museale 25 Impianti Sportivi Comunali 26 Centri Sportivi Municipali 26 Luoghi di culto a Roma 27 Consulte 28 Numeri utili 29 Siti utili 29 Elenco uffici postali nel Comune di Roma 30 2 A cura della Commissione Capitolina delle Pari Opportunità Introduzione L’opuscolo “Roma in breve. Formazione, Lavoro, Salute e Tempo libero - Guida ai Servizi di Roma Capitale” vuole essere un vademecum per i cittadini che hanno bisogno di informazioni su quanto l’Amministrazione Capitolina mette a disposizione per le necessità degli stessi, su alcuni servizî essenziali presenti sul territorio e su quanto può essere utile nella quotidianità, fornendo per questo anche una guida alla navigazione sul sito di Roma Capitale. -

Deliberazione Assemblea Capitolina N. 55-2018
Protocollo RC n. 32393/2017 Deliberazione n. 55 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA Anno 2018 VERBALE N. 27 Seduta Pubblica del 15 maggio 2018 Presidenza: DE VITO - STEFÀNO L’anno 2018, il giorno di martedì 15 del mese di maggio, alle ore 13,05 nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 13 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi. Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa TURCHI. Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all’appello dei Consiglieri. (OMISSIS) Alla ripresa dei lavori - sono le ore 13,30 - il Presidente dispone che si proceda al secondo appello. Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 25 Consiglieri: Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diario Angelo, Donati Simona, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Giachetti Roberto, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Montella Monica, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna Carola, Seccia Sara, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco, Vivarelli Valentina e Zotta Teresa Maria. ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri: Baglio Valeria, Bordoni Davide, Celli Svetlana, Coia Andrea, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Di Biase Michela, Diaco Daniele, Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, Ghera Fabrizio, Grancio Cristina, Iorio Donatella, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia e Tranchina Fabio. -

Avviso Pubblico Per Incarico Di Medico Fiduciario Roma
Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA UFFICIO 1 – AFFARI GENERALI E SEGRETERIA TECNICA-ORGANIZZATIVA ATTRIBUZIONE DI N. 1 INCARICO DI MEDICO GENERICO FIDUCIARIO PER L’ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO-LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL’AVIAZIONE CIVILE, PER LOCALITA’ DI ROMA – AREA TERRITORIALE DEI MUNICIPI III, XIV E XV. Premesso che si è determinata la necessità di attivare le procedure, di cui all’articolo 2 del D.M. n. 95 del 25 giugno 2013, pubblicato sulla G.U. n. 193 del 18/08/2013, per il conferimento della titolarità di 1 incarico di medico generico fiduciario per la località di Roma in grado di assicurare l’assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante nel seguente territorio: Municipio III (zone urbanistiche: Monte Sacro, Val Melaina, Monte Sacro Alto, Fidene, Serpentara, Casal Boccone, Conca d'Oro, Sacco Pastore, Tufello, Aeroporto dell'Urbe, Settebagni, Bufalotta, Tor San Giovanni), Municipio XIV (zone urbanistiche: Medaglie d'Oro, Primavalle, Ottavia, Santa Maria della Pietà, Trionfale, Pineto, Castelluccia, Santa Maria di Galeria), Municipio XV (zone urbanistiche: Tor di Quinto, Acquatraversa, Tomba di Nerone, Farnesina, Grotta Rossa Ovest, Grotta Rossa Est, Giustiniana, La Storta, Santa Cornelia, Prima Porta, Labaro, Cesano, Martignano, Foro Italico). VISTO IL D.M. 8 APRILE 2015 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della Salute. SI RENDE NOTO CHE deve essere attribuito 1 incarico di medico generico fiduciario per la località -

Piano Dei Servizi Minimi Essenziali
PIANO DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI SCIOPERO DEL 13 NOVEMBRE 2020 ID NOME COGNOME COMMESSA GLOBAL 1 DANIELA ABODI MUNICIPIO I 2 SIMONETTA ABODI MUNICIPIO I 3 ALBERTO AGNELLI MUNICIPIO I 4 JANE NEXHMIJE ALIBALI MUNICIPIO I 5 ROSSANA AMICONE MUNICIPIO I 6 ANNA ANGIOLINO MUNICIPIO I 7 ROMANO BATTISTINI MUNICIPIO I 8 ROSARIA BONURA MUNICIPIO I 9 DIEGO CAPIZZANO MUNICIPIO I 10 ITA CAPRARO MUNICIPIO I 11 MARIA ASSUNTA CARUSO MUNICIPIO I 12 SIMONA CERRONE MUNICIPIO I 13 RITA CESTONI MUNICIPIO I 14 MAURIZIO COMIN MUNICIPIO I 15 BARBARA CORTELLESI MUNICIPIO I 16 FRANCO D'ALESSANDRO MUNICIPIO I 17 MARIA D'ANGELI MUNICIPIO I 18 CRISTIAN D'ANGELO MUNICIPIO I 19 LAURA D'ANSELMO MUNICIPIO I 20 ANNA RITA DE LUCA MUNICIPIO I 21 NADIA DI PASCALE MUNICIPIO I 22 VERONICA DONATI MUNICIPIO I 23 EMANUELA D'OVIDIO MUNICIPIO I 24 ANNA RITA FABI MUNICIPIO I 25 AUGUSTO FANTINI MUNICIPIO I 26 ANNA FILIPPI MUNICIPIO I 27 MARIA ANTONIETTA GENTILE MUNICIPIO I 28 EDVIGE GIANNINI MUNICIPIO I 29 ELISABETTA GRANATO MUNICIPIO I 30 DORIS IAFRATE MUNICIPIO I 31 CLAUDIA LORETI MUNICIPIO I 32 SALVATORE MAESANO MUNICIPIO I 33 MASSIMO MANICCIA MUNICIPIO I 34 GIACOMO MOLTONI MUNICIPIO I 35 ELEONORA MONTANUCCI MUNICIPIO I 36 FRANCESCA NATALI MUNICIPIO I 37 DEBORAH PAPA MUNICIPIO I 38 PATRIZIA PARISSE MUNICIPIO I 39 CARLA PAVONI MUNICIPIO I 40 ALESSANDRO PELLICCIONI MUNICIPIO I 41 STEFANIA PIACENTE MUNICIPIO I 42 ANNALISA PIACENTINI MUNICIPIO I 43 NATALIIA POLIANSKA MUNICIPIO I 44 MANUEL PRIMAVERA MUNICIPIO I 45 CHIARA PUGLIESE MUNICIPIO I 46 DANIELA RUIS MUNICIPIO I PIANO DEI -

Lista Dei Centri Di Aggregazione Di Roma Capitale
Lista dei Centri di aggregazione di Roma Capitale Municipio I "Una mano per..." Centro diurno per adolescenti Ente gestore: CIOFS FP LAZIO (centro italiano opere femminili salesiane) Indirizzo: via Ginori, 10 Contatti: Tel. 06.5783433 - 345.1347230 email: [email protected] - [email protected] Centro di aggregazione preadolescenti e adolescenti MaTeMu' Ente gestore: CiES ong Indirizzo: via Vittorio Amedeo II, 14 Contatti: Tel. 06.77070411 - 06.77264611 email: [email protected] Centro polivalente giovani Ente gestore: Associazione Culturale di volontariato S.S.C.M. Indirizzo: via Boezio, 1c Contatti: Tel. Fax 06.68392163 email: [email protected] Municipio II Progettare con l'adolescenza La Bottega delle Idee Ente gestore: Pegaso Cooperativa Sociale Integrata Indirizzo: via dei Campani, 77 Contatti: Tel. 06.4957871 - 06.6273654 email: [email protected] Municipio III Centro Diurno Spazio Adolescenti ... alla scoperta del mondo Ente gestore: ANSEA Associazione Nazionale Sport Educazione Ambientale Indirizzo: via Francesco Cocco Ortu, 22 Contatti: Tel. 06.89766106 - 06.8108249 email: [email protected] Municipio IV Area Agio - La casa dei ragazzi e delle ragazze Ente gestore: UISP Comitato di Roma Indirizzo: via dell'Acqua Marcia, 51 Contatti: Tel. 06.5758395 - 340.8212353 email: [email protected] Frequenza200 San Basilio Ente gestore: Cemea del mezzogiorno Indirizzo: Via Pergola 21, Plesso scuola Gandhi Contatti: Tel. 06.27800248 Municipio V Centro 6 Spazio No Stop giovani - Centro Diurno Polivalente per Minori Ente gestore: Ruotalibera soc. coop. sociale ONLUS Indirizzo: via Albona (angolo via Buie d'Istria) Contatti: Tel. 06.21800754 - 06.25393527; Tel./Fax 06.27801063 email: [email protected] Centro aggregazione adolescenti Ente gestore: Antropos Associazione Indirizzo: Viale Giorgio Morandi, 98 Contatti: Tel. -

Moving Towards the Implementation of the Right to the City in Regional and Internationally Perspective Avanzar Hacia La Implemen
Moving Towards the Implementation of the Right to the City in Regional and Internationally Perspective Avanzar Hacia la Implementación del Derecho a la Ciudad en Perspectiva Internacional y Regional Avançando na Implementação do Direito à Cidade na Perspectiva Internacional e Regional Proposers Support Coordinators Researchers Nelson Saule Júnior Latin America Lorena Zárate Maria Silvia Emanuelli Paulo Romeiro Irene Maestro Guimarães Vanessa Koetz Colaboradora Karina Uzzo Africa Adoné Kitching, Alfred Omenya Akoth Ouma Joseph Schechla Mirjam van Donk Scott Drimie Tabitha Onyinge Waruguru Gikonyo Europe Eva Garcia Chueca Giovanni Allegretti Colaboradores Yasar Adanali, Michela Barbot, Laura Colini, Owen Dowsett Jez Hall Manuel Lutz, Giulio Mattiazzi, Michelangelo Sechi Michael Rostalski Colectivo Ministarstvo Prostora Introduction This publication contains the preliminary versions of the researches reports, which are part of the project “Advancing the implementation of the Right to the City in Latin America and internationally” and it was funded by Ford Foundation. The research was coordinated by POLIS Institute (FNRU coordinator-member of the National Urban Reform Forum) and by Habitat International Coalition for Latin America (HIC-AL). In Latin America, since the beginning of the new millennium, HIC member organizations and other networks have settled common issues. Essential contents and strategic actions, at the regional level, were agreed in favor of the realization of land rights, housing and the city. Various actions and projects were enabled to move forward in this 10 years path. It was reaffirmed the importance of promoting, defending and supporting collective processes of production and social management of housing and habitat; Evictions and forced displacement prevention, particularly arising from mega projects investment and “development”, both in the countryside and the city; defending the right to water and systematization and dissemination of technologies for the mitigation of risks and participatory processes of post-disaster reconstruction.