Il Consumo Di Suolo Di Roma Capitale
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

“Dona Un Albero a Roma” (Donate a Tree to Rome)
To Roma Capitale Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile U.O. Gestione Verde Pubblico Piazza di Porta Metronia, 2 00183 Roma [email protected] REGISTRATION FORM “Dona un albero a Roma” (Donate a Tree to Rome) I, the undersigned, _____________________________________________ born in ____________________________ in the Province of ________________________ on ___/___/_______, a resident of the municipality (Comune) of, ______________________ in the Province of ________________________ at: VIA _________________________________________nr. ___ CAP (postcode) ___________________ Tel ______/__________________________ Mobile______/_________________________ Fax _________________/ e-mail _____________________________________ @ ___________________________ DECLARE that I intend to take part in the “DONA UN ALBERO A ROMA” (Donate a Tree to Rome) project, by donating a total of _____________ tree/trees paying € 250.00 per tree (total amount € _____________.00) as a donation to Roma Capitale for the purchase and maintenance of the tree/s donated. specifying the area/areas (Municipio/Municipi, or administrative borough/s) in which the tree/s is/are to be planted: no. trees____type1 __________ □ MUNICIPIO I no. trees____type __________ □ no. trees____type __________ □ MUNICIPIO II MUNICIPIO IX no. trees____type __________ □ MUNICIPIO III no. trees____type __________ □ no. trees____type __________ □ MUNICIPIO IV MUNICIPIO X2 no. trees____type __________ □ MUNICIPIO V no. trees____type __________ □ no. trees____type __________ -

Il Consumo Di Suolo Di Roma Capitale
Il consumo di suolo di Roma Capitale Analisi della copertura di suolo nel territorio del Comune di Roma Rapporto 2019 Progetto del Servizio Civile Nazionale della U.O. Statistica – Open Data di Roma Capitale in collaborazione con l’ISPRA – Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia 2 Roma Capitale Dipartimento Trasformazione Digitale UO Statistica – Open Data Via della Greca, 5 – 00186 Roma www.comune.roma.it ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma www.isprambiente.gov.it Riproduzione autorizzata citando la fonte Finito di stampare nel mese di dicembre 2019 1 Curatori Michele Munafò ISPRA – Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia michele.munafò@isprambiente.it Romina Polverini Roma Capitale – Dipartimento Trasformazione digitale - UO Statistica-Open Data [email protected] Autori Dott. Marco d’Antona - ISPRA Dott. Marco Di Leginio - ISPRA Dino Di Renzo - Università di Ferrara Dip. Di Fisica e Scienze della Terra Giulia Esposito - Servizio Civile Nazionale Teresa Oreade Grillo - Servizio Civile Nazionale Michele Munafò - ISPRA Romina Polverini- Roma Capitale Gian Marco Ritacco - Servizio Civile Nazionale Leonardo Rizzo - Servizio Civile Nazionale Giulia Valentino - Servizio Civile Nazionale Supporto tecnico Gino Casale Alice Cavalli Luca Congedo Valentina Falanga Fotointerpretazione, classificazione, produzione cartografica Dino Di Renzo Giulia Esposito Teresa Oreade Grillo Gian Marco Ritacco Leonardo Rizzo Giulia Valentino Contributo Gianluca Ferri - Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile Roma Capitale 2 Le attività di elaborazione dei dati e di preparazione del rapporto sono state realizzate nell’ambito di un progetto sviluppato per il Servizio Civile Nazionale ed inserito nel Piano statistico nazionale vigente Dati e cartografia www.isprambiente.gov.it www.comune.roma.it Ringraziamenti Si ringraziano per il contributo tecnico e scientifico: Roma Capitale: Dott. -

Deliberazione N. 49 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'assemblea CAPITOLINA
Protocollo RC n. 37739/2018 Deliberazione n. 49 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA Anno 2019 VERBALE N. 40 Seduta Pubblica del 25 giugno 2019 Presidenza: STEFÀNO L’anno 2019, il giorno di martedì 25 del mese di giugno, alle ore 14,05 nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 14 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi. Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Generale, dott. Pietro Paolo MILETI. Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Vice Presidente Vicario Enrico STEFÀNO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all’appello dei Consiglieri. (OMISSIS) Eseguito l’appello, il Vice Presidente Vicario comunica che sono presenti i sottoriportati n. 25 Consiglieri: Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, Bordoni Davide, Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, Chiossi Carlo Maria, Coia Andrea, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Guadagno Eleonora, Iorio Donatella, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna Carola, Seccia Sara, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco e Zotta Teresa Maria. 2 ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri: Baglio Valeria, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, Giachetti Roberto, Grancio Cristina, Guerrini Gemma, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Montella Monica, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia, Vivarelli Valentina e Zannola Giovanni. Il Vice Presidente Vicario, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che la Consigliera Guerrini ha giustificato la propria assenza. -

Programma Integra and Rome Reception System
Programma integra and Rome reception system Valentina Fabbri Programma integra STUDY VISIT ABOUT US Programma integra is an integrated social cooperative founded in 2005 and dealing with innovative projects for social inclusion of migrants and refugees. Its activities cover the design and implementation of social inclusion paths and the Community development. Between 2005 and 2016 Programma integra has assisted 4,946 beneficiaries (migrants, refugees and asylum seekers, migrant/unaccompanied minors). The center for migration, asylum and social integration The Civic Center for Migration, asylum and social integration of Roma Capitale is a multifunctional space dedicated to the themes of migration, international protection, social inclusion and acceptance. It was established in 2005 by the Department of Social Policy with the aim of uniting the inside activities and services for citizens in social marginality conditions to facilitate the integration processes in the territory. The center: The Immigration Office of Roma Capitale in charge of coordinating the reception of immigrants, asylum seekers and refugees, and provides assistance Italians who decide to return home from abroad. The reception center for homeless' M. Teresa of Calcutta '. The center is part of the reception circuit in emergency adult homeless capital of Rome and accommodates 80 people. Services for immigrants and refugees - legal, job orientation, counseling, social mediation in the field of housing - made by Programma integra. 1 conference room, 1 meeting room, 1 exhibition space managed by the PI for the organization of training courses, conferences and initiatives on social issues and available for the territory. Management of the information website programmaintegra.it SERVICES TO MIGRANTS AND REFUGEES Social and legal counseling: it provides information and support in relation to legislation and administrative procedures on asylum and immigration; locally available orientation services and access to social benefits. -

Roma Strategia Di Resilienza
MA Roma Strategia di Resilienza Roma Strategia di Resilienza PREFAZIONE Roma è stata selezionata nel dicembre del 2013 tra il primo gruppo di 32 città per far parte della rete di città 100RC. II progetto “100 Resilient Cities” (100 Città Resilienti), avviato da Rockefeller Foundation (100RC), si prefigge di aiutare le città di tutto il mondo a diventare più resilienti di fronte alle sfide ambientali, sociali ed economiche in rapida evoluzione nel XXI secolo. Il Programma promuove la resilienza delle città attraverso la nomina di un Chief Resilience Officer (CRO), la creazione di una Strategia di Resilienza e la condivisione delle conoscenze e di casi studio, tramite la rete globale di città 100RC e l’accesso ad una piattaforma di partner. 100RC affronta il tema della resilienza con un approccio olistico che coinvolge una vasta gamma di soggetti interessati e consente alle città di costruire la propria capacità di adattamento e miglioramento preparandosi al crescente numero di shock e stress cronici cui sono sottoposte (eventi traumatici come terremoti, inondazioni, epidemie ecc. ed eventi stressanti che indeboliscono il tessuto di una città). Roma ha iniziato questo percorso il 4 dicembre 2013. Dopo una prima fase di analisi, è stata pubblicata la “Valutazione Preliminare di Resilienza” nella quale sono elencati e descritti i punti di forza e di debolezza, gli shock e gli stress nonché le azioni in essere della città. La Strategia è il risultato di una stretta collaborazione tra l’Amministrazione Capitolina, 100 Resilient Cities e i loro partner strategici. Durante l’esecuzione dei lavori sono stati individuati e coinvolti numerosi stakeholder interni ed esterni all’Amministrazione Capitolina. -

The Transfer Service Is Not Available from the Following Hotels
The transfer service is not available from the following hotels. For accommodations that do not have a registered business name (such as those that operate within a private residence), you may refer to the address to check if your hotel is not covered by the route. Hotel Name Address Best Western Blu Hotel Roma Largo Domenico de Dominicis 4 Hotel Oltremare Lungomare della Salute 111/a Hotel La Conchiglia Lungomare di Ponente 4, Fregene Barceló Aran Blu Lungomare Duca Degli Abruzzi, 72, Hotel La Scaletta Lungomare Paolo Toscanelli 130, Hotel La Caravella Lungomare Paolo Toscanelli 156, Ostia Lido Sirenetta Lungomare Paolo Toscanelli 46, Parco delle Valli Bedrooms Piazza Conca d'Oro 25, Hotel Belvedere Century Piazza dei Ravennati, 4, Apartment in Rome With Air Conditioning, Lift, Washing Machine Piazza Salvatore Galgano, 90, 00173, Roma, Italy Rossana Holidays Piazza Tommaso de Cristoforis 1, Holiday and Rome Piazza Tommaso de Cristoforis 6, Bellavista Piazzale Magellano 16 La Riva Piazzale Magellano 22, Appiantica Roma Iro419 Apartment in Rome With Terrace, Parking, Washing Machine Salita della Marcigliana, 1-43, 00138, Roma, Italy Country House in Rome With Air Conditioning, Parking, Washing Machine Salita della Marcigliana, 43, 00138, Roma, Italy Apartment in Rome With Parking, Washing Machine Salita della Marcigliana, 48, 00138, Roma, Italy Country House in Rome With Parking, Washing Machine Salita della Marcigliana, 48, 00138, Roma, Italy Hotel Eurogarden Salita di Castel Giubileo 197, Apartment in Rome With Terrace, Air Conditioning, -

1. Urban Growth and Suburbanization
T U R A S TRANSITIONING TOWARDS URBAN RESILIENCE AND SUSTAINABILITY FORMS OF URBAN G R O W T H I N SOUTHEAST EUROPE: T R A N S I T I O N I N G TOWARDS URBAN R E S I L I E N C E A N D S U S T A I N A B I L I T Y VOLUME 1 Edited by Atanas Kovachev Aleksandar D. Slaev Diliana Daskalova Varna Free University “Chernorizets Hrabar” Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia 1 T U R A S TRANSITIONING TOWARDS URBAN RESILIENCE AND SUSTAINABILITY This book has been prepared and published with the financial support by the European Union FP7-ENV.2011.2.1.5-1 (TURAS Project) Grant Agreement no. 282834. Information about the TURAS Project is available on the Internet at http://www.turas-cities.org/ Edited by Atanas Kovachev, Aleksandar D. Slaev and Diliana Daskalova Copiright: Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged. Citation Kovachev, A., A.D. Slaev, and D. Daskalova, 2016. Forms of Urban Growth in Southeast Europe: Transitioning Towards Urban Resilience and Sustainability. Varna: Varna Free University. Published by Varna Free University “Chernorizets Hrabar” KK “Chaika”, Varna 9007, Bulgaria in cooperation with Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia Bulevar Kralja Aleksandra 73/II, 11000 Belgrade, Serbia Printed by Reklama consult EOOD 18 “Zhelezni vrata” St, Stara Zagora, Bulgaria ISBN 978-954-305-428-2 2 T U R A S TRANSITIONING TOWARDS URBAN RESILIENCE AND SUSTAINABILITY Content Foreword .................................................................................................................... 7 1. Urban Growth and Urbanization on Sofiа, Belgrade and Rome: the Interaction between Urban Planning and the Market – A. -
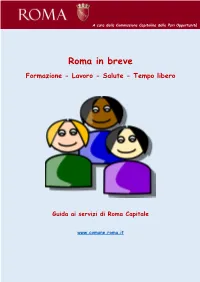
Opuscolo Roma in Breve.Pdf
A cura della Commissione Capitolina delle Pari Opportunità Roma in breve Formazione - Lavoro - Salute - Tempo libero Guida ai servizi di Roma Capitale www.comune.roma.it A cura della Commissione Capitolina delle Pari Opportunità INDICE Introduzione 3 Servizi di Roma Capitale. Iniziamo dal sito 4 Iscrizione anagrafica 5 o Gli uffici anagrafici nei Municipi 5 Punti Roma Facile 6 o Sedi Punti Roma Facile 6 Centri di Formazione Professionale - CFP 9 Scuole d’Arte e Mestieri 10 Centri per l’Istruzione e la formazione degli Adulti 11 Rete dei Centri di Orientamento al Lavoro 12 o Sedi C.O.L. 12 La tua salute è importante 13 Farmacie Comunali 14 o Elenco delle farmacie comunali 14 o Elenco dei presidi sociali e punti RECUP Lazio 15 Persone fragili e con disabilità 16 Salute al femminile 16 o Consultori a Roma 17 Violenza e maltrattamenti 18 o Lo sai che la legge italiana è dalla tua parte? 18 Se sei vittima di abusi chiedi aiuto! Come? 19 o Centri Anti Violenza – CAV 19 Sistema Bibliotecario 22 Sistema Museale 25 Impianti Sportivi Comunali 26 Centri Sportivi Municipali 26 Luoghi di culto a Roma 27 Consulte 28 Numeri utili 29 Siti utili 29 Elenco uffici postali nel Comune di Roma 30 2 A cura della Commissione Capitolina delle Pari Opportunità Introduzione L’opuscolo “Roma in breve. Formazione, Lavoro, Salute e Tempo libero - Guida ai Servizi di Roma Capitale” vuole essere un vademecum per i cittadini che hanno bisogno di informazioni su quanto l’Amministrazione Capitolina mette a disposizione per le necessità degli stessi, su alcuni servizî essenziali presenti sul territorio e su quanto può essere utile nella quotidianità, fornendo per questo anche una guida alla navigazione sul sito di Roma Capitale. -

Struttura Proponente - Municipio Roma X - C.F
Struttura Proponente - Municipio Roma X - C.F. 02438750586 Pubblicazione Tabelle Riassuntive dei dati di scelta del Contraente Periodo 1.1.2020 / 31.12.2020 Importo Importo Somme Cig Struttura proponente Oggetto Scelta Contraente Partecipanti Aggiudicatario Data Inizio Data Fine Aggiudicazione Liquidate 5179833569 02438750586 ROMA CAPITALE - MUNICIPIO ROMA X M.O.E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STELLA 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE • 10679771005 LA.E.STRA SRL • 11107941004 EDILIZIA E RESTAURI SRL 86.200,00 0 DEL MARE VIA MAR DEI CARAIBI 28 - GLI EUCALIPTI VIA CAPO • 11107941004 EDILIZIA E RESTAURI SRL D'ARMI, 80 - PESCE MAGICO VIA GHERARDI, 39 - ADEGUAMENTO • 10109021005 MAMI SRL E POTENZIAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI FONDI DIP.TO XI • 06031990580 RESINE INDUSTRIALI SRL • 08938701003 D'ANNUNZIO LUCIANO 5538834668 02438750586 ROMA CAPITALE - MUNICIPIO ROMA X M.O. STRADE PRONTO INTERVENTO E SORVEGLIANZA ZONA B 23-AFFIDAMENTO DIRETTO • 00704490580 VARUSA STRADE SRL • 00704490580 VARUSA STRADE SRL 0 0 ENTROTERRA -ANNO 2014 - PERIODO 01/01/2014 - 28/02/2014 51868514D9 02438750586 ROMA CAPITALE - MUNICIPIO ROMA X M.O. E RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA GLI 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE • 04677370589 EDILCIEFFE SRL • 03639410582 I.C.E.S.A. SRL 0 0 EUCALIPTI VIA CAPO D'ARMI,80 - FONDI DIP.TO XI • 01050321007 GER SRL • 08360221009 I.C.E.R. 2005 SRL • 03639410582 I.C.E.S.A. SRL • 11461611003 PETRUCCI MARIANO SRL Z070A83813 02438750586 ROMA CAPITALE - MUNICIPIO ROMA X INTERVENTI MANUTENTIVI E ADEGUAMENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO • 01188761008 EDIL METAL SRL • 01188761008 EDIL METAL SRL 372.908,95 0 NORMATIVO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI F.O. 2013 DIP.TO S.E.E.S. -

Deliberazione Assemblea Capitolina N. 55-2018
Protocollo RC n. 32393/2017 Deliberazione n. 55 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA Anno 2018 VERBALE N. 27 Seduta Pubblica del 15 maggio 2018 Presidenza: DE VITO - STEFÀNO L’anno 2018, il giorno di martedì 15 del mese di maggio, alle ore 13,05 nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 13 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi. Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott.ssa Mariarosa TURCHI. Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Presidente Marcello DE VITO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all’appello dei Consiglieri. (OMISSIS) Alla ripresa dei lavori - sono le ore 13,30 - il Presidente dispone che si proceda al secondo appello. Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 25 Consiglieri: Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, De Vito Marcello, Di Palma Roberto, Diario Angelo, Donati Simona, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Giachetti Roberto, Guadagno Eleonora, Guerrini Gemma, Montella Monica, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna Carola, Seccia Sara, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco, Vivarelli Valentina e Zotta Teresa Maria. ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri: Baglio Valeria, Bordoni Davide, Celli Svetlana, Coia Andrea, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Di Biase Michela, Diaco Daniele, Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, Ghera Fabrizio, Grancio Cristina, Iorio Donatella, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia e Tranchina Fabio. -

Avviso Pubblico Per Incarico Di Medico Fiduciario Roma
Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA UFFICIO 1 – AFFARI GENERALI E SEGRETERIA TECNICA-ORGANIZZATIVA ATTRIBUZIONE DI N. 1 INCARICO DI MEDICO GENERICO FIDUCIARIO PER L’ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO-LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL’AVIAZIONE CIVILE, PER LOCALITA’ DI ROMA – AREA TERRITORIALE DEI MUNICIPI III, XIV E XV. Premesso che si è determinata la necessità di attivare le procedure, di cui all’articolo 2 del D.M. n. 95 del 25 giugno 2013, pubblicato sulla G.U. n. 193 del 18/08/2013, per il conferimento della titolarità di 1 incarico di medico generico fiduciario per la località di Roma in grado di assicurare l’assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante nel seguente territorio: Municipio III (zone urbanistiche: Monte Sacro, Val Melaina, Monte Sacro Alto, Fidene, Serpentara, Casal Boccone, Conca d'Oro, Sacco Pastore, Tufello, Aeroporto dell'Urbe, Settebagni, Bufalotta, Tor San Giovanni), Municipio XIV (zone urbanistiche: Medaglie d'Oro, Primavalle, Ottavia, Santa Maria della Pietà, Trionfale, Pineto, Castelluccia, Santa Maria di Galeria), Municipio XV (zone urbanistiche: Tor di Quinto, Acquatraversa, Tomba di Nerone, Farnesina, Grotta Rossa Ovest, Grotta Rossa Est, Giustiniana, La Storta, Santa Cornelia, Prima Porta, Labaro, Cesano, Martignano, Foro Italico). VISTO IL D.M. 8 APRILE 2015 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della Salute. SI RENDE NOTO CHE deve essere attribuito 1 incarico di medico generico fiduciario per la località -

Municipio Xiii), in Via Di Casal Selce
IMPIANTO DI PRODUZIONE DI COMPOST DI QUALITÀ, SITO A ROMA (MUNICIPIO XIII), IN VIA DI CASAL SELCE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE SINTESI NON TECNICA COD. 18V030 - V. 01 – Febbraio 2018 Sistema di gestione per la qualità certificato da DNV Sistema di gestione ambientale certificato da DNV UNI EN ISO 9001:2008 UNI EN ISO 14001:2004 CERT-12313-2003-AQ-MIL-SINCERT CERT-98617-2011-AE-ITA-ACCREDIA Progettazione ed erogazione di servizi di ricerca, analisi, pianificazione e consulenza nel campo dell’ambiente e del territorio Studio di impatto ambientale – Sintesi non tecnica PROGETTO Direzione Operativa – Servizio Gestione Patrimonio Responsabile unico del procedimento (RUP): Arch. Massimo Bagatti Gruppo di lavoro responsabile per la progettazione: Ing. Dario Bonanni (Responsabile) Arch. Roberto Panei Ing. Giovanni Petrucciani Arch. Valeria Russi Arch. Paolo Ratto Dott.ssa Emanuela Brandizzi Dis. Cad. Emanuele Marini STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE Gruppo di lavoro responsabile per lo SIA: Dott. Mario Zambrini Eng. Teresa Freixo Santos Dott. Giulio Conte Direttore Tecnico Amministratore Unico Direttore Tecnico Iscritto all’Ordine degli Ingegneri del Portogallo Tecnico competente in acustica ambientale Iscritto all’Ordine Nazionale dei Biologici riconosciuto con DGR Lombardia n. 10602 del 23 (n. 44550 del 24/06/2005) e Tecnico competente nel giugno 2004 campo dell’acustica ambientale riconosciuto con (n. AA_045465 del 15/07/1996) DGR Lombardia n. 12714 del 3 Dicembre 2010 Arch. Mario Miglio Ing. Elio Altese Dott. Carlo Bossi Dott.ssa Laura Andreazzoli Dott. Roberto Bellasio (Enviroware) – Studio Previsionale di impatto atmosferico e olfattivo Dott. Roberto Bianconi (Enviroware) – Studio Previsionale di impatto atmosferico e olfattivo COD. 18V030 - V.