Municipio Xiii), in Via Di Casal Selce
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Deliberazione N. 49 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'assemblea CAPITOLINA
Protocollo RC n. 37739/2018 Deliberazione n. 49 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA Anno 2019 VERBALE N. 40 Seduta Pubblica del 25 giugno 2019 Presidenza: STEFÀNO L’anno 2019, il giorno di martedì 25 del mese di giugno, alle ore 14,05 nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l’Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 14 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi. Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Generale, dott. Pietro Paolo MILETI. Assume la presidenza dell’Assemblea Capitolina il Vice Presidente Vicario Enrico STEFÀNO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all’appello dei Consiglieri. (OMISSIS) Eseguito l’appello, il Vice Presidente Vicario comunica che sono presenti i sottoriportati n. 25 Consiglieri: Agnello Alessandra, Angelucci Nello, Ardu Francesco, Bernabei Annalisa, Bordoni Davide, Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, Chiossi Carlo Maria, Coia Andrea, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Guadagno Eleonora, Iorio Donatella, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna Carola, Seccia Sara, Stefàno Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco e Zotta Teresa Maria. 2 ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri: Baglio Valeria, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, Giachetti Roberto, Grancio Cristina, Guerrini Gemma, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mennuni Lavinia, Montella Monica, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro, Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia, Vivarelli Valentina e Zannola Giovanni. Il Vice Presidente Vicario, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che la Consigliera Guerrini ha giustificato la propria assenza. -

Il Consumo Di Suolo Di Roma Capitale
Roma Capitale Dipartimento Trasformazione Digitale UO Statistica – Open Data Via della Greca, 5 – 00186 Roma www.comune.roma.it ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma www.isprambiente.gov.it Riproduzione autorizzata citando la fonte Curatori Michele Munafò ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale [email protected] Fabio Cesetti Roma Capitale – Dipartimento Trasformazione digitale - UO Statistica-Open Data [email protected] Autori Marialuigia De Stefano – Servizio Civile Universale Daniele Giustozzi – Servizio Civile Universale Miranda Lippolis – Servizio Civile Universale Alice Cavalli – Università degli Studi della Tuscia Supporto tecnico Alice Cavalli – Università degli Studi della Tuscia Fotointerpretazione, classificazione, produzione cartografica Marialuigia De Stefano Daniele Giustozzi Miranda Lippolis Le attività di elaborazione dei dati e di preparazione del rapporto sono state realizzate nell’ambito di un progetto sviluppato per il Servizio Civile Universale ed inserito nel Piano statistico nazionale vigente Dati e cartografia www.isprambiente.gov.it www.comune.roma.it Ringraziamenti Si ringraziano per il contributo tecnico e scientifico: Roma Capitale: Mario Carbone - Dipartimento Trasformazione Digitale UO Statistica-Open Data Gino Casale – Dipartimento Trasformazione Digitale UO Statistica-Open Data Fabio Cesetti - Dipartimento Trasformazione Digitale UO Statistica-Open Data Maria Ciuffreda - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica Gianluca Ferri - Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile Roma Capitale Giulio Rauco - Dipartimento Trasformazione digitale UO Statistica-Open Data Claudio Succhiarelli – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ISPRA: Luca Congedo Chiara Giuliani Ines Marinosci La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. -
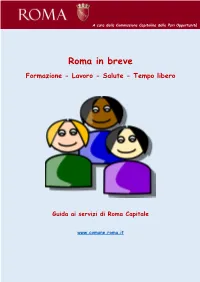
Opuscolo Roma in Breve.Pdf
A cura della Commissione Capitolina delle Pari Opportunità Roma in breve Formazione - Lavoro - Salute - Tempo libero Guida ai servizi di Roma Capitale www.comune.roma.it A cura della Commissione Capitolina delle Pari Opportunità INDICE Introduzione 3 Servizi di Roma Capitale. Iniziamo dal sito 4 Iscrizione anagrafica 5 o Gli uffici anagrafici nei Municipi 5 Punti Roma Facile 6 o Sedi Punti Roma Facile 6 Centri di Formazione Professionale - CFP 9 Scuole d’Arte e Mestieri 10 Centri per l’Istruzione e la formazione degli Adulti 11 Rete dei Centri di Orientamento al Lavoro 12 o Sedi C.O.L. 12 La tua salute è importante 13 Farmacie Comunali 14 o Elenco delle farmacie comunali 14 o Elenco dei presidi sociali e punti RECUP Lazio 15 Persone fragili e con disabilità 16 Salute al femminile 16 o Consultori a Roma 17 Violenza e maltrattamenti 18 o Lo sai che la legge italiana è dalla tua parte? 18 Se sei vittima di abusi chiedi aiuto! Come? 19 o Centri Anti Violenza – CAV 19 Sistema Bibliotecario 22 Sistema Museale 25 Impianti Sportivi Comunali 26 Centri Sportivi Municipali 26 Luoghi di culto a Roma 27 Consulte 28 Numeri utili 29 Siti utili 29 Elenco uffici postali nel Comune di Roma 30 2 A cura della Commissione Capitolina delle Pari Opportunità Introduzione L’opuscolo “Roma in breve. Formazione, Lavoro, Salute e Tempo libero - Guida ai Servizi di Roma Capitale” vuole essere un vademecum per i cittadini che hanno bisogno di informazioni su quanto l’Amministrazione Capitolina mette a disposizione per le necessità degli stessi, su alcuni servizî essenziali presenti sul territorio e su quanto può essere utile nella quotidianità, fornendo per questo anche una guida alla navigazione sul sito di Roma Capitale. -

Rapporto Sullo Stato Di Salute Della Popolazione a Roma E Nel Lazio
STATO DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE A ROMA E NEL LAZIO Aggiornamento dati al 31/12/2014 Maggio 2016 Indice Premessa ............................................................................................................ 5 Parte A – Mortalità ............................................................................................. 6 Metodi .......................................................................................................................... 6 Fonte dei dati .............................................................................................................6 Misure epidemiologiche ................................................................................................6 Risultati ........................................................................................................................ 6 Tutte le cause ............................................................................................................9 Malattie infettive e parassitarie ................................................................................... 15 Tubercolosi .............................................................................................................. 20 Tumori maligni ......................................................................................................... 22 Tumori maligni dell'esofago ........................................................................................ 27 Tumori maligni dello stomaco .................................................................................... -

Diapositiva 1
Assessorato Trasformazione Urbana Deliberazione della Giunta Capitolina del 24/04/2014 n. 115 Approvazione dell’Invito pubblico alla manifestazione d’Interesse per la formulazione di proposte di interventi privati finalizzata alla redazione dei Programmi Preliminari relativi agli Ambiti per i Programmi Integrati contenenti i Tessuti per attività della Città da ristrutturare. Assessorato Trasformazione Urbana Ambiti per i Programmi integrati PRG approvato con Del. C.C. n. 18/2008 PRINT prevalentemente per Attività Mun / Ex Mun Numero Denominazione Tipologia Città Superfice territoriale (ha) II / Ex II IIa1 Acqua Acetosa attività da ristrutturare 5,29 III / Ex IV IVa1 Villa Ada attività da ristrutturare 35,05 III / Ex IV IVa2 Salario attività da ristrutturare 27,11 III / Ex IV IVa3 Castel Giubileo attività da ristrutturare 21,24 III / Ex IV IVa4 Settebagni attività da ristrutturare 46,32 III / Ex IV IVa5 Ficarone attività da ristrutturare 56,55 III / Ex IV IVa6 S. Colomba attività da ristrutturare 65,76 III / Ex IV IVa8 Città del Mobile attività da ristrutturare 35,15 III / Ex IV IVa9 Cesarina Nuova attività da ristrutturare 16,28 III / Ex IV IVa10 Bufalotta - Marcigliana attività da ristrutturare 5,73 III / Ex IV IVa11 Casal Boccone attività da ristrutturare 3,04 IV / Ex V Va4 Tor Cervara attività da ristrutturare 73,61 IV / Ex V Va5 Tiburtino - Quarto S. Eusebio attività da ristrutturare 133,01 IV / Ex V Va6 Casal Monastero attività da ristrutturare 19,79 IV / Ex V Va7 S. Eusebio - Salone attività da ristrutturare 291,39 IV / Ex V Va8 -

Relazione Del Presidente Del Municipio Roma XIII Aurelio
Relazione del Presidente del Municipio Roma XIII Aurelio Luglio 2017 – Giugno 2018 Redatta da Giuseppina Castagnetta Relazione annuale della Presidente Giuseppina Castagnetta – Luglio 2017 / Giugno 2018 Indice PREMESSA .................................................................................................................................................................. 6 LAVORI PUBBLICI: MANUTENZIONE STRADE .............................................................................................................. 6 BANDI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA MUNICIPALE ............................................................................................... 6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE ............................................................................................................................. 7 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA .............................................................................................................................. 8 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE DI GRANDE VIABILITÀ ......................................................................................................... 9 LAVORI PUBBLICI: MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI ............................................................................................ 9 APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA ...................................................................................................................... 9 MANUTENZIONI EDIFICI ERP ................................................................................................................................................ -

“Dona Un Albero a Roma” (Donate a Tree to Rome)
To Roma Capitale Dipartimento Tutela Ambientale – Protezione Civile U.O. Gestione Verde Pubblico Piazza di Porta Metronia, 2 00183 Roma [email protected] REGISTRATION FORM “Dona un albero a Roma” (donate a tree to Rome) I undersigned __________________________________________________________________________________ born in (city and state) _________________________________________________________________________ on (date of birth) ______________________________________________________________________________ resident in (city and state) _________________________________________________________________________ address ____________________________________________________________________________________ Postcode ___________________ Tel ____________________________Mobile ______________________________ Fax _________________/ Email _____________________________________ @ ____________________________ DECLARE that I intend to take part in the “DONA UN ALBERO A ROMA” (donate a tree to Rome) initiative, for which purpose I, the undersigned, donate a total of _____________ tree/trees transfer the sum of € 250.00 per tree for a sum total of € _____________.00 as donation to Roma Capitale for purchase and maintenance of the tree/s donated. specify the area/areas (Municipio/Municipi, or administrative borough/s) in which the tree/s is/are to be located: nr. ____type1 _________ □ MUNICIPIO I nr. ____type _________ □ MUNICIPIO IX nr. ____type __________ □ MUNICIPIO II nr. ____type _________ □ MUNICIPIO X2 nr. ____type __________ □ MUNICIPIO -

Appello UNA RIPARTENZA PER L'europa #Imillexeuropafederale Elenco Firmatari
Appello UNA RIPARTENZA PER L'EUROPA #iMillexEuropaFederale Elenco firmatari Alla cortese attenzione del Presidente del Parlamento europeo On. David Sassoli Oggetto: Adesioni all’Appello Una ripartenza per l’Europa Signor Presidente, la campagna #iMillexEuropaFederale sull’Appello Una ripartenza per l’Europa, che – inserendosi in questo momento così importante per le scelte europee – ha coinvolto tra l’inizo di giugno e i primi di luglio esponenti a tutti i livelli del mondo politico, accademici, rappresentanti del mondo del lavoro, del Terzo settore, della cultura, anche semplici cittadini, è un contriButo che i federalisti offrono al Parlamento europeo per far sentire la vicinanza sui temi europei da parte di chi opera sul territorio. L’Europa non è solo la garanzia del nostro futuro in termini di prosperità, di sosteniBilità amBientale, di equità sociale, ma è ancor di più una visione della politica e del mondo che si Basa sul primato dei valori universali, a partire da quello della pace, dei diritti civili e politici, sulla solidarietà, la coesione, l’inclusione, il multilateralismo, la cooperazione internazionale. E’ questa visione, che deve accompagnarsi agli strumenti politico-istituzionali in grado di preservarla al nostro interno e difenderla nel mondo, che ispira le donne e gli uomini, e i giovani, che si Battono ogni giorno per rendere concreti questi ideali, e che guardano alla realtà del Parlamento europo come un punto di riferimento fondamentale per rendere questa Europa una realtà irreversiBile e forte. Sapendo di poter contare sulla sua condivisione di questa visione e sul suo impegno, la ringraziamo per l’attenzione e nell’augurarle Buon lavoro la salutiamo con viva cordialità, Luisa Trumellini Antonio Argenziano Segretaria nazionale MFE Segretario nazionale GFE [email protected] - www.mfe.it [email protected] - https://giovanifederalisti.eu UNA RIPARTENZA PER L’EUROPA Verso l’Unione federale europea La Commissione europea ha presentato al Parlamento europeo un pacchetto ambizioso per il Recovery Plan for Europe. -

CONTRASSEGNO SPECIALE DI CIRCOLAZIONE DOVE RIVOLGERSI MUNICIPIO I – CENTRO STORICO Segretariato Sociale Via Petroselli, 50
CONTRASSEGNO SPECIALE DI CIRCOLAZIONE DOVE RIVOLGERSI MUNICIPIO I – CENTRO STORICO Segretariato Sociale Via Petroselli, 50 - telefono 06.69601665-648 orari: martedì ore 9,00 - 12,00 e ore 14,00 - 16,00 - venerdì ore 9,00 - ore 12,00 MUNICIPIO II Via Dire Daua,11- tel. 06.69602445- orari: martedì e venerdì ore 8,30 - 12,30 e ore 14,30 - 16,30 MUNICIPIO III Sportello Unico U.O.S.E.C.S. (Unità Organizzativa Socio-Educativa, Culturale, Sportiva) telefono 06 69603644. Per maggiori dettagli consulta il sito del Municipio III: MUNICIPIO IV Sportello "Ufficio Relazioni con il pubblico" (URP) Via Umberto Fracchia, 45 (tel. 06.696.04.333 -334-433–432) e Piazza Sempione, 15 (tel. 06.69604.340) orari: lunedì – mercoledì – venerdì: dalle ore 8.30 alle ore 12.00 martedì e giovedì: dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 Per maggiori dettagli consulta il sito del Municipio IV MUNICIPIO V Sportello "Ufficio Relazioni con il pubblico" dell’Accoglienza Unica, Via Tiburtina 1163, P.T. - orari: dal lunedì al venerdì 8.30-12.00; martedì e giovedì anche orario pomeridiano 14.00-16.00- Per maggiori dettagli consulta il sito del Municipio V MUNICIPIO VI Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - via Torre Annunziata, 1 - tel. 06.69606455 MUNICIPIO VII Viale Palmiro Togliatti, 983 - telefono 06.69607626 - orari: lunedì e venerdì 9.00-12.30 - martedì 14,30-15,50 - giovedì 09.00-12.30 e 14,30-15,50 Per maggiori dettagli consulta il sito del Municipio VII MUNICIPIO VIII Sportello Unico di Segretariato Sociale - Via Natale Balbiani, 20. -

456 321 Municipio I Classificare
T2 T2 —456 32 Comune di Roma (Opzione: Classificare qui Roma fino al 476; preferire —3763) —456 321 Municipio I Classificare qui le opere sul centro storico di Roma Classificare qui i rioni Monti, Trevi, Colonna, Campo Marzio, Ponte, Parione, Regola, Sant’Eustachio, Pigna, Campitelli, Sant’Angelo, Ripa, Trastevere, Borgo, Esquilino, Ludovisi, Sallustiano, Castro Pretorio, Celio, Testaccio, San Saba, Prati Classificare qui il quartiere della Vittoria Per il quartiere Ostiense e Ardeatino vedi —4563264; Per il quartiere Trionfale vedi —4563288 —456 322 Municipio II Classificare qui i quartieri Flaminio, Parioli, Pinciano, Salario, Nomentano, Tiburtino, Trieste Per il rione Castro Pretorio vedi —456321; Per il quartiere Pietralata vedi —4563244 —456 324 Municipi a est —456 324 2 Municipio III Classificare qui i quartieri Monte Sacro, Monte Sacro Alto Classificare qui le zone Val Melaina, Castel Giubileo, Marcigliana, Casal Boccone, Tor San Giovanni —456 324 4 Municipio IV Classificare qui i quartieri Pietralata, Collatino, Ponte Mammolo, San Basilio Classificare qui le zone Settecamini e Tor Cervara Per il quartiere Tiburtino vedi —456322; Per la zona Tor Sapienza vedi —4563246; Per la zona Acqua Vergine vedi —4563248 —456 324 6 Municipio V Classificare qui i quartieri Prenestino Labicano, Prenestino Centocelle, Alessandrino Classificare qui le zone Tor Sapienza, Torre Spaccata Per il quartiere Tiburtino vedi —456322; Per il quartiere Collatino vedi —4563244; Per il quartiere Don Bosco vedi —4563248; Per il quartiere Tuscolano vedi —4563262 -

CIRC. FARMACIA INDIRIZZO C.A.P. TELEFONO FAX E-MAIL I Alicicco S.N.C. V. Tibullo, 4 00193 Roma 06/6876019 06/33661022 Farmaciaa
CIRC. FARMACIA INDIRIZZO C.A.P. TELEFONO FAX E-MAIL MUNICIPIO I I Alicicco s.n.c. V. Tibullo, 4 00193 Roma 06/6876019 06/33661022 [email protected] I Anmig L.tevere Castello, 2 00193 Roma 06/6875352 [email protected] I Baschieri Francesco V. Settembrini, 33 00195 Roma 06/3217496 [email protected] I Bisozzi s.n.c. C.ne Trionfale, 57 00195 Roma 06/39734890 [email protected] I Brienza Giancarlo P.zza Risorgimento, 44 00192 Roma 06/39738166 06/39738183 [email protected] I D'Attilio Aldo V. Oslavia, 66 00195 Roma 06/3612496 06/3612496 [email protected] I De Longis Fausto V. Candia, 30 00192 Roma 06/39742140 06/39742140 [email protected] I Di Gioacchino Giorgio V. Cola di Rienzo, 124 00192 Roma 06/3235371 06/32629175 [email protected] I Ercolani Cristina P.le Clodio, 54 00195 Roma 06/37515007 06/37515007 [email protected] I Eredi Ricci P.zza Cola di Rienzo, 31 00192 Roma 06/3216521 [email protected] I Fargion Gloria s.a.s. V. Cola di Rienzo, 213 00192 Roma 06/3243130 06/3244476 [email protected] I Fettarappa Marina V. Paolucci de' Calboli, 10 00195 Roma 06/3729615 06/33260309 [email protected] Fiorucci - Serraino I s.n.c. V. Brofferio, 55 00195 Roma 06/3729475 06/37513212 [email protected] I Frattura Mario S.A.S. V. Cipro, 42 00136 Roma 06/39722653 [email protected] I Infante Leila P.zza dei Quiriti, 1 00192 Roma 06/3242987 [email protected] Ingria Maria Catena- I Lupoi Chiara S.n.c. -

Atlante Delle Disuguaglianze a Roma
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma ATLANTE DELLE DISUGUAGLIANZE A ROMA A cura di Filippo Celata e Silvia Lucciarini Realizzato in collaborazione con: Dipartimento Metodi e Modelli per Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche l’Economia, il Territorio e la Finanza Università di Roma La Sapienza Università di Roma La Sapienza Ottobre 2016 Introduzione L’impressionante crescita delle disuguaglianze, che riguarda Roma così come molte altre città e regioni nel mondo, è una delle chiavi fondamentali per comprendere l’epoca attuale, i suoi problemi e le possibili soluzioni. E’ questa l’idea dalla quale è scaturito il progetto per la realizzazione di questo Atlante. Nell’Atlante, le diverse dimensioni sociali ed economiche delle disuguaglianze sono intese soprattutto nella loro dimensione territoriale, ovvero per come esse si iscrivono nello spazio urbano e come caratterizzano le diverse zone o quartieri della città dando luogo a squilibri territoriali. Le finalità dell’Atlante sono in primo luogo informative: il lavoro di ricerca è consistito prevalentemente nel reperimento e nell’elaborazione di informazioni statistiche disaggregate e di dati geo-statistici. Lo scopo è presentare tali informazioni, in particolare sotto forma di carte tematiche, per discutere il più ampio insieme di aspetti che hanno a che fare con le condizioni socio-economiche delle varie aree della città, analizzare lo stato attuale e la distribuzione spaziale delle disuguaglianze, le dinamiche che incidono su di esse, in particolare in seguito alla crisi economica. L’obiettivo finale è realizzare un prodotto che evidenzi in modo efficace e sintetico le principali criticità, le loro relazioni reciproche e le loro implicazioni, soprattutto per il sistema delle imprese, e che costituisca uno strumento utile a sostenere le decisioni in ambiti di policy diversi che vanno dalle politiche sociali agli interventi a favore delle imprese, dalla pianificazione spaziale ai programmi di riqualificazione urbana, la gestione dei servizi sanitari, scolastici, di trasporto, ecc.