Studi E Documenti Di Storia Ligure
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
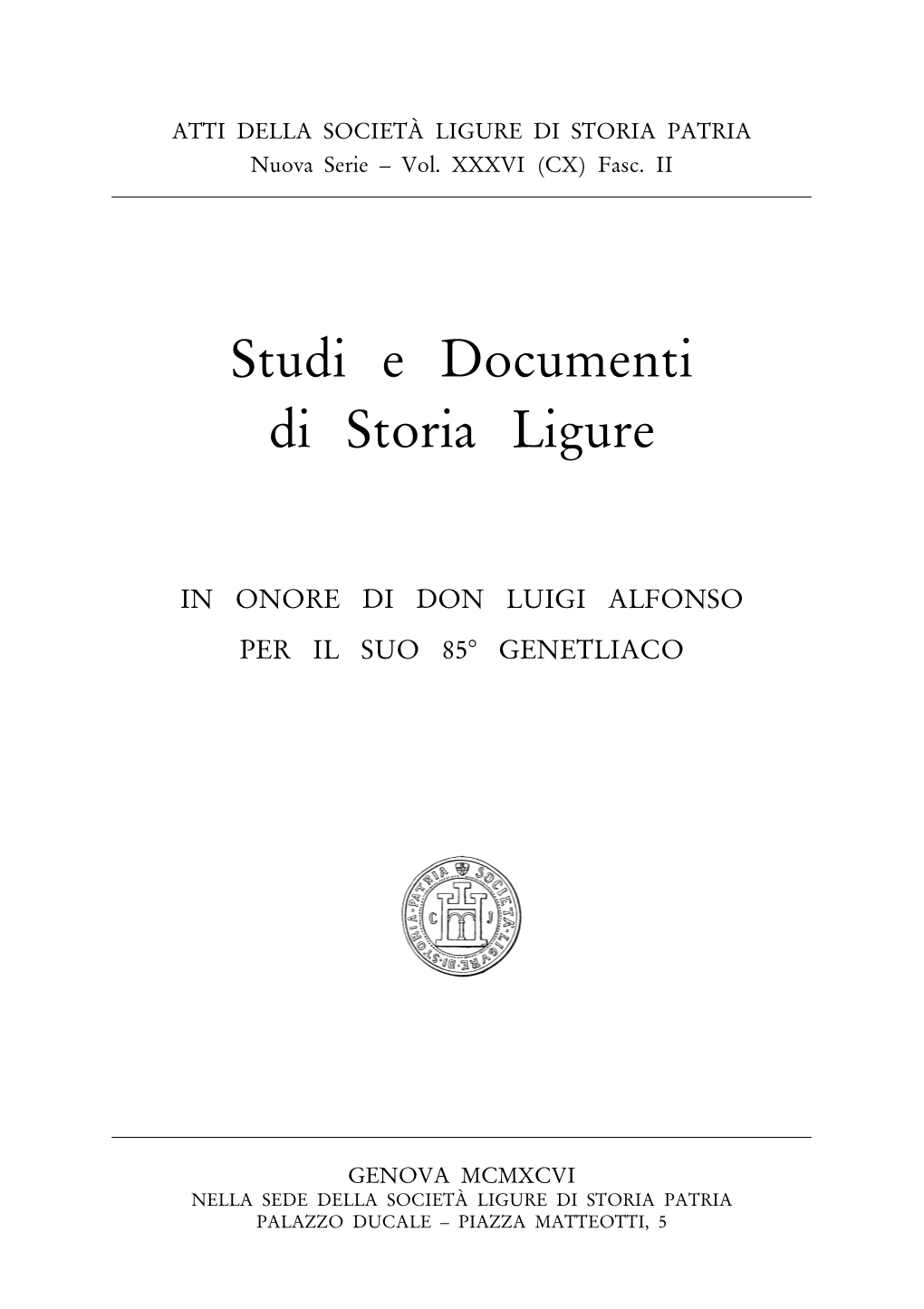
Load more
Recommended publications
-

La Società Ligure Di Storia Patria Nella Storiografia Italiana 1857-2007
ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA Nuova Serie – Vol. L (CXXIV) Fasc. II La Società Ligure di Storia Patria nella storiografia italiana 1857-2007 a cura di Dino Puncuh ** GENOVA MMX NELLA SEDE DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA PALAZZO DUCALE – PIAZZA MATTEOTTI, 5 Indice degli « Atti » (1858-2009) del « Giornale Ligustico » (1874-1898) e del « Giornale storico e letterario della Liguria » (1900-1943) a cura di Davide Debernardi e Stefano Gardini Gli indici che seguono riportano gli scritti editi sulle pubblicazioni periodiche della Società: « Atti della Società Ligure di Storia Patria », 1858-2009 (ASLi,); « Atti della Società Ligure di Storia Patria, serie del Risorgimento », 1923-1950 (ASLi, serie Risorgimento); « Giornale Ligu- stico », 1874-1898 (GL); « Giornale Storico e Letterario della Liguria », 1900-1908, 1925-1943 (GSLL). L’articolazione in più serie all’interno della singola testata è resa dalla sigla n.s.; per agevolare la consultazione, gli ordinali dei singoli volumi e dei loro fascicoli sono resi in nu- meri arabi. Il primo indice riporta gli scritti organizzati in ordine alfabetico per autore; gli scritti anonimi, gli atti congressuali, gli inventari archivistici e le edizioni documentarie costituisco- no voce principale alla stregua degli autori. All’interno della voce di ciascun autore gli scritti sono organizzati secondo il medesimo criterio, con in calce gli opportuni rimandi ad altre voci correlate: altri autori degli scritti in collaborazione, curatele, edizioni documentarie, etc. Ru- briche, rassegne bibliografiche e notizie di altri enti ed istituti sono elencate di seguito. Le rassegne bibliografiche sono ordinate tematicamente; l’indice degli scritti recensiti, attual- mente in fase di compilazione, sarà prossimamente fruibile on-line sul sito della Società. -

Trident and Oar in Bronzino's Portrait of Andrea Doria
Trident and Oar in Bronzino’s Portrait of Andrea Doria JOSEPH ELIAV, Tel Aviv University / University of Haifa Previously unpublished X-ray images prove that in the portrait commissioned for Giovio’s museum, Bronzino painted Andrea Doria holding an oar, not a trident. The article interprets the portrait in its original form. Examination of the portrait together with the eulogy Giovio attached to it shows that Doria is painted as Odysseus, not as Neptune, and explains the incongruous oar. Erotic insin- uations in the portrait suggest that, like Bronzino’s burlesque poetry, it has a hidden meaning. Further analysis in the context of Giovio’s historiography and a precise dating unveil a meaning that criticizes Doria’s incompetence in a recent crucial naval battle. INTRODUCTION IN THE ALLEGORICAL portrait of Andrea Doria (1466–1560) by Agnolo di Cosimo, known as Bronzino (1503–72), the Genovese admiral is standing in the nude onboard a ship holding a trident; he is obviously in the guise of the god of the sea and therefore the painting, now in the Pinacoteca di Brera in Milan, is appropriately known as Portrait of Andrea Doria as Neptune (fig. 1). However, according to a hypothesis accepted with no contention in the research literature, Bronzino painted Doria holding an oar and the trident is a modification effected at a later time;1 and yet, interpretations of the portrait refer mainly to its present form, whereas attempts to understand it in the original form, with the oar, are tentative and inconclusive. The oar hypothesis has, up until now, rested on indirect evidence that is plausible but open to doubt and based on the report of a visual observation that will be shown here to be a simple mistake; and yet the hypothesis is correct in spite of the weak evidence. -

Alma Mater Studiorum – Università Di Bologna
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna DOTTORATO DI RICERCA IN Les Littératures de l’Europe Unie - European Literatures - Letterature dell’Europa Unita Ciclo XXX Settore Concorsuale: 10 F/1 Letteratura italiana, critica letteraria e letterature comparate Settore Scientifico Disciplinare: L-FIL-LET/10 Letteratura italiana Between Epic and History: European epic poems of the XVIth - XVIIth centuries on Lepanto and the Reconquista Presentata da: Maria Shakhray Coordinatore Dottorato Supervisore Prof.ssa Bruna Conconi Prof. Andrea Battistini Co-supervisore Prof.ssa Bruna Conconi Esame finale anno 2018 1 2 Acknowledgements This work became possible due to the support and the precious contributions of many people. First of all, I would like to express my profound gratitude to my supervisor, Prof. Andrea Battistini, for his valuable guidance, his patience and encouragement. I am infinitely grateful for his kind help and support throughout all of these years. I would also like to thank Prof. Anna Soncini for being a crucial presence during my CLE and DESE years. I am particularly grateful to Prof. Bruna Conconi for her encouragement and moral support at all of the most difficult moments. I would also like to thank all the professors of the DESE consortium for their valuable remarks and comments as to the realization of the present research. I would like to express my heartfelt gratitude to Lucia Manservisi for having always helped me to cope with all kinds of practical problems I faced during my years in Bologna. My gratitude is as well extended to Prof. Pedro Ruiz Perez and Prof. Rafael Bonilla Cerezo from the University of Cordova for their help and valuable advice during my stay in Spain. -

Genoa and Its Treasures
Comune di Genova - Ufficio sviluppo e Promozione del Turismo Palazzo delle Torrette - Via Garibaldi, 12r [email protected] www.genova-turismo.it Tourist Information Centres (T.I.C.) IAT Via Garibaldi Useful info: Via Garibaldi 12r Ph. +39 010 55 72 903/ 751 Genoa Aquarium Fax +39 010 55 72 414 www.acquariodigenova.it (7/7 - h. 9.00 - 18.30) C. Colombo Airport [email protected] Ph. +39 010 60 151 - www.airport.genova.it IAT De Ferrari City sightseeing open top bus Largo Pertini 13 Genova in Tour Pesci Viaggi Ph. +39 010 86 06 122 Ph. +39 010 53 05 237 - Mobile +39 328 98 55 419 Fax +39 010 86 06 476 www.pesciviaggi.it (7/7 - h. 9.00 - 13.00 / 14.30 - 18.30) [email protected] Hop-on hop-off city tour CITYSIGHTSEEING GENOVA IAT C. Colombo Airport (arrivals area) Ph. +39 010 86 91 632 Genova - Sestri Ponente www.genova.city-sightseeing.it Ph./Fax +39 010 60 15 247 (7/7 - h. 9.00 - 13.00 / 13.30 - 17.30) Genoa Museums [email protected] www.museidigenova.it - www.rolliestradenuove.it Radio Taxi Walking guided tour to the historical centre Ph. +39 010 5966 - www.cooptaxige.it and the Palazzi dei Rolli, UNESCO World Heritage Visit of the city with little train Every weekend you can visit the historical city Trenino Pippo centre and discover the fascination of some of Ph. +39 328 69 42 944 - www.treninopippo.it the famous Palazzi dei Rolli. Trains More information about costs and languages Ph. -

Andrea Lercari LA NOBILTÀ CIVICA a GENOVA E in LIGURIA DAL
Andrea Lercari LA NOBILTÀ CIVICA A GENOVA E IN LIGURIA DAL COMUNE CONSOLARE ALLA REPUBBLICA ARISTOCRATICA 1 Ogni studioso che si trovi ad affrontare un tema afferente alla storia genovese, sia questo di taglio politico, sia economico, sia ancora storico-artistico o architettonico o urbanistico, deve confron- tarsi con il composito e complesso ceto dirigente che ebbe il control- lo politico e sociale della città dalle origini del Comune, nel XII secolo, a tutta la durata della Repubblica aristocratica, nata nel 1528 e caduta nel 1797. Attraverso un’evoluzione continua e articolata, il gruppo di potere, diviso nelle fazioni cittadine dei guelfi e ghibellini, prima, e dei nobiles e populares, poi, con la riforma costituzionale del 1528 si organizzò in un vero e proprio patriziato sovrano, nel quale confluirono coloro che avevano già acquisito il diritto di parte- cipare all’amministrazione della cosa pubblica. Si era trattato in sostanza di un’operazione di riordino del ceto dirigente cittadino – nel quale erano già riscontrabili tutte le caratteristiche di una vera e propria nobiltà civica – ispirata dalla necessità di porre fine alle lotte di fazione per il controllo della città. 1 Desidero esprimere un sentito ringraziamento per aver favorito la mia partecipazione al convegno Le aristocrazie cittadine. Evoluzione dei ceti dirigenti urbani nei secoli XV-XVIII all’amico Saverio Simi de Burgis, il quale come discendente di una delle famiglie compo- nenti la nobiltà genovese sin dalle sue origini, i Di Negro, condivide l’interesse per le vicen- de del ceto dirigente dell’antica Repubblica di Genova, e a Marino Zorzi e Girolamo Mar- cello del Majno membri del comitato organizzatore del convegno. -

RELATIONS BETWEEN OTTOMAN CORSAIRS and the IMPERIAL NAVY in the 16Th CENTURY
RELATIONS BETWEEN OTTOMAN CORSAIRS AND THE IMPERIAL NAVY IN THE 16th CENTURY MEHMET KURU Submitted to the Graduate School of Arts and Social Sciences in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts Sabancı University June 2009 RELATIONS BETWEEN OTTOMAN CORSAIRS AND THE IMPERIAL NAVY IN THE 16TH CENTURY APPROVED BY: Yrd. Doç Dr. Yusuf Hakan Erdem ………….……………. (Thesis Supervisor) Doç. Dr. Halil Berktay .............……............... Prof. Dr. Tosun Terzioğlu ……............................. DATE OF APPROVAL: 10.08.2009 i © Mehmet Kuru, 2009 All Rights Reserved ii ABSTRACT RELATIONS BETWEEN OTTOMAN CORSAIRS AND THE IMPERIAL NAVY IN THE 16th CENTURY Mehmet Kuru History, M.A. Thesis, Spring 2009 Thesis Supervisor: Y. Hakan Erdem This thesis endeavors to present an analysis of the nature of the relations between ottoman corsairs and the imperial navy in the 16th century. Recruitment of corsairs as naval officers by Ottoman central authority to make up for the insufficient numbers of skilled seamen was presented as a fact in various works. However, there is no study to explain construction period of this relationship and to define the system. This thesis aims to construct a model to explicate this relationship. As of the mid-fifteenth century, Ottoman seapower started to strengthen and Empire conquered several crucial harbors and islands in Black sea and Mediterranean until the end of this century. Ottoman Imperial navy gained a strong infrastructure thanks to these conquests. Apart from Imperial navy, Ottoman corsairs' attacks that were based on these harbors increased and they strengthened gradually. In 1495, an old corsair, Kemal Reis was taken into Ottoman service, thus he became a pioneer for the recruitment of corsairs to Imperial Navy. -

Download Lepanto 1571 Rulebook
A sea turned red by blood Lepanto Sunday, october 7th, 1571 A Rules Acies Edizioni Index 1. THE SYSTEM .................................................1 6.3. Ramming Results ....................................9 1.1. Game Components .................................1 7. GRAPPLING (AND BOARDING) .........................9 1.2. The Map ..................................................1 7.1. Grappling Procedure ...............................9 1.3. The Playing Pieces ..................................2 7.2. Engaged Units .........................................9 1.4. Glossary ..................................................2 8. BOARDING ...................................................10 1.5. Tracks And Logs .....................................3 8.1. Boarding Procedure ..............................10 2. SEQUENCE OF PLAY .......................................3 8.2. Boarding Table Results .........................10 2.1. Game-Turns ............................................3 9. DAMAGE .....................................................10 2.2. Action Phases .........................................3 9.1. Mast Down ...........................................10 2.3. End Turn Phase .......................................3 9.2. Fires Aboard .........................................11 2.4. Special Chits ...........................................4 9.3. Hits ........................................................11 3. MOVEMENT ...................................................4 9.4. Procedure ..............................................11 -

Renaissance Chart Tradition in the Mediterranean Corradino Astengo
7 • The Renaissance Chart Tradition in the Mediterranean Corradino Astengo Introduction coast, and thus sailing them required special techniques and capacities—as Juan de Escalante de Mendoza recog- Medieval nautical charts were adequate for the needs of nized when he distinguished between sailors plotting the navigators of the day, who sailed the Atlantic and courses for coastlines (de costa y derrota) and those for Mediterranean coasts of Europe along well-established deep seas (de altura y escuadría), each group with their routes that were in part determined by the nature of local own skills and aptitudes.5 winds and currents and never led to ships’ losing sight of For more than two centuries the large cities and smaller land for more than two or three days.1 Yet in addition to ports of the Mediterranean continued the medieval tradi- being important working tools, these charts were also the tion of producing manuscript portolan charts and atlases documents that recorded the first achievements of At- organized around the distribution of wind rhumbs.6 lantic exploration, indicating newly discovered archipela- These charts were generally produced in small family gos and the gradually emerging features of the coast of workshops; the traditional art of making charts and im- Africa. Ultimately, the conquest of the oceans made nav- ages for navigation was handed down from generation to igation by the stars a necessity, and thus indications of lat- itude—along with the equator and the Tropics—were Abbreviations used in this chapter include: Carte da navigar for Su- added to the old rhumb line charts, gradually transform- sanna Biadene, ed., Carte da navigar: Portolani e carte nautiche del ing them into flat gridded charts that, even though non- Museo Correr, 1318–1732 (Venice: Marsilio Editori, 1990). -

THE MYTH of LEPANTO and ITS LITERARY REPRESENTATIONS in EUROPEAN EPIC POETRY of the LATE CINQUECENTO-EARLY SEICENTO Maria Shakhray Università Di Bologna
THE MYTH OF LEPANTO AND ITS LITERARY REPRESENTATIONS IN EUROPEAN EPIC POETRY OF THE LATE CINQUECENTO-EARLY SEICENTO Maria Shakhray Università di Bologna RIASSUNTO: Stimolata da fondamentali eventi storici come la guerra d’Oriente e in particolare il suo momento culminante – il leggendario trionfo di Lepanto –, la tradizione epica europea del secondo Cinquecento e primo Seicento subisce profonde trasformazioni. L’adozione stessa dei fatti storici recenti come argomento epico significava una deviazione radicale dal percorso tradizionale in quanto faceva abbandonare agli autori dell’epica eroica “moderna” i modelli classici per avventurarsi in audaci esperimenti poetici. Questo articolo intende analizzare alcuni degli aspetti più importanti privilegiati dagli autori dei tre testi selezionati, appartenenti alla tradizione epica italiana, francese e spagnola: La Christiana vittoria maritima di Francesco Bolognetti, L’Austriade di Pierre de Deimier e La Austríada di Juan Rufo. Il presente saggio è un tentativo di stabilire affinità e differenze semantiche e formali nel discorso poetico della nuova realtà storica, politica, militare e ideologica, esaminando più da vicino la natura dei nuovi fermenti responsabili dell’innovazione profonda di topoi epici tradizionali – il processo che secondo Mikhail Bachtin, costituisce la condizione essenziale per l’evoluzione e per il rinnovamento continuo di ogni genere letterario. PAROLE CHIAVE: Lepanto, storia, mito, crociata, Francesco Bolognetti, Juan Rufo, Pierre de Deimier ABSTRACT: Stimulated by fundamental -

A Complex Diplomatic Mission. Leonardo Donà at the Spanish Court of Philip Ii (1570-1573)
A COMPLEX DIPLOMATIC MISSION. LEONARDO DONÀ AT THE SPANISH COURT OF PHILIP II (1570-1573) Resumen El presente artículo de investigación analiza mediante una metodología cualitativa la etapa entre 1570 y 1573, cuando Leonardo Donà fue embajador de la Serenissima en la corte de Felipe II. En Madrid, el futuro Doge llevó a cabo una acción diplomática delicada y comple- ja. La duración de su embajada coincidió exactamente con los años de la guerra de Chipre y las circunstancias de su misión gravitaron en la órbita de esos eventos. En los tres años que pasó en la corte mantuvo relaciones constantes con el Soberano y su entourage. Entre la constitución de la Liga Santa, la batalla de Lepanto y la paz estipulada por Venecia con el Imperio Otomano sin el conocimiento de los “confederados”, Leonardo Donà ejerció su misión diplomática de manera ejemplar: colocó los intereses de la Serenissima antes de cualquier consideración de naturaleza personal y, con prudencia y astucia, pudo enfrentar la difícil misión de justificar a Filippo II la paz estipulada entre Venecia y la Sublime Puerta. La correspondencia del embajador veneciano de Madrid y dirigida al Senado veneciano está llena de consideraciones políticas de alto valor moral, inspiradas en un alto sentido del deber hacia el Signoria y, sobre todo, dictadas por un conocimiento refinado del arte de la diplomacia. Donà permaneció en Madrid hasta el 17 de septiembre de 1573. Palabras clave Leonardo Donà, Misión diplomática, Felipe II, Corte Española, Liga Santa, Imperio Otomano. Abstract This research article studies through a qualitative methodology perspective the period bet- ween 1570 and 1573, when Leonardo Donà was ambassador of the Serenissima to the court of Philip II. -

Giovanni Andrea Doria: Citizen of Genoa, Prince of Melfi, Agent of King Philip Ii of Spain
CHAPTER THREE GIOVANNI ANDREA DORIA: CITIZEN OF GENOA, PRINCE OF MELFI, AGENT OF KING PHILIP II OF SPAIN Thomas Kirk Giovanni Andrea Doria (1539–1606) was a prominent citizen of the Republic of Genoa as well as Prince of Melfi in the kingdom of Naples. A subject of King Philip II of Spain, King of Naples, Doria was also bound to the Spanish crown through a contractual relationship as naval condottiero, hiring out a number of his vessels to the Spanish and commanding a squadron of galleys on behalf of the king. In this capacity he was very clearly an agent of the King of Spain. Given the importance of the term ‘agent’ in this as in all the contri- butions to this volume, a clear definition of just how the word is used here is in order. Clearly the standard definition of ‘one (. .) who acts for another’ applies to Doria’s contractual relationship with Philip II; Doria provided, commanded and equipped a naval squadron on behalf of the king, following the king’s orders regarding the use of the squad- ron.1 Much honing of that general definition of the agent is necessary, though, regarding both the mechanisms through which agents were able to perform the tasks assigned to them and by which they main- tained or furthered their social condition at the same time. As outlined by Marika Keblusek, both of these things depended on the agent’s abil- ity to develop and fruitfully use a network or networks.2 Such networks are usually associated with the gathering of information, although, as we will see in the case of Giovanni Andrea Doria, they could also per- form an exquisitely political function as well. -

The Spanish Naval High Command in the Early Modern Mediterranean
Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi Sayı II/1 – July 2016, 1-14 COMMANDING THE SEA: THE SPANISH NAVAL HIGH COMMAND IN THE EARLY MODERN MEDITERRANEAN Hüseyin Serdar Tabakoğlu* Abstract The Ottoman and Spanish empires confronted each other in the Mediterranean of the 16th century as formidable sea-powers. The Spanish Monarchy completed the political union in the Iberian Peninsula with the end of Reconquista and moved its forces to the North Africa and thus eventually faced the Ottomans in the region. We should evaluate the rise of the Spanish naval organization in the context of Ottoman-Spanish rivalry. D. García de Toledo who became the Captain-general of the Sea in 1564, realized significant reforms in the Spanish naval organization and the galley fleet, thus he played an important role in the rise of the Spanish sea-power in the way to Lepanto. Keywords: Ottoman, Spain, Mediterranean, sea-power, naval organization, García de Toledo Denize Hükmetmek: Erken Modern Dönem Akdeniz’inde İspanyol Donanma Komutanlığı Özet Osmanlı ve İspanyol İmparatorlukları birer denizgücü olarak 16. Yüzyıl Akdeniz’inde karşı karşıya gelmişlerdi. İber Yarımadası’nda Reconquista’nın tamamlanması ile siyasi birliğini sağlayan İspanyol Monarşisi hâkimiyet sahasını Kuzey Afrika’ya taşımış ve kaçınılmaz olarak Osmanlılarla karşı karşıya gelmişti. İspanyol donanma teşkilatının bu dönemde gösterdiği gelişmeyi Osmanlı-İspanyol rekabeti içinde değerlendirmek gerekir. 1564 yılında İspanyol kadırga filosunun komutanlığına atanan D. García de Toledo donanma teşkilatında ve kadırga filosunda ciddi reformlar gerçekleştirmiş ve İnebahtı’ya giden yolda İspanya’nın Akdeniz’de önemli bir denizgücü haline gelmesinde önemli rol oynamıştı. Anahtar Kelimeler: Osmanlı, İspanya, Akdeniz, denizgücü, donanma teşkilatı, García de Toledo * Research Assistant, Kırklareli University, Faculty of Arts and Sciencens, Department of History.