Relazioni, Abstract
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
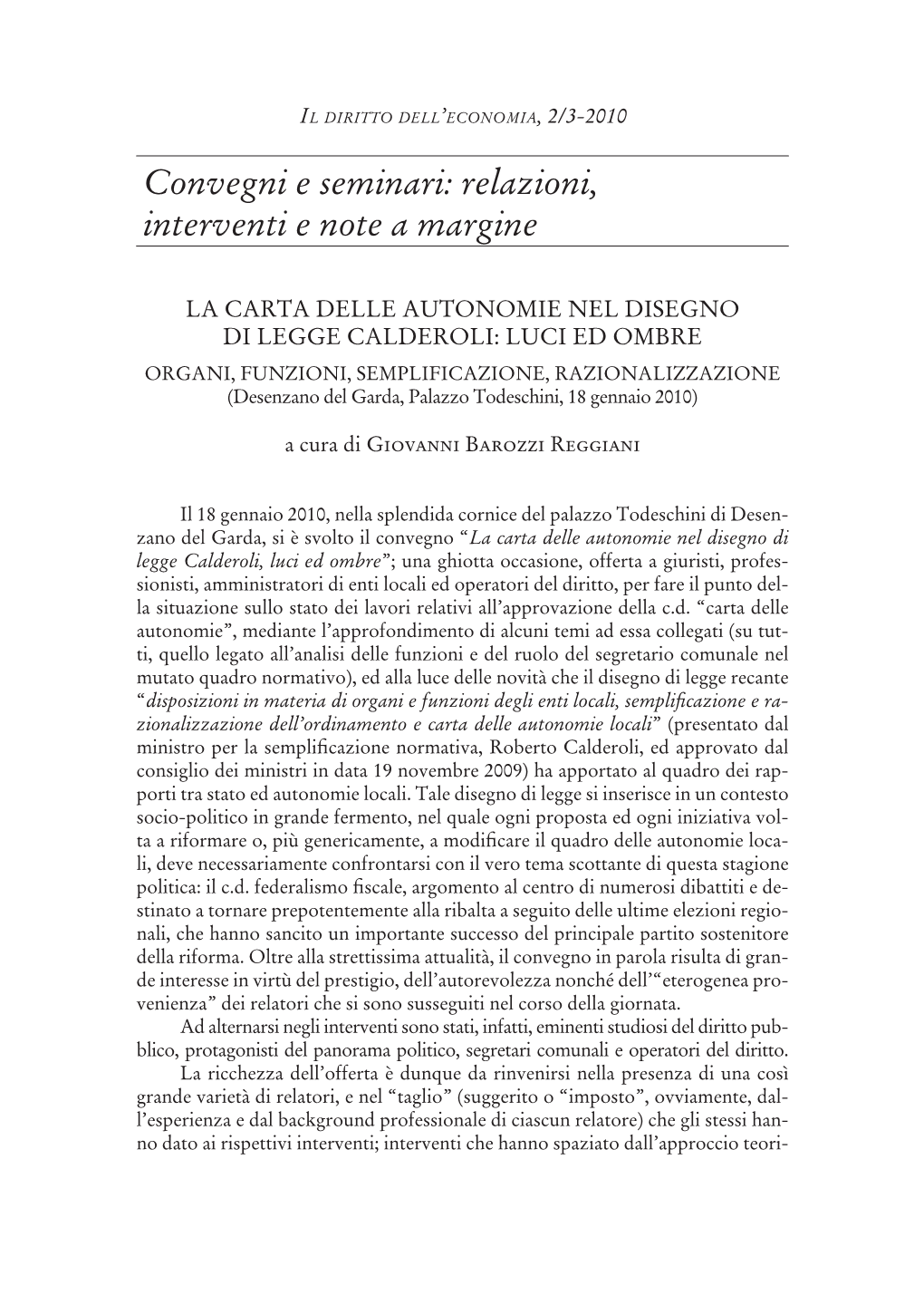
Load more
Recommended publications
-

Abruzzo Camera
ABRUZZO CAMERA Nome e Cognome Luogo e data di nascita 1) Silvio Berlusconi Milano, 29 settembre 1936 2) Gianfranco Fini Bologna, 3 gennaio 1952 3) Maurizio Scelli Sulmona (AQ), 28 febbraio 1961 4) Carla Castellani Rieti, 13 gennaio 1944 5) Sabatino Aracu L’Aquila, 18 agosto 1953 6) Paola Pelino Sulmona (AQ), 20 novembre 1954 7) Marcello De Angelis Roma, 18 febbraio 1960 8) Daniele Toto Roma, 10 ottobre 1972 9) Giovanni Dell’Elce Pescara – 28giugno 1956 10) Lorenzo Sospiri Pescara, 20 marzo 1975 11) Giuseppe Stanziale Cerignola (FG), il 10 agosto 1946 12) Emilio Nasuti Castel Frentano (CH), 21 settembre 1964 13) Luca Ricciuti L’Aquila, 24 gennaio 1966 14 Etelwardo Sigismondi Vasto, 29 settembre 1974 BASILICATA CAMERA Nome e Cognome Luogo e data di nascita 1) Silvio Berlusconi Milano – 29 settembre 1936 2) Gianfranco Fini Bologna – 3 gennaio 1952 3) Donato Lamorte Rionero in Vulture (PZ) – 1 marzo 1931 4) Vincenzo Taddei Castelmezzano (PZ) – 3 giugno 1958 5) Rocco Giuseppe Moles Potenza – 7 gennaio 1967 6) Mariano Antonio Pici Lauria (PZ) – 1 gennaio 1962 CALABRIA CAMERA Nome e Cognome Luogo e data di nascita 1) SILVIO BERLUSCONI Milano, 29 settembre 1936 2) GIANFRANCO FINI Bologna, 3 gennaio 1952 3)FRANCESCO NUCARA Reggio di Calabria, 3 aprile 1940 4) SANTO VERSACE Reggio di Calabria, 2 gennaio 1945 5) GIOVANNI DIMA Corigliano Calabro (CS), 22 settembre 1959 6) GIANCARLO PITTELLI Catanzaro, 9 febbraio 1953 7) JOLE SANTELLI Cosenza, 28 dicembre 1968 8) ANGELA NAPOLI Varallo (VC), 26 novembre 1945 9) CONSOLATA GOLFO detta “LELLA” Reggio -

Qui Comincia L'avventura... Elezioni Politiche 2013
Qui comincia l'avventura... Elezioni politiche 2013 A cura di Corrado Bevilacqua I libri di Belfagor Corradobevilacqua.wordpress.com Premessa I nostri politici, infatti, sono usi a dare il peggio di se stessi proprio in campagna elettorale. Vediamoli all'ora all'opera. Chi non fosse interessato alla cosa, può saltare piè pari alla seconda e terza parte dove si parla dei problemi dei quali non si parlerà in campagna elettorale o se ne parlerà per slogan. Se il buon giorno di vede dal mattino... "Discussione con Lega ancora in corso. Alcune importanti questioni, però, non ci convincono e potrebbero indurci a separare nostro percorso", scrive il segretario del Pdl Angelino Alfano su Twitter. Le parole di Alfano arrivano al termine di un vertice fra Pdl e Lega nella residenza milanese di via Rovani di Silvio Berlusconi. Presente, per il Carroccio, il responsabile organizzativo Roberto Calderoli, che ha raggiunto Berlusconi, Alfano, Formigoni e Verdini che erano già presenti per il pranzo. Assente il segretario della Lega Roberto Maroni, che via Twitter ha fatto sapere di essere in via Bellerio al lavoro per la campagna elettorale. Calderoli ha lasciato dopo circa due ore la residenza milanese di Berlusconi. L'ex ministro, si legge in un lancio Ansa, unico esponente della Lega presente, non ha rilasciato dichiarazioni. La richiesta di un'alleanza in Lombardia prima di discutere di quella (eventuale) sul piano nazionale e anche il no, ribadito ancora, a una premiership di Silvio Berlusconi sarebbero i principali punti di divergenza fra la Lega e il Pdl. L'incontro di oggi a Milano, in via Rovani, ha rimandato ancora le decisioni di "qualche giorno": al Pdl non sarebbe nemmeno piaciuta l'impuntatura di Maroni su una condivisione totale del programma legato alla sua candidatura lombarda. -

Statuto E Attività 1962-2012
ISTITUTO PER LA DOCUMENTAZIONE E GLI STUDI LEGISLATIVI Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica STATUTO E ATTIVITÀ 1962-2012 JOVENE EDITORE NAPOLI 2012 ISLE Via del Plebiscito 102 - 00186 ROMA Tel. 06 679 5142 - Fax 06 679 3449 [email protected] DIRITTI D’AUTORE RISERVATI © Copyright 2012 ISBN 978-88-243-2109-9 JOVENE EDITORE Via Mezzocannone 109 - 80134 NAPOLI NA - ITALIA Tel. (+39) 081 552 10 19 - Fax (+39) 081 552 06 87 web site: www.jovene.it e-mail: [email protected] Printed in Italy Stampato in Italia ISTITUTO PER LA DOCUMENTAZIONE E GLI STUDI LEGISLATIVI Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica UFFICIO DI PRESIDENZA Presidente Onorario Antonio Maccanico Presidente Giovanni Pieraccini Vicepresidenti In rappresentanza In rappresentanza dei Soci ordinari: dei Soci collettivi: Augusto Barbera Giuseppe Mazzei Francesco D’Onofrio Segretario Generale Silvio Traversa Consiglio Direttivo Augusto Barbera A.B.I. Francesco D’Onofrio Domenico Siniscalco ASSOGESTIONI Gaetano Gifuni Alessandro Rossi Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene s.r.l. Giuseppe Guarino Giuseppe Mazzei Il Chiostro Vincenzo Lippolis ENEL Antonio Maccanico GRUPPO FERROVIE DELLO STATO Donato Marra Giovanni Ialongo Massimo Sarmi Giovanni Pieraccini POSTE ITALIANE S.P.A. Massimo Scioscioli Gaetano Blandini Paolo Agoglia Elisabetta Serafin SIAE Franco Bernabé Silvio Traversa TELECOM ITALIA Ugo Zampetti UNICREDIT Tesoriere Massimo Scioscioli Revisori dei Conti Gaetano De Vito - Sebastiano Piana - Francesco Sposato INDICE GIOVANNI PIERACCINI, Presentazione.................................................................. p. 7 SILVIO TRAVERSA, Introduzione........................................................................... » 11 ANTONIO MACCANICO, La nascita dell’ISLE ...................................................... » 15 ANTIGONO DONATI, I primi quindici anni dell’ISLE......................................... » 19 GIULIANO AMATO, La Scuola di Scienza e Tecnica della Legislazione.............. -

Governo Berlusconi Iv Ministri E Sottosegretari Di
GOVERNO BERLUSCONI IV MINISTRI E SOTTOSEGRETARI DI STATO MINISTRI CON PORTAFOGLIO Franco Frattini, ministero degli Affari Esteri Roberto Maroni, ministero dell’Interno Angelino Alfano, ministero della Giustizia Giulio Tremonti, ministero dell’Economia e Finanze Claudio Scajola, ministero dello Sviluppo Economico Mariastella Gelmini, ministero dell’Istruzione Università e Ricerca Maurizio Sacconi, ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali Ignazio La Russa, ministero della Difesa; Luca Zaia, ministero delle Politiche Agricole, e Forestali Stefania Prestigiacomo, ministero dell’Ambiente, Tutela Territorio e Mare Altero Matteoli, ministero delle Infrastrutture e Trasporti Sandro Bondi, ministero dei Beni e Attività Culturali MINISTRI SENZA PORTAFOGLIO Raffaele Fitto, ministro per i Rapporti con le Regioni Gianfranco Rotondi, ministro per l’Attuazione del Programma Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione e l'Innovazione Mara Carfagna, ministro per le Pari opportunità Andrea Ronchi, ministro per le Politiche Comunitarie Elio Vito, ministro per i Rapporti con il Parlamento Umberto Bossi, ministro per le Riforme per il Federalismo Giorgia Meloni, ministro per le Politiche per i Giovani Roberto Calderoli, ministro per la Semplificazione Normativa SOTTOSEGRETARI DI STATO Gianni Letta, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le funzioni di segretario del Consiglio medesimo PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Maurizio Balocchi, Semplificazione normativa Paolo Bonaiuti, Editoria Michela Vittoria -

“Autodromo Del Veneto”
"Pensare globalmente, agire localmente" elaborato dal circolo Legambiente “Il Tiglio” - Vigasio (VR) iltiglio.altervista.org DOSSIER “AUTODROMO DEL VENETO” …… ccoonntttrrroo cchhiii ssootttttteerrrrrraa lllaa ccoosscciiieennzzaa nneelll cceemmeenntttoo !!! SOMMARIO PREMESSA 1. CRONACA DI UN SACCHEGGIO ANNUNCIATO 2. SOGGETTI ECONOMICI, POLITICI, SOCIALI COINVOLTI 3. PROGETTI SIMILI IN ITALIA 4. STATO ED EVOLUZIONE DELL’OPERAZIONE 5. RIFERIMENTI NORMATIVI 6. VALUTAZIONE ECONOMICA E OCCUPAZIONALE (costi / benefici sociali – Redditività finanziaria) 7. MOTIVI DI OPPOSIZIONE 8. PROPOSTE ALTERNATIVE SOSTENIBILI 9. PAROLE IN LIBERTA’ Per informazioni e rassegna stampa: iltiglio.altervista.org prima edizione: Luglio 2005 1 di 55 Edizione del: 03/05/2016 dossier_autodromo.doc © by Circolo Legambiente “Il Tiglio” – Vigasio (VR) PREMESSA (cfr. osservazioni alla var. 3 PAQE) L’economia italiana attraversa una grave crisi e di conseguenza si prospetta il declino anche del modello di sviluppo, basato sulla quantità e riduzione dei costi di produzione, che l’ha sostenuta negli ultimi 50 anni. Come evidenziato dagli osservatori economici, le strade da percorrere iniziano da un nuovo modello, che abbia come cardini la ricerca, l’innovazione del prodotto, la qualità e richiedono attenta programmazione e sinergia tra tutti gli attori economici (amministrazioni pubbliche, investitori, imprenditori, commercianti, consumatori). In particolare, in campo agroalimentare, se da un lato non sembra avere futuro la concorrenza con i paesi emergenti sul fronte quantità / prezzo, molto promettenti sono i risultati e le prospettive nel campo della ricerca di qualità in quella che viene chiamata “agricoltura sostenibile”, che passa attraverso la valorizzazione del prodotto tipico e locale, la riscoperta delle varietà autoctone e dei cibi tradizionali, la diversificazione dei prodotti e/o dei loro utilizzi (es. -

The Persistence of Corruption in Italy
The Persistence of Corruption in Italy: Politicians and the Judiciary since Mani Pulite Raffaele Asquer Department of Political Science University of California, Los Angeles Paper prepared for the WPSA 2013 ANNUAL MEETING March 28th, 2013 PRELIMINARY DRAFT – PLEASE DO NOT CITE OR CIRCULATE 1 Abstract Starting in 1992, the Mani Pulite (“Clean Hands”) anti-corruption campaign promised to eradicate corruption from Italian political life. For a brief, yet intense period, the public rallied behind the prosecutors, and punished the allegedly corrupt politicians and parties at the polls. However, twenty years later, Italy is still ranked as highly corrupt by Western standards. Why, then, did the Mani Pulite campaign fail to have a long-lasting effect? Relying on original data on the anti-corruption investigations in Milan, as well as on a variety of datasources from the existing literature, this paper argues, first, that the investigations left essentially untouched entire parts of the country where corruption was widespread. Overall, the Mani Pulite campaign had limited deterring effects because judicial inquiries were obstructed by the statute of limitations, and even in case of conviction the sentences were generally mild. Second, the paper finds that the structures of corruption networks have changed since the Mani Pulite season, becoming less vulnerable to further judicial inquiries. There now seem to be multiple sites for corrupt transactions, somewhat dispersed throughout the political system, whereas in the past such activities were centrally managed by a cartel of parties. We reach this conclusion by combining evidence from the literature with original data on two subnational legislatures, the Regional Council of Campania (1992-94) and the Regional Council of Lombardy (2010-12) in which political malfeasance in general seemed widespread. -

La Politica Estera Dell'italia. Testi E Documenti
AVVERTENZA La dottoressa Giorgetta Troiano, Capo della Sezione Biblioteca e Documentazione dell’Unità per la Documentazione Storico-Diplomatica e gli Archivi ha selezionato il materiale, redatto il testo e preparato gli indici del presente volume con la collaborazione della dott.ssa Manuela Taliento, del dott. Fabrizio Federici e del dott. Michele Abbate. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI UNITÀ PER LA DOCUMENTAZIONE STORICO-DIPLOMATICA E GLI ARCHIVI 2005 LA POLITICA ESTERA DELL’ITALIA TESTI E DOCUMENTI ROMA Roma, 2009 - Stilgrafica srl - Via Ignazio Pettinengo, 31/33 - 00159 Roma - Tel. 0643588200 INDICE - SOMMARIO III–COMPOSIZIONE DEI GOVERNI . Pag. 3 –AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI . »11 –CRONOLOGIA DEI PRINCIPALI AVVENIMENTI CONCERNENTI L’ITALIA . »13 III – DISCORSI DI POLITICA ESTERA . » 207 – Comunicazioni del Ministro degli Esteri on. Fini alla Com- missione Affari Esteri del Senato sulla riforma dell’ONU (26 gennaio) . » 209 – Intervento del Ministro degli Esteri Gianfranco Fini alla Ca- mera dei Deputati sulla liberazione della giornalista Giulia- na Sgrena (8 marzo) . » 223 – Intervento del Ministro degli Esteri on. Fini al Senato per l’approvazione definitiva del Trattato costituzionale euro- peo (6 aprile) . » 232 – Intervento del Presidente del Consiglio, on. Silvio Berlusco- ni alla Camera dei Deputati (26 aprile) . » 235 – Intervento del Presidente del Consiglio on. Silvio Berlusco- ni al Senato (5 maggio) . » 240 – Messaggio del Presidente della Repubblica Ciampi ai Paesi Fondatori dell’Unione Europea (Roma, 11 maggio) . » 245 – Dichiarazione del Ministro degli Esteri Fini sulla lettera del Presidente Ciampi ai Capi di Stato dei Paesi fondatori del- l’UE (Roma, 11 maggio) . » 247 – Discorso del Ministro degli Esteri Fini in occasione del Cin- quantesimo anniversario della Conferenza di Messina (Messina, 7 giugno) . -

Top News Finanza Locale
TOP NEWS FINANZA LOCALE TOP NEWS FINANZA LOCALE 26/08/2011 Corriere della Sera - NAZIONALE 4 «È poco credibile» I difetti della manovra secondo Confindustria 26/08/2011 Il Sole 24 Ore 6 SULLE NUOVE ENTRATE PARTITA DA 30 MILIARDI 26/08/2011 Il Sole 24 Ore 10 Le case rurali senza certezze 26/08/2011 Il Sole 24 Ore 11 Vincolo dei cinque anni da superare 26/08/2011 Il Sole 24 Ore 12 Case rurali al cambio catastale 26/08/2011 Il Sole 24 Ore 14 Imu potenziata e anticipata al 2012 26/08/2011 Il Sole 24 Ore 15 Calderoli-Alemanno, lite sui debiti di Roma 26/08/2011 La Repubblica - Bologna 16 "Noi sindaci in trincea contro questa manovra iniqua e insostenibile" 26/08/2011 La Repubblica - Torino 18 I sindaci dei piccoli Comuni bocciano la proposta Calderoli 26/08/2011 La Repubblica - Nazionale 19 Berlusconi e la tentazione del video-appello "Ma prima un compromesso con Umberto" 26/08/2011 La Stampa - NAZIONALE 21 I mini-Comuni attaccano Tremonti 26/08/2011 Il Messaggero - Nazionale 22 Aumento dell'Iva, no di Tremonti primo stop al taglio delle Province 26/08/2011 Il Messaggero - Nazionale 23 Un tesoretto da 160 milioni a favore dei Comuni del Nord a disposizione di Brancher 26/08/2011 Avvenire - Nazionale 24 IMMOBILI P.A. 26/08/2011 Avvenire - Nazionale 25 «Evasione, basta schizofrenie» 26/08/2011 Libero - Nazionale 28 Il Pdl tenta il Cav: tagliamo del 25% i dipendenti pubblici 26/08/2011 ItaliaOggi 30 Bilanci senza più proroghe 26/08/2011 ItaliaOggi 31 Sponsor, enti più liberi 26/08/2011 ItaliaOggi 32 Spese in chiaro, un circolo vizioso 26/08/2011 -

Npagosto10 Copy.Indd
Italian-Australian monthly/mensile uovo$2.50 Print Post Approved PP535216/00031 paese agosto 2010 * La crisi dilaga ma gli elettori vanno a destra? p18 * L’acqua è un diritto umano p7 I bisogni della gente BOMBE A GRAPPOLO: Il mondo le mette al bando Dopo anni di discussioni e negoziati, entra in vigore dal primo agosto la Convenzione sulle munizioni cluster (Ccm), un trattato internazionale che mette al bando le cosiddette «cluster bombs», le bombe a grappolo che hanno fatto migliaia di vittime civili negli ultimi anni. Una grande vittoria per la comunità internazionale e le vittime di queste armi disumane, grazie agli sforzi della Cluster munition coalition (Cmc) e altre associazioni umanitarie. Fra gli obblighi vincolanti per gli stati aderenti vi sono: la distruzione entro 8 anni degli stock di bombe a grappolo, l’assistenza alle comunità e alle vittime delle bombe per un reinserimento nella società, l’identificazione e la bonifica entro 10 anni delle zone inquinate da bombe a grappolo, e l’assistenza ai paesi che necessitano aiuto per la distruzione degli stock e la bonifica dei terreni. Naturalmente, sotto la convenzione, le nazioni aderenti non potranno più usare né produrre questo tipo di bomba, considerata anche più letale delle mine anti-uomo. Le bombe cluster, per la loro forma e il colore, sono spesso scambiate dai bambini per giocattoli: il risultato è che fra le vittime civili almeno un terzo sono minori, secondo quanto riportato dalla Cluster munition coalition (Cmc). Eppure i principali paesi produttori e utilizzatori (Stati uniti, Cina, Russia, Israele, India e Pakistan) non hanno aderito, rendendo meno efficaci i benefici della convenzione. -
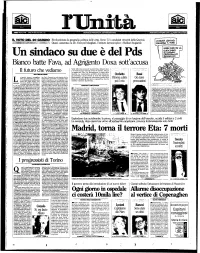
Un Sindaco Su Due È Del Pds CSSSCCRAAMJO Aertiss
@nci TUnità Consorzio Cooperative Abitazione ANNO TP, N• 1 «** SPCD. IN AMI. *©ST. ó*. 1 rro GIORNALE FONDATO DA ANTONIO GRAMSCI IL VOTO DEL 20 GIUGNO Rivoluzionata la geografìa politica delle città. Sono 72 i candidati vincenti della Quercia SMB^^^^BS^S^^^^^ Quasi «azzerata» la De. Exit poli sbagliati, l'istituto demoscopico: «Siciliani bugiardi» GOMMERSe IL -**b 1, VORRÀ* WRGCHE UÀ, 4 (SU ORASSI _ Un sindaco su due è del Pds CSSSCCRAAMJO aertiss. HO Bianco batte Fava, ad Agrigento Doxa sott'accusa Nelle 122 città con più di quindicimila abitanti dove si è votato hanno vinto 72 sindaci di sinistra, 56 con Il futuro che vediamo la tessera del Pds. Nel Mezzogiorno il pieno della WALTER VELTRONI Quercia. La «catastrofica» sconfitta della Democra zia Cristiana: c'è chi chiede la testa del segretario Occhelto Bossi a grande, strana e coraggiosa mo Fiat». È questa la mala pianta che ha Martinazzoli. Ad Agrigento clamoroso errore della Italia sta costruendo il suo futu disseminato di sconfitte il cammino della Doxa che sbaglia gli exit poli e si giustifica: «hanno Riforma subito Ora temo ro. Le macerie del vecchio sono sinistra. Castellani, e non un leghista, è sin mentito i siciliani». E polemica. ormai alle nostre spalle, testi- daco a Torino perché in quella città, come poi il voto provocazioni maa^L^ monianza fredda e dolorosa di a Belluno, la sinistra ha saputo conquistare un mondo che non deve torna e attrarre posizioni di centro. E questo 6 il re, che non tornerà. Agli italiani si e offerta dato che unifica i risultati. -

PROGETTO NAZIONALE PROMETEO Per Il Libero Accesso Universitario
PROGETTO NAZIONALE PROMETEO per il libero accesso universitario Associazione Demokratìa, www.progettonazionaleprometeo.org sede nazionale: Torino Via Bossi n. 1 - 10144 Torino [email protected] Tel e Fax. 011-488835; cell 329-9386454 Direttore: Dott. Massimo Citro PROTOCOLLO DI PROPOSTA PER IL GOVERNO Al Presidente della Repubblica, On. Giorgio Napolitano, al Presidente del Consiglio, On. Silvio Berlusconi, al Presidente della Camera, On. Gianfranco Fini, al Presidente del Senato, On. Renato Schifani, ai Sottosegretari di Stato, On. Gianni Letta, On. Paolo Bonaiuti, On. Gianfranco Miccichè, On. Carlo Giovanardi, On. Michela Vittoria Brambilla, On. Aldo Brancher, On. Rocco Crimi, On. Maurizio Balocchi, On. Guido Bertolaso, al Ministro degli Affari Esteri, On. Franco Frattini, al Ministro dell’Interno, On. Roberto Maroni, al Ministro della Giustizia, On. Angelino Alfano, al Ministro della Difesa, On. Ignazio La Russa, al Ministro dell’Economia e Finanze, On. Giulio Tremonti, al Ministro dello Sviluppo Economico, On. Claudio Scajola, al Ministro delle Politiche Agricole, On. Luca Zaia, al Ministro dell’Ambiente, On. Stefania Prestigiacomo, al Ministro delle Infrastrutture,On. Altero Matteoli, al Ministro del Lavoro Salute e Politiche sociali, On. Maurizio Sacconi, al Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca, On. Mariastella Gelmini, al Ministro dei Beni Culturali, On. Sandro Bondi, al Ministro delle Pari Opportunità, On. Mara Carfagna, al Ministro della Gioventù, On. Giorgia Meloni, al Ministro dell’Amministrazione e Innovazione On. Renato Brunetta, al Ministro delle Riforme per il Federalismo, On. Umberto Bossi, al Ministro dei Rapporti col Parlamento, On. Elio Vito, al Ministro delle Politiche Europee, On. Andrea Ronchi, al Ministro dei Rapporti con le Regioni, On. -

Rivista N°: 2/2011 Data Pubblicazione: 14/06/2011
RIVISTA N°: 2/2011 DATA PUBBLICAZIONE: 14/06/2011 Chiara Rivadossi Dottoranda in Diritto costituzionale italiano ed europeo Università degli Studi di Verona LA VICENDA DEL MINISTRO BRANCHER Il 18 giugno 2010 la Presidenza del Consiglio dei Ministri rendeva nota l’intenzione di voler provvedere alla nomina a Ministro senza portafoglio dell’onorevole dottor Aldo Brancher, già Sottosegretario alla semplificazione normativa, nonché di conferirgli “la delega per tutti gli adempimenti relativi alla pratica e concreta attuazione del Federalismo amministrativo e fiscale”1. Lo stesso giorno facevano quindi seguito il decreto del Presidente della Repubblica2 e quello di delega delle funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri3. Con la nomina dell’on. Aldo Brancher veniva istituito il 24° Ministro del IV Governo Berlusconi. La regolamentazione della materia del federalismo fiscale risultava così affidata al coordinamento delle competenze di tale nuovo Ministro con quelle, in particolare, dell’on. Calderoli, Ministro senza portafoglio per la semplificazione normativa, dell’on. Umberto Bossi, Ministro senza portafoglio per le riforme per il federalismo e, infine, dell’on. Raffaele Fitto, Ministro senza portafoglio per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale4. Tale circostanza veniva fatta oggetto di dure critiche: in particolare, la creazione di un nuovo Ministero, in un ambito materiale per altro già occupato da altri esponenti dell’Esecutivo, risultava contraddittoria con gli intendimenti espressi dal Governo caratterizzati da significativi tagli alla spesa pubblica5. Inoltre, mentre si creava un nuovo Ministero, continuava l’interim al Presidente del Consiglio di quello dello sviluppo economico detenuto sin dal 5 maggio 2010, data delle dimissioni dell’on.