Nuova Corvina Numero 31 (2018.)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more
Recommended publications
-

Cuadernos Hispanoamericanos
„ Cuadernos Hispanoamericanas 1 L^r ^ n 532 Eduardo Rosenzvaig El Chaco: Una física de los espacios monstruosos Rafael Gutiérrez Girardot Los Ditirambos de Dyonisos de Nietzsche José Miguel Oviedo La poesía peruana actual Ana María Diez y Jesús Díaz Armas La Epístola satírica y censoria de Quevedo Textos sobre Borges, Onetti, Machado, Miguel Hernández, Julián Ríos, Luis Landero, Benedetti y Juan Gelman Cuadernos anoamencanos iir "-— HAN DIRIGIDO ESTA PUBLICACIÓN Pedro Laín Entralgo Luis Rosales José Antonio Maravall DIRECTOR Félix Grande SUBDIRECTOR Blas Matamoro REDACTOR JEFE Juan Malpartida SECRETARIA DE REDACCIÓN María Antonia Jiménez SUSCRIPCIONES Maximiliano Jurado Teléf.: 583 83 96 REDACCIÓN Instituto de Cooperación Iberoamericana Avda. de los Reyes Católicos, 4 - 28040 MADRID Teléfs.: 583 83 99 - 583 84 00 - 583 84 01 DISEÑO Manuel Ponce IMPRIME Gráficas 82, S.L. Lérida, 41 - 28020 MADRID Depósito Legal: M. 3875/1958 ISSN: 00-11250-X - ÑIPO: 028-94-003-9 fnigpanoamcricanog) 532 Invenciones y ensayos 7 El Chaco: una física de los espacios monstruosos EDUARDO ROSENZVAIG 31 La Epístola satírica y censoria de Quevedo ANA MARÍA DÍEZ BENÍTEZ JESÚS DÍAZ ARMAS 45 Las trampas JUAN GRACIA ARMENDÁRIZ 53 Padres pródigos e hijos fecundos JOSÉ MIGUEL OVIEDO 69 Los Ditirambos de Dyonisos de Nietzsche RAFAEL GUTIÉRREZ GIRARDOT 85 Los poemas del padre ALEJANDRO LÓPEZ ANDRADA 7 X La muerte silenciada JOSÉ MARTÍNEZ HERNÁNDEZ Lecturas 109 En defensa de un rescate FRANCISCO JOSÉ CRUZ PÉREZ 532 /Hispanoamericanos) 115 Historia y leyenda del cante flamenco JOSÉ MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 118 Cuentos de Juan Carlos Onetti EDUARDO TIJERAS 121 Julián Ríos y Eduardo Arroyo: transformaciones para Alicia NILO PALENZUELA 123 Reedición de Morínigo FRANCISCO MORENO FERNÁNDEZ 126 Antonio Machado hoy, siempre y todavía JOSÉ CARLOS MAINER 130 La estética de Luis Landero LUIS BELTRÁN ALMERÍA 133 La narrativa breve de Mario Benedetti NELSON MARRA 138 Nueva crítica sobre Miguel Hernández RAMÓN F. -

Saverio Strati Voce Di Un Sud Umile E Dignitoso
@Documento elettronico rilasciato per uso personale. DRM - 08b4908d2f8c6298573218d6ac83f01a77f7f2bc40ad9d8285f42f6029593b8b963f72125731019fea271b8b873f6b39112e8d57767e5ea5378b2cdf6b9852b9 SABATO 12 APRILE 2014 LA SICILIA ggi Cultura .23 IL PREMIO LETTERARIO MORTA LA SCRITTRICE INGLESE I 12 in gara per lo «Strega» Townsend, «madre» di Adrian Mole Il Comitato direttivo del Premio Strega presieduto da Tullio De Mauro (nella foto) ha È morta a 68 anni Sue Townsend, la scrittrice britannica creatrice del personaggio selezionato i dodici libri in gara nel 2014. «Abbiamo constatato una qualità alta e di Adrian Mole, al centro di numerosi romanzi e di serie televisive. Si è spenta a l’emergere di temi legati sia alla ricostruzione storica sia ai dilemmi della nostra coscienza seguito di una breve malattia. Townsend aveva perso la vista negli anni ‘80 a di fronte al mondo contemporaneo» spiega De Mauro. «Abbiamo anche alcune novità: un causa del diabete. Divenne celebre nel 1982 dopo la pubblicazione del romanzo graphic novel e forme letterarie sperimentali». Ecco i libri candidati: «Non dirmi che hai «Il diario segreto di Adrian Mole, Anni 13 e 3/4», sulla tribolazioni, i sogni e le paura» (Feltrinelli) di Giuseppe Catozzella, presentato da Giovanna Botteri e Roberto delusioni di un adolescente. Considerato l’enorme successo del primo volume, ha Saviano; «Lisario o il piacere infinto delle donne» (Mondadori) di Antonella Cilento (Nadia continuato a scrivere la vita di Adrian Mole, rappresentandola fino all’età adulta, Fusini e Giuseppe Montesano); «Bella mia» (Elliot) di Donatella Di Pietrantonio (Antonio in molti altri volumi. Oltre a parlare della vita di Adrian, Townsend descrisse la Debenedetti e Maria Ida Gaeta); «Una storia» (Coconino Press) di Gipi (Nicola Lagioia e situazione sociale e politica in Gran Bretagna, con particolare riferimento alla Sandro Veronesi); «Come fossi solo» (Giunti) di Marco Magini (Maria Rosa Cutrufelli e Piero sinistra politica negli anni ottanta, nell’epoca thatcheriana. -
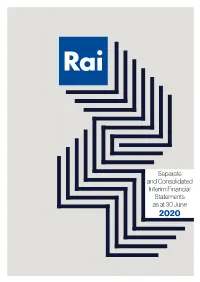
Separate and Consolidated Interim Financial Statements As at 30 June 2020
Separate and Consolidated Interim Financial Statements as at 30 June 2020 Separate and Consolidated Interim Financial Statements as at 30 June 2020 Contents 7 Introduction 17 Report on Operations 171 Interim Separate Financial Statements as at 30 June 2020 239 Interim Consolidated Financial Statements as at 30 June 2020 303 Corporate Directory 4 Contents Introduction 7 Corporate Officers 8 Organisational Structure 9 Introduction from the Chairman of the Board of Directors 11 Financial Highlights 12 Report on Operations 17 Mission 18 Market scenario 18 The Rai Group 24 Television 41 Radio 97 RaiPlay and Digital 107 Public broadcasting service function 116 TV production 119 Technological activities 120 Transmission and distribution activities 129 Sales activities 130 Other activities 135 Changes in the regulatory framework 143 Corporate governance 148 Corporate Governance Report - the Rai Control Governance Model and the Internal Control and Risk Management System (SCIGR) 150 Other information 155 Human Resources and Organisation 155 Safety & Security 159 Intercompany Relations 161 Significant events occurring after 30 June 2020 168 Outlook of operations 168 5 Interim Separate Financial Statements as at 30 June 2020 171 Analysis of the results and performance of operating results, financial position and cash flows for the first half of 2020 172 Financial Statements of Rai SpA 186 Notes to the Interim Separate Financial Statements as at 30 June 2020 191 Certification pursuant to article 154-bis of Italian Legislative Decree 58/98 235 Independent -

History and Emotions Is Elsa Morante, Goliarda Sapienza and Elena
NARRATING INTENSITY: HISTORY AND EMOTIONS IN ELSA MORANTE, GOLIARDA SAPIENZA AND ELENA FERRANTE by STEFANIA PORCELLI A dissertation submitted to the Graduate Faculty in Comparative Literature in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, The City University of New York 2020 © 2020 STEFANIA PORCELLI All Rights Reserved ii Narrating Intensity: History and Emotions in Elsa Morante, Goliarda Sapienza and Elena Ferrante by Stefania Porcell i This manuscript has been read and accepted for the Graduate Faculty in Comparative Literature in satisfaction of the dissertation requirement for the degree of Doctor of Philosophy. ________ ______________________________ Date [Giancarlo Lombardi] Chair of Examining Committee ________ ______________________________ Date [Giancarlo Lombardi] Executive Officer Supervisory Committee: Monica Calabritto Hermann Haller Nancy Miller THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK iii ABSTRACT Narrating Intensity: History and Emotions in Elsa Morante, Goliarda Sapienza and Elena Ferrante By Stefania Porcelli Advisor: Giancarlo Lombardi L’amica geniale (My Brilliant Friend) by Elena Ferrante (published in Italy in four volumes between 2011 and 2014 and translated into English between 2012 and 2015) has galvanized critics and readers worldwide to the extent that it is has been adapted for television by RAI and HBO. It has been deemed “ferocious,” “a death-defying linguistic tightrope act,” and a combination of “dark and spiky emotions” in reviews appearing in popular newspapers. Taking the considerable critical investment in the affective dimension of Ferrante’s work as a point of departure, my dissertation examines the representation of emotions in My Brilliant Friend and in two Italian novels written between the 1960s and the 1970s – La Storia (1974, History: A Novel) by Elsa Morante (1912-1985) and L’arte della gioia (The Art of Joy, 1998/2008) by Goliarda Sapienza (1924-1996). -

1+1=Wow Collection Sconto Del 15% 2017 Sconto Del
IL MENSILE DI NOTIZIE, 04 APPROFONDIMENTO E OFFERTE 2017 DEI MONDADORI STORE 1+1=WOW COLLECTION SCEGLI TRA TANTISSIMI GRANDI AUTORI 2 LIBRI 15€ SCONTO DEL 15% “CHE COSA PASSA SU TANTE GUIDE TURISTICHE PER LA TESTA E CARTE STRADALI di quelle persone che leggono, DALL’ 1 AL 30 APRILE immerse in un nuovo cielo, dimentiche di tutto il mondo circostante?” SCONTO DEL 20% R.M. Rilke SU TUTTI I LIBRI LATERZA ESCLUSI I TASCABILI NEI MONDADORI STORE DALL’ 1 AL 30 APRILE DAL 3 AL 30 APRILE APRILE 2017 2 NARRATIVA [ ] Sveva Casati Modignani Joe R. Lansdale Antonio Dikele Distefano Federica Manzon Andrea Frediani UN BATTITO D’ALI IO SONO DOT CHI STA MALE LA NOSTALGIA IL CUSTODE DEI Mondadori Electa, € 16,90 Einaudi, € 17,50 NON LO DICE DEGLI ALTRI 99 MANOSCRITTI ROMANZO ROMANZO Mondadori, € 12,00 Feltrinelli, € 16,00 Newton Compton, € 9,90 ROMANZO ROMANZO ROMANZO STORICO In questo nuovo libro auto- Una ragazzina che proprio biografico, Sveva ripercorre non ce la fa a tenere la lin- Questa è la storia di due “Nessuno è più irrimedia- Roma, IX secolo d.C. il suo passato e conduce il gua a freno. E affronta il ragazzi, Yannick e Ifem. bilmente perduto di due Nel periodo più cupo del lettore fino alle soglie del- mondo nel solo modo che Una storia di mancanze, as- bravi ragazzi che si sono Medioevo, mentre i pon- la sua affermazione come conosce: a rotta di collo. senze, abbandoni, di come rovinati a vicenda.” Un’au- tefici contendono il potere scrittrice, quando pubblica è difficile credere nella vita trice raffinata, una scrittura all’imperatore, un complot- il suo primo romanzo. -

ERMENEUTICHE DI CESARE GARBOLI Andrea Rondini
rivista di storia della letteratura italiana contemporanea Direttore : Cesare De Michelis Condirettori : Armando Balduino, Saveria Chemotti, Silvio Lanaro, Anco Marzio Mutterle, Giorgio Tinazzi Redazione : Beatrice Bartolomeo * Indirizzare manoscritti, bozze, libri per recensioni e quanto riguarda la Redazione a : « Studi Novecenteschi », Dipartimento di Italianistica, Università di Padova (Palazzo Maldura), Via Beato Pellegrino, 1, 35137 Padova. * « Studi Novecenteschi » è redatto nel Dipartimento di Italianistica, Università di Padova. Registrato al Tribunale di Padova il 17 luglio 1972, n. 441. Direttore responsabile : Cesare De Michelis. * Per la migliore riuscita delle pubblicazioni, si invitano gli autori ad attenersi, nel predisporre i materiali da consegnare alla Redazione ed alla casa editrice, alle norme specificate nel volume Fabrizio Serra, Regole redazionali, editoriali & tipografiche, Pisa · Roma, Serra, 20092 (Euro 34,00, ordini a : [email protected]). Il capitolo Norme redazionali, estratto dalle Regole, cit., è consultabile Online alla pagina « Pubblicare con noi » di www.libraweb.net. * « Studi Novecenteschi » is a Peer-Reviewed Journal. * Stampato in Italia · Printed in Italy www.libraweb.net issn 0303-4615 issn elettronico 1724-1804 rivista di storia della letteratura italiana contemporanea Fabrizio Serra editore Pisa · Roma xxxvi, numero 78, luglio · dicembre 2009 Indirizzare abbonamenti, inserzioni, versamenti e quanto riguarda ® l’amministrazione a : Fabrizio Serra editore , Casella postale n. 1, Succursale n. 8, i 56123 Pisa. * Uffici di Pisa : Via Santa Bibbiana 28, i 56127 Pisa, tel. 050/542332, fax 050/574888, [email protected] Uffici di Roma : Via Carlo Emanuele I 48, i 00185 Roma, tel. 06/70493456, fax 06/70476605, [email protected] * I prezzi ufficiali di abbonamento cartaceo e/o Online sono consultabili presso il sito Internet della casa editrice www.libraweb.net Print and/or Online official subscription prices are available at Publisher’s web-site www.libraweb.net. -

Chapter Four
Chapter Four Morante and Kafka The Gothic Walking Dead and Talking Animals Saskia Ziolkowski Although the conjunction of Elsa Morante and Franz Kafka may initially seem surprising, Morante asserts that Kafka was the only author to influence Iler (Lo scialle 215). Morante 's own claim notwithstanding, relatively few ·:tudies compare in detail the author of La Storia (History) and that of Der !'rocess (The Trial). 1 In contrast to Morante, who openly appreciates Kafka but is infrequently examined with him, Dino Buzzati is often associated with Kalka, despite Buzzati's protests. Referring to Kafka as the "cross" he had to ll ·ar (54), Buzzati lamented that critics called everything he wrote Kafka \' ·que. Whereas Buzzati insists that he had not even read Kafka before writ- 111 ' fl deserto dei Tartari (The Tartar Steppe, 1940), which was labeled a 111 ·re imitation of Kafka's work.,2 Morante mentions Kafka repeatedly, par- 1 cularly in the 1930s. Clarifying that Morante later turned from Kafka to 't ·ndhal and other writers, Moravia also remarked upon Kafka's signifi •11111.:c to Morante in this period, referring to the author as Morante's "master" 111d "religion."3 While Morante may be less obviously Kafkan than Buzzati, 11 111.: xploration of her work and her "master's" sheds new light on Morante. I ,ike Marcel Proust, whose importance to Morante has been shown by it ·li1nia Lucamante, Kafka offers Morante an important reference point, es p •iully in the years in which she was establishing herself as an author. l1owing the productive affinities between Morante and Kafka, a German li1 11111:1gc author from Prague, complements studies on Morante and French 111t h11rs. -

La Réception De La Littérature Italienne En France Des Années 1980 À 2002 Élodie Cartal
La réception de la littérature italienne en France des années 1980 à 2002 Élodie Cartal To cite this version: Élodie Cartal. La réception de la littérature italienne en France des années 1980 à 2002. Histoire. 2010. dumas-00537149 HAL Id: dumas-00537149 https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00537149 Submitted on 17 Nov 2010 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Elodie CARTAL La réception de la littérature italienne en France des années 1980 à 2002 Mémoire de Master 2 « Sciences humaines et sociales» Mention : Histoire et Histoire de l’art Spécialité : Métiers des bibliothèques Sous la direction de Mme Marie-Anne MATARD BONUCCI et M. Olivier FORLIN Année universitaire 2009-2010 Elodie CARTAL La réception de la littérature italienne en France des années 1980 à 2002 Mémoire de Master 2 « Sciences humaines et sociales» Mention : Histoire et Histoire de l’art Spécialité : Métiers des bibliothèques Sous la direction de Mme Marie-Anne MATARD BONUCCI et M. Olivier FORLIN Année universitaire 2009-2010 Remerciements Je tiens à remercier Mme Marie-Anne MATARD-BONUCCI pour avoir accepté de superviser ce travail de recherche et M. -

Transnational Female Identity and Literary Narratives Between Italy and Eastern Europe
UNIVERSITY OF CALIFORNIA Los Angeles Cartographies of Estrangement: Transnational Female Identity and Literary Narratives between Italy and Eastern Europe A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in Italian by Renata Redford 2016 © Copyright by Renata Redford 2016 ABSTRACT OF DISSERTATION Cartographies of Estrangement: Transnational Female Identity and Literary Narratives between Italy and Eastern Europe by Renata Redford Doctor of Philosophy in Italian University of California, Los Angeles, 2016 Professor Lucia Re, Chair This dissertation investigates a vital body of women’s writing in Italian about the estranging effects of migration in order to emphasize the articulation of a literary discourse that undermines conventional depictions of the Eastern European female migrant. I provide evidence of the emergence in their work of a distinctly transnational approach to literary writing (narrative in particular), founded on a creative way of addressing questions of estrangement, the body, and memory. I consider the work of three authors, who have yet to be fully acknowledged in the Italian literary landscape: the Italophone writers Jarmila Očkayová (1955-present; Italo- Slovakian) and Ingrid Beatrice Coman (1971-present; Italo-Romanian living in Malta), and Marisa Madieri (1938-1996; Italo-Hungarian from Istria), whose native language was Italian. My analysis focuses on the stylistic, thematic, and structural elements that Očkayová, Coman and Madieri employ to engage with and -

04 Recensioni 4-04 21/04/12 23.31 Pagina 406
04 Recensioni 3-09_04 Recensioni 4-04 21/04/12 23.31 Pagina 406 406 recensioni e segnalazioni Laura Desideri. Bibliografia di Cesare Garboli (1950-2005) , nota introduttiva di Carlo Ginzburg. Pisa: Edizioni della Normale, 2007, XXXV, 217 p. (Strumenti; 7). ISBN 978-88-7642-196-9. €15,00. Habent sua fata libelli : come i romanzi, così le bibliografie. Cesare Garboli (Viareggio, 17 dicembre 1928 – 10/ 11 aprile 2004) s’addormenta, come il suo Dante, mentre lavorava alla revisione del commento giovanile della Divina Com - media (La Divina Commedia. Le rime, i versi della Vita nuova e le canzoni del Convivio , Tori - no, Einaudi, 1954 [I millenni, 27. Parnaso italiano, II]): era giunto al canto XIX del Pur - gatorio «ne l’ora che non può ‘l calor dïurno | intepidar più ‘l freddo de la luna | vinto da terra, e talor da Saturno» (vv. 1-3). Inattuale fino alla fine in quanto capace di scegliersi autonomamente le proprie strade culturali, politiche ed ideologiche sapendo bene che la forza di una parola critica non risiede solo nell’autorevolezza e nella verità dell’enun - ciato ma soprattutto nei rischi che l’enunciatore corre nell’esporsi (vedi Il coraggio di esse - re inattuali , «La repubblica», 26 giugno 2002, discussione con Roberto Calasso). Inattua - le anche nelle sue enunciazioni di metodo (e quindi nella lotta contro l’insulsa vuotaggine dei pensieri e della scrittura e contro l’ikeaizzazione dell’università): nascono così prese di posizione che lo conducono ad affermare che Sono quel che annoto («Panorama», 2 luglio 1989), Critico sono, ma detesto i libri («Corriere della sera», 6 marzo 1989), Lotto con i libri corpo a corpo («Millelibri», IV, 26 gennaio 1990), Siate postumi! («Panorama», 3 1 maggio 1992, a proposito del Journal di Matilde Manzoni), Troppi pettegolezzi ma è meglio così («La repubblica», 5 novembre 1995 [sulla funzione della critica e sulle sue degenerazioni]). -

0506 Garboli 4G
Comune di Firenze - Assessorato alla Cultura LEGGERE PER NON DIMENTICARE ciclo d’incontri a cura di Anna Benedetti Biblioteca Comunale Centrale Via S. Egidio 21 – Firenze www.leggerepernondimenticare.it mercoledì 26 ottobre 2005 – ore 17.30 CESARE GARBOLI Storie di seduzione (Einaudi, 2005) Introducono: Rosetta Loy e Salvatore Settis Letture di: Carlo Cecchi Nell'ultimo libro di uno dei massimi e piú originali saggisti italiani, ad essere raccontati, con passione e lucidità, sono: la vita e il teatro di Molière; il destino di autodistruzione ilare e buffonesco (e pure cosí tragico) di Antonio Delfini; il genio istrionico di Roberto Longhi e la sua esattezza nel fondere il reale e l'immaginario; la disumanità del desiderio e la perversione saturnina di Sandro Penna; la concordanza di pensiero e viscere in Natalia Ginzburg; le metamorfosi e la pesanteur di Elsa Morante; la doppia e lunga felicità di Mario Soldati. E accanto, e intorno a questi autori, i loro libri: Lessico famigliare, Cinque romanzi brevi, Caro Michele, Salmace, La confessione, I Diari, Pro e contro la bomba atomica, La Storia, la Carmen e le poesie senza risparmio di Penna, il teatro del Tartufo e del Misantropo, i progetti abbozzati e abbandonati e quelli rimasti inediti, le carte e le diverse vicende editoriali. I romanzi, ha scritto una volta Garboli, stanno nella realtà come in letargo e aspettano solo di farsi leggere. Prende cosí corpo un libro affettuoso e forte, un «romanzo» di chi, pur affermando di non amare la lettura, sa di essere invaso dal suo demone e assalito dal suo raptus. In un mosaico dove ogni tessera trova infine il proprio posto e forma un ritratto appassionato e originale del nostro Novecento letterario, ciascuna di queste storie diventa cosí, non tanto (o non solo) un argomento di studio, quanto piuttosto un evento e un incontro di seduzione che si rinnova nel tempo. -

PREMIO LETTERARIO VIAREGGIO-RÈPACI Verbale Della
PREMIO LETTERARIO VIAREGGIO-RÈPACI GIURIA Verbale della seduta di venerdì 19 giugno 2009 Alle ore 15,45 si riunisce la Giuria presso l’Hotel Esplanade di Viareggio. Sono presenti: Rosanna Bettarini (Presidente), Gloria Manghetti (Segretaria letteraria), Giorgio Amitrano , Eugenio Borgna , Marisa Bulgheroni , Marcello Ciccuto , Franco Contorbia , Simona Costa , Luciano Erba , Paolo Fabbri , Piero Gelli , Sergio Givone , Giuseppe Leonelli , Grazia Livi , Alberto Melloni , Mario Graziano Parri , Giorgio Pressburger , Paolo Rossi . Sono assenti giustificati: Luciano Canfora, Carlo Sisi (motivi di lavoro), Guido Fink , Pietro Ghilarducci (motivi di salute). Il Presidente ringrazia i componenti della Giuria per la numerosa presenza e dà lettura del verbale della riunione tenutasi a Firenze il 28 maggio 2009, nella quale sono state selezionate le opere da includere nelle rose selettive di Narrativa, Poesia e Saggistica. La Giuria approva il verbale. La Giuria viene aggiornata circa le ulteriori variazioni apportate al Calendario 2009, già più volte distribuito; gli Incontri sotto le stelle tra gli autori finalisti e il pubblico avranno luogo il 4 e l’11 agosto sulla Terrazza del Principe di Piemonte e saranno condotti, come di consuetudine, da due membri della Giuria cortesemente disponibili. La Segretaria letteraria distribuisce ai giurati gli elenchi dei libri rientrati nelle rose selettive distinti in ordine alfabetico sezione per sezione. Si apre la discussione per votare le terne dei libri finalisti, da affrontare nel seguente ordine: Narrativa, Poesia, Saggistica. NARRATIVA La Giuria viene informata sui messaggi inviati al Presidente da Daniele Del Giudice e da Roberto Calasso, entrambi inclusi a maggio nella rosa selettiva della Narrativa; si dà lettura dei due messaggi, dove Del Giudice e Calasso manifestano il desiderio di ‘non continuare la corsa’, pur ringraziando per l’attenzione riservata al loro lavoro.