Comune Di MELPIGNANO
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
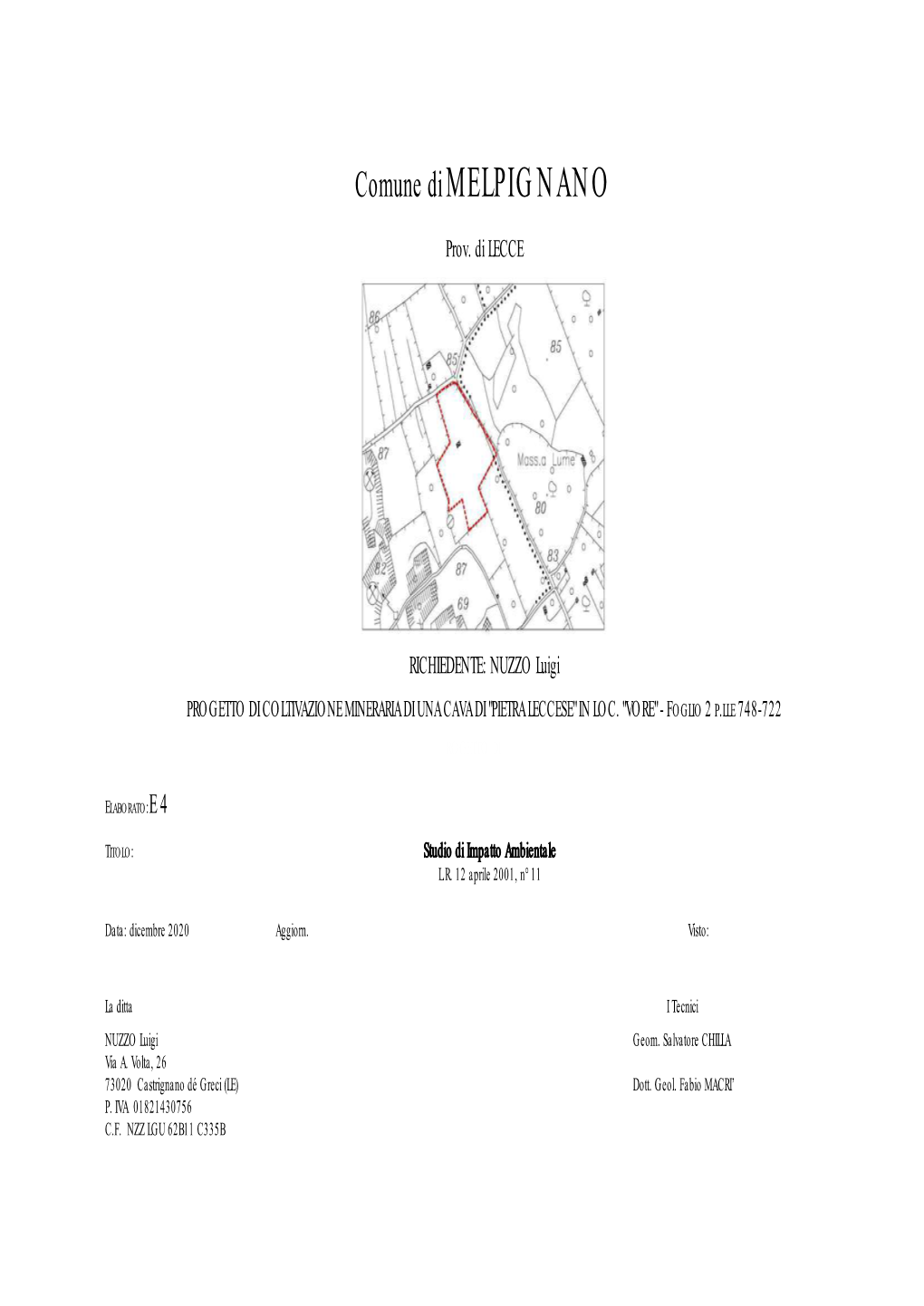
Load more
Recommended publications
-

M F M F M F M F M F M F M F M F Acquarica Del Capo 87 71 105 90
Tabella 4 - Popolazione residente al 1/1/2019 per sesso, classe di età e comune della provincia di Lecce Classe di età Comune 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 M F M F M F M F M F M F M F M F Acquarica del Capo 87 71 105 90 114 98 118 129 148 123 149 148 133 117 116 116 Alessano 114 106 132 101 161 154 203 155 195 160 184 201 162 175 192 187 Alezio 122 101 131 144 161 137 145 143 154 130 128 134 138 130 169 199 Alliste 130 105 136 141 173 162 195 175 185 186 197 196 177 181 208 223 Andrano 86 72 80 86 91 104 135 97 156 134 162 153 133 99 130 119 Aradeo 184 151 190 205 259 213 220 229 242 236 253 270 261 276 311 300 Arnesano 86 66 109 103 121 111 122 104 107 91 115 95 122 129 135 109 Bagnolo del Salento 42 27 27 22 43 40 49 52 55 50 47 52 47 49 46 46 Botrugno 45 51 61 46 45 49 65 63 67 79 64 69 75 68 67 87 Calimera 109 116 158 153 160 157 140 160 165 154 148 167 160 164 201 193 Campi Salentina 173 153 210 203 245 230 265 269 279 242 303 250 283 292 295 336 Cannole 24 22 39 27 48 33 47 47 39 34 33 36 37 37 43 53 Caprarica di Lecce 36 28 68 49 53 38 56 47 50 44 57 62 60 59 59 79 Carmiano 216 220 278 257 277 282 300 261 304 294 365 359 340 313 388 405 Carpignano Salentino 56 71 69 61 89 83 81 80 68 64 112 83 108 110 106 107 Casarano 387 380 462 439 479 474 570 517 573 569 525 531 548 555 635 635 Castri di Lecce 44 45 65 50 57 50 87 74 107 64 72 85 76 79 87 81 Castrignano de' Greci 62 48 64 60 73 61 81 85 117 111 109 100 104 97 123 112 Castrignano del Capo 97 68 72 84 127 117 139 90 135 121 155 145 140 121 143 126 Castro 21 25 32 -

Tabella 1 - Indicatori Territoriali Dei Comuni Della Provincia Di Lecce
Tabella 1 - Indicatori territoriali dei comuni della provincia di Lecce Livello altimetrico (m.) Coordinate geografiche Superficie Densità Sistema Grado di Comune territoriale demografica Regione agrariaLocale del Litoraneità Del Latitudine Longitudine urbanizzazione Minimo Massimo 2011 (kmq.) 2018 (ab/kmq) Lavoro centro Nord Est Acquarica del Capo 110 99 170 39° 55' 18° 15' 18,70 247,98 Intermedio Pianura di Leuca Presicce Non litoraneo Alessano 140 0 189 39° 53' 18° 20' 28,69 223,05 Intermedio Pianura di Leuca Alessano Litoraneo Alezio 75 12 75 40° 04' 18° 03' 16,79 335,27 Intermedio Pianura di Gallipoli Gallipoli Non litoraneo Alliste 54 0 86 39° 57' 18° 05' 23,53 284,44 Intermedio Pianura di Gallipoli Taviano Litoraneo Andrano 110 0 134 39° 59' 18° 23' 15,71 304,93 Intermedio Pianura di Leuca Tricase Litoraneo Aradeo 75 60 86 40° 08' 18° 08' 8,58 1.078,96 Intermedio Pianura di Nardò Galatina Non litoraneo Arnesano 33 17 44 40° 20' 18° 06' 13,56 298,86 Intermedio Pianura di Copertino Lecce Non litoraneo Bagnolo del Salento 96 82 104 40° 09' 18° 21' 6,74 269,54 Intermedio Pianura Salentina centrale Maglie Non litoraneo Botrugno 95 83 114 40° 04' 18° 19' 9,75 278,87 Intermedio Pianura di Otranto Maglie Non litoraneo Calimera 54 39 98 40° 15' 18° 17' 11,18 619,63 Intermedio Pianura di Lecce Melendugno Non litoraneo Campi Salentina 33 27 62 40° 24' 18° 01' 45,88 224,22 Intermedio Pianura di Copertino Lecce Non litoraneo Cannole 100 28 106 40° 09' 18° 21' 20,35 82,31 Basso Pianura di Lecce Maglie Non litoraneo Caprarica di Lecce 60 43 101 -

Campi Salentina
P.T.A Campi Salentina Il PRESIDIO TERRITORIALE DI ASSISTENZA ( P.T.A) d. s. s. 52 Campi Salentina Dott. L. Lanzolla BARI 16 – SETTEMBRE 2016_Fiera del levante 1 Il PRESIDIO TERRITORIALE DI ASSISTENZA ( P.T.A) d. s. s. 52 Campi Salentina Dott. L. Lanzolla BARI 16 – SETTEMBRE 2016_Fiera del levante 2 P.T.A Campi Salentina La Legge Regionale n. 39 del 28/12/2006 ha previsto dal 1 gennaio 2007 la fusione delle AA.UU.SS.LL. Le/1 e Le/2 nella nuova ASL di Lecce denominata ASL LE L'Azienda Sanitaria di LECCE interessa quindi l'intera provincia di Lecce che per popolazione residente (808,939) risulta la seconda ASL della Regione Puglia dopo quella di Bari Comprende 97 Comuni in una superficie di Kmq. 2.759. 3 P.T.A Campi Salentina L'Azienda Sanitaria Locale Lecce per l’ Assistenza Territoriale è articolata in 10 Distretti Sanitari. Ad essi è demandato il compito di rispondere in modo unitario e globale ai bisogni di salute della popolazione residente nei Comuni ricompresi nei rispettivi ambiti territoriali ed è loro assegnata la responsabilità di assicurare, secondo criteri di equità, accessibilità ed appropriatezza, la disponibilità di servizi sanitari e sociosanitari 4 P.T.A Campi Salentina Mappa dei Distretti ASL Lecce 5 P.T.A Campi Salentina Distretto S.S. Comuni x Distretto n° Residenti x Distretto ASL LE - DSS CAMPI SALENTINA CAMPI SALENTINA - CARMIANO - GUAGNANO - NOVOLI - SALICE 88.817 SALENTINO - SQUINZANO - TREPUZZI - VEGLIE - ASL LE - DSS CASARANO CASARANOChi - COLLEPASSO siamo - MATINO - PARABITA - RUFFANO - 74.101 SUPERSANO - TAURISANO -

Apulia Agro-Biodiversity Between Rediscovery and Conservation: the Case of the «Salento Km0» Network
Central European Journal of Geography and Sustainable Development 2021, Volume 3, Issue 1, Pages: 49-59 ISSN 2668-4322, ISSN-L 2668-4322 https://doi.org/10.47246/CEJGSD.2021.3.1.4 Apulia agro-biodiversity between rediscovery and conservation: the case of the «Salento km0» network Sara Nocco,* Department of History Society and Human Studies, University of Salento, Complesso Studium 2000, Ed. 5 - Via di Valesio, 73100 Lecce, Italy [email protected] Received: 31 March 2021; Revised: 20 May 2021; Accepted: 11 June 2021; Published online: 29 June 2021 __________________________________________________________________________________________________________________________ Abstract: Green Revolution and the birth of the current global economic system had two opposite, subsequent effects. If, initially, they led to processes of crop homogenization, seasonal adjustment, homogenization of the landscape and markets standardization, they have subsequently pushed local communities towards a recovery of endemic biodiversity at risk of extinction because of such planetary processes, as well as a fundamental element in terms of local development, food security and sovereignty and reduction of environmental impacts. Starting from these instances of recovery and protection, which are increasingly taking place in Apulia, this work will examine both projects created "from above" and initiatives "from below", being the latter the result of a new consciousness that renews social cohesion and gives new value to the territorial milieu. In this regard, the case of the «Salento km0» network will be examined: born in 2011 and now made up of 61 local subjects including producers, restaurateurs, associations, ethical purchasing groups and traditional stores, which represent a key symbol of a territory that resists and a population that has chosen to stay and innovate according to economic, social, cultural and environmental sustainability. -

Historic Records and GIS Applications for Flood Risk Analysis in the Salento
Natural Hazards and Earth System Sciences, 5, 833–844, 2005 SRef-ID: 1684-9981/nhess/2005-5-833 Natural Hazards European Geosciences Union and Earth © 2005 Author(s). This work is licensed System Sciences under a Creative Commons License. Historic records and GIS applications for flood risk analysis in the Salento peninsula (southern Italy) F. Forte1, L. Pennetta1, and R. O. Strobl2 1Sezione di Geografia fisica e Geomorfologia – Dipartimento di Geologia e Geofisica, Universita` degli Studi di Bari, via E. Orabona 4, 70125 Bari, Italy 2ITC – International Institute for Geoinformation Science and Earth Observation, Hengelosestraat 99, 7514 AE Enschede, The Netherlands Received: 17 November 2004 – Revised: 13 October 2005 – Accepted: 19 October 2005 – Published: 2 November 2005 Abstract. The occurrence of calamitous meteoric events rep- ing and emergency states to the population and economic ac- resents a current problem of the Salento peninsula (Southern tivity. Italy). In fact, flash floods, generated by very intense rainfall, occur not only in autumn and winter, but at the end of sum- 1.2 Geological and geomorphological settings mer as well. These calamities are amplified by peculiar geo- logical and geomorphological characteristics of Salento and The Salento peninsula, the southeast portion of the Apulia by the pollution of sinkholes. Floodings affect often large region (southern Italy), covers 7000 km2 of area and stretches areas, especially in the impermeable lowering zones. These over 150 km between the Ionian and Adriatic seas (Fig. 1). events cause warnings and emergency states, involving peo- The peninsula includes two extreme geographical points: the ple as well as socio-economic goods. -

Rapporto Preliminare Di Orient
PUG_I Piano Urbanistico Generale Intercomunale – Associazione dei comuni di Presicce e Acquarica del Capo VAS ‐ Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto Preliminare di Orientamento (RPO) rev. 00 maggio 2018 INDICE PREMESSA 1. La Valutazione Ambientale Strategica 1.1 Riferimenti normativi in materia di VAS 1.2 Il processo di VAS 2. L’avvio del processo del PUG_I 2.1 Atto di Indirizzo delle Amministrazioni comunali per la formazione del PUG_I 2.2 L’Ufficio di Piano e lo studio di fattibilità 2.3 Il percorso partecipativo 3. Inquadramento territoriale 3.1 Il contesto territoriale 3.2 Il contesto demografico 3.3 Il sistema della mobilità 3.4 Il contesto socio‐economico 3.5 Il patrimonio residenziale 4. Il sistema ambientale 4.1 Aria 4.2 Acqua 4.3 Suolo e sottosuolo 4.3.1 Uso del suolo 4.3.2 Consumo del suolo 4.3.3 Attività estrattive 4.3.4 Siti contaminati 4.3.5 Grotte e cavità antropiche 4.4 Natura e biodiversità 4.4.1 La struttura ecosistemica 4.4.2 Aree di interesse naturalistico 4.4.3 Aree percorse dal fuoco 4.5 Il Paesaggio 4.5.1 Le serre ioniche 4.5.2 Il paesaggio locale 4.5.3 Configurazione strutturale 4.6 Patrimonio culturale, architettonico e archeologico 4.7 Rifiuti 4.8 Agenti fisici 5. Il Rapporto Ambientale e la metodologia di valutazione 5.1 Il Rapporto ambientale 5.2 La metodologia di valutazione 5.2.1 Analisi del contesto territoriale 5.2.2 L’analisi di coerenza 5.2.3 Valutazione degli effetti del Piano sull’ambiente 5.2.4 Misure di mitigazione e compensazione 5.2.5 Analisi delle alternative di Piano 5.3 La Valutazione di Incidenza 6. -

LECCE E Provincia INFORMA SALUTE Accesso Al Servizio Sanitario Nazionale Per I Cittadini Stranieri
Progetto Istituto Ministero della Salute Ministero dell’Interno co-finanziato Nazionale Dipartimento Dipartimento dall’Unione Salute, Migrazioni della Prevenzione per le Libertà Civili Europea e Povertà e Comunicazione e l’Immigrazione IFoNndo EuFropOeo perR l'InMtegraziAone dSei CAittadLini dUei PaTesi TE erzi Accesso al Servizio Sanitario Nazionale per i Cittadini stranieri I Servizi Sanitari di LECCE e Provincia INFORMA SALUTE Accesso al Servizio Sanitario Nazionale per i Cittadini Stranieri I PRINCIPALI SERVIZI SANITARI DI LECCE E PROVINCIA LES PRINCIPAUX SERVICES DE SANTÉ DE LECCE ET SA PROVINCE THE MAIN HEALTH SERVICES OF LECCE AND ITS PROVINCE I PRINCIPALI SERVIZI SANITARI DI LECCE E PROVINCIA LES PRINCIPAUX SERVICES DE SANTÉ DE LECCE ET SA PROVINCE/ THE MAIN HEALTH SERVICES OF LECCE AND ITS PROVINCE L’Azienda Sanitaria di Lecce interessa l’intera provincia di Lecce e si articola in dieci Distretti Sanitari che comprendono i 97 comuni del territorio. Il Distretto sanitario è la struttura organizzativa che assicura i servizi sanitari “territoriali”, comprendenti tutte le attività di pre - venzione, diagnosi, cura e riabilitazione erogati in regime ambu - 2 latoriale, diurno, semiresidenziale e residenziale. DISTRETTO SANITARIO DI LECCE Sede: Piazza Bottazzi, Lecce Telefono: 0832/215286 -215139 - Fax: 0832/215764 E-mail: [email protected] Territorio di riferimento: Comuni di Lecce, Arnesano, San Cesario, Cavallino, Monteroni, S. Pietro in Lama, Lizzanello, S. Donato, Lequile, Surbo. DISTRETTO SANITARIO DI CAMPI SALENTINA Sede: Via Lecce, Campi Salentina Telefono: 0832/7901 E-mail: [email protected] Territorio di riferimento: Comuni di Campi Salentina, Squinzano, Trepuzzi, Novoli, Guagnano, Salice Salentino, Carmiano, Veglie. DISTRETTO SANITARIO DI CASARANO Sede: Via Vittorio Emanuele 18, Casarano Telefono: 0833/508550 - Fax: 0833/512908 E-mail: [email protected] Territorio di riferimento: Comuni di Casarano, Taurisano, Collepasso, Supersano, Parabita, Matino, Ruffano. -

Comune Di Acquarica Del Capo
Comune di Acquarica del Capo Provincia di Lecce COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE VERBALE N. _12_ ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 NOMINA DEGLI SCRUTATORI (art. 6, legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni) I’anno duemilaquindici, il giorno undici del mese di maggio alle ore 16,40 nella Sede Comunale si è riunita la Commissione elettorale comunale, con funzioni di Ufficiale Elettorale ai sensi dell'art. 4-bis del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto affisso all'albo pretorio del Comune e in altri luoghi pubblici. Sono presenti i Signori: Presente Assente Ferraro Francesco - Sindaco – Presidente X Luca Davide - Membro effettivo X Verardo Adamo - Membro effettivo X Negro Carlo - Membro effettivo X Ciullo Luigi - Membro supplente X Duca Marco - Membro supplente X Cassiano Santo Carlo - Membro supplente X con l'assistenza del Responsabile del Servizio Elettorale, Stasi Francesco, delegato dal Segretario comunale Riconosciuta legale l'adunanza, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni e dichiarata aperta la seduta, il Presidente comunica agli intervenuti che la Commissione deve procedere alla nomina degli scrutatori, compresi nell'apposito albo unico, così come previsto dalla legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni, da destinarsi agli Uffici elettorali delle N.5 sezioni in cui è suddiviso il Comune, ed alla formazione della graduatoria prevista dall'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95. Avverte che all'adunanza possono assistere i rappresentanti di lista della prima sezione se già designati. -

TAV. 5 Bis Metri Gli Istituti Rappresentati Cartograficamente Fanno Riferimento Alle Sole Aree "Confermate" Dal Piano
ISTITUTI DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE 2017 – 2022 – PROPOSTA AGGIORNAMENTO PROVINCIA DI LECCE Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Naturali - Servizio Caccia 2760000 4500000 2780000 4490000 2800000 4480000 2820000 4470000 2840000 4460000 LEGENDA OASI DI PROTEZIONE DI NUOVA ISTITUZIONE 38 - BOSCO PECORARA Sup. 907.80 Ha 39 - BOSCO SERRA DEI CIANCI Sup. 421.24 Ha 40 - LECCE TANGENZIALE EST Sup. 893.12 Ha 41 - MADONNA CONSOLAZIONE - LE COLONNE Sup. 315.78 Ha 0 0 0 42 - MANCARELLA Sup. 292.76 Ha 0 0 5 4 43 - MASSERIA CORILLO Sup. 109.24 Ha 0 44 - MASSERIA DONNA TERESA / AUTOPISTA EX FIAT Sup. 1494.56 Ha 0 0 0 5 4 45 - MASSERIA LA LAMA Sup. 940.46 Ha 4 59 46 - MASSERIA LI BELLI Sup. 259.73 Ha 47 - MASSERIA MONTERUGA - MASSERIA MAZZETTA Sup. 891.58 Ha LECCE 48 - MASSERIA POMPEA O GRANDE Sup. 416.06 Ha SQUINZANO 49 - MASSERIA SANTI DIMITRI Sup. 259.69 Ha Provincia Brindisi 50 - MASSERIA TONDA Sup. 529.21 Ha SURBO 40 51 - MASSERIA ZANZARA Sup. 258.15 Ha TREPUZZI VERNOLE 52 - MASSERIA ZUMMARI Sup. 607.94 Ha 56 53 - MASSERIE ARCHE - CANISI - ANNIBALE Sup. 131.99 Ha 61 54 - MASSERIE LO LEZZI - LA NOVA Sup. 691.45 Ha CAMPI SALENTINA MELENDUGNO 55 - MONTAGNA SPACCATA / RUPI DI S. MAURO Sup. 293.19 Ha LIZZANELLO 56 - TORRE DELL'ORSO Sup. 164.99 Ha 0 0 0 57 - TORRE SUDA Sup. 1025.59 Ha 0 NOVOLI 9 4 4 58 - ZPS BAIA VERDE Sup. 112.09 Ha 0 0 0 0 4 ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA DI NUOVA ISTITUZIONE 4 CASTRI DI LECCE 4 GUAGNANO 59 - MASSERIA CERRATE - BOSCO GALIARDI Sup. -

Abitanti Acquarica E Presicce
Consiglio Regionale della Puglia X Legislatura DELIBERAZIONE Seduta pubblica martedì 25/09/2018 N. 228 reg. deliberazioni OGGETTO: "Effettuazione del referendum consultivo delle popolazioni interessate dal disegno di legge 13/09/2018, n. 187 (Istituzione del nuovo comune di 'Presicce-Acquarica' derivante dalla fusione dei comuni di Presicce e Acquarica del Capo)" L’anno duemiladiciotto, il giorno venticinque del mese di settembre, alle ore 10:30, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio regionale, in seduta pubblica, si è riunito IL CONSIGLIO REGIONALE sotto la Presidenza di Mario Cosimo Loizzo Vice Presidenti: Giuseppe Longo – Giacomo Diego Gatta Consigliere segretario: Luigi Morgante e con l’assistenza: del Segretario generale del Consiglio: Domenica Gattulli Consiglio Regionale della Puglia X Legislatura CONSIGLIERI PRESENTI/ASSENTI Consigliere Presente Assente ABATERUSSO Ernesto X AMATI Fabiano X BARONE Rosa X BLASI Sergio X BORRACCINO Cosimo X BOZZETTI Gianluca X CAMPO Francesco Paolo X CARACCIOLO Filippo X CAROPPO Andrea X CASILI Cristian X CERA Napoleone X COLONNA Vincenzo X CONCA Mario X CONGEDO Saverio X DAMASCELLI Domenico X DE LEONARDIS Giannicola X DI BARI Grazia X DI GIOIA Leonardo X EMILIANO Michele (Presidente Giunta regionale) X FRANZOSO Francesca X GALANTE Marco X GATTA Giacomo Diego X GIANNINI Giovanni X LARICCHIA Antonella X LEO Sebastiano Giuseppe X LIVIANO D'ARCANGELO Giovanni X LOIZZO Mario Cosimo X LONGO Giuseppe X MANCA Luigi X MARMO Nicola X MAURODINOIA Anna X MAZZARANO Michele X MENNEA Ruggiero X MORGANTE Luigi X NUNZIANTE Antonio X PELLEGRINO Paolo X PENDINELLI Mario X PENTASSUGLIA Donato X PERRINI Renato X PIEMONTESE Raffaele X PISICCHIO Alfonsino X ROMANO Giuseppe X ROMANO Mario X SANTORSOLA Domenico X STEA Giovanni Francesco X TREVISI Antonio Salvatore X TURCO Giuseppe X VENTOLA Francesco X VIZZINO Mauro X ZINNI Sabino X ZULLO Ignazio X 2 Consiglio Regionale della Puglia X Legislatura VISTI gli articoli 22, 26, 32, 35 e 37 dello Statuto della Regione Puglia; VISTI l’articolo 6, comma 1, della l.r. -

Comuni Di Taurisano, Acquarica Del Capo, Presicce E Ugento
ASSOCIAZIONE TERRA DEL SOLE E DEL MARE Comuni di Taurisano, Acquarica del Capo, Presicce e Ugento Alla cortese attenzione Regione Puglia Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei Talenti Servizio Mediterraneo Claudio Polignano [email protected] Provincia di Lecce Settore Territorio Ambiente e Programmazione strategica Servizio Ambiente e Polizia Provinciale Ing. Dario Corsini [email protected] Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce [email protected] Ordine degli Architetti Pianificatori, Conservatori e Paesaggisti della Provincia di Lecce [email protected] Collegio dei Geometri della Provincia di Lecce [email protected] Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Lecce [email protected] ANCI Puglia Sen. Luigi Perrone [email protected] [email protected] ANCI Puglia Europa Referenti per il Patto dei Sindaci Covenant Coordinator – Ginevra del Vecchio [email protected] Media officer - Leonardo Colucci [email protected] Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione - ARTI [email protected] ADICONSUM Sede regionale PUGLIA Giovanni D'Elia [email protected] ADICONSUM Lecce Guida Lucio Paolo [email protected] Anaci [email protected] Anapi [email protected] Cna Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media Impresa Presidente Vito Negro [email protected] Confartigianato Presidente Francesco Scherza [email protected] Camera di Commercio [email protected] -

Historic Records and GIS Applications for Flood Risk Analysis in the Salento Peninsula (Southern Italy) F
Historic records and GIS applications for flood risk analysis in the Salento peninsula (southern Italy) F. Forte, L. Pennetta, R. O. Strobl To cite this version: F. Forte, L. Pennetta, R. O. Strobl. Historic records and GIS applications for flood risk analysis in the Salento peninsula (southern Italy). Natural Hazards and Earth System Sciences, Copernicus Publ. / European Geosciences Union, 2005, 5 (6), pp.833-844. hal-00301659 HAL Id: hal-00301659 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00301659 Submitted on 2 Nov 2005 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Natural Hazards and Earth System Sciences, 5, 833–844, 2005 SRef-ID: 1684-9981/nhess/2005-5-833 Natural Hazards European Geosciences Union and Earth © 2005 Author(s). This work is licensed System Sciences under a Creative Commons License. Historic records and GIS applications for flood risk analysis in the Salento peninsula (southern Italy) F. Forte1, L. Pennetta1, and R. O. Strobl2 1Sezione di Geografia fisica e Geomorfologia – Dipartimento di Geologia e Geofisica, Universita` degli Studi di Bari, via E. Orabona 4, 70125 Bari, Italy 2ITC – International Institute for Geoinformation Science and Earth Observation, Hengelosestraat 99, 7514 AE Enschede, The Netherlands Received: 17 November 2004 – Revised: 13 October 2005 – Accepted: 19 October 2005 – Published: 2 November 2005 Abstract.