Petrarchismo E Petrarchisti in Inghilterra
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more
Recommended publications
-
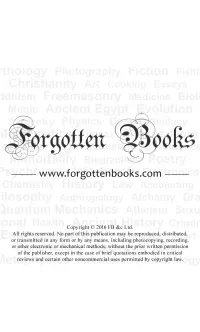
Pavannes and Divisions
EZ RA PO UND C AMER A PO RT R AIT BY E H [ . O . O PPE. LO NDO N] PAV A N N E S A N D D IV IS IO N S EZ RA PO U ND NEW RK D PF MC M YO ALFRE A. KNO XVIII 1918 B C O PYR IG HT , , Y EZ RA PO UND Pu bli sh ed Ju ne 1 91 8 “ JUL i918 Certain o f th ese sketches and essays have appeared in “ F R ” “ ” Poetry, The ortnightly eview, The New Age , ” ” “ R F -ist The Quarterly eview , The uture , The Ego , “ R w o f e and The Little evie , to the editors which p ri o di cals the author wishes to make du e ack n o wledg men t . CONTENTS ’ JOdin dran ath Mawh wo r s Occupation An Anachron ism at Chinon Religio Aux Etu ves de Wiesbaden ’ L Homm e Moyen Sensuel Pierrots Stark Realism Twelve Dialogues o f Fonten elle I Alexander and Phrine II Dido and St rat o n ice 111 Anacreon and Ari stotle IV Homer and ZE SOp V Soc rates and Montaign e V I Charles V and Erasmus — V II Agnes Sorel R oxel an e VIII Brutus and Faustina IX Helen and Fulvia X Seneca and Scarron XI S R o f trato , aphael Urbino XII Bom b ast es Parac elsus and Mok ere A Retros pect ’ A Few Do n ts Prolegomena CONTENTS Remy de Gourmon t I II Fo rd Madox Hu etf er an d the Pro se Tradition in Verse Th R e ev . -
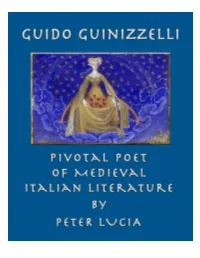
Guido Guinizzelli
Guido Guinizzelli: Pivotal Poet of Medieval Italian Literature By Peter Lucia, B.A., M.A. As ever, dedicated to Angela De Vito-Lucia Copyright © 2020, Peter Lucia All rights reserved ISBN: 0-9741139-4-8 ISBN 13: 978-0-9741139-4-4 Peter Lucia Projects, Tinton Falls, NJ This work originated in an honors essay by Peter Lucia, Italian Department, Columbia University, 1984 Cover illustration adapted from La Dame de Coeur, Bibliothèque de France, Christine de Pizan. Épître d’Othéa. Paris, vers 1406. !2 Sections Index Introduction 3 Note on the Translations 5 The Poems, Translations and Commentary 7 Two Fine Translations of Guinizzelli’s Poems 85 Bibliography 89 !3 Introduction Guido Guinizzelli di Magnano was born about 1230 in Bologna and died in Monselice in 1276. His importance in Italian literature is that his small body of poems (only about twenty) represents the link between two styles: that of the so-called “Sicilian School,” which represents the official origin of Italian literature (to which one adds a nod to the various poets of central Italy and the still older French troubadours), and that of the Dolce Stil Nuovo (the “Sweet New Style”), which gave Italy its first truly elevated poetry. Actually, among his twenty poems only a few award him his singular position: they caught the eye of Dante, the movement’s most distinguished representative, who was inspired by Guinizzelli’s exulted use of the common tongue (the vernacular or Il volgare) in service of an advanced spiritualization of Love— and his application a kind of scientific rationale to the workings of it all. -

Xperience Monthly – August 2019
Music Art Culture Rejuvenate August 2019 Volume 1, Issue 7 Buck Dharma Inside the green room with one of 22 the most iconic rock guitarists.. Graham Tichy Passing on a life-long tradition 18 to create tomorrow’s sound.,. www.radioradiox.com Free August 2019 Page 3 Music Art Culture Revolution The Nice People on the Planet Graham Tichy A new generation of players are learning to take over the Capital Region, and Graham Tichy’s at the blackboard. Page 18 Photo provided. (l - r) Pete Donnelly, Pete Hayes, Mike Gent With a raw determination to gather no moss, The Figgs forge ahead on a massic project, one of evolution and revolution. bUCK dHARMA Neither Blue Oyster Cult nor The Figgs are a band that transformative too. When you guitarist Buck Dharma are By Liam Sweeny haved carved out their own lem- go back from your earlier work fearing the reaper as they continue to tour. onade stand on the edge of that to now, how would you say its Page 22 usic’s a hard road. The superhighway. Thirty years out, evolved with the time, either as rock and roll dream is close to as many albums released, the pure music itself, or in the Msomething you can do The Figgs (Mike Gent, Pete Don- way you put it together? with a guitar, a garage and a ful- nelly, and Pete Hayes) deliver Mike: We started in August of ly-stocked bar. No, I’m talking a very textured and energetic 1987 so I guess we’ve now been at Observations about music. -

Dante and His Circle, with the Italian Poets Preceding Him (1100-1200
HANDBOUND AT THE UNI\TERSITY OF TORONTO PRESS Digitized by tine Internet Arcliive in 2007 witli funding from IVIicrosoft Corporation littp://www.arcliive.org/details/danteliiscirclewiOOrossuoft /[^ K^^J DANTE AND HIS CIRCLE. r^ /jj DANTE AND HIS CIRCLE WUH THE ITALIAN POETS PRECEDING HIM (l lOO— I200— 1300) A COLLECTION OF LYRICS TRANSLATED IN THE ORIGINAL METRES BY DANTE GABRIEL ROSSETII PART T. DANTE'S VITA NUOVA. ETa I POETS OF DANTE'S CIRCLE PART n. rOETS CHIEFLY BEFORE DANTE A NE W EDITION WITH PREFACE BY WILLIAM M. ROSSETTI ELLIS AND ELVEY LONDON 1892 All rights reserved PRINTED BV HAZRLL, WATSON, AND VINBY, LD. LONDON AND AVLESBUKY. y PREFACE TO THE PRESENT EDITION. DANTE GABRIEL ROSSETTI published in 1861 his book The Early Italian Poets, which is the first form of the present book named Dante and his Circle. Ever since its first publication this series of translations has occupied, I think, a somewhat peculiar position ; partly as being the only form in which a large portion of the poems here treated are available for English readers; and partly because the Italian compositions have so special a character of their own, and the translator has entered so keenly into their spirit, and has reinforced this with so manifest a ^ poetic tone and savour proper to himself, that the ^fc versions have taken rank as a sort of cross between Hptranslated and original work. They have been accepted ^F as bringing the English reader as close to the mediaeval ^^ Italians as he is ever likely to be brought ; and also as ^introducing him to the tone and quality of Rossetti's own mind and hand in poetic production. -

Download File
Sì come dice lo Filosofo: Translating Philosophy in the Early Italian Lyric Akash Kumar Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of Arts and Sciences COLUMBIA UNIVERSITY 2013 ©2013 Akash Kumar All rights reserved ABSTRACT Sì come dice lo Filosofo: Translating Philosophy in the Early Italian Lyric Akash Kumar This study pushes back to the origins of the Italian lyric tradition in order to demonstrate that the impulse to distill the highest levels of intellectual culture into the vernacular love lyric was present from the very inception of the poetic vernacular. I aim to nuance our understanding of the divide between the early schools of poetry as determined by Dante in his role as a literary historian by analyzing early experiments in vulgarizing philosophy and science in the lyric production of Giacomo da Lentini, Guido delle Colonne, Guittone d’Arezzo, and Guido Guinizzelli. By isolating both formal elements of Scholastic argumentation and complex renderings of philosophical/scientific ideas, I develop a broad understanding of the early vernacular poetic engagement with Aristotelian philosophy that encompasses such areas as sensory perception, meteorology, and ethics. I trace the progression of this engagement from its Sicilian beginnings to the poetry of Guido Guinizzelli that is informed by the university culture of Bologna and posit that this early lyric form of vernacular humanism has profound implications for Dante’s poetic identity as well as the development of a vernacular intellectual identity that feeds in to such developments as Humanism and the Scientific Revolution. TABLE OF CONTENTS Chapter 1 Prime Mover: Giacomo da Lentini and the Philosophy of Vernacular Innovation p. -

Vertical Readings in Dante's Comedy
Vertical Readings in Dante’s Comedy Volume 1 EDITED BY GEORGE CORBETT AND HEATHER WEBB To access digital resources including: blog posts videos online appendices and to purchase copies of this book in: hardback paperback ebook editions Go to: https://www.openbookpublishers.com/product/367 Open Book Publishers is a non-profit independent initiative. We rely on sales and donations to continue publishing high-quality academic works. Vertical Readings in Dante’s Comedy Volume 1 edited by George Corbett and Heather Webb http://www.openbookpublishers.com © George Corbett and Heather Webb. Copyright of individual chapters is maintained by the chapter’s author. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0). This license allows you to share, copy, distribute and transmit the work; to adapt the work and to make commercial use of the work providing attribution is made to the author (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Attribution should include the following information: George Corbett and Heather Webb (eds.), Vertical Readings in Dante’s ‘Comedy’. Cambridge, UK: Open Book Publishers, 2015. http://dx.doi.org/10.11647/OBP.0066 Further details about CC BY licenses are available at http://creativecommons.org/ licenses/by/4.0/ All external links were active on 30/07/2015 unless otherwise stated. Digital material and resources associated with this volume are available at http:// www.openbookpublishers.com/isbn/9781783741724 ISBN Paperback: 978-1-78374-172-4 ISBN Hardback: 978-1-78374-173-1 ISBN Digital (PDF): 978-1-78374-174-8 ISBN Digital ebook (epub): 978-1-78374-175-5 ISBN Digital ebook (mobi): 978-1-78374-176-2 DOI: 10.11647/OBP.0066 Cover image: Domenico di Michelino, La Commedia illumina Firenze (1465). -

Likeness, Bewilderment, and Sweetness: the Italian Pathway to Lyrical Science
LIKENESS, BEWILDERMENT, AND SWEETNESS: THE ITALIAN PATHWAY TO LYRICAL SCIENCE A Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of Cornell University In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy by Antonio Di Fenza May 2018 © 2018 Antonio Di Fenza LIKENESS, BEWILDERMENT, AND SWEETNESS: THE ITALIAN PATHWAY TO LYRICAL SCIENCE Antonio Di Fenza, Ph. D. Cornell University 2018 Scholars have defined Guido Guinizzelli, Guido Cavalcanti, Dante Alighieri, and Michelangelo Buonarroti philosopher-poets, and yet, they have overlooked the implications of such articulation. In my dissertation, I clarify how these authors articulate philosophy and poetry into a single one discipline – a lyric science – devise its thinking tools, and urge us to consider love as the defining experience of human life, and the gateway to knowledge. The results of this experiment can be summarized in four key-terms which name the different chapters of my dissertation: likeness, bewilderment, sweetness, and excess. Chapter 1. “Irresistible likeness: Al cor gentil rimpaira sempre amor” is dedicated to Guinizzelli’s poetical manifesto, in which he challenges the primacy of logical argumentation by devising a mode of thinking based on resemblance, likeness. Chapter 2. “Bewildering love: Donna me prega” deals with Cavalcanti’s response to Guinizzelli’s manifesto, in which he devises a theory of bewilderment, an experience of love as destructive, disconnecting, and eventually mortal. However, Cavalcantian love also works positively, since it manifests the basic structures of human’s intellect. Chapter 3 “Unfinished praise: Donne ch’avete intelletto d’amore” analyzes how Dante lays out the ground work to connect Cavalcanti and Gunizzelli’s approaches into a comprehensive doctrine of love. -

Ellingtontitles.Pdf
Duke Ellington Song Titles Title Also Known As Writer 11:60 P.M. E.K. Ellington 23rd Psalm 4:30 Blues E.K. Ellington 9:20 Special E. Warren 99% Won’t Do Ninety-Nine Per Cent E.K. Ellington A Beautiful Friendship J. Styne S. Cahn A Blue Fog That You Can Almost See Through (see - E.K. Ellington L. Brown Transblucency) A Blue Mural From Two Perspectives E.K. Ellington B. Strayhorn A Blues Riff D. Reinhardt A Blus Serenade F. Signorelli V. Grande J. Lytell M. Parish A.C. (see - Opening Titles) E.K. Ellington A City Called Heaven B. Warren A Contrapuntal Stomp (see - Back Room Romp) A Day In The Life Of A Fool L. Benfa C. Sigman A Door Will Open H. Brooks D. George A Drum Is A Woman E.K. Ellington B. Strayhorn A Fire And Brimstone Sermonette (see - The Biggest) E.K. Ellington A Flower Is A Lovesome Thing B. Strayhorn A Foggy Day (In London Town) G. Gershwin I. Gershwin A Friend Of Yours J. Van Heusen J. Burke A Garden In The Rain C. Gibbons J. Dyrenforth A Gatherin’ In A Clearin’ Hometown E.K. Ellington C. Anderson A Ghost Of A Chance (I Don’t Stand . With You) V. Young N. Washington B. Crosby A Hundred Dreams A Hundred Dreams Ago from Now - E.K. Ellington J. Burke Champagne Oasis) A Hundred Dreams From Now (see - A Hundred Dreams Ago) A Hymn Of Sorrow E.K. Ellington A Lesson In C E.K. Ellington I. Mills H. Nemo A Little Max E.K. -

Past Playlist
Jan. 11, 2020 Set 1 Roy Eldridge, Complete Verve Studio Sessions, “Tin Roof Blues” Vic Dickenson, Ding Dong, “Rosetta” Milt Jackson & Big Brass, For Someone I Love, “Save Your Love For Me” Set 2 Duke Ellington, Latin American Suite, “The Sleeping Lady and the Giant Who Watches Over Her” Thelonious Monk, “You Took The Words Right Out of My Heart” Rob McConnell, Three for the Road, “A Sleepin’ Bee” Set 3 Thad Jones, The Magnificent Thad Jones, “Billy Doo” Weslia Whitfield, September Songs, “I Only Have Eyes for You” John Coltrane & Paul Quinichette, Cattin’ with Coltrane & Quinichette, “Tea for Two” Set 4 Marc Copland & Greg Osby, Round and Round, “Balloonman” Yazz Ahmed, Polyhymnia, “2857” Louis Smith, Soon, “Mike” Set 5 SF Jazz Collective, Live 2009: 6th Annual Concert Tour, “Migrations” Teddy Charles, New Directions, “Decibels” Cecil Taylor, Jazz Advance, “Sweet and Lovely” Set 6 Lou Donaldson, Blue Note Sessions, “That Good Old Feeling” Karin Krog with Dexter Gordon, Some Other Spring, “Shiny Stockings” Mal Waldron & Steve Lacy, Sempre Amore, “To the Bitter” Set 7 Billie Holiday, Lady Day: The Complete Billie Holiday on Columbia, “Pennies from Heaven” Don Byas, 1944-45, “Pennies from Heaven” Dinah Washington, Complete on Mercury, “Pennies from Heaven” Eddie “Lockjaw” Davis, Smokin’, “Pennies from Heaven” Set 8 Count Basie and His Orchestra, Complete Decca Recordings, “Pennies from Heaven” Lester Young, Complete Studio Sessions on Verve, “Pennies from Heaven” Ernesto Cervini’s Turboprop, Rev, “Pennies from Heaven” Set 9 Antonio Sanchez, Quartet Live, “Question and Answer” Delfeayo Marsalis, Sweet Thunder, “Star-Crossed Lovers” Jane Ira Bloom, Sixteen Sunsets, “Gershwin’s Skyline/I Loves You, Porgy” Set 10 Ed Bickert, The Guitar Mastery of Ed Bickert, “Soul Eyes” Miles Davis Quintet, E.S.P. -

An Analysis of Eduardo De Filippo's Theatre By
University of Warwick institutional repository: http://go.warwick.ac.uk/wrap A Thesis Submitted for the Degree of PhD at the University of Warwick http://go.warwick.ac.uk/wrap/3666 This thesis is made available online and is protected by original copyright. Please scroll down to view the document itself. Please refer to the repository record for this item for information to help you to cite it. Our policy information is available from the repository home page. Translation of Dialect and Cultural Transfer: an Analysis of Eduardo De Filippo’s Theatre by Alessandra De Martino Cappuccio A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Italian University of Warwick, Department of Italian February 2010 Dedico questa tesi alla mia città e alle sue contraddizioni irrisolte. TABLE OF CONTENTS List of Illustrations……………………………………………………………… p. v Acknowledgements ………………………………………………………………p. vi Declaration ……………………………………………………………………….p. vi Abstract …………………………………………………………………………. p. vii Introduction Eduardo De Filippo: A New Style in Comedy …………...p. 1 Translating Dialect: Objectives and Methodology………..p. 5 The Neapolitan Scenario ………………………………….p. 9 A Brief Outline of Neapolitan Dialect ……………………p. 13 Chapter One Dialect and Cultural Transfer Translating Drama or Translating Theatre? ………………p. 19 Dialect Theatre and Standard Italian Theatre ……………. p. 22 Dialect Theatre under Fascism …………………………... p. 27 Dialect and Theatre in Antonio Gramsci ………………… p. 32 Dialects and Standard English in England ………………. p. 39 Translation as Cultural Transfer: The State of the Debate . p. 42 Chapter Two Translating Neapolitan Dialect: From Language to Culture Introduction ……………………………………………….p. 68 Eduardo De Filippo’s Theatre and its Language ………… p. 70 Translation of Dialect ………………………………….... -
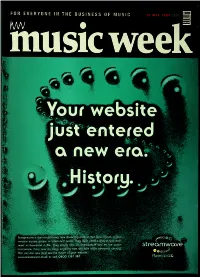
FOR EVERYONE in the BUSINESS of MUSIC Rr Your Website Just
FOR EVERYONE IN THE BUSINESS OF MUSIC r r Your website just entered a new era. > History. ^ .^0 J yseOOOQ streàmwave ♦©000°° PlanetQOCEO Give your website the powef of instant sound and pictures. Embloze™ Video llve No streaming, server requi Embltxze™ Audio Lîve Broadcast liye audio cost effectively. Low "cover ail" monthly fee. No streaming server required. No downloads required by your customers. Np calls made to your site will be blocked. Emblaze™ Video On Demand Broadcast prè-recorded video cost effectively. NoLow streaming "cover ail" server monthly required; fee. I ' \ ~ -A No Wra<«dAo/4. .•t.SLfe . \/r-" Emblaze™ Audio On Demand Broadcast pre-recorded audio cost effectively. Low "cover ail" monthly fee. No streaming server required. No downloads required by your customers. No calls made to your site will be blocked. lll^ r streamwave ®Oooo®0 PlanetoocEO hasNEWS: renewed its deal withmoving THE into BOX other while areas also of music sponsorship |L FOR EVERVOHE IN THE BUSINESS OF MUSIC Whitney and Brihiey bid lo ease release famine Musicby Paul retailers Williams have issued a stark "life saver" to music retailers. K warningup with tomore record big companies:releases or corne face albumsSeveral by Richardbig titles, Ashcroft, including The $ thebusiness conséquence to computer of games,losing moreDVD Corrs,Keating Stephen are set Gatelyfor release and beforeRonan andThe other arrivai rival today leisure (Monday) pursuits. of new theretailers end noteof the record third companies quarter, arebut Hammer & Tongs producer Garth Jennings (plctured) gleefully br Britneyalbums Spearsby Whitney is expected Houston to (and focusing their attention earlier than twoWeek of Creative hls company's and Design unbeatable Awards five staged awards at London'sat last Thursday's Hilton Hôtel. -

The Labels of Bob Thiele Signature Label Discography
The Labels of Bob Thiele The Signature Record Label was established in 1942 in New York City. The output of the label was popular, jazz, gospel and C & W, The Company was moved to Shelton, Connecticut in the late 1940’s. The President of the label was Bob Thiele and the Musical Director was orchestra leader Ray Bloch. During the forties and early fifties the company released 78 RPM albums and a few 10 inch 33 1/3 albums but the company was moribund in the later 50’s. The company was reorganized in May 1959 evidently with the addition of Steve Allen, a popular TV personality. When Allen came into the label he brought the Hanover Label that he established in 1958. Hanover-Signature Record Corp. was located at 119 West 57th Street, New York 19, N. Y., was owned by Bob Thiele and Steve Allen. The label’s spoken word records included recordings by Jack Kerouac; and, Bill Dana’s hit comedy album “My Name José Jiménez”. Other comics and jazz artists on the label included: Steve Allen, Jayne Meadows, Don Cornell, Jack Kane, Milt DeLugg, Jerry Fielding, Morey Amsterdam, George Cates, Audrey Meadows, Jane Harvey, Don Adams, Sam Levenson, Yank Lawson, and Pat Harrington, Jr. In the summer of 1960, Roulette Records purchased 55% of Hanover -Signature- In the fall of 1960 the offices for Hanover- Signature was shuttered. In January 1961, Bob Thiele became head of A&R for Roulette and Signature-Hanover was again moribund. Signature Label Discography 10 Inch Series (Some May be 78 RPM albums only, S-6 and S-9 Hawkins were definitely a 10” LP) S-1 - A Piano Recital - Hazel Scott [1946] 4-record set.