Svolgimento Del Processo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
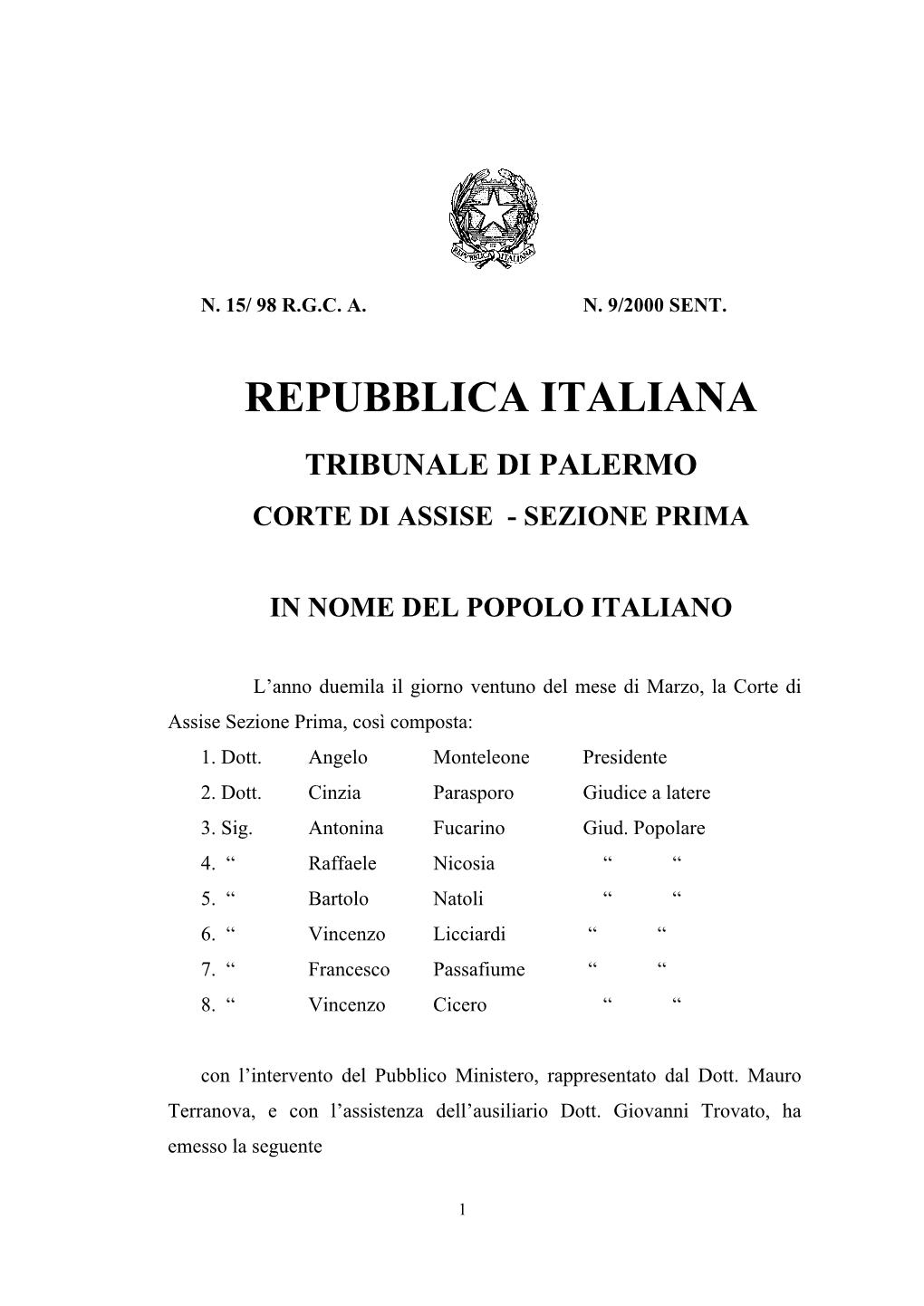
Load more
Recommended publications
-

STRUTTURE Cosa Nostra E 'Ndrangheta a Confronto
STRUTTURE Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto Francesco Gaetano Moiraghi Andrea Zolea WikiMafia – Libera Enciclopedia sulle Mafie www.wikimafia.it Strutture: Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto, di Francesco Gaetano Moiraghi e Andrea Zolea La mafia dura da decenni: un motivo ci deve essere. Non si può andare contro i missili con arco e frecce: in queste vicende certe intemperanze si pagano duramente. Con il terrorismo, con il consenso sociale, potevi permettertele: con la mafia non è così. Nella società c’è un consenso distorto. Altro che bubbone in un tessuto sociale sano. Il tessuto non è affatto sano. Noi estirperemo Michele Greco, poi arriverà il secondo, poi il terzo, poi il quarto. Giovanni Falcone 1 www.wikimafia.it Strutture: Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto, di Francesco Gaetano Moiraghi e Andrea Zolea PREMESSA Questo lavoro ha lo scopo di offrire uno sguardo d’insieme sulle articolazioni strutturali delle organizzazioni mafiose denominate Cosa nostra e ‘ndrangheta . La prima sezione, curata da Francesco Gaetano Moiraghi, si concentra sull’analisi di Cosa nostra. La seconda sezione, che sposta il focus sulla ‘ndrangheta, è curata da Andrea Zolea. Come si potrà notare, le due sezioni non sono state realizzate secondo uno stesso modello, ma analizzano le due organizzazioni con un approccio differente. Ad esempio, la parte su Cosa nostra avrà un orientamento maggiormente diacronico, diversamente da quella sulla ‘ndrangheta, basata su un approccio sincronico. Il presente testo ha infatti l’obiettivo di offrire due proposte di analisi differenti che riescano a mettere in luce le analogie e le differenze delle strutture delle due organizzazioni mafiose. -

14 Gennaio 1998
PRESIDENTE: Ci siamo? Buongiorno. Bagarella è presente? IMPUTATO Bagarella: (voce fuori microfono) Presente. PRESIDENTE: Avvocato Ceolan, avvocato Cianferoni; presenti entrambi. Barranca Giuseppe. SEGR. D’UDIENZA: (voce fuori microfono) Rinunciante. PRESIDENTE: Avvocato Barone e avvocato Cianferoni, che è presente. Benigno Salvatore. SEGR. D’UDIENZA: (voce fuori microfono) Rinunciante. PRESIDENTE: Avvocato Farina e avvocato Maffei, è sostituito dall’avvocato Cianferoni. Brusca Giovanni: lo sentiremo fra poco. Avvocato Li Gotti e avvocato Falciani… C’è qualcuno dei due? Ah, l’ho vista. Grazie, mi scusi. E’ presente l’avvocato Falciani. Calabrè Gioacchino. IMPUTATO Calabrè: (voce fuori microfono) Presente. AVVOCATO Li Gotti: E’ presente l’avvocato Li Gotti, Presidente. PRESIDENTE: C’è? (voce fuori microfono) PRESIDENTE: Dunque… chi abbiamo chiamato? Calabrè Gioacchino? IMPUTATO Calabrè: (voce fuori microfono) Presente. PRESIDENTE: Avvocato Gandolfi, Fiorentini e Cianferoni, che è presente. Cannella Cristoforo. SEGR. D’UDIENZA: (voce fuori microfono) E’ rinunciante. PRESIDENTE: Avvocato Di Peri e avvocato Rocchi… C’è l’avvocato Rocchi, sostituito dall’avvocato Gramigni. Carra Pietro: libero, assente. Avvocato Cosmai e avvocato Batacchi… AVVOCATO: E’ presente. PRESIDENTE: E’ presente. Di Natale Emanuele: contumace. Avvocato Gentile, Di Russo, Falciani, che è presente. Ferro Giuseppe: rinunciante. Avvocato Miniati Paoli, sostituito dall’avvocato Falciani. Ferro Vincenzo: libero, assente. Avvocato Traversi e avvocato Gennai… AVVOCATO: (voce fuori microfono) E’ presente l’avvocato Traversi. AVVOCATO Traversi: (voce fuori microfono) Sì, presente. PRESIDENTE: Ah, mi scusi. AVVOCATO Traversi: Eccomi, Presidente. PRESIDENTE: E’ presente l’avvocato Traversi. Frabetti Aldo. IMPUTATO Frabetti: (voce fuori microfono) Presente. PRESIDENTE: Avvocato Monaco, Usai, Roggero, sostituiti dall’avvocato Cianferoni. Giacalone Luigi. SEGR. D’UDIENZA: (voce fuori microfono) Rinunciante. -
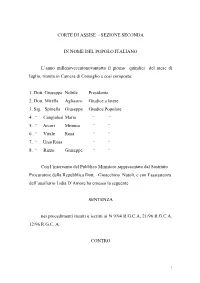
Processo Lima
CORTE DI ASSISE - SEZIONE SECONDA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L’anno millenovecentonovantotto il giorno quindici del mese di luglio, riunita in Camera di Consiglio e così composta: 1. Dott. Giuseppe Nobile Presidente 2. Dott. Mirella Agliastro Giudice a latere 3. Sig. Spinella Giuseppe Giudice Popolare 4. “ Cangialosi Maria “ “ 5. “ Arceri Mimma “ “ 6. “ Vitale Rosa “ “ 7. “ Urso Rosa “ “ 8. “ Rizzo Giuseppe “ “ Con l’intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Gioacchino Natoli, e con l’assisstenza dell’ausiliario Lidia D’Amore ha emesso la seguente SENTENZA nei procedimenti riuniti e iscritti ai N 9/94 R.G.C.A, 21/96 R.G.C.A. 12/96 R.G.C. A. CONTRO 1 1) RIINA Salvatore n. Corleone il 16.11.1930 Arrestato il 18.01.1993 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO- Detenuto per altro - Assente per rinunzia Assistito e difeso Avv. Cristoforo Fileccia Avv. Mario Grillo 2) MADONIA Francesco n. Palermo il 31.03.1924 Arrestato il 21.04.1995 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Giovanni Anania Avv. Nicolò Amato del foro di Roma 3) BRUSCA Bernardo n. San Giuseppe Jato il 09.09.1929 Arrestato il 21.10.1992 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Ernesto D’Angelo 4) BRUSCA Giovanni n. San Giuseppe Jato il 20.02.1957 Arrestato il 23.05.1996 - Scarcerato il 10.04.1998 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Luigi Li Gotti del foro di Roma Avv. -
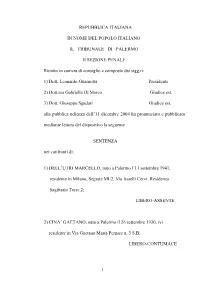
Sentenza.Pdf
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO II SEZIONE PENALE Riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri: 1) Dott. Leonardo Guarnotta Presidente 2) Dott.ssa Gabriella Di Marco Giudice est. 3) Dott. Giuseppe Sgadari Giudice est. alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2004 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA nei confronti di: 1) DELL’UTRI MARCELLO, nato a Palermo l’11 settembre 1941, residente in Milano, Segrate MI/2, Via fratelli Cervi, Residenza Sagittario Torre 2; LIBERO-ASSENTE 2) CINA’ GAETANO, nato a Palermo il 26 settembre 1930, ivi residente in Via Gaetano Maria Pernice n. 3 S.B. LIBERO-CONTUMACE 1 IMPUTATI DELL’UTRI MARCELLO A) del delitto di cui agli artt. 110 e 416 commi 1, 4 e 5 c.p., per avere concorso nelle attività della associazione di tipo mafioso denominata “Cosa Nostra”, nonché nel perseguimento degli scopi della stessa, mettendo a disposizione della medesima associazione l’influenza ed il potere derivanti dalla sua posizione di esponente del mondo finanziario ed imprenditoriale, nonché dalle relazioni intessute nel corso della sua attività, partecipando in questo modo al mantenimento, al rafforzamento ed alla espansione della associazione medesima. E così ad esempio: 1. partecipando personalmente ad incontri con esponenti anche di vertice di Cosa Nostra, nel corso dei quali venivano discusse condotte funzionali agli interessi della organizzazione; 2. intrattenendo, inoltre, rapporti continuativi con l’associazione per delinquere tramite numerosi esponenti di rilievo di detto sodalizio criminale, tra i quali Bontate Stefano, Teresi Girolamo, Pullarà Ignazio, Pullarà Giovanbattista, Mangano Vittorio, Cinà Gaetano, Di Napoli Giuseppe, Di Napoli Pietro, Ganci Raffaele, Riina Salvatore; 3. -

Processo Omicidio Francese
CORTE DI ASSISE DI APPELLO PALERMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L’anno duemiladue il giorno 13 del mese di dicembre N° 61/2002 Sent. LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI PALERMO N° 30/2002 R.G. SEZIONE SECONDA N° 1314/96 N.R. composta dai Sigg.ri : D.D.A. PA 1. Dott.1 Vincenzo OLIVERI Presidente Art. ______________ 2. Dott.2 Gianfranco GAROFALO Consigliere Camp. Penale 3. Sig.3 Giovanni INCANDELA Giud. Popolare Art.______________ 4. Sig.4 Giovanni GAROFALO “ “ Campione Civile 5. Sig.5 Isabella ZUMMO “ “ 6. Sig.6 Nicola TURRISI “ “ Compilata scheda per il Casellario e per 7. Sig.7 Antonio RIGGIO “ “ l’elettorato Addì______________ 8. Sig.8 Giuseppa GIAMMARINARO “ “ Depositata in con l’intervento del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cancelleria Antonino GATTO e con l’assistenza del cancelliere B3 Sig. Addì_______________ Aurelio DI CRISTINA ha pronunziato la seguente Irrevocabile il _________________ S E N T E N Z A nei confronti di : 1) RIINA SALVATORE, fu Giovanni e Rizzo Maria Concetta, nato a Corleone il 16.11.1930 ed ivi residente in via La Rua del Piano n. 13. Detenuto in forza di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 12.11.1998 dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo, notificata in carcere il 17.11.1998, in atto presso la Casa Circ.le di Ascoli Piceno. ASSENTE PER RINUNZIA Difensori: Avv. Cristoforo Fileccia del Foro di Palermo Avv. Domenico La Blasca “ “ 1 2) MADONIA FRANCESCO, fu Antonino e fu Trapani Rosa, nato a Palermo il 31.3.1924 ed ivi residente via Patti n. -

The Value of Connections: Evidence from the Italian-American Mafia
The Value of Connections: Evidence from the Italian-American Mafia ∗ Giovanni Mastrobuoni† September 2013‡ Abstract Using declassified Federal Bureau of Narcotics records on 800 US Mafia mem- bers active in the 1950s and 1960s, and on their connections within the Cosa Nostra network, I estimate network effects on gangsters’ economic status. Lacking informa- tion on criminal proceeds, I measure economic status exploiting detailed information about their place of residence. Housing values are reconstructed using current de- flated transactions recorded on Zillow.com. I deal with the potential reverse causality between the economic status and the gangster’s position in the network exploiting exogenous exposure to potential pre-immigration connections. In the absence of pre-immigration data I use the informational content of surnames, called isonomy, to measure the place of origin. The instrument is valid as long as conditional on the characteristics of the gang- sters (including his region of birth) such exposure influences the gangsters’ position inside the network but not the preference for specific housing needs. A standard deviation increase in closeness centrality increases economic status by about one standard deviation (100 percent). Keywords: Mafia, Networks, Centrality, Housing Prices, Value of Connections, Crime, Surnames, Isonomy. JEL classification codes: A14, C21, D23, D85, K42, Z13 ∗I would like to thank Edoardo Gallo and Michele Pellizzari for their comments. Martino Bernardi, Isabella David, and Dominic Smith have provided excellent research assistance. †Department of Economics, University of Essex, [email protected]. ‡© 2013 by Giovanni Mastrobuoni. Any opinions expressed here are those of the author. 1 Introduction In January 2011, exactly 50 years after Robert F. -

Repubblica Italiana Tribunale Di Palermo Corte Di Assise Sezione Prima
Proc. n. 18/96 R.G.C.Assise N. 22/01 Sent. REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI PALERMO CORTE DI ASSISE SEZIONE PRIMA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L’anno duemilauno, il giorno sedici del mese di novembre, la Corte di Assise così composta: 1. Dott. Claudio Dall’Acqua Presidente 2. Dott. Roberto Binenti Giudice a latere 3. Sig. Maria Rosa Piraino Giudice Popolare 4. “ Elisabetta Liparoto “ “ 5. “ Giuseppe Bondì “ “ 6. “ Rosario Salvatore Priolo “ “ 7. “ Maria Pollina “ “ 8. “ Maria Di Blasi “ “ con l’intervento del Pubblico Ministero rappresentato dai Sostituti Procuratori della Repubblica Dott.ssa Marzia Sabella e Dott. Egidio La Neve e con l’assistenza della Dott.ssa Anna Maria Giunta, ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento penale CONTRO 1. ADELFIO Francesco nato Palermo il 24.03.1941 Arrestato il 26.04.95 - Scarcerato il 12.04.99 (O.C.C. 1427/95) Assistito e difeso di fiducia da: Avv. C. Fileccia Avv. D. La Blasca Libero – residente in Palermo Via Starrabba n. 19 Assente 2. AGLIERI Pietro nato a Palermo il 09.06.1959 Arrestato il 09.06.97 - Scarcerato il 22.11.00 (O.C.C. 1427/95) Assistito e difeso di fiducia da: Avv. R. Di Gregorio Detenuto c/o Casa Circondariale Roma Rebibbia Presente in videocollegamento 3. AGRIGENTO Giuseppe nato San Cipirello il 25.11.1941 Arrestato 03.02.98 (O.C.C. 6416/97) Assistito e difeso di fiducia da: Avv. S. Priola Detenuto c/o Istituto Penitenziario di Parma Presente in video collegamento 4. ALFANO Paolo nato a Palermo 12/04/1953 Arrestato il 09.05.96 - Scarcerato il 18.05.99 (O.C.C. -

18 Settembre 1999
PRESIDENTE: Buongiorno. Vediamo i presenti. Graviano Giuseppe. è attivato il collegamento audiovisivo con Tolmezzo? ISPETTORE Colella: Buongiorno, signor Presidente, qui è Tolmezzo. Graviano Giuseppe è presente; e attualmente si trova in comunicazione telefonica col proprio avvocato di fiducia. PRESIDENTE: è nella saletta? Non lo vediamo. Non lo vediamo e… ISPETTORE Colella: sì, signor Presidente, perchè è in cabina telefonica. PRESIDENTE: Ah, c’è una cabina che non vediamo, va bene. Allora, intanto ci dà la sua qualità? Lei è ufficiale di Polizia Giudiziaria? ISPETTORE Colella: Sono l’ispettore Colella, Colella Antonio. PRESIDENTE: Bene. Nel caso che non ci sia già un provvedimento, lei è autorizzato a svolgere le funzioni di assistenza nell’udienza, ai sensi dell’articolo 146 disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale. Ecco, ci dà atto ora che non sono posti limitazioni, o impedimenti all’esercizio… Prego. ISPETTORE Colella: Do atto che non sono posti impedimenti, o limitazioni, all’esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti all’imputato. Che è attivato il collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo in cui si trova l’imputato, con modalità che assicurano la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei luoghi collegati e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Do atto inoltre che è garantita la possibilità per l’imputato di consultarsi riservatamente con il proprio difensore di fiducia. PRESIDENTE: Grazie. è presente il difensore dell’imputato, l’avvocato Giangualberto Pepi, anche in sostituzione del codifensore, avvocato Salvo. Riina Salvatore. è attivato il collegamento audiovisivo con Ascoli Piceno? VICESOVRINT. Leo: Buongiorno, signor Presidente, da Ascoli. -

Dead Silent: Life Stories of Girls and Women Killed by the Italian Mafias, 1878-2018 Robin Pickering-Iazzi University of Wisconsin-Milwaukee, [email protected]
University of Wisconsin Milwaukee UWM Digital Commons French, Italian and Comparative Literature Faculty French, Italian and Comparative Literature Books Department 2019 Dead Silent: Life Stories of Girls and Women Killed by the Italian Mafias, 1878-2018 Robin Pickering-Iazzi University of Wisconsin-Milwaukee, [email protected] Follow this and additional works at: https://dc.uwm.edu/freita_facbooks Part of the Criminology and Criminal Justice Commons, Italian Language and Literature Commons, and the Women's Studies Commons Recommended Citation Pickering-Iazzi, Robin, "Dead Silent: Life Stories of Girls and Women Killed by the Italian Mafias, 1878-2018" (2019). French, Italian and Comparative Literature Faculty Books. 2. https://dc.uwm.edu/freita_facbooks/2 This Book is brought to you for free and open access by UWM Digital Commons. It has been accepted for inclusion in French, Italian and Comparative Literature Faculty Books by an authorized administrator of UWM Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. DEAD SILENT: Life Stories of Girls and Women Killed by the Italian Mafias, 1878-2018 Robin Pickering-Iazzi Robin Pickering-Iazzi is Professor of Italian and Comparative Literature in the Department of French, Italian, and Comparative Literature at the University of Wisconsin-Milwaukee. She is the author of The Mafia in Italian Lives and Literature: Life Sentences and Their Geographies, published in Italian as Le geografie della mafia nella vita e nella letteratura dell’Italia contemporanea, and editor of the acclaimed volumes The Italian Antimafia, New Media, and the Culture of Legality and Mafia and Outlaw Stories in Italian Life and Literature. She is currently working on a book that examines representations of feminicide in Italian literature, film, and media. -

C) BERNARDO BRUSCA I Motivi
• .4i!'.! .1 c) BERNARDO BRUSCA I motivi ;diimpugnazione ,concernenti Ja-posizione l'rocessualedi questo imputato possono essere suddivisi;in due parti: una, comune al Calò, .cheafiTonta temigenerali,-'Iuali j .criteri di valutazione della prova, con particolare riferimento a quelli -previsti 1ler la chiamata .in correità e leregole sul concorso di.persone-nel reato, dei qualila Corte di primo grado, ad avviso del difensore, avrebbe -fatto malgoverno, ed un'altra che riguarda, più da vicino, la .posizione processuale nel • Brusca, quale sostituto di Salamone Antonino. Quanto al primo dei due ordirri ài censure,-rileva il Collegio che la questione ha avuto abbondante trattazione, sia nella-parte generale, che nelle precedenti posizioni processuali, sicché appare .superfluo ripetere quanto, in altre seài, già detto. Giova, comunque, ricordare che .al Tilievo concernente Ja -causale asseritamente, in maniera apodittica, Tiportata dalla Corte di primo grado a contrasti del Reina con Cianciminoe i suoi alleati '~corleonesi", nonostante le propalazioni del Mutolo fossero .rimaste .sostanzialmente • smentite dal D'Alia, il Collegio ha già risposto nel corso dell'~same della posizione processuale del Greco, mentre il -rilievo concernente l'omicidio in danno deII' Onorevole La Torre sarà trattato inqueIIa sede. Del tutto pnva, poi, di reale significato si palesa l'osservazione difensiva, secondo la quale le modalità di esecuzione .deldelitto in esame consentirebbero di ricondurre, in maniera certa, l'omicidio ad 143 organizzazioni terroristiche in quel periodo operanti (peraltro :non risulta, anzi la storia giudiziaria ci dice il contrario, che in quel periodo operassero in Sicilia propagginidi .gruppi orerroristiciaventimatrice polit.ica, sicuramente costituiti in altre partiàel territorio :nazionale). -

Corte Di Assise Di Appello Di Caltanissetta La Corte Di Assise Di Appello Di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A N.14/02 Reg. Sent N. 18/01 R. G. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 1314/96 R.G.N.R. Corte di Assise di Appello di Caltanissetta S E N T E N Z A La Corte di Assise di Appello di Caltanissetta In data 24/06/2002 - composta dai Sigg. Magistrati: Depositata in Cancelleria 1. Dott. Antonio MAFFA ____________________ Presidente il __________________ 2. Dott.ssa Daniela Rita TORNESI______________ Consigliere Rel. 3. Sig.ra Maria CASTROGIOVANNI ___________ Giudice Popolare Il Cancelliere 4. Sig.ra Domenica CANCILLA ________________ Giudice Popolare 5. Sig.ra Anna Maria GIAMBARRESI ___________ Giudice Popolare 6. Sig. Antonino LO VETERE __________________Giudice Popolare Addì _________________ 7. Sig. Giuseppe FALZONE ___________________ Giudice Popolare Redatt _____ sched _ 8. Sig. Armando FERRARA ____________________Giudice Popolare N. __________________ Con l’intervento del Procuratore Generale Dott. G. BARCELLONA e dei Art. Camp. Pen. Sost. Procuratori Generali Dott. Dolcino FAVI e Dott. Luigi BIRRITTERI; con l’assistenza del Cancelliere Maria Cristina LETO; ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A 1 CONTRO 1)RIINA Salvatore nato a Corleone (PA) il 16/11/1930; in atto detenuto c/o Casa Circondariale di Ascoli Piceno; Ord. cust. caut. in carcere del 09/06/1997 - Notif. 11/06/1997. Difeso dall’Avv. Cristoforo Fileccia e dall’Avv. Domenico La Blasca del Foro di Palermo. Detenuto - assente per rinuncia 2) PROVENZANO BERNARDO, nato a Corleone il 31/01/1933; Ord. cust. caut. in carcere del 09/06/1997; Decr. -
Evidence from the Italian-American Mafia
ISSN 2279-9362 The Value of Connections: Evidence from the ItalianAmerican Mafia Giovanni Mastrobuoni No. 335 December 2013 www.carloalberto.org/research/working-papers © 2013 by Giovanni Mastrobuoni. Any opinions expressed here are those of the authors and not those of the Collegio Carlo Alberto. The Value of Connections: Evidence from the Italian-American Mafia ∗ Giovanni Mastrobuoni† January 2014‡ Abstract Using declassified Federal Bureau of Narcotics records on 800 US Mafia mem- bers active in the 1950s and 1960s, and on their connections within the organized crime network, I estimate network effects on gangsters’ economic status. Lacking information on criminal proceeds, I measure economic status exploiting detailed information about their place of residence. Housing values are reconstructed using current deflated transactions recorded on Zillow.com. I deal with the potential reverse causality between the economic status and the gangster’s position in the network exploiting exogenous exposure to potential pre-immigration connections. In the absence of pre-immigration data I use the informational content of surnames, called isonomy, to measure the place of origin. The instrument is valid as long as conditional on the characteristics of the gang- sters (including the region of birth and a rich set of controls about the gangsters’ legal and illegal activities) such exposure influences the gangsters’ importance in- side the network (called centrality) but not the preference for specific housing needs. A standard deviation increase in closeness centrality increases economic status by between one forth (OLS) and one standard deviation (2SLS). Keywords: Mafia, Networks, Centrality, Housing Prices, Value of Connections, Crime, Surnames, Isonomy.