Le Trattative
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

STRUTTURE Cosa Nostra E 'Ndrangheta a Confronto
STRUTTURE Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto Francesco Gaetano Moiraghi Andrea Zolea WikiMafia – Libera Enciclopedia sulle Mafie www.wikimafia.it Strutture: Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto, di Francesco Gaetano Moiraghi e Andrea Zolea La mafia dura da decenni: un motivo ci deve essere. Non si può andare contro i missili con arco e frecce: in queste vicende certe intemperanze si pagano duramente. Con il terrorismo, con il consenso sociale, potevi permettertele: con la mafia non è così. Nella società c’è un consenso distorto. Altro che bubbone in un tessuto sociale sano. Il tessuto non è affatto sano. Noi estirperemo Michele Greco, poi arriverà il secondo, poi il terzo, poi il quarto. Giovanni Falcone 1 www.wikimafia.it Strutture: Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto, di Francesco Gaetano Moiraghi e Andrea Zolea PREMESSA Questo lavoro ha lo scopo di offrire uno sguardo d’insieme sulle articolazioni strutturali delle organizzazioni mafiose denominate Cosa nostra e ‘ndrangheta . La prima sezione, curata da Francesco Gaetano Moiraghi, si concentra sull’analisi di Cosa nostra. La seconda sezione, che sposta il focus sulla ‘ndrangheta, è curata da Andrea Zolea. Come si potrà notare, le due sezioni non sono state realizzate secondo uno stesso modello, ma analizzano le due organizzazioni con un approccio differente. Ad esempio, la parte su Cosa nostra avrà un orientamento maggiormente diacronico, diversamente da quella sulla ‘ndrangheta, basata su un approccio sincronico. Il presente testo ha infatti l’obiettivo di offrire due proposte di analisi differenti che riescano a mettere in luce le analogie e le differenze delle strutture delle due organizzazioni mafiose. -

14 Gennaio 1998
PRESIDENTE: Ci siamo? Buongiorno. Bagarella è presente? IMPUTATO Bagarella: (voce fuori microfono) Presente. PRESIDENTE: Avvocato Ceolan, avvocato Cianferoni; presenti entrambi. Barranca Giuseppe. SEGR. D’UDIENZA: (voce fuori microfono) Rinunciante. PRESIDENTE: Avvocato Barone e avvocato Cianferoni, che è presente. Benigno Salvatore. SEGR. D’UDIENZA: (voce fuori microfono) Rinunciante. PRESIDENTE: Avvocato Farina e avvocato Maffei, è sostituito dall’avvocato Cianferoni. Brusca Giovanni: lo sentiremo fra poco. Avvocato Li Gotti e avvocato Falciani… C’è qualcuno dei due? Ah, l’ho vista. Grazie, mi scusi. E’ presente l’avvocato Falciani. Calabrè Gioacchino. IMPUTATO Calabrè: (voce fuori microfono) Presente. AVVOCATO Li Gotti: E’ presente l’avvocato Li Gotti, Presidente. PRESIDENTE: C’è? (voce fuori microfono) PRESIDENTE: Dunque… chi abbiamo chiamato? Calabrè Gioacchino? IMPUTATO Calabrè: (voce fuori microfono) Presente. PRESIDENTE: Avvocato Gandolfi, Fiorentini e Cianferoni, che è presente. Cannella Cristoforo. SEGR. D’UDIENZA: (voce fuori microfono) E’ rinunciante. PRESIDENTE: Avvocato Di Peri e avvocato Rocchi… C’è l’avvocato Rocchi, sostituito dall’avvocato Gramigni. Carra Pietro: libero, assente. Avvocato Cosmai e avvocato Batacchi… AVVOCATO: E’ presente. PRESIDENTE: E’ presente. Di Natale Emanuele: contumace. Avvocato Gentile, Di Russo, Falciani, che è presente. Ferro Giuseppe: rinunciante. Avvocato Miniati Paoli, sostituito dall’avvocato Falciani. Ferro Vincenzo: libero, assente. Avvocato Traversi e avvocato Gennai… AVVOCATO: (voce fuori microfono) E’ presente l’avvocato Traversi. AVVOCATO Traversi: (voce fuori microfono) Sì, presente. PRESIDENTE: Ah, mi scusi. AVVOCATO Traversi: Eccomi, Presidente. PRESIDENTE: E’ presente l’avvocato Traversi. Frabetti Aldo. IMPUTATO Frabetti: (voce fuori microfono) Presente. PRESIDENTE: Avvocato Monaco, Usai, Roggero, sostituiti dall’avvocato Cianferoni. Giacalone Luigi. SEGR. D’UDIENZA: (voce fuori microfono) Rinunciante. -
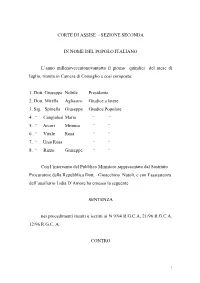
Processo Lima
CORTE DI ASSISE - SEZIONE SECONDA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L’anno millenovecentonovantotto il giorno quindici del mese di luglio, riunita in Camera di Consiglio e così composta: 1. Dott. Giuseppe Nobile Presidente 2. Dott. Mirella Agliastro Giudice a latere 3. Sig. Spinella Giuseppe Giudice Popolare 4. “ Cangialosi Maria “ “ 5. “ Arceri Mimma “ “ 6. “ Vitale Rosa “ “ 7. “ Urso Rosa “ “ 8. “ Rizzo Giuseppe “ “ Con l’intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Gioacchino Natoli, e con l’assisstenza dell’ausiliario Lidia D’Amore ha emesso la seguente SENTENZA nei procedimenti riuniti e iscritti ai N 9/94 R.G.C.A, 21/96 R.G.C.A. 12/96 R.G.C. A. CONTRO 1 1) RIINA Salvatore n. Corleone il 16.11.1930 Arrestato il 18.01.1993 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO- Detenuto per altro - Assente per rinunzia Assistito e difeso Avv. Cristoforo Fileccia Avv. Mario Grillo 2) MADONIA Francesco n. Palermo il 31.03.1924 Arrestato il 21.04.1995 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Giovanni Anania Avv. Nicolò Amato del foro di Roma 3) BRUSCA Bernardo n. San Giuseppe Jato il 09.09.1929 Arrestato il 21.10.1992 - Scarcerato il 05.05.1997 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Ernesto D’Angelo 4) BRUSCA Giovanni n. San Giuseppe Jato il 20.02.1957 Arrestato il 23.05.1996 - Scarcerato il 10.04.1998 LIBERO - Detenuto per altro - Assente per Rinunzia Assistito e difeso Avv. Luigi Li Gotti del foro di Roma Avv. -

Italiens Langer Weg Zur Wahrheit
DIE RHEINPFALZ — NR. 119 HINTERGRUND MITTWOCH, 23. MAI 2012 03_POLI Russland: Italiens langer Weg zur Wahrheit Putin zementiert seine Machtbasis 20 Jahre nach den spektakulären Bomben-Attentaten auf die Staatsanwälte Giovanni Falcone und Paolo Borsellino sind gewichtige Fragen noch immer offen. Wie kamen die Täter an die riesigen Mengen Militärsprengstoffs? VON ELKE WINDISCH, MOSKAU Wer trug Borsellinos Aktentasche vom Tatort? Wer bediente die Fernzündungen? Ja, sicher die Mafia, aber wer genau? Alle Erlasse sind unterschrieben: Russlands Präsident Putin hat sein VON PAUL KREINER, PALERMO neues Kabinett verkündet. Neuer In- nenminister wird ausgerechnet der Wie hält dieser Baum sich nur am Le- bisherige Moskauer Polizeichef ben? An einer zubetonierten, vielspu- Wladimir Kolokolzew, dessen har- rigen Innenstadtstraße, wo in der si- te Hand gegen Demonstranten be- zilianischen Hitze sonst nur Kübel- rüchtigt ist. Sechs seiner früheren pflanzen vor sich hin kümmern, Minister holt der vormalige Pre- wächst diese Magnolie vier Stock- mier Putin in den Kreml. werke hoch. Dankesbekundungen hängen dran wie sonst nur an wun- Putin war Anfang Mai nach einem dertätigen Heiligenstatuen. Die Mag- vierjährigen Intermezzo als Regie- nolie von Palermo ist ein nationales rungschef für eine dritte Amtszeit Mahnmal in Italien, so wie es in als Präsident vereidigt worden. Ei- Deutschland einmal die Berliner nen Tag später wählte das russische Mauer war. Jedes Jahr kommen un- Parlament seinen Vorgänger Medwe- zählige Schulklassen zum freiwilli- dew zum Ministerpräsidenten. Ge- gen oder pädagogisch angeleiteten gen den Ämtertausch gibt es in Russ- Gedenken vorbei: Die Pflanze land seit Monaten Proteste. wächst vor dem Haus, in dem der An- timafia-Staatsanwalt Giovanni Falco- ne gewohnt hat. -

Il Giorno 3 Del Mese Di Aprile, Uniti D'america), Presso L'u.S. Meridionale Di New York, Sono PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
12956 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA L'anno millenovecentonovantatrè, il giorno 3 del mese di aprile, alle ore 10, in New York (Stati Uniti d'America), presso l'U.S. Attorney' s ottice del Distretto Meridionale di New York, sono presenti :. l'Assistant U.S. Attorney Patrick FITZGERALDi il Procuratore della Repubblica di Palermo dottor Gian Carlo CASELLI e il Sostituto Procuratore della Repubblica di Palermo dottor Guido LO FORTEi il signor Francesco MARINO MANNOIA, nato a Palermo il 5 marzo 1951i gli avvocati Luigi LI GOTTI del foro di Roma e Carlo FABBRI del foro di Palermo, difensori di fiducia del MARINO MANNOIA. si dà atto della presenza del dottor Francesco GRATTERI in forza alla DIA per esigenze investigative i presenza autorizzata dall'Autorità giudiziaria degli stati Uniti. • si dà atto che con autorizzazione del Dipartimento di Giustizia rappresentato daPatrick FITZGERALD si dà corso all'interrogatorio di MARINO MANNOIA Francesco, nell'ambito della commissione rogatoria internazionale già autorizzata in relazione al procedimento penale n. 1557/92 della Procura della Repubblica di Palermo concernente l'omicidio di Salvatore LIMA commesso in Palermo il 12 marzo 1992. Giusta autorizzazione già concessa, al predetto interrogatorio 1 procedono direttamente il Procuratore della Repubblica dottor • CASELLI e il Sostituto Procuratore dottor LO FORTE . Preliminarmente il dottor Patrick FITZGERALD precisa che, giusta note dell'Ambasciata degli stati Uniti d'America in data 30 marzo 1993, dirette al Ministero di Grazia e Giustizia dello stato italiano, l'Autorità statunitense, in conformità al Trattato di mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti e l'Italia, impone le sotto indicate condizioni: .. -

Brief History of Sicilian Mafia
For centuries, there had been banditry in southern Italy. It is not surprising when we consider that the area south of Rome was ruled for hundreds of years by foreign powers and the land was generally (mis)managed by absentee landlords. In their absence, the bandits stepped in to enforce the payment of dues or meagre profits from the peasants to the landowners, creaming a lot off the top. Stealing from the rich to give to the poor was no part of their raison d’etre. Over time, they became the landowners’ enforcers and then began to take over large tracts but it was the unification of Italy, following Garibaldi’s march through Sicily and up through southern Italy defeating and forcing the capitulation of the Spanish Bourbons, rulers of the Kingdom of the Two Sicilies, which gave them their greatest opportunity . If you have read “The Leopard” by Giuseppe di Lampedusa or seen the film, you will have recognised that the Mafia were gaining an important role in the running of Sicilian cities, towns and regions; they were gaining election as mayors and they were marrying into families of the nobility of the island. The Risorgimento whilst unifying the country also exaggerated the division between the north and the south. Sicilians often used to dispute (at least publicly) the existence of the Mafia or La Cosa Nostra (Our Thing) as the organisation names itself. They claimed that it was a northern construct. However, there is an excellent book by Gianni Riotta, “Prince of the Clouds”, which describes how the mafia, acting as a private army on behalf of the landowner against her peasants, uses force and murder to keep the poor of Sicily under control. -

Magisterarbeit
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by OTHES Magisterarbeit Titel der Magisterarbeit La Cosa Nostra – Struktur, Funktionen und mediale Berichterstattung im Zuge des Maxiprozesses von Palermo (10.2.1986 – 17.12.1987) Verfasser Fabio Arienti BA angestrebter akademischer Grad Magister der Philosophie (Mag. phil.) Wien, 2009 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 236 349 Studienrichtung lt. Studienblatt: Italienisch Betreuer: Ao. Univ.-Prof. Dr. Robert Tanzmeister Inhaltsverzeichnis: Inhaltsverzeichnis S.1 1. Fragestellung S.3 2. Methode S.6 3. Aktueller Forschungsstand S.9 4. Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte S.12 4.1. Etymologie S.13 4.2. Glossar S.13 4.3. Entwicklung seit dem 19. Jahrhundert S.16 4.3.1. Die Einigung Italiens S.17 4.3.2. Implementierung einer lokalen Verwaltung S.19 4.3.3. Der Erste Weltkrieg S.22 4.3.4. Faschismus S.22 4.3.5. Die Nachkriegsjahre S.23 4.3.6. Wirtschaftlicher Aufschwung S.26 4.3.7. Der Drogenhandel S.27 4.3.8. Änderungen in der öffentlichen Wahrnehmung S.29 4.3.9. Wiederbelebung und zweite Phase des Drogenhandels S.31 4.3.10. Die Machtergreifung der Mafia aus Corleone S.33 4.3.11. Dalla Chiesa, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino und der Antimafia Pool S.34 4.3.12. Revolutionierung der politischen Landschaft Italiens S.36 5. Struktur und soziale Funktionen S.38 5.1. Ihre Struktur nach Giovanni Falcone S.38 5.2. Ihre Funktionen nach Raimondo Catanzaro S.46 5.2.1. Die Mafia als Vermittler zwischen unterschiedlichen sozialen Gruppen S.48 1 5.2.2. -
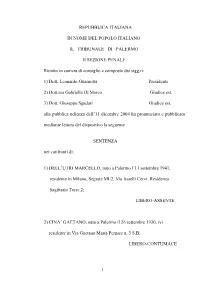
Sentenza.Pdf
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALERMO II SEZIONE PENALE Riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri: 1) Dott. Leonardo Guarnotta Presidente 2) Dott.ssa Gabriella Di Marco Giudice est. 3) Dott. Giuseppe Sgadari Giudice est. alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2004 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA nei confronti di: 1) DELL’UTRI MARCELLO, nato a Palermo l’11 settembre 1941, residente in Milano, Segrate MI/2, Via fratelli Cervi, Residenza Sagittario Torre 2; LIBERO-ASSENTE 2) CINA’ GAETANO, nato a Palermo il 26 settembre 1930, ivi residente in Via Gaetano Maria Pernice n. 3 S.B. LIBERO-CONTUMACE 1 IMPUTATI DELL’UTRI MARCELLO A) del delitto di cui agli artt. 110 e 416 commi 1, 4 e 5 c.p., per avere concorso nelle attività della associazione di tipo mafioso denominata “Cosa Nostra”, nonché nel perseguimento degli scopi della stessa, mettendo a disposizione della medesima associazione l’influenza ed il potere derivanti dalla sua posizione di esponente del mondo finanziario ed imprenditoriale, nonché dalle relazioni intessute nel corso della sua attività, partecipando in questo modo al mantenimento, al rafforzamento ed alla espansione della associazione medesima. E così ad esempio: 1. partecipando personalmente ad incontri con esponenti anche di vertice di Cosa Nostra, nel corso dei quali venivano discusse condotte funzionali agli interessi della organizzazione; 2. intrattenendo, inoltre, rapporti continuativi con l’associazione per delinquere tramite numerosi esponenti di rilievo di detto sodalizio criminale, tra i quali Bontate Stefano, Teresi Girolamo, Pullarà Ignazio, Pullarà Giovanbattista, Mangano Vittorio, Cinà Gaetano, Di Napoli Giuseppe, Di Napoli Pietro, Ganci Raffaele, Riina Salvatore; 3. -

Processo Omicidio Francese
CORTE DI ASSISE DI APPELLO PALERMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L’anno duemiladue il giorno 13 del mese di dicembre N° 61/2002 Sent. LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI PALERMO N° 30/2002 R.G. SEZIONE SECONDA N° 1314/96 N.R. composta dai Sigg.ri : D.D.A. PA 1. Dott.1 Vincenzo OLIVERI Presidente Art. ______________ 2. Dott.2 Gianfranco GAROFALO Consigliere Camp. Penale 3. Sig.3 Giovanni INCANDELA Giud. Popolare Art.______________ 4. Sig.4 Giovanni GAROFALO “ “ Campione Civile 5. Sig.5 Isabella ZUMMO “ “ 6. Sig.6 Nicola TURRISI “ “ Compilata scheda per il Casellario e per 7. Sig.7 Antonio RIGGIO “ “ l’elettorato Addì______________ 8. Sig.8 Giuseppa GIAMMARINARO “ “ Depositata in con l’intervento del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cancelleria Antonino GATTO e con l’assistenza del cancelliere B3 Sig. Addì_______________ Aurelio DI CRISTINA ha pronunziato la seguente Irrevocabile il _________________ S E N T E N Z A nei confronti di : 1) RIINA SALVATORE, fu Giovanni e Rizzo Maria Concetta, nato a Corleone il 16.11.1930 ed ivi residente in via La Rua del Piano n. 13. Detenuto in forza di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 12.11.1998 dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo, notificata in carcere il 17.11.1998, in atto presso la Casa Circ.le di Ascoli Piceno. ASSENTE PER RINUNZIA Difensori: Avv. Cristoforo Fileccia del Foro di Palermo Avv. Domenico La Blasca “ “ 1 2) MADONIA FRANCESCO, fu Antonino e fu Trapani Rosa, nato a Palermo il 31.3.1924 ed ivi residente via Patti n. -

The Value of Connections: Evidence from the Italian-American Mafia
The Value of Connections: Evidence from the Italian-American Mafia ∗ Giovanni Mastrobuoni† September 2013‡ Abstract Using declassified Federal Bureau of Narcotics records on 800 US Mafia mem- bers active in the 1950s and 1960s, and on their connections within the Cosa Nostra network, I estimate network effects on gangsters’ economic status. Lacking informa- tion on criminal proceeds, I measure economic status exploiting detailed information about their place of residence. Housing values are reconstructed using current de- flated transactions recorded on Zillow.com. I deal with the potential reverse causality between the economic status and the gangster’s position in the network exploiting exogenous exposure to potential pre-immigration connections. In the absence of pre-immigration data I use the informational content of surnames, called isonomy, to measure the place of origin. The instrument is valid as long as conditional on the characteristics of the gang- sters (including his region of birth) such exposure influences the gangsters’ position inside the network but not the preference for specific housing needs. A standard deviation increase in closeness centrality increases economic status by about one standard deviation (100 percent). Keywords: Mafia, Networks, Centrality, Housing Prices, Value of Connections, Crime, Surnames, Isonomy. JEL classification codes: A14, C21, D23, D85, K42, Z13 ∗I would like to thank Edoardo Gallo and Michele Pellizzari for their comments. Martino Bernardi, Isabella David, and Dominic Smith have provided excellent research assistance. †Department of Economics, University of Essex, [email protected]. ‡© 2013 by Giovanni Mastrobuoni. Any opinions expressed here are those of the author. 1 Introduction In January 2011, exactly 50 years after Robert F. -

The Antimafia Movement and Its Counter-Hegemonic Attack on Cosa Nostra Jennifer Anne Diefendorf Bates College, [email protected]
Bates College SCARAB Honors Theses Capstone Projects Spring 5-2011 Taking Back Sicily: The Antimafia Movement and its Counter-Hegemonic Attack on Cosa Nostra Jennifer Anne Diefendorf Bates College, [email protected] Follow this and additional works at: http://scarab.bates.edu/honorstheses Recommended Citation Diefendorf, Jennifer Anne, "Taking Back Sicily: The Antimafia Movement and its Counter-Hegemonic Attack on Cosa Nostra" (2011). Honors Theses. 3. http://scarab.bates.edu/honorstheses/3 This Open Access is brought to you for free and open access by the Capstone Projects at SCARAB. It has been accepted for inclusion in Honors Theses by an authorized administrator of SCARAB. For more information, please contact [email protected]. Diefendorf 1 Taking Back Sicily: The Antimafia Movement and its Counter-Hegemonic Attack on Cosa Nostra An Honors Thesis Presented to The Faculty of the Department of Politics Bates College In partial fulfillment of the requirements for the Degree of Bachelor of Arts By Jennifer Diefendorf Lewiston, Maine March 25, 2011 Diefendorf 2 Table of Contents 1. Acknowledgements ………………………………………………………………3 2. Abstract …………………………………………………………………………...4 3. Introduction ………………………………………………………………………5 4. Chapter 1 : Gramsci, Hegemony, and Civil Society…………………………….15 5. Chapter 2 : Establishing Cosa Nostra and the Italian State as a Hegemonic Bloc…………...32 6. Chapter 3 : The History of the Antimafia Movement…………………………...65 7. Chapter 4 : The Counter-Hegemonic Nature of the Contemporary Movement.....................114 8. Conclusion……………………………………………………………………..167 9. Bibliography …………………………………………………………………...174 Diefendorf 3 ACKNOWLEDGEMENTS: Numerous individuals deserve to be recognized for the formative role they each played in helping to create this project. First, I give my sincere gratitude and appreciation to my advisor, Jim Richter. -

Il Processo Andreotti. Il Confine Labile Fra La Partecipazione E Il Concorso Esterno Nei Reati Associativi
La ricerca 3 IL PROCESSO ANDREOTTI. IL CONFINE LABILE FRA LA PARTECIPAZIONE E IL CONCORSO ESTERNO NEI REATI ASSOCIATIVI Paolo Intoccia Abstract By examining an exceptional criminal proceeding in this paper we propose to conduct a study on criminal law ‘in action’ in order to verify the mechanisms of application of two associative offenses (‘simple’ criminal conspiracy and mafia-type criminal conspiracy). As a matter of fact the analysis reconstructs the intense trial about Giulio Andreotti’s working with Cosa Nostra – Andreotti, starting from March 4 1993, is accused of being at first an external competitor and subsequently a participant of Cosa Nostra in connection with a qualitatively complex accusatory apparatus. As a result of this analysis we come to ascertain how fleeting the boundary between the role of participant and external competitor in a criminal conspiracy can be, especially in case of political working with mafia-type criminal conspiracy (here Cosa Nostra). Keywords: Andreotti, Cosa Nostra, grey area, associative offenses, fake news 1. Introduzione I reati associativi offrono, tradizionalmente, grande spazio alle riflessioni in merito al rapporto fra diritto teorico e diritto pratico; ciò avviene, principalmente, in ragione di una sensibile lacunosità della disciplina di fonte legislativa che, unita all’influenza esercitata da un repertorio di conoscenze non solo giuridiche (e cioè criminologiche, sociologiche, storiche), induce addirittura a sospettare, rispetto a taluni di detti reati, del fatto che sia lo stesso legislatore ad aver voluto lasciare alla prassi il compito di selezionare, volta per volta, le condotte qualificabili come degne di rilevanza penale. Nel presente elaborato ci si propone, allora, di condurre uno studio sul diritto penale ‘in azione’, con specifico riferimento ai reati associativi, prendendo in esame un 79 Cross Vol.3 N°3 (2017) - DOI: http://dx.doi.org/10.13130/cross-9278 La ricerca 3 procedimento penale d’eccezione (il cd.