Estremi Confini
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more
Recommended publications
-

My Dear Beaufort: a Personal Letter from John Ross's Arctic Expedition
ARCTIC VOL. 40, NO. 1 (MARCH 1987) P. 66-77 My Dear Beaufort: A Personal Letter from John Ross’s Arctic Expedition of 1829-33 CLIVE HOLLAND’ and JAMES M. SAVELLE2 (Received 30 January 1986; accepted in revised form 6 October 1986) ABSTRACT. During his four years’ residence in the Canadian Arctic in search of a Northwest Passage in 1829-33, John Ross wrote a private letter to Francis Beaufort, Hydrographer of the Navy. The letter, reproduced here, provides valuable historical insights into many aspects of Ross’s character and of the expedition generally. His feelings of bitterness toward several of his contemporaries, especially John Barrow and William E. Parry, due to the ridicule suffered as a result of the failure of his first arctic voyage in 1818, are especially revealing, as is his apparently uneasy relationship with his nephew and second-in-command, James Clark Ross. Ross’s increasing despair andpessimism with each succeeding enforced wintering and, eventually, the abandonment of the expedition ship Victory are also clearly evident. Finally,the understandable problems of maintaining crew discipline during the final year of the expedition, though downplayed, begin to emerge. Key words: John Ross, arctic exploration, 1829-33 Arctic Expedition, unpublished letter RÉSUMÉ. Durant les quatre années où ilr6sidadans l’Arctique canadien à la recherche du Passage du Nord-Ouest, de 1829 à 1833, John Ross écrivit une lettre personnelle à Francis Beaufort, hydrographe de la marine. Cette lettre, reproduite ici, permet de mieux apprécier du point de vue historique, certains aspects du caractère de Ross et de l’expédition en général. -
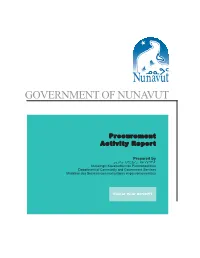
Procurement Activity Report 2016-2017
GOVERNMENT OF NUNAVUT Procurement Activity Repor t kNo1i Z?m4fiP9lre pWap5ryeCd6 t b4fy 5 Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut Department of Community and Government Services Ministère des Services communautaires et gouvernementaux Fiscal Year 2016/17 GOVERNMENT OF NUNAVUT Procurement Activity Report Table of Contents Purpose . 3 Objective . 3 Introduction . 3 Report Overview . 4 Sole Source Contract Observations . 5 General Observations . 9 Summary . 11 1. All Contracts (> $5,000) . 11 2. Contracting Types . 15 3. Contracting Methods . 18 4. Sole Source Contract Distribution . 22 Appendices Appendix A: Glossary and Definition of Terms . 27 Appendix B: Sole Source (> $5,000) . 29 Appendix C: Contract Detailed Listing (> $5,000) . 31 1 GOVERNMENT OF NUNAVUT Procurement Activity Report Purpose The Department of Community and Government Services (CGS) is pleased to present this report on the Government of Nunavut (GN's) procurement and contracting activities for the 2016/17 fiscal year. Objective CGS is committed to ensuring fair value and ethical practices in meeting its responsibilities. This is accomplished through effective policies and procedures aimed at: • Obtaining the best value for Nunavummiut overall; • Creating a fair and open environment for vendors; • Maintaining current and accurate information; and • Ensuring effective approaches to meet the GN's requirements. Introduction The Procurement Activity Report presents statistical information and contract detail about GN contracts as reported by GN departments to CGS's Procurement, Logistics and Contract Support section. Contracts entered into by the GN Crown agencies and the Legislative Assembly are not reported to CGS and are not included in this report. Contract information provided in this report reflects contracts awarded and reported during the 2016/2017 fiscal year. -

Arts Books & Ephemera
Arts 5. Dom Gusman vole les Confitures chez le Cardinal, dont il est reconnu. Tome 2, 1. Adoration Des Mages. Tableau peint Chap. 6. par Eugene Deveria pour l'Eglise de St. Le Mesle inv. Dupin Sculp. A Paris chez Dupin rue St. Jacques A.P.D.R. [n.d., c.1730.] Leonard de Fougeres. Engraving, 320 x 375mm. 12½ x 14¾". Slightly soiled A. Deveria. Lith. de Lemercier. [n.d., c.1840.] and stained. £160 Lithograph, sheet 285 x 210mm. 11¼ x 8¼". Lightly Illustration of a scene from Dom Juan or The Feast foxed. £80 with the Statue (Dom Juan ou le Festin de pierre), a The Adoration of the Magi is the name traditionally play by Jean-Baptiste Poquelin, known by his stage given to the representation in Christian art of the three name Molière (1622 - 1673). It is based on the kings laying gifts of gold, frankincense, and myrrh legendary fictional libertine Don Juan. before the infant Jesus, and worshiping Him. This Engraved and published in Paris by Pierre Dupin interpretation by Eugene Deveria (French, 1808 - (c.1690 - c.1751). 1865). From the Capper Album. Plate to 'Revue des Peintres' by his brother Achille Stock: 10988 Devéria (1800 - 1857). As well as a painter and lithographer, Deveria was a stained-glass designer. Numbered 'Pl 1.' upper right. Books & Ephemera Stock: 11084 6. Publicola's Postscript to the People of 2. Vauxhall Garden. England. ... If you suppose that Rowlandson & Pugin delt. et sculpt. J. Bluck, aquat. Buonaparte will not attempt Invasion, you London Pub. Octr. 1st. 1809, at R. -
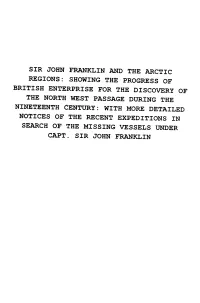
Sir John Franklin and the Arctic
SIR JOHN FRANKLIN AND THE ARCTIC REGIONS: SHOWING THE PROGRESS OF BRITISH ENTERPRISE FOR THE DISCOVERY OF THE NORTH WEST PASSAGE DURING THE NINE~EENTH CENTURY: WITH MORE DETAILED NOTICES OF THE RECENT EXPEDITIONS IN SEARCH OF THE MISSING VESSELS UNDER CAPT. SIR JOHN FRANKLIN WINTER QUARTERS IN THE A.ROTIO REGIONS. SIR JOHN FRANKLIN AND THE ARCTIC REGIONS: SHOWING FOR THE DISCOVERY OF THE NORTH-WEST PASSAGE DURING THE NINETEENTH CENTURY: WITH MORE DETAILED NOTICES OF THE RECENT EXPEDITIONS IN SEARCH OF THE MISSING VESSELS UNDER CAPT. SIR JOHN FRANKLIN. BY P. L. SIMMONDS, HONORARY AND CORRESPONDING JIIEl\lBER OF THE LITERARY AND HISTORICAL SOCIETIES OF QUEBEC, NEW YORK, LOUISIANA, ETC, AND MANY YEARS EDITOR OF THE COLONIAL MAGAZINE, ETC, ETC, " :Miserable they Who here entangled in the gathering ice, Take their last look of the descending sun While full of death and fierce with tenfold frost, The long long night, incumbent o•er their heads, Falls horrible." Cowl'ER, LONDON: GEORGE ROUTLEDGE & CO., SOHO SQUARE. MDCCCLI. TO CAPT. SIR W. E. PARRY, R.N., LL.D., F.R.S., &c. CAPT. SIR JAMES C. ROSS, R.N., D.C.L., F.R.S. CAPT. SIR GEORGE BACK, R.N., F.R.S. DR. SIR J. RICHARDSON, R.N., C.B., F.R.S. AND THE OTHER BRAVE ARCTIC NAVIGATORS AND TRAVELLERS WHOSE ARDUOUS EXPLORING SERVICES ARE HEREIN RECORDED, T H I S V O L U M E I S, IN ADMIRATION OF THEIR GALLANTRY, HF.ROIC ENDURANCE, A.ND PERSEVERANCE OVER OBSTACLES OF NO ORDINARY CHARACTER, RESPECTFULLY DEDICATED, BY THEIR VERY OBEDIENT HUMBLE SERVANT, THE AUTHOR. -

National Energy Board Office National De L’Énergie
NATIONAL ENERGY BOARD OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE PUBLIC REVIEW OF ARCTIC SAFETY AND ENVIRONMENTAL OFFSHORE DRILLING REQUIREMENTS EXAMEN PUBLIC DES EXIGENCES RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET À L’ENVIRONNEMENT POUR LES ACTIVITÉS DE FORAGE EXTRACÔTIER DANS L’ARCTIQUE VOLUME 1 Roundtable held at Table ronde tenue au Midnight Sun Complex Inuvik, Northwest Territories September 12, 2011 le 12 septembre 2011 International Reporting Inc. Ottawa, Ontario (613) 748-6043 © Her Majesty the Queen in Right of Canada 2011 © Sa Majesté du Chef du Canada 2011 as represented by the National Energy Board représentée par l‟Office national de l‟énergie This publication is the recorded verbatim transcript Cette publication est un compte rendu textuel des and, as such, is taped and transcribed in either of the délibérations et, en tant que tel, est enregistrée et official languages, depending on the languages transcrite dans l‟une ou l‟autre des deux langues spoken by the participant at the public hearing. officielles, compte tenu de la langue utilisée par le participant à l‟audience publique. Printed in Canada Imprimé au Canada Transcript Hearing Order GH-1-2011 ROUNDTABLE / TABLE RONDE Public Review of Arctic Safety and Environmental Offshore Drilling Requirements Examen public des exigences relatives à la sécurité et à l‟environnement pour les activités de forage extracôtier dans l‟Arctique ROUNDTABLE LOCATION/LIEU DE LA TABLE RONDE Roundtable held in Inuvik (Northwest Territories), Monday, September 12, 2011 Table ronde tenue à Inuvik (Territoires du Nord-Ouest), lundi, le 12 septembre 2011 BOARD PANEL/COMITÉ D'AUDIENCE DE L'OFFICE G. Caron Chairman/Président D. -
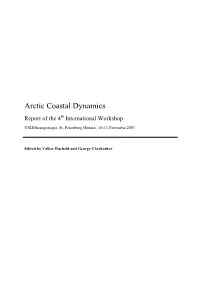
Downloaded Daily to the Geodetic Survey Division in Ottawa, Where They Are Reviewed for Quality Control, Archived, and Uploaded to the International GPS Service
Arctic Coastal Dynamics Report of the 4th International Workshop VNIIOkeangeologia, St. Petersburg (Russia), 10-13 November 2003 Edited by Volker Rachold and Georgy Cherkashov Volker Rachold, Alfred Wegener Institute, Research Unit Potsdam, Telegrafenberg A43, 14473 Potsdam, Germany Georgy Cherkashov, VNIIOkeangeologia (Institute for Geology and Mineral Resources of the Ocean), Angliysky prospect 1, 190121 St. Petersburg, Russia Preface Arctic Coastal Dynamics (ACD) is a joint project of the International Arctic Sciences Committee (IASC) and the International Permafrost Association (IPA) and a regional project of IGBP-LOICZ (International Geosphere-Biosphere Programme – Land- Ocean Interactions in the Coastal Zone). Its overall objective is to improve our understanding of circum-Arctic coastal dynamics as a function of environmental forcing, coastal geology and cryology and morphodynamic behavior. The fourth IASC-sponsored ACD workshop was held in St. Petersburg, Russia, on November 10-13, 2003. Participants from Canada (7), Germany (7), Great Britain (2), the Netherlands (1), Norway (1), Russia (32), Ukraine (1) and the United States (8) attended. During the first part of the workshop, 63 papers dealing with regional and/or circum-Arctic coastal dynamics were presented. Based on the material presented, five thematic working groups were identified: (1) GIS working group to develop of a circum-Arctic coastal GIS system, (2) coastal permafrost working group to discuss processes involved in the transition of onshore to offshore permafrost, (3) biogeochemistry working group with the focus on transport and fate of eroded material (4) biodiversity working group to initiate planning of an Arctic Coastal Biodiversity research agenda, (5) environmental data working group to discuss coastal dynamics as a function of environmental forcing. -

Coversheet for Thesis in Sussex Research Online
A University of Sussex MPhil thesis Available online via Sussex Research Online: http://sro.sussex.ac.uk/ This thesis is protected by copyright which belongs to the author. This thesis cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the Author The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the Author When referring to this work, full bibliographic details including the aut hor, title, awarding institution and date of the thesis must be given Please visit Sussex Research Online for more information and further details THE MEANING OF ICE Scientific scrutiny and the visual record obtained from the British Polar Expeditions between 1772 and 1854 Trevor David Oliver Ware M.Phil. University of Sussex September 2013 Part One of Two. Signed Declaration I hereby declare that this Thesis has not been and will not be submitted in whole or in part to another University for the Award of any other degree. Signed Trevor David Oliver Ware. CONTENTS Summary………………………………………………………….p1. Abbreviations……………………………………………………..p3 Acknowledgements…………………………………………….. ..p4 List of Illustrations……………………………………………….. p5 INTRODUCTION………………………………………….……...p27 The Voyage of Captain James Cook. R.N.1772 – 1775..…………p30 The Voyage of Captain James Cook. R.N.1776 – 1780.…………p42 CHAPTER ONE. GREAT ABILITIES, PERSEVERANCE AND INTREPIDITY…………………………………………………….p54 Section 1 William Scoresby Junior and Bernard O’Reilly. Ice and the British Whaling fleet.………………………………………………………………p60 Section 2 Naval Expeditions in search for the North West passage.1818 – 1837...........……………………………………………………………..…….p 68 2.1 John Ross R.N. Expedition of 1818 – 1819…….….…………..p72 2.2 William Edward Parry. -
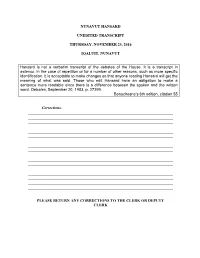
Opening Prayer
NUNAVUT HANSARD UNEDITED TRANSCRIPT THURSDAY, NOVEMBER 23, 2016 IQALUIT, NUNAVUT Hansard is not a verbatim transcript of the debates of the House. It is a transcript in extenso. In the case of repetition or for a number of other reasons, such as more specific identification, it is acceptable to make changes so that anyone reading Hansard will get the meaning of what was said. Those who edit Hansard have an obligation to make a sentence more readable since there is a difference between the spoken and the written word. Debates, September 20, 1983, p. 27299. Beauchesne’s 6th edition, citation 55 Corrections: PLEASE RETURN ANY CORRECTIONS TO THE CLERK OR DEPUTY CLERK 2016 Youth Parliament Speaker Hon. Neil Ammakiak (Amittuq) Hon. Elena Akammak-Nipisar Justin Kalluk McDonald Charlene Porter (Arviat South) (Quttiktuq) (Gjoa Haven) Minister of Environment and Minister of Community and Government Elaine Lau Siku Rojas Services (Iqaluit-Niaqunnguu) (Iqaluit-Sinaa) Hon. Felix Anablak Hon. Elisapee Maniapik Hon. Steffie Sinnisiak (Kugluktuk) (Pangnirtung) (Arviat North-Whale Cove) Premier Minister of Family Services and Minister Minister of Culture and Heritage and responsible for the Qulliq Energy Minister responsible for the Nunavut Katrina Anderson Corporation Housing Corporation (Rankin Inlet South) Hon. Simon McDonald Esuaktuk Temela Hon. Qumangaapik Arnatsiaq (Iqaluit-Tasiluk) (South Baffin) (Aggu) Minister of Health Minister of Education and Minister Tasha Tigullaraq responsible for Nunavut Arctic College Hon. Devon Nahogaloak (Uqqummiut) (Cambridge Bay) Alexander Cookie Minister of Finance and Minister of Hayley Totalik (Hudson Bay) Justice (Netsilik) Jackson Ford Jenny Nuluk Tanya Tugak (Baker Lake) (Aivilik) (Rankin Inlet North-Chesterfield Inlet) Hon. -

Inuit, Polar Bears, and Sustainable Use
Inuit, Polar Bears, and Sustainable Use Local, National and International Perspectives Milton M.R. Freeman and Lee Foote, Editors CCI Press 2009 Library and Archives Canada Cataloguing in Publication Inuit, polar bears, and sustainable use: local, national and international perspectives / Milton M.R. Freeman and Lee Foote, editors. (Occasional publication, ISSN 0068-0303; no. 61) Includes bibliographical references. ISBN 978-1-896445-45-8 1. Polar bear hunting. 2. Polar bear. 3. Inuit—Hunting. 4. Wildlife management—Canada, Northern. 5. Wildlife conservation—Canada, Northern. 6. Wildlife management—Government policy—Canada, Northern. 7. Endangered species—Law and legislation—United States. I. Freeman, Milton M. R., 1934- . II. Foote, Lee III. Series: Occasional publication series (Canadian Circumpolar Institute) ; no. 61 QL737.C27I58 2009 333.95'9786 C2009-902382-2 KEYWORDS: Inuit hunting; environmental knowledge; Inuit Qaujimajatuqangit (IQ); polar bear; sustainable use; governance; conservation hunting; guided hunting; trophy hunting; sustainable use; co-management; socio-economics © 2009 CCI Press, University of Alberta All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means – electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise without the express written permission of the copyright owner/s. CCI Press is a registered publisher with access© the Canadian Copyright Licensing Agency (Publisher Number 3524) Cover design by art design printing, -
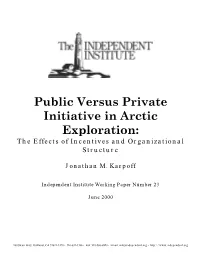
The Effects of Incentives and Organizational Structure
The Effects of Incentives and Organizational Structure Jonathan M. Karpoff Independent Institute Working Paper Number 23 June 2000 100 Swan Way, Oakland, CA 94621-1428 • 510-632-1366 • Fax: 510-568-6040 • Email: [email protected] • http://www.independent.org Public Versus Private Initiative in Arctic Exploration: The Effects of Incentives and Organizational Structure Jonathan M. Karpoff Norman J. Metcalfe Professor of Finance School of Business University of Washington Seattle, WA 98195 206-685-4954 [email protected] First draft: January 6, 1999 Third revision: January 24, 2000 I thank Peter Conroy for research assistance, and Helen Adams, George Benston, Mike Buesseler, Harry DeAngelo, Linda DeAngelo, Wayne Ferson, Alan Hess, Charles Laird, Paul Malatesta, John Matsusaka, Dave Mayers, Harold Mulherin, Jeff Netter, Jeff Pontiff, Russell Potter, Ed Rice, Sherwin Rosen, Sunil Wahal, Ralph Walkling, Mark White, an anonymous referee, and participants at seminars at the 1999 Arizona Finance Conference, the University of Alabama, University of British Columbia, Emory University, University of Georgia, University of Southern California, Texas A&M University, and the University of Washington for helpful comments. Public Versus Private Initiative in Arctic Exploration: The Effects of Incentives and Organizational Structure Abstract From 1818 to 1909, 35 government and 57 privately-funded expeditions sought to locate and navigate a Northwest Passage, discover the North Pole, and make other significant discoveries in arctic regions. Most major arctic discoveries were made by private expeditions. Most tragedies were publicly funded. By other measures as well, publicly-funded expeditions performed poorly. On average, 5.9 (8.9%) of their crew members died per outing, compared to 0.9 (6.0%) for private expeditions. -

Information to Users
INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand corner and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. ProQuest Information and Learning 300 North Zeeb Road, Ann Arbor, Ml 48106-1346 USA 800-521-0600 UMT UNIVERSITY OF OKLAHOMA GRADUATE COLLEGE HOME ONLY LONG ENOUGH: ARCTIC EXPLORER ROBERT E. PEARY, AMERICAN SCIENCE, NATIONALISM, AND PHILANTHROPY, 1886-1908 A Dissertation SUBMITTED TO THE GRADUATE FACULTY in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy By KELLY L. LANKFORD Norman, Oklahoma 2003 UMI Number: 3082960 UMI UMI Microform 3082960 Copyright 2003 by ProQuest Information and Learning Company. All rights reserved. This microform edition is protected against unauthorized copying under Titie 17, United States Code. ProQuest Information and Learning Company 300 North Zeeb Road P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 c Copyright by KELLY LARA LANKFORD 2003 All Rights Reserved. -

Instructions Nautiques
Volume 1, quatneme edition DFO - Libra I MPO - Bibllothequel II I II lill 1111111 II II 14062957 INSTRUCTIONS NAUTIQUES ARCTIQUE CANADIEN VK 808 157 V.1 1994 Peches Fisheries et Oceans and Oceans Canadi t - LSANS CANIOC\ '1471rognyme C!:•(iermel)n Rimouski (01,14bed 35:_ 484 TOL et fax ,418) `,723-18,31 marinas, topographiques et mattes VK 808 157 V.1 1994 Service hydrographique d.. Instructions nautiques : Arctique canadien, vol. 1 179860 14062957 c.1 INSTRUCTIONS NAUTIQUES-ARCTIQUE CANADIEN Volume 1 Photographie de couyerture — Brise- glace NGCC George R. Pearkes escortant les remorqueurs Angus Sherwood et Johnny Hope. Le Service hydrographique du Canada produit et distribue des Cartes marines, des Instructions nautiques, des Guides nautiques et des Tables des mardes des voies navigables du Canada. Les usagers de cette publication sont pries de signaler les dangers nouvellement reperes, les changements des aides a la navigation, l'existence de nouveaux hauts-fonds ou chenaux, les erreurs d'impression ou autres renseignements utiles a la correction des cartes marines et des publications hydrographiques touchant les eaux canadiennes au : Directeur general Service hydrographique du Canada Ministere des Peches et des Oceans Ottawa (Ontario) K 1 A 0E6 Les Instructions nautiques, Guides nautiques, Tables des maries, Tables des niveaux de l'eau, Rapports des activites et Marine Sciences Papers sont publies par la Direction generale des communications pour le Service hydrographique du Canada. On peut se procurer ces publications par le Groupe Communication Canada — Edition ou au Service hydrographique du Canada. YGO INSTRUCTIONS NAUTIQUES ARCTIQUE CANADIEN VOL. 1 QUATRIEME EDITION 1994 Ministere des Vetches et des Oceans Ottawa, Canada ©Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1994 En vente par la poste au : Groupe Communication Canada — Edition Ottawa, Canada K1A 0S9 ou chez votre libraire ou au Bureau de distribution des cartes marines Ministere des Peches et des Oceans C.P.