Due Città, Un Porto, Un Unico Waterfront Abstract
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
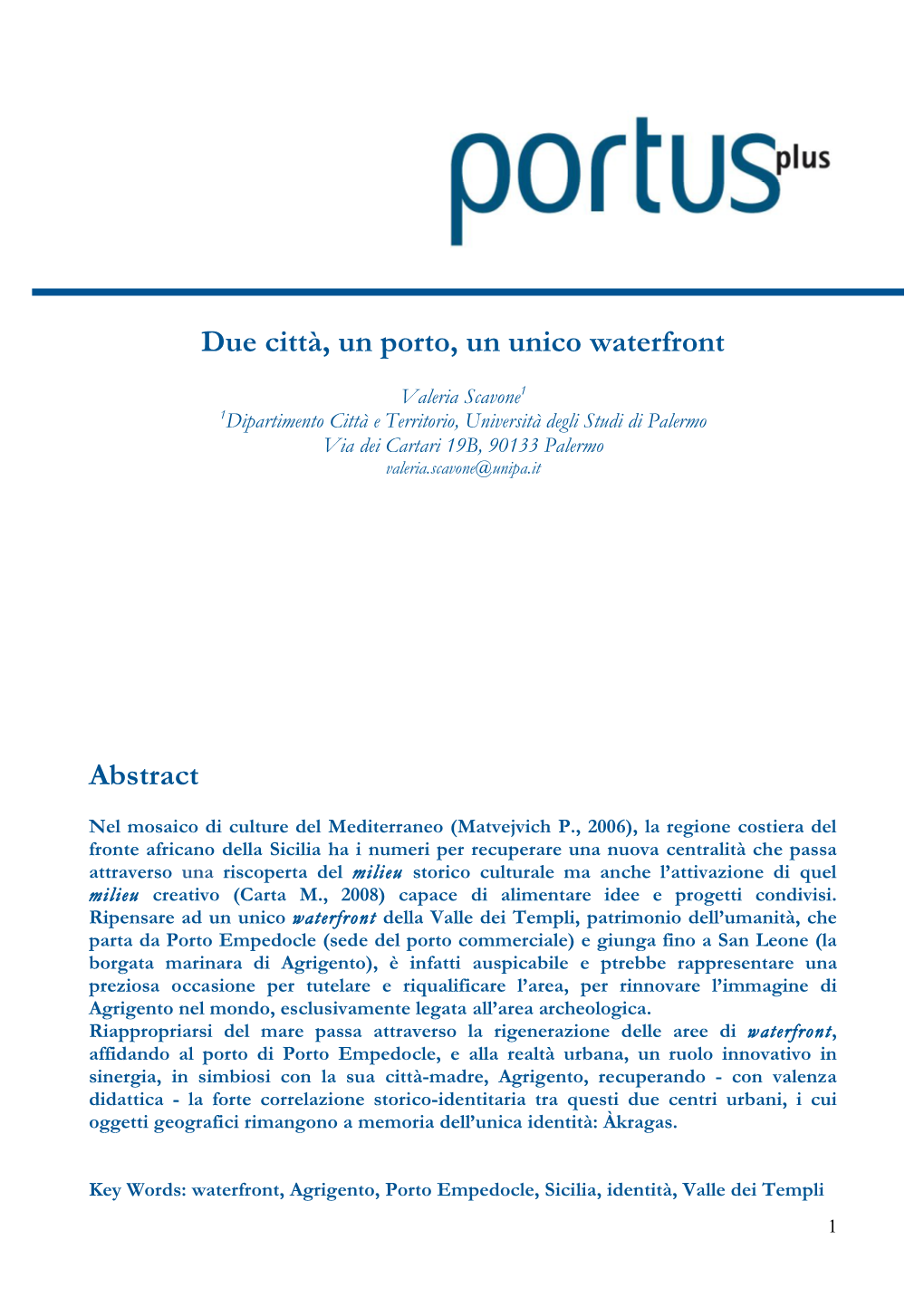
Load more
Recommended publications
-

Aragona - Comitini - Favara - Joppolo Giancaxio - Porto Empedocle - Raffadali - Realmonte - Santa Elisabetta - Sant'angelo Muxaro - Siculiana
DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI Comune capofila AGRIGENTO Aragona - Comitini - Favara - Joppolo Giancaxio - Porto Empedocle - Raffadali - Realmonte - Santa Elisabetta - Sant'Angelo Muxaro - Siculiana Dirigente Coordinatore Z· f·.YQ c, l 20'/. " Dott. Gaetano Di Giovanni DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE COORDINATORE Nr.-dJa. del.{1102/2014 A Piano di Zona 2010/2012 - Area di intervento "Disabilità" - l A e 2 annualità - Azione 4.3 - Progetto per l' "Abbattimento del disagio, delle barriere e dei pregiudizi sull'Alzheimer, aiuto riabilitativo attraverso l'offerta dei servizi e il OGGETTO coinvolgimento delle famiglie" - Importo progettuale per le due annualità: € 78.593,42IVA al 4% esclusa, di cui € 17.999.50 IVA al 4% esclusa, quale importo a base d'asta. CIG: 5210081609 - Approvazione aggiudicazione definitiva. IL RESPONSABILE DISTRETTUALE DEL PROGETTO Com.te Luigi BARBA PREMESSO: - che con determinazione n. 546 del 12111/2013 del Dirigente/Coordinatore del Distretto D l di Agrigento venivano approvati gli atti di gara (scheda progetto, bando di gara, capitolato tecnico e disciplinare di gara, schema dichiarazione protocollo di legalità, scheda personale di accesso, scheda monitoraggio e valutazione) del progetto in oggetto e disposto di: a) indire la gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, del progetto per l' "Abbattimento de disagio, delle barriere e dei pregiudizi sull'Alzheimer, aiuto riabilitativo attraverso l'offerta dei servizi e il coinvolgimento delle famiglie" previsto nel Piano di Zona 2010/2012 - Area di intervento "Disabilità" _la e 2" annualità - Azione 4.3; b) di stabilire che la, gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D. -

Aragona - Comitini - Fm'ara -Joppolo Giancaxio - Porto Empedocle Raffadali --Realmonte - Santa Elisabetta - Sani 'Angelo Muxaro Siculiana
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI Comune capofila AGRIGENTO Aragona - Comitini - Fm'ara -Joppolo Giancaxio - Porto Empedocle _ Raffadali --Realmonte - Santa Elisabetta - SanI 'Angelo Muxaro _ Siculiana - Tel. 0922 590111 - Fax 0922610775 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELÌJ~0J:.'12IJ~~~ DEI SINDACI N. J2- d e I 7L~f: ------------ OGGETTO Istituzione Aree Omogenee Distrettuali (AOD) - "Linee guida per l'attuazione delle politiche sociali e socio-sanitarie 2013- 2015" L'anno Duemilatredici il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 11,00 e seguenti in Agrigento nel Palazzo Municipale, si è riunito, in seconda convocazione, il Comitato dei Sindaci nelle seguenti persone: 1-- c_o_m_u_n_e +-_N_o_m_e_e--=-c_o_g_n~J\o0-~-m:e~_-1+++ZLS.==:c:a_r_i ....:::_P,---+-2~ Agrigento ~ _c_a_~~~:__ )( ---l Aragona Comitini Favara Ioppolo Giancaxio Porto Empedocle Raffadali Realmonte Santa Elisabetta Sant'Angelo Muxaro Siculiana Partecipa alla seduta il Dirigente/Coordinatore dotto Gaetano Di Giovanni che svolge funzioni di verbalizzante, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del Regolamento del Distretto D1 approvato con deliberazione n02/2013, e che si avvale della collaborazione del Rag. Tommaso Calabrese. Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato dei Sindaci a prendere le proprie determinazioni in ordine alla proposta di cui all'oggetto. Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000 i seguenti pareri: ~el responsabile del servizio interessato per quanto attiene alla regolarità tecnica; D del responsabile del servizio di Ragioneria per quanto attiene alla regolarità contabile. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Il sottoscritto Avv. Marco Zambuto, nella qualità di Sindaco del Comune di Agrigento, capofila del Distretto socio-sanitario 01 Premesso che: » con D.P. -

Sintesi Non Tecnica Impianto Termoelettrico “Vigata” Di Porto Empedocle
SINTESI NON TECNICA IMPIANTO TERMOELETTRICO “VIGATA” DI PORTO EMPEDOCLE SINTESI NON TECNICA Centrale “Vigata ” di Porto Empedocle Pagina 1 di 18 SINTESI NON TECNICA IMPIANTO TERMOELETTRICO “VIGATA” DI PORTO EMPEDOCLE Sommario 1. DESCRIZIONE DELL’AREA D’INSEDIAMENTO DELL’IMPIANTO 3 1.1 IL SITO DELLA CENTRALE ................................................................................................................................................................. 3 1.2 INQUADRAMENTO FISICO ................................................................................................................................................................. 4 1.2.1 CARATTERISTICHE IDRICHE E IDROGEOLOGICHE ............................................................................................................................ 4 1.2.3 CARATTERISTICHE DEL SUOLO ...................................................................................................................................................... 7 2. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO PRODUTTIVO 9 2.1. DESCRIZIONE FASE 1 E FASE 3 ................................................................................................................................................ 9 2.2 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ...................................................................................................................................... 11 2.1.1. Approvvigionamento, stoccaggio e movimentazione dei combustibili liquidi AC1) ............. 11 2.1.2. Impianto trattamento acque reflue -

Il Protocollo D'intesa
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO PREFETTURA DI AGRIGENTO ITALCEMENTI SpA COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE CONFINDUSTRIA AGRIGENTO FILLEA-CGIL AGRIGENTO FILCA-CISL AGRIGENTO FENEAL-UIL AGRIGENTO Protocollo d'Intesa La grave crisi economico che ha caratterizzato negli ultimi anni il settore edilizio ha prodotto una riduzione del consumo di cemento e conseguentemente la Italcementi è stata costretta a riorganizzare l'intero comparto con decisioni drastiche e pesanti per i lavoratori. L'azienda ha deciso di convertire il sito produttivo dello stabilimento di Porto Empedocle in Centro di Macinazione con un esubero finale di 18 dipendenti addivenendo ad un accordo, sottoscritto con le 00.88. di Categoria, FILLEA, FILCA e FENEAL, in data 28 Agosto 2014, con cui Italcementi si impegnava alternativamente a: 1.ricercare potenziali soluzioni di ricollocazione per il personale posto in mobilità presso una delle proprie sedi del territorio nazionale o presso terzi che avessero aderito al progetto di riconversione industriale del sito di Porto Empedocle: 2. riconoscere un indennizzo economico, in caso di mancato perfezionamento della citata soluzione di ricollocazione. Purtroppo la persistente crisi e la vendita del gruppo Italcementi al colosso tedesco Heidelberg cement ha prodotto nuovi esuberi in Italia e quindi l'azienda ha potuto rispettare l'accordo sottoscritto con le 00.88. mediante il riconoscimento del previsto riconoscimento economico, ma ha riconfermato e prorogato, in sede di Confindustria in data 04 febbraio 2017, il predetto impegno fino a tutto il 2018. - Date le enormi difficoltà ed i tentativi posti in essere per ricollocare il personale posto in mobilità a dicembre 2014. - Considerato che alcuni di questi lavoratori sono già privi di ammortizzatori sociali e che altri fra qualche mese saranno nelle stesse condizioni. -

Carte Varie - Amministrative E Finanziarie - Fabbricati
ARCHIVIO DI STATO DI AGRIGENTO Intendenza di finanza di Agrigento, Carte varie - Amministrative e finanziarie - Fabbricati. Elenco ESTREMI N° BUSTA LETT. OGGETTO NOTE CRONOLOGICI 1 Manutenzione dei Fabbricati CATTIVO STATO 2 Manutenzione dei Fabbricati CATTIVO STATO 3 1887 Ruolo imposta fabricati comune di Porto Empedocle CATTIVO STATO 4 1887 Ruolo imposta fabricati comune di Porto Empedocle CATTIVO STATO 5 1885 Ruolo imposta fabricati comune di Porto Empedocle CATTIVO STATO 6 1885 Ruolo imposta fabricati comune di Porto Empedocle CATTIVO STATO 7 1881 Ruolo imposta fabricati comune di Porto Empedocle CATTIVO STATO 8 1883 Ruolo imposta fabricati comune di Porto Empedocle CATTIVO STATO 9 1885 Ruolo imposta fabricati comune di Porto Empedocle CATTIVO STATO 10 1883 Ruolo imposta fabricati comune di Porto Empedocle CATTIVO STATO 11 1885 Ruolo imposta fabricati comune di Porto Empedocle CATTIVO STATO 12 1884 Ruolo imposta fabricati comune di Porto Empedocle CATTIVO STATO 13 1876 Ruolo imposta fabricati comune di Canicattì CATTIVO STATO 14 M-P Registro vecchie matricole fabbricati di Agrigento CATTIVO STATO 15 G-I Registro vecchie matricole fabbricati di Agrigento CATTIVO STATO 16 B-C Registro vecchie matricole fabbricati di Agrigento CATTIVO STATO 17 M Registro vecchie matricole fabbricati di Agrigento CATTIVO STATO 18 M-Z Registro vecchie matricole fabbricati CATTIVO STATO 19 R-S Registro vecchie matricole fabbricati CATTIVO STATO 20 P-R Registro vecchie matricole fabbricati CATTIVO STATO 21 R-S Registro vecchie matricole fabbricati CATTIVO STATO 22 C-G Registro vecchie matricole fabbricati CATTIVO STATO 23 A-C Registro vecchie matricole fabbricati CATTIVO STATO 24 B-C- Registro vecchie matricole fabbricati CATTIVO STATO ©ARCHIVIO DI STATO DI AGRIGENTO 1 ESTREMI N° BUSTA LETT. -

Graduatoria Cacciatori Regionali Ammessi ATC
REPUBBLICA ITALIANA Regione Siciliana ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE SERVIZIO XIII – UFFICIO SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI PALERMO U.O. n° 3 – GESTIONE DELLE RISORSE NATURALISTICHE – RIPARTIZIONE FAUNISTICO VENATORIA DI PALERMO Stagione Venatoria 2017/2018 - Elenco dei cacciatori residenti in Sicilia ammessi Posiz. Data spediz. Cognome Nome Data nascita Città di residenza Prov. A.T.C. Note 47 09/12/2016 AGOGLITTA LEONARDO 21/07/1950 CASTELVETRANO TP PA1 AMMESSO 19 04/02/2016 AGUSTA BALDASSARE EMILIO 17/08/1965 MAZARA DEL VALLO TP PA1 AMMESSO 13 01/02/2016AIELLO SALVATORE 01/11/1957 PARTANNA TP PA1 AMMESSO 74 22/12/2016 ALAIMO SALVATORE 03/09/1954 PORTO EMPEDOCLE AG PA1 AMMESSO 9 01/02/2016 ALONGI GERLANDO 04/05/1956 AGRIGENTO AG PA1 AMMESSO 12 01/02/2016ANATRA SANTO 05/03/1955 PARTANNA TP PA1 AMMESSO 22 25/02/2016ANGILERI NICOLO' 04/09/1950 MARSALA TP PA1 AMMESSO 71 30/12/2016ASTA IGNAZIO 18/09/1981ALCAMO TP PA1 AMMESSO 31 08/08/2016BAIATA MARIANO 20/05/1959 MARSALA TP PA1 AMMESSO 24 07/03/2016 BATTAGLIA AGOSTINO 13/07/1965 TERMINI IMERESE PA PA1 AMMESSO 26 14/03/2016 BONANNO JOSE' PASQUALINO 20/01/1966 POGGIOREALE TP PA1 AMMESSO 37 17/11/2016 BONANNO SALVATORE 23/03/1967 GIBELLINA TP PA1 AMMESSO 77 27/12/2016 BORSELLINO SALVATORE 23/03/1946 AGRIGENTO AG PA1 AMMESSO 56 29/12/2016BRUNO LORITO 28/04/1963 SALAPARUTA TP PA1 AMMESSO 49 23/12/2016BRUSCIA FELICE 20/07/1962USTICA PA PA1 AMMESSO 52 23/12/2016BRUSCIA GIOVANNI 12/08/1991 -

Gli Uffici Della Provincia in Formato
Polizia di Stato Questura Agrigento Ufficio Denunce Via Francesco Crispi, 101 - 92100 AGRIGENTO (AG) Telefono: 0922 466354 Fax: Email: [email protected] Commissariato Canicattì Via Ciaccio Montalto, 16 - 92024 CANICATTI` (AG) Telefono: 0922730111 Fax: Email: [email protected] Compartimento Polizia Postale Sicilia - Sezione Agrigento Piazza Vittorio Emanuele - 92100 AGRIGENTO (AG) Telefono: 0922 551593 Fax: 0922 551537 Email: [email protected] Distaccamento Polizia Stradale Canicattì Via Croce, 6 - 92024 CANICATTI` (AG) Telefono: 0922 851400 Fax: Email: [email protected] Posto Polizia Ferroviaria Agrigento Piazza Marconi - 92100 AGRIGENTO (AG) Telefono: 0922 483531 - 0922 20122 Fax: Email: [email protected] Questura Agrigento Piazza Vittorio Emanuele, 2 - 92100 AGRIGENTO (AG) Telefono: 0922483111 Fax: 0922483616 - 0922483540 Email: [email protected] Commissariato Licata Via Campobello n.106 - 92027 LICATA (AG) Telefono: 0922896111 Fax: Email: [email protected] Distaccamento Polizia Stradale Sciacca Via Jacopo Ruffini - 92019 SCIACCA (AG) Telefono: 0925 965023 Fax: Email: [email protected] Posto Polizia Ferroviaria Canicattì Via Palermo - 92024 CANICATTI` (AG) Telefono: 0922 851998 Fax: Email: [email protected] Compartimento Polizia Postale Sicilia - Sezione Agrigento Ricezione pubblico Piazza Vittorio Emanuele - 92100 AGRIGENTO -

Ex Post Evaluation of Major Projects Supported by the European Regional Development Fund (ERDF) and Cohesion Fund Between 2000 and 2013
Ref. Ares(2019)621567 - 04/02/2019 Ex post evaluation of major projects supported by the European Regional Development Fund (ERDF) and Cohesion Fund between 2000 and 2013 Lot environment Call for Tenders N° CCI 2018CE16BAT044 Second Interim Report Pilot case studies Written by CSIL, Centre for Industrial Studies (Italy), in partnership with Ramboll Management January – 2019 Ex post evaluation of major projects supported by the European Regional Development Fund (ERDF) and Cohesion Fund between 2000 and 2013 RECONSTRUCTION OF THE FAVARA DI BURGIO AQUEDUCT Italy This version: 30 November 2018 This report is part of a study carried out by a Team selected by the Evaluation Unit, DG Regional and Urban Policy, European Commission, through a call for tenders by open procedure No 2016CE16BAT077. The consortium selected comprises CSIL – Centre for Industrial Studies (lead partner, Italy) and Ramboll Management Consulting A/S (Denmark). The Core Team comprises: • Scientific Director: Massimo Florio (CSIL and University of Milan); • Project Manager: Silvia Vignetti (CSIL); • Scientific Committee: Henrik Andersson, Phoebe Koundouri, Per-Olov Johansson; • Task managers: Jakob Louis Pedersen (Ramboll), Thomas Neumann (Ramboll), Chiara Pancotti (CSIL), Xavier Le Den (Ramboll), Silvia Vignetti (CSIL); • Thematic Experts: Mario Genco (CSIL), Lara Alvarez Rodriguez (Ramboll), Alexander Greßmann (Ramboll), Trine Stausgaard Munk (Ramboll). A network of National Correspondents provides the geographical coverage for the field analysis. The authors of this report are Chiara Pancotti, Matteo Pedralli and Mario Genco. The authors are grateful to all the project managers, stakeholders and beneficiaries who provided data, information and opinions during the field work. The authors are grateful for the very helpful insights from the EC staff and particularly to Malgorzata Kicia, Daria Gismondi and Witold Willak and other members of the Steering Group. -

Verdura Resort
“To have seen Italy without having seen Sicily is not to have seen Italy at all, for Sicily is the clue to everything.” JOHANN WOLFGANG VON GOETHE 1 USTICA FILICUDI ALICUDI SALINA ISOLE EOLIE LIPARI SICILY T VULCANO G OLFO DI MILAZZO FALCONE G OLFO A18 SAN VITO A20 LO CAPO RISERVA BORSELLINO DI PATTI MESSINA NATURALE A29 DELLO G OLFO SS114 ISOLE ZINGARO DI TERMINI EGADI PALERMO IMERESE A19 CEFALÙ TRAPANI ERICE CASTELLAMARE PARCO FAVIGNANAA DEL GOLFO A20 Sicily is an island at the crossroads of ancient civilisations. SS115 SEGESTA DEI NEBRODI A29DIR PARCO MISTRETTA TEATRO TRAPANI DELLE MADONIE G RECO ROMANO MOZIA BIRGI It’s rich in natural beauty, with rocky mountain ranges, olive TAORMINA RISERVA DELLO groves, vineyards, beaches and azure waters. It’s a place where STAGNONE S. MARGHERITA BELICE PARCO DELL’ETNA A29 food, family and festivities flourish. RISERVA PARCO DEI FOCE DEL MAZARA DEL VALLO MONTI SICANI BELICE A18 MARINELLA BURGIO DI SS114 SELINUNTE ENNA Verdura Resort is located on the south-west coast, a perfect SITO CATANIA SCIACCA ARCHEOLOGICO A19 F ONTANAROSSA CALTANISSETTA DI MORGANTINA ERACLEA MINOA position for exploring the island. The seaside town of Sciacca, SS640 G OLFO RISERVA NATURALE TORRE SALSA DI CATANIA AGRIGENTO VILLA renowned for its Carnival, and the orange groves of Ribera sit SCALA DEI TURCHI ROMANA DEL CASALE NSA339 VALLE PORTO EMPEDOCLE DEI CALTAGIRONE next to the resort. The Valley of the Temples in Agrigento and the TEMPLI SS114 AUGUSTA Temple of Selinunte are both just a 40-minute drive away. The PARCO GELA ARCHEOLOGICO NEAPOLIS SIRACUSA capital, Palermo, is just over an hour’s drive, and the Aeolian, GOLFO A18 DI GELA COMISO Egadi and Pelagian islands can easily be reached by helicopter. -

Strade Provinciali (SP) POGGIOREALE
PETRALIA SOPRANA SANTA NINFA ALIA CASTELLANA SICULA Strade Provinciali (SP) POGGIOREALE Numero Lunghezza Lunghezza tratti SP Denominazione COMUNE attraversato SP tratto (km) totale SP (km) CAMPOFIORITO AGRIGENTO SP 1-A Quadr. Spinasanta (SS118)-Villaseta(SS115) 4.376 Sp1 12.017 SP 1-B dir.Fondacazzo - C.Borsellino 5.696 AGRIGENTO-IOPPOLO GIANCAXIO LERCARA FRIDDI BLUFI SP 1-C c.da Fondacazzo - viadotto Morandi (fiume Drago) 1.945 AGRIGENTO S P 3 VALLEDOLMO SP 2-A bivio Piano Gatta-Montaperto 5.124 AGRIGENTO 8 Sp2 8.720 4 3.596 AGRIGENTO P 4 SP 2-B Montaperto-Giardina Gallotti - BOMPIETRO SP S B SP 3-A Bivio Caldare (SS189)-Favara 6.804 ARAGONA-FAVARA 4 Sp3 13.698 5 S CONTESSA ENTELLINA SP 3-B Favara-SS115 (bivio Crocca) 6.894 AGRIGENTO-FAVARA PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO PARTANNA S 6 Sp4 SP 4 Strada Valle dei Templi (Panoramica) 2.409 2.409 AGRIGENTO 2 4 SP 5-A Camastra (SS 410) - Sottafari - C. Aronica 7.612 CAMASTRA-LICATA Sp5 13.677 Sistema Informativo Territoriale Provinciale (SITP) SP 5-B C. Aronica - Cipolla - SS 123 6.065 LICATA PRIZZI Sp6 SP 6 Licata (SS115) - Ravanusa 18.279 18.279 RAVANUSA-CAMPOBELLO DI LICATA-LICATA Nodo provinciale del S.I.T.R. Sicilia Sp7 SP 7 Licata (SS115) - Riesi - confine provincia di Caltanissetta 9.172 9.172 LICATA Sp8 SP 8 Ranciditi - Cozzo San Vincenzo 3.089 3.089 FAVARA-ARAGONA MONTEVAGO Sp9 SP 9 Ravanusa - Fiume Salso prov. Di Caltanissetta 6.703 6.703 RAVANUSA BISACQUINO Sp10 SP 10 Campobello - Fiume Salso prov. -

Curriculum Arch Giuseppe Cimino
CURRICULUM VITAE PROFESSIONALE Dott. Arch. Giuseppe Cimino, nato a Canicattì (Ag) il 23/02/47 residente in via dei Giacinti n. 08 a San Leone - Agrigento tel. 0922413331 - 3334431422, frequenta le scuole dell’obbligo a Canicattì e diplomatosi Geometra nell’anno scolastico 1965/1966. Dopo aver superato concorso per assistente indetto dal Ministero Lavori Pubblici è risultato vincitore è stato nominato presso il Genio Civile di Agrigento con decorrenza 01/01/1972. Successivamente è stato bandito un concorso per titoli ed esami presso il Ministero dei Lavori Pubblici per accedere alla qualifica di geometra presso lo stesso ufficio del Genio Civile di Agrigento, accedendo così alla qualifica superiore di Geometra. Si iscrive presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo nell’Anno Accademico 1978/79 e laureatosi nell’Anno Accademico 1983/84. Sostiene con esito positivo, l’esame all’esercizio della libera professione di Architetto e si iscrive all’Albo dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Agrigento al N° 263 dal 05/02/85. Il 9 maggio 1985, previo concorso interno alla Regione Siciliana, ha superato l’esame per l’accesso alla qualifica di dirigente tecnico 1 architetto presso l’Assessorato Regionale Lavori Pubblici e continua a prestare servizio presso l’ufficio del Genio Civile di Agrigento fino al 30 luglio 2001 con qualifica di Dirigente Tecnico Architetto, rivestendo diversi incarichi di Direzione dei Lavori di opere finanziate dall’Assessorato Regionale Lavori Pubblici di Palermo: Progetto e direzione dei lavori per il consolidamento della Cala di levante nel Comune di Lampedusa – Linosa. Importo €. 129.114,22; Progetto e direzione dei lavori di somma urgenza per la costruzione di un muro di sostegno e consolidamento della via S. -

Distretto Socio -Sanitario D1
DISTRETTO SOCIO -SANITARIO D1 Comune capofila AGRIGENTO Aragona - Comitini - Favata - loppolo Giancaxio - Porto Empedocle - Raffadali • Realmonte - Santa Elisabetta - Sant'Angelo Muxaro - Siculiana - AREA: Minori - Famiglia - giovani Piano di zona: 2010/2012 Azione Progettuale: Potenziamento Centro Affidi Distrettuale Responsabile distrettuale: Dott. ssa Loredana Mazza referente Comune di Favara e Dott.ssa Rosanna Pitrone. 1. Relazione 2. Scheda variazione N.B. Pubblicazione ai sensi delle direttive Ass.to della Famiglia e delle politiche sociali - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali - ufficio Piano - prot. nr. 4247 del 31 ottobre 2006 - Ali. 1 macro area: variazione Azione di Piano. DISTRETTO SOCIO -SANITARIO DI Comune capofila Agrigento Aragona - Comi/ini - /•avara - lappola Giancaxio - Porto Empedocle - Raffadali - Realmente - Santa Elisabetta - Sant'Angelo Muxaro - Siculiana - Tel.-0922 590244 Fax 0922 590204- distretto [email protected] Relazione di sintesi rimodulazione azione progettuale "Potenziamento Centro Affidi Distrettuale" Piano di Zona 2010/2012. In ottemperanza all'incarico conferito con determinazione del Dirigente Coordinatore del Distretto Socio Sanitario DI Comune Capofila Agrigento n. 255 del 22/08/2011, le scriventi hanno provveduto a porre in essere gli adempimenti propedeutici all'avvio dell'azione di cui all'oggetto tra cui anche un'analisi della fattibilità della stessa, dalla quale è emerso che l'azione progettuale prevede tra le risorse umane la presenza dello psicologo al quale spetta il compito di avviare azioni di sostegno psico-sociale per le famiglie affidatane durante tutto il percorso dell'affidamento. A fronte di eguali compiti di lavoro previsti per tale figura professionale, nell'ambito dell'azione progettuale Potenziamento Centro Affidi Distrettuale inserita nel Piano di Zona 2004/2006, nella medesima azione progettuale inserita nel successivo piano di zona 2010-2012, è previsto un numero di ore di servizio inferiore.