ROMA 1960 (Stadio Olimpico – Panoramica)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Mitalitaulukko
KISAOPAS Kesäolympialaiset, Rio de Janeiro, 5.–21.8.2016 Sisältö BRASILIA JA RIO DE JANEIRO 4 BRASILIAN OLYMPIAMITALIT 6 KESÄOLYMPIAKRONIKKA 1896–2012 7 KESÄOLYMPIAKISOJEN YLEISTILASTOT 16 Ammunta 38 Golf 43 Jalkapallo 44 Jousiammunta 46 Judo 48 Koripallo 50 Käsipallo 52 Lentopallo 54 Maahockey 56 Melonta 58 Miekkailu 61 Nykyaikainen viisiottelu 63 Nyrkkeily 65 Paini 68 Painonnosto 73 Purjehdus 75 Pyöräily 79 Toimitus: Pöytätennis 82 Ratsastus 84 Urheilumuseon tietopalvelu: Matti Hintikka ja Vesa Tikander Rugby sevens 86 Rytminen voimistelu 87 Kuvat: Soutu 88 Kansainvälinen Olympiakomitea (IOC) ja Sulkapallo 91 Urheilumuseon kuvapalvelu. Taekwondo 93 Taitto ja digijulkaisu: Taitouinti 95 Telinevoimistelu 96 Edita Prima Oy Tennis 99 Julkaisija: Trampoliinivoimistelu 101 Suomen Olympiakomitea Triathlon 102 Uimahypyt 103 ©Copyright Uinti 105 Urheilumuseo ja Vesipallo 110 Suomen Olympiakomitea Yleisurheilu 111 ISBN 978-952-5794-48-9 (NID.) MAALYHENTEET 130 ISBN 978-952-5794-47-2 (PDF) PARALYMPIALAISET 132 Urheilumuseon tietopalvelu: RIO DE JANEIRO 2016 - KILPAILUAIKATAULU 134 [email protected] KARTTA 138 Suomen Olympiakomitea: www.olympiakomitea.fi Kansainvälinen Olympiakomitea: www.olympic.org Rio 2016: www.rio2016.com BRASILIAN BRASILIA LIITTOTASAVALTA República Federativa do Brasil Pinta-ala: 8 515 767 km² Asukasluku: 205 miljoonaa Etelän jättiläinen Pääkaupunki: Brasília Brasilia on sekä pinta-alaltaan että asukasluvultaan maailman Bkt/asukas (arvio): 15 893 $ viidenneksi suurin maa. Laajuudessa sen voittavat vain Venä- (Suomi: 40 676) jä, Kanada, Kiina ja Yhdysvallat, väkimäärässä Kiina, Intia, Rahayksikkö: real USA ja Indonesia. Valtio kattaa lähes puolet Etelä-Amerikan Virallinen kieli: portugali pinta-alasta. Valtionpää: presidentti Hallitusmuodoltaan Brasilia on liittotasavalta, jossa on 26 osavaltiota. Laajaan maahan mahtuu monta ilmasto- aluetta Amazonin trooppisesta sademetsästä koillisen kuiviin savanneihin ja maan eteläosien lauhkeaan havumet- sävyöhykkeeseen. -

2020 Len European Water Polo Championships
2020 LEN EUROPEAN WATER POLO CHAMPIONSHIPS PAST AND PRESENT RESULTS Cover photo: The Piscines Bernat Picornell, Barcelona was the home of the European Water Polo Championships 2018. Situated high up on Montjuic, it made a picturesque scene by night. This photo was taken at the Opening Ceremony (Photo: Giorgio Scala/Deepbluemedia/Insidefoto) Unless otherwise stated, all photos in this book were taken at the 2018 European Championships in Barcelona 2 BUDAPEST 2020 EUROPEAN WATER POLO CHAMPIONSHIPS PAST AND PRESENT RESULTS The silver, gold and bronze medals (left to right) presented at the 2018 European Championships (Photo: Giorgio Scala/Deepbluemedia/Insidefoto) CONTENTS: European Water Polo Results – Men 1926 – 2018 4 European Water Polo Championships Men’s Leading Scorers 2018 59 European Water Polo Championships Men’s Top Scorers 60 European Water Polo Championships Men’s Medal Table 61 European Water Polo Championships Men’s Referees 63 European Water Polo Club Competitions – Men 69 European Water Polo Results – Women 1985 -2018 72 European Water Polo Championships Women’s Leading Scorers 2018 95 European Water Polo Championships Women’s Top Scorers 96 European Water Polo Championships Women’s Medal Table 97 Most Gold Medals won at European Championships by Individuals 98 European Water Polo Championships Women’s Referees 100 European Water Polo Club Competitions – Women 104 Country By Country- Finishing 106 LEN Europa Cup 109 World Water Polo Championships 112 Olympic Water Polo Results 118 2 3 EUROPEAN WATER POLO RESULTS MEN 1926-2020 -

Record Storici
RECORD STORICI I primati Mondiali, Europei, Olimpici stabiliti dagli atleti italiani A scorrere le vecchie carte, si rintracciano numerose grandi prestazioni che gli atleti italiani hanno ottenuto nel Secolo XX. Prestazioni delle quali, per la gran parte, si è persa memoria. Quindi, appare opportuno riproporle in quella che potrebbe essere una delle voci di un nostro “ABBECEDARIO” di atletica, un testo di lettura per le prime classi dei dirigenti federali. Il primo record da ricordare, dei più nobili, è quello di Dorando Pietri a Londra 1908: un proto-primato nella Maratona (come avrebbe scritto Bruno Bonomelli …) cancellato alla pari della sua vittoria. Gli ultimi, già molto lontani nel tempo, sono quelli che Maurizio Damilano ha ottenuto sulla pista di Cuneo nell’autunno 1992. Fra mezzo, molti riscontri tecnici di notevole significato temporale e storico. Nelle tabelle che seguono si è tentato un primo elenco – in ordine cronologico – di tutti quei record Mondiali , Europei e Olimpici che hanno fatto la storia dell’atletica italiana, oltre ad una appendice per non tralasciare una serie di risultati che, per vari motivi, non hanno goduto del crisma dell’ufficialità. In chiave storica va ricordato che la federazione italiana è stata fondata a Milano il 21 ottobre 1906 e che la IAAF ha preso corpo a Berlino nell’ agosto 1913 , dopo che il 17 luglio 1912 i rappresentanti di 17 nazioni – riunitisi a Stoccolma durante i Giochi Olimpici (e tra i quali non figurava nessun italiano) – avevano stabilito di costituire una struttura internazionale che regolamentasse norme e primati dell’atletica leggera. Tra i primi atti della IAAF fu proprio la stesura di una prima lista di record mondiali che venne presentata nel 1914. -

Speciale 290
Diretto da Giors Oneto SPECIALE /290 [email protected] 3. X. 2013 La lunghissima marcia di Abdon Pamich (ha tagliato il traguardo degli 80 anni) di Vanni Lòriga Il 3 ottobre 1933 nasceva in Fiume Abdon Pamich che pertanto oggi compie anni ottanta. Nei suoi 29.220 giorni di vita si dice ( e più altro si calcola) che abbia coperto, marciando o camminando ad alta velocità, almeno 100.000 chilometri. Praticamente ha fatto due volte e mezzo il giro dell’Equatore. Ed ancora non si è fermato. Tutti conoscono il suo curriculum atletico che, per maggiore comodità dei lettori di Spiridon, riassumiamo alla fine del pezzo. Certificate così la sue credenziali sportive, peraltro di pubblico dominio, passiamo ad aspetti meno noti della sua vita. LA FAMIGLIA - E’ figlio di Giovanni, dottore commercialista e direttore di aziende che operano nel legname e nel tannino e di Irene Susanj, una certa parentela con quel Luciano Susanj campione europeo sugli 800 metri nel 1974 a Roma con 1’44”07. I figli di Giovanni e di Irene sono quattro: il primogenito classe 1932 (in seguito primario di chirurgia toracica a Monfalcone) si chiama anche lui Giovanni ( come d’altra parte il nonno paterno e fra gli avi di Abdon c’era anche una Giuliana Salomon, erede di Dogi veneziani); poi (1937) nascerà Raoul (laureato in economia) ed infine (1944) Irma (insegnante). Le radici della famiglia vanno ricercate in Veneto: ma si può definire Abdon Pamich un Italiano nato nell’Istria italiana e cittadino del mondo. Dal suo matrimonio con Maura Grisanti nascono Tamara (medico sportivo all’Acquacetosa) e Sennen (laureato negli USA ed ora amministratore delegato a San Diego della Colomer, un colosso nel campo dei cosmetici a cui è giunto dopo aver lavorato con Proctor & Gamble, Johnson & Johnson e Bulgari). -

Issue No: 402 January/February 2021 Editor: Dave Ainsworth RACE
Issue No: 402 January/February 2021 Happy New Year Editor: Dave Ainsworth RACE WALKING ASSOCIATION Preliminary Notice of AGM Notice is hereby given that due to Covid19 restrictions, the Annual General Meeting of the Race Walking Association will be held as a virtual (online) event on Saturday 30 January 2021. The RWA acknowledge that online meetings are difficult for a number of people so a method of advance participation is being implemented to help achieve inclusion as far as is reasonably possible. This will result in slight modification to the usual timeline and is detailed further within this notice. The main feature is that all reports will be circulated prior to meeting (but will not be read out in the meeting). Any comments on reports received before AGM will be read out at AGM followed by debate or discussion of the report if appropriate. Votes may be submitted in writing or electronically prior to the meeting and will be anonymous to the meeting. The Honorary General Secretary (HGS) will receive and validate advance votes. As current president, the HGS will chair the meeting and, as per the rules of the association, will only vote where a casting vote is required. Advance votes must be in writing and will be available for scrutiny by the other officers of the RWA after the meeting. Voting in the meeting will be open (ie not-anonymous), advance votes will be then be added after the live vote to obtain the result. Votes for affiliated bodies will only be accepted (both in advance and on the day) from delegates who have been formally authorised by the secretary of the body (or other official duly acting on behalf of the secretary). -
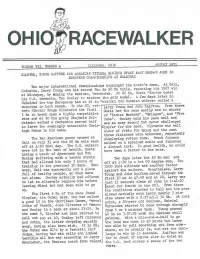
ORW 1971-08.Pdf
AUGUST 1971 VOLUMEVII, NUMBER6 COLUMBUS,OHIO KLOPFER, YWNG CAPTUREl'Atl AIOOICANTITLESJ SOVIE.'"£SUPS.l:!:T EAST GERMANACES I N EUROPEANCHAMPIONSHIPS AT llliLSINKI Two major international championships highligh~ the month'~ ne~. At Ca~i, Coltnnbia Larry Young won his second Pan Am 50 Km title, repeating his 1967 win at Winne;eg, by edging the Mexican, Hernandez. At 20 1~:i-11,Goetz h-lopfer ups~t his U.S. teammate, Tom Dooley to capture _,the gold medal. A few days later 1:n Helsinki the top Europe.?.ns had at it in tielsinki and Russian walkers ·pulled a surpri~e in.both race~. In the 20~ vet- Larry Young and John Knifton. From there eran .Nikolai Smaga blistered the final Goetz had the race easily won to shouts 11 5 Km to break open a highly :cm?etitiv-e of "Yankee J:a.stard. , "Gringos", and "Viva race and at 50 the gutty l?enJanu.n Sol- Cuba". Dooley held his pace well and datenko walked a fantastic second hal~ was an easy second but never challenged to leave th~ se~ingly unbeatable Chris- Klopfer for the lead. Oliveros was well toph Hohne in his wake. clea .r of Jobin for third and the next three finishers were unknowns, reportedly The Pan American games opened at displaying rotten fonn. Frank J~h1;1son Cali on July 31 and the 20 }(.m walk went walked on a sprained ankle and firushed off at 4:30 that day. The U.S. walkers a distant last. In good health, he could were not in the best of health, Goetz have been a factor in the race. -

Vainqueurs D'étapes Du Tour D'italie (Le Giro)
Vainqueurs d'étapes du Tour d'Italie (Le Giro) Vainqueurs d'étapes du Tour d'Italie (Le Giro) depuis 1909. Etapes du 08/05 au 30/05/2021 1 Torino - Torino, 8.6 km C.M.Individuel 2 Stupinigi - Novara, 179 km 3 Biella - Canale, 190 km 4 Piacenza - Sestola, 187 km 5 Modena - Cattolica, 177 km 6 Grotte di Frasassi - Ascoli Piceno, 160 km 7 Notaresco - Termoli, 181 km 8 Foggia - Guardia Sanframondi, 170 km 9 Castel di Sangro - Campo Felice, 158 km 10 L'Aquila - Foligno, 139 km 11 Perugia - Montalcino, 162 km 12 Siena - Bagno di Romagna, 212 km 13 Ravenna - Verona, 198 km 14 Cittadella - Monte Zoncolan, 205 km 15 Grado - Gorizia, 147 km 16 Sacile - Cortina d'Ampezzo, 153 km 17 Canazei - Sega di Ala, 193 km 18 Rovereto - Stradella, 231 km 19 Abbiategrasso - Alpe di Mera, 176 km 20 Verbania - Valle Spluga-Alpe Motta, 164 km 21 Milano - Milano, 30.3 km C.M.Individuel 1ère étape. 1er Filippo Ganna (Ita) C.M.Individuel 2ème étape. 1er Tim Merlier (Bel) 3ème étape. 1er Taco Van Der Hoorn (Hol) 4ème étape. 1er Joseph Lloyd Dombrowski (Usa) 5ème étape. 1er Caleb Ewan (Aus) 6ème étape. 1er Gino Mäder (Sui) 7ème étape. 1er Caleb Ewan (Aus) 8ème étape. 1er Victor Lafay (Fra) 9ème étape. 1er Egan Arley Bernal Gomez (Col) 10ème étape. 1er Peter Sagan (Svq) 11ème étape. 1er Mauro Schmid (Sui) 12ème étape. 1er Andrea Vendrame (Ita) 13ème étape. 1er Giacomo Nizzolo (Ita) 14ème étape. 1er Lorenzo Fortunato (Ita) 15ème étape. 1er Victor Campenaerts (Bel) 16ème étape. -

Bibliografia E Storiografia Dell'atletica Leggera Italiana
siss 9,5 su 12,5 con loghetto ALTERNATIVA red copia_impaginato Dennis intero Bodoni 26/04/14 17:39 Pagina 71 la storiografia dello sport in Italia. Stato dell’arte, indagini, riflessioni BiBLiografia e storiografia deLL’atLetiCa Leggera itaLiana Sergio Giuntini [email protected] Dovendo indicare quello che si può definire un ”incunabolo” della nostra moderna atletica, viene spontaneo chiamare in causa Excelsior! L’uomo cavallo Achille Bargossi. Autobiografia e memorie (1882). Un opuscolo a stampa conservato tra i materiali della fondazione “Piancastelli”, presso la biblioteca “Aurelio Saffi” di Forlì, che Bargossi, il pedestrian italiano più popolare dell’Ottocento, scrisse aiutato da un bibliotecario in Argentina. Ma come ha insegnato Georges Vigarello con il suo Culture e tecniche dello sport (1993), la storiografia dell’atletica leggera d’an- tan (e ciò vale analogamente per diverse altre discipline sportive) si fa innanzitutto, prima che collazionando risultati e gare, sui manuali e la trattatistica, ricostruendone le iniziali tappe evo- lutive attraverso quei testi che si sforzarono di gettarne le basi divulgandone i regolamenti e fissandone le prime metodiche d’allenamento. 1.1 La manualistica delle origini In quest’ottica si deve necessariamente risalire al corposo testo di 170 pagine Corse di resistenza: norme e consigli pratici per eseguirle, che Paolo Salvi pubblicò a Roma nel 1895. lo stesso anno in cui, dal 6 ottobre, prese ad uscire a Milano, impresso dalla tipografia Anselmi di corso Concordia, Il corridore pedestre, ossia il bollettino dell’Unione Dilettanti Corse Pedestri. Testata atletica che si ha motivo di ritenere tra le più antiche del Paese. Da tali dati emerge subito come in questa fase genetica, i primi campionati nazionali banditi dall’Unione Pedestre Torinese si tennero a Torino il 31 ottobre 1897 limitandosi a una corsa sui 35 km., con atletica leggera s’in- tendesse – Bargossi docet – pressoché esclusivamente il podismo di lunga e lunghissima lena. -

11 Settembre
_Olimpiadi_1960_menabò 15-07-2010 20:51 Pagina 289 11 SETTEMBRE Preceduta dal Gran Premio di salto a squadre sul prato dell’Olimpico, vinto dai cavalieri tedeschi dinanzi agli Stati Uniti e all’Italia, un’intensa cerimo- nia conclude dopo diciotto giorni la festa mondiale di gioventù coincidente con la celebrazione della XVII edizione dei Giochi. Un’immensa fiaccolata saluta sugli spalti dello stadio l’arrivederci a Tokyo 1964. “...struggente nostalgia di una stagione serena, che per diciotto giorni fu stagione del mondo...”. _Olimpiadi_1960_menabò 15-07-2010 20:51 Pagina 290 agosto 25 26 27 28 29 30 31 settembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 “Undici minuti dopo le sette di sera, i Fedeli di l’Italia, con Piero D’Inzeo e The Rock, 32 penalità (24+8), Vitorchiano, togati come senatori, piumati come moschet- e Antonio Oppes su The Scolar, 24 penalità e mezza nel tieri, illuminati come comparse di scena, soffiarono nelle primo turno, 16 nel secondo. Mezz’ora per liberare il loro trombe d’argento. Furono squilli prolungati, ripetitivi, prato, e alle 18.50, annunciate dagli squilli olimpici tratti trattenuti e lenti...Era l’annuncio, dato al fuoco, dell’avvici- dall’Inno al Sole ed eseguiti dalle Bande dei Carabinieri, narsi della sua fine...E mentre un coro eseguiva l’inno dell’Aeronautica, della Guardia di Finanza e dal Corpo olimpico, passarono quattro minuti, i riflettori si spensero, delle Guardie di Pubblica Sicurezza, fanno ingresso le e come per incanto nelle scalee s’accesero migliaia di bandiere della 84 Nazioni – prima la Grecia, ultima l’Italia fiaccole di carta improvvisate...”. -

C. C. NAPOLI Martedì, 14 Luglio 2020 C
C. C. NAPOLI martedì, 14 luglio 2020 C. C. NAPOLI martedì, 14 luglio 2020 C. C. NAPOLI 14/07/2020 Il Mattino Pagina 29 4 Scotti Galletta, le mani che afferrarono l' Europa 14/07/2020 Il Roma Pagina 21 Gennaro Iorio 6 Addio a Scotti Galletta, un altro dei grandi 14/07/2020 Il Roma Pagina 21 7 Da Trapanese a Notarangelo: «Un uomo eccezionale» 14/07/2020 La Repubblica (ed. Napoli) Pagina 14 9 Scotti Galletta: eroe della pallanuoto in vasca e al cinema 14/07/2020 Corriere del Mezzogiorno Pagina 14 Do.Mar. 11 Addio a Mario Scotti Galletta, leggenda della pallanuoto 14/07/2020 La Città di Salerno Pagina 30 12 Addio Scotti Galletta, leggenda della pallanuoto 14/07/2020 Corriere dello Sport (ed. Campania) Pagina 36 13 Mondiale nel '78 e attore: addio Scotti Galletta 14/07/2020 La Gazzetta dello Sport Pagina 43 14 Addio a Scotti Galletta Iridato col Settebello 14/07/2020 Il Secolo XIX Pagina 38 15 Addio a Mario Scotti Galletta icona della pallanuoto 14/07/2020 Il Messaggero Pagina 34 16 PALLANUOTO ADDIO A SCOTTI GALLETTA È scomparso dopo una lunga malattia Mario Scotti Galletta. 13/07/2020 ilmattino.it Raffaella Ascione 17 Pallanuoto, morto Mario Scotti Galletta: eroe del Settebello della Canottieri 13/07/2020 ilmattino.it Diego Scarpitti 18 Pallanuoto, chi era il celebre «baffo» Mario Scotti Galletta 13/07/2020 repubblica.it JACOPO MANFREDI 19 Pallanuoto: addio a Mario Scotti Galletta. Fu campione del mondo nel 1978 e portiere di "Palombella Rossa" 13/07/2020 ilroma.net 20 Addio a Mario Scotti Galletta, leggenda della pallanuoto 13/07/2020 2anews.it -

Melbourne 1956
MELBOURNE 1956 The Games of the XVI Summer Olympiad. November 22 - December 8, 1956. Melbourne, Australia. 1 ATHLETICS MEN 100 m 1.Bobby Morrow (USA) 2 200 m 1.Bobby Morrow (USA) 4 x 100 m: 1.USA (Bobby Morrow) 4 x 100 m: 2.USSR (Yuriy Konovalov) 400 m: 1.Charlie Jenkins (USA) 4 x 400 m: 1.USA (Tom Courtney, Charlie Jenkins) 3 800 m 1.Tom Courtney (USA) 4 1500 m 1.Ron Delany (Ireland) 5 5000 m 1.Vladimir Kuts (USSR) 10000 m 1.Vladimir Kuts (USSR) 6 110 m hurdles 1.Lee Calhoun (USA) 400 m hurdles 1.Glenn Davis (USA) 7 3000 m steeplechase 1.Chris Brasher (Great Britain) 4 x 100 m 1.USA 8 4 x 400 m 1.USA Pole vault 1.Bob Richards (USA) 9 Marathon 1.Alain Mimoun (France) 10 20 km walk 1.Leonid Spirin (USSR) 11 50 km walk 1.Norman Read (New Zealand) 12 13.Ronald Crawford (Australia) DNF.Don Thompson (Great Britain) 13 High jump 1.Charles Dumas (USA) 14 Triple jump 1.Adhemar da Silva (Brazil) 2.Vilhjalmur Einarsson (Iceland) 15 Shot put 1.Parry O’Brien (USA) 3.Jiri Skobla (Czechoslovakia) 16 Discus throw 1.Al Oerter (USA) 17 Javelin throw 1.Egil Danielsen (Norway) 18 Decathlon 1.Milt Campbell (USA) 19 2.Rafer Johnson (USA) 20 WOMEN 100 m 1.Betty Cuthbert (Australia) 21 200 m 1.Betty Cuthbert (Australia) 4 x 100 m: 1.Australia (Betty Cuthbert) 4 x 100 m: 3.USA (Wilma Rudolph) 22 80 m hurdles 1.Shirley Strickland de la Hunty (Australia) 2.Gisela Kohler (Germany) 4 x 100 m: 1.Australia (Shirley Strickland de la Hunty) 23 Long jump 1.Elzbieta Krzesinska (Poland) High jump 1.Mildred McDaniel (USA) 24 Javelin throw 1.Inese Jaunzeme (USSR) 25 Discus -

Bollettino SSV N. 91.Indb
ANNO XLVII 2018 BOLLETTINO STORICO VERCELLESE 91 SOCIETÀ STORICA VERCELLESE 2018 BOLLETTINO STORICO VERCELLESE ISSN 0391-4550 Autorizzazione del Tribunale di Vercelli, n. 152 del 20 settembre 1972. Gli autori sono i soli responsabili dei contenuti e delle opinioni espresse nei rispettivi saggi. Proprietà riservata. È vietata la riproduzione, anche parziale, del contenuto senza autorizzazione. 2 SOMMARIO Giancarlo Andenna Due bolle papali e una sentenza episcopale inedite dell’Archivio Borromeo all’Isola Bella ..............................................................pag. 5 Matteo Moro La repressione dell’ingiuria fra legislazione statutaria e prassi giudiziaria (secoli XIII-XV). Vercelli, Novara e Alessandria ...........................................................................pag. 15 Giorgio Dell’Oro “Feudi Pontifici” piemontesi. Un inventario di fondi archivistici vaticani (XVI-XVIII secolo) .........................pag. 57 Edoardo Villata Una piccola aggiunta al Maestro di San Martino Alfieri (e a Macrino d’Alba?) ........................................................................................pag. 85 Pierluigi Piano L’ospizio dei Poveri di Vercelli alla fine dell’800 ...............................................pag. 99 Viviana Gili Le tombe della famiglia Arborio Mella ..............................................................pag. 129 Maurizio Massa Gino Cantone (1917-1997). Unica medaglia d’oro olimpica individuale nella scherma (Londra 1948) .......pag. 159 RECENSIONI E SEGNALAZIONI ..................................................................pag.