Libero Consorzio Comunale Di Enna
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Riepilogo Periodo
Riepilogo periodo: 31/12/2020 - 29/04/2021 Giorni effettivi di vaccinazione Comune di Gagliano Castelferrato (EN) Prot. N.0004568 del 04-05-2021 arrivo Cat14 Cl.1 Fascicolo 113 / Periodo selezionato Centro vaccinale Riepilogo delle vaccinazioni effettuate 31/12/2020 29/04/2021 Tutte Somministrazioni e Totali per Data Vaccinazione e Tipo Vaccino Somministrazioni cumulate per data vaccinazione e proiezione a 10 gg Tipo Vaccino ASTRAZENECA MODERNA PFIZER Totali 70K 1.400 60K 1.200 ate 50K 1.000 ul um c oni i 40K oni az 800 i tr az s tr ni i s 30K m ni 600 i m om S om 20K 400 S 200 10K 0 0K gen 2021 feb 2021 mar 2021 apr 2021 gen 2021 feb 2021 mar 2021 apr 2021 mag 2021 Data Vaccinazione Data Vaccinazione Dosi somministrate % per Vaccino Dosi 1 2 Dose 1 2 Totale Vaccino Somministra % Somministra % Somministra % 3,6K (6,7%) 9,02K zioni zioni zioni (16,79%) ASTRAZENECA 8999 16,76% 17 0,03% 9016 16,79% MODERNA 2225 4,14% 1375 2,56% 3600 6,70% Vaccino 68,22% 31,78% PFIZER 25412 47,32% 15671 29,18% 41083 76,51% PFIZER Comune di Gagliano Castelferrato (EN) Prot. N.0004568 del 04-05-2021 arrivo Cat14 Cl.1 Fascicolo ASTRAZENECA Totale 36636 68,22% 17063 31,78% 53699 100,00% MODERNA 53699 475,21 41,08K (76,51%) 0% 50% 100% Totale somministrazioni Media giornaliera Somministrazioni / Periodo selezionato Centro vaccinazione Somministrazioni per centro di 31/12/2020 29/04/2021 vaccinazione Tutte Somministrazioni per centro vaccinale Somministrazioni per centro vaccinale 2,3K Vaccino ASTRAZENECA MODERNA PFIZER Totale 2,4K (4,46%) (4,28%) Città 1 2 Totale -
In Centro Curiosità Lu Signuri Di Li Fasci Gli Appuntamenti Numeri Utili
COMITATO PROVINCIALE ENNA C/o Pro Loco Calascibetta Via Dante, 2 - 94010 – Calascibetta (EN) [email protected] | www.unplienna.it Piazza Vittorio Emanuele, 2 Chiostro Santa Maria di Gesù 94016 Pietraperzia (EN) [email protected] www.unplisicilia.it | [email protected] Progetto grafico e impaginazione, Vantaggio - Signorelli & Partners Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione anche parziale dell’opera, in ogni forma e con ogni mezzo, inclusi fotocopia, la registrazione e il trattamento informatico, senza l’autorizzazione del possessore dei diritti. È stato fatto ogni sforzo per contattare i detentori dei diritti d’autore relativi al materiale incluso nella presente guida. Per i casi in cui non è stato possibile invitiamo a contattare l’autore. Progetto “Itinerari e prodotti tipici nei tre Valli”: Promozione & Fruizione” - Finanziato ai sensi della misura 313. Azione B “Servizi per la fruizione degli itinerari rurali” del PSR SICILIA 2007-2013, GAL “Rocca di Cerere”. Il territorio del Gal Rocca di Cerere Il territorio del “GAL Rocca di Cerere” comprende 16 Comuni: Aidone, Agira, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Cerami, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Santa Caterina Villarmosa, Troina, Villarosa ed è racchiusa da una sorta di perimetro montuoso, costituito dalle estreme pendici meridionali dei Nebrodi, delle Madonie a Nord e dai rilievi degli Erei, che ne occupano gran parte della superficie. Il comprensorio del “GAL Rocca di Cerere” offre allo sguardo un paesaggio decisamente ricco di suggestioni, costellato da catene montuose, valloni, fiumi, laghi, antichi centri arroccati e colline che degradano dolcemente verso le estese pianure del catanese. Nella zona sorgono alcuni fra i comuni più alti sul livello del mare, a partire da Enna che con i suoi 900 metri è il capoluogo più alto d’Italia. -

La Geoarcheologia Come Chiave Di Lettura Per Uno Sviluppo Sostenibile Del Territorio
Geologia dell’Ambiente Periodico trimestrale della SIGEA Società Italiana di Geologia Ambientale Supplemento al n. 2/2015 ISSN 1591-5352 oma A cura di GIOVANNI BRUNO Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1 comma - DCB R Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. Atti del convegno nazionale di geoarcheologia La geoarcheologia come chiave di lettura per uno sviluppo sostenibile del territorio Aidone (EN) 4-5 luglio 2014 Geologia dell’Ambiente Periodico trimestrale della SIGEA Società Italiana di Geologia Ambientale Sommario Associazione di protezione ambientale a carattere nazionale riconosciuta dal Ministero dell’ambiente, Relazioni ad invito della tutela del territorio e del mare, con D.M. 24 maggio 2007, G.U. n. 127 del 4.6.2007 Evidenze di cambiamento climatico desunte da dati Supplemento al n. 2/2015 idrogeologici e dagli schemi di funzionamento Anno XXIII - aprile-giugno 2015 della fontana monumentale di Morgantina (Sicilia) GIOVANNI BRUNO, LUIGI BOBBO, ALESSANDRO FLAVIO BRUNO 7 Iscritto al Registro Nazionale della Stampa n. 06352 Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 229 Recenti scavi a Morgantina: Il progetto Contrada Agnese del 31 maggio 1994 (2013-2014) J. BENTON, R. GORHAM, J.F. HUEMOELLER, L.A. LIEBERMAN, Comitato scientifico Mario Bentivenga, Aldino Bondesan, D. MASSEY, A. SMALLING, R. SOUZA, A. TRUETZEL, Giancarlo Bortolami, Giovanni Bruno, D.A. WALTHALL 19 Felice Di Gregorio, Giuseppe Gisotti, Giancarlo Guado, Gioacchino -

Provincia Di Enna
COMUNE DI NISSORIA Provincia di Enna Procedura aperta per l’appalto dei lavori di adeguamento dell’area mercatale del Comune di Nissoria previsto nel P.S.R. Sicilia 2007/13 Misura 321/A/1 Servizi Commerciali rurali C.U.P.: H27D12000000006 C.I.G.: 5768129A9F VERBALE DI AGGIUDICAZIONE L’anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di Giugno – alle ore 09.00 – nella sede del Palazzo Municipale, sono presenti il geom. Licata Nunzio, Responsabile del Settore Tecnico del Comune nella qualità di Presidente di gara, il sig. Francesco Campagna e sig.ra Rosina Testa, impiegati del Comune, nella qualità di testimoni cogniti, idonei e nominati con disposizione del segretario Comunale prot. n. 3851 del 28 Maggio 2014. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il predetto sig. Francesco Campagna. Si procede all’esperimento della gara mediante procedura aperta per il conferimento dell’appalto dei lavori in oggetto per l’importo complessivo di €.168.568,67 di cui €. 134.140,23 soggetti a ribasso ed €. 5.800,00 quale somma per oneri per la sicurezza posti in evidenza ai sensi dell’art.131 – comma 3° - D.L.vo 163/06 ed €. 28.628,44 quale costo di mano d’opera, non soggetti a ribasso. Si premette che: con deliberazione di Giunta Comunale n.112 del 04 Ottobre 2013, esecutiva, è stato approvato il progetto per la realizzazione dell’area mercatale di contrada Piano Comune di Nissoria; con determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 135 del 10 Aprile 2014 è stato stabilito di procedere all’affidamento dei lavori mediante appalto pubblico a procedura aperta, secondo quanto previsto dall’art.55 del D.L.vo n. -

Libero Consorzio Comunale Di Enna Già Provincia Regionale Di Enna SETTORE III Territorio – Pianificazione – Ambiente – Lavori Pubblici Dirigente: Dott
15/06/2020 Libero Consorzio Comunale di Enna già Provincia Regionale di Enna SETTORE III Territorio – Pianificazione – Ambiente – Lavori Pubblici Dirigente: Dott. Ing. Paolo PULEO SERVIZIO 1 Gestione e Manutenzione Stradale Accertamenti e Violazioni al Codice della Strada – Autoparco Responsabile: Geom. Salvatore RAGONESE Enna, 3 febbraio 2020 LA PROVINCIA DI ENNA NEL CUORE DELLA SICILIA UNICA SENZA SBOCCHI SUL MARE CON RILIEVI COLLINARI E MONTUOSI ESTESA 2.562,50 km2 COMPOSTA DA 20 COMUNI 1 VIABILITÀ NEL TERRITORIO PROVINCIALE AUTOSTRADA A19 PALERMO - CATANIA PROVINCIALE TERRITORIO TERRITORIO VIABILITÀ NEL NEL 15/06/2020 2 15/06/2020 VIABILITÀ NEL TERRITORIO PROVINCIALE AUTOSTRADA A19 IL PIÙ IMPORTANTE COLLEGAMENTO VIARIO PALERMO - CATANIA TRA LA SICILIA ORIENTALE E OCCIDENTALE DIVIDE A METÀ SVILUPPO SU TERRITORIO PROVINCIALE IL TERRITORIO PROVINCIALE km 63,100 SVINCOLI AUTOSTRADALI RICADENTI NEL TERRITORIO PROVINCIALE FERRARELLE ENNA MULINELLO DITTAINO AGIRA CATENANUOVA VIABILITÀ NEL TERRITORIO PROVINCIALE TERRITORIO NEL 3 15/06/2020 VIABILITÀ NEL TERRITORIO PROVINCIALE TRATTI RICADENTI N. N. DENOMINAZIONE TERRITORIO COMUNALE ATTRAVERSATO SUL TERRITORIO Ordine PROVINCIALE 1 SS 117 Centrale Sicula Nicosia - Cerami - Leonforte - Assoro 40,556 2 SS 117 bis di Nicosia Enna - Piazza Armerina 63,400 3 SS 120 dell'Etna e delle Madonie Sperlinga - Nicosia - Cerami - Troina 68,400 4 SS 121 Catanese Villarosa - Enna - Leonforte - Nissoria - Agira - Regalbuto 79,300 5 SS 122 Agrigentina Enna 8,891 6 SS 191 Barrafranca Barrafranca - Pietraperzia 17,900 7 SS 192 della Valle del Dittaino Enna - Zona Industriale Dittaino - Catenanuova 51,000 8 SS 288 di Aidone Aidone (Morgantina) - Piazza Armerina 21,400 9 SS 290 di Alimena Calascibetta - Enna 20,520 10 SS 560 Mercato Bianco Enna - Pietraperzia 9,800 11 SS 561 Pergusina Enna - Valguarnera 10,500 12 SS 575 di Troina Troina - Centuripe 32,805 13 SS 626 della Valle del Salso Enna - Pietraperzia 16,050 14 SS 640 Strada degli Scrittori (già di Porto Empedocle) Villarosa 1,400 sommano …………….…..…. -

Prefettura Di Enna -U.T.G.- Progetto : ”Museo Diffuso”
Prefettura di Enna -U.T.G.- Progetto : ”Museo diffuso” IITINERARIO tematico ICONOGRAFIA DI NOSTRA SIGNORA PRESSO I BENI DEL FEC DELLA PROVINCIA DI ENNA Quello della Madonna è il tema iconografico più ricco di tutta l’arte cristiana. La più antica immagine conosciuta è quella della catacombe di Priscilla a Roma, risalente alla metà del III secolo. Il tema ebbe il suo sviluppo trionfale nell’arte italiana del Duecento e del Trecento, nei dipinti famosi di Cimabue, Giotto, Duccio di Buoninsegna e Simone Martini che rinnovarono profondamente la tradizione iconografica. Si sviluppava così un tipo iconograficamente più umano di Madonna, che ebbe nell’arte occidentale variazioni infinite, tra le quali si distinguono la Madonna del latte o dell’umiltà e la Madonna del roseto. Dal Quattrocento al Seicento la Madonna col Bambino venne raffigurata con grande libertà e varietà inventiva. Madonna con Bambino, L’Annunciazione, XVII sec., autore ignoto Presso i Sacri Edifici di culto del Fec è possibile ammirare olii su tela policromi , statue marmoree ed in cartapesta raffiguranti Nostra Signora in atteggiamenti di particolare, XVII secolo autore Chiesa del Carmine di Regalbuto ignoto Chiesa di San raggiante ed austera maternità ma anche di dolore e compassione straziante per la morte di suo Figlio Gesù Cristo. Giovanni Battista di Enna L’itinerario tematico si snoda attraverso otto comuni della provincia ennese nei quali son presenti i sacri edifici ed i beni mobili afferenti al FEC. Ogni bene testimonia l’abilità delle maestranze locali e raffigura ,nel suo splendore ed originalità ,tracce della vita mariana. Elementi fondamentali risultano esser la sapiente scelta dei materiali e dei colori:dalle vestigia auree della Madonna de L’Annunciazione di Regalbuto ,al manto ceruleo della Madonna con Bambino di Nicosia. -

Report Voti Consiglieri Comune Di GAGLIANO CASTELFERRATO (EN) Risultati Consiglieri Relativi a N.4 Su N
REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI Elezioni Provinciali del 15-16 giugno 2008 Report Voti Consiglieri Comune di GAGLIANO CASTELFERRATO (EN) Risultati Consiglieri relativi a n.4 su n. 4 sezioni Dati relativi allo scrutinio completo N° Lista Candidati 1 VERITAS RIFONDAZIONE CRISTIANA 11 N° Candidati Consigliere Data e Luogo di Nascita Voti 1 CASALI VINCENZO detto CASALE 04-05-1954 - LICATA 0 2 BARTOLOTTA NATALE 06-10-1960 - CENTURIPE 0 3 CALI' GIUSEPPA 30-11-1970 - CATENANUOVA 0 4 CAPIZZI SANTI 11-07-1966 - ENNA 0 5 CARDACI GIUSEPPE 14-02-1985 - CATANIA 0 6 FORTUNATO MATTEO 03-11-1958 - VALDERICE 0 7 MIRAGLIA GIUSEPPE 22-04-1981 - ADRANO 0 8 PRIVITERA SANTA 05-01-1947 - CATANIA 0 9 MALLAMACI LUCIO 12-01-1958 - CARIATI 0 10 MORACA SERGIO 29-06-1958 - NAPOLI 0 11 LEONARDO GAETANO 12-10-1956 - ENNA 0 Trattasi di dati provvisori comunicati dai Comuni attraverso le Prefetture Uffici Territoriali del Governo 17/06/2008 8.06 AM Pagina 1 di 14 Totale 0 N° Lista Candidati 2 PARTITO SOCIALISTA - PSE 11 N° Candidati Consigliere Data e Luogo di Nascita Voti 1 DI FRANCO SANTO 04-05-1985 - LEONFORTE 0 2 GUAGLIARDO ANTONIO 18-02-1981 - PATERNO' 2 3 LAMBUSTA ANTONINO 14-07-1958 - GAGLIANO C.TO 109 4 MINACAPILLI ROSARIA 23-09-1984 - PIAZZA ARMERINA 0 5 MIRODDI SALVATORE detto TOTUCCIO 06-05-1948 - AIDONE 0 6 NASCA ALESSANDRO 12-07-1965 - TROINA 0 7 RAINIERI FILIPPO RITA 01-03-1975 - CATANIA 0 8 SANFILIPPO LUCIA 15-03-1966 - MAUBEUGE 0 9 TESTAI' PIETRO 04-06-1947 - ASSORO 0 10 TROVATO -
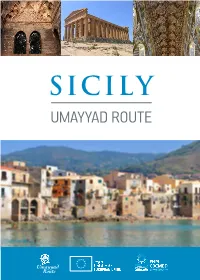
Sicily UMAYYAD ROUTE
SICILY UMAYYAD ROUTE Umayyad Route SICILY UMAYYAD ROUTE SICILY UMAYYAD ROUTE Umayyad Route Index Sicily. Umayyad Route 1st Edition, 2016 Edition Introduction Andalusian Public Foundation El legado andalusí Texts Maria Concetta Cimo’. Circuito Castelli e Borghi Medioevali in collaboration with local authorities. Graphic Design, layout and maps Umayyad Project (ENPI) 5 José Manuel Vargas Diosayuda. Diseño Editorial Free distribution Sicily 7 Legal Deposit Number: Gr-1518-2016 Umayyad Route 18 ISBN: 978-84-96395-87-9 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, nor transmitted or recorded by any information retrieval system in any form or by any means, either mechanical, photochemical, electronic, photocopying or otherwise without written permission of the editors. Itinerary 24 © of the edition: Andalusian Public Foundation El legado andalusí © of texts: their authors © of pictures: their authors Palermo 26 The Umayyad Route is a project funded by the European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) and led by the Cefalù 48 Andalusian Public Foundation El legado andalusí. It gathers a network of partners in seven countries in the Mediterranean region: Spain, Portugal, Italy, Tunisia, Egypt, Lebanon and Jordan. Calatafimi 66 This publication has been produced with the financial assistance of the European Union under the ENPI CBC Mediterranean Sea Basin Programme. The contents of this document are the sole responsibility of the beneficiary (Fundación Pública Castellammare del Golfo 84 Andaluza El legado andalusí) and their Sicilian partner (Associazione Circuito Castelli e Borghi Medioevali) and can under no Erice 100 circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union or of the Programme’s management structures. -

Sicily Before the Greeks. the Interaction with Aegean and the Levant in the Pre-Colonial Era
Open Archaeology 2020; 6: 172–205 Review Article Davide Tanasi* Sicily Before the Greeks. The Interaction with Aegean and the Levant in the Pre-colonial Era https://doi.org/10.1515/opar-2020-0107 received April 17, 2020; accepted July 1, 2020. Abstract: The relationship between Sicily and the eastern Mediterranean – namely Aegean, Cyprus and the Levant – represents one of the most intriguing facets of the prehistory of the island. The frequent and periodical contact with foreign cultures were a trigger for a gradual process of socio-political evolution of the indigenous community. Such relationship, already in inception during the Neolithic and the Copper Age, grew into a cultural phenomenon ruled by complex dynamics and multiple variables that ranged from the Mid-3rd to the end of the 2nd millennium BCE. In over 1,500 years, a very large quantity of Aegean and Levantine type materials have been identified in Sicily alongside with example of unusual local material culture traditionally interpreted as resulting from external influence. To summarize all the evidence during such long period and critically address it in order to attempt historical reconstructions is a Herculean labor. Twenty years after Sebastiano Tusa embraced this challenge for the first time, this paper takes stock on two decades of new discoveries and research reassessing a vast amount of literature, mostly published in Italian and in regional journals, while also address the outcomes of new archaeometric studies. The in-depth survey offers a new perspective of general trends in this East-West relationship which conditioned the subsequent events of the Greek and Phoenician colonization of Sicily. -

Attention Arba Sicula Members! Our Address Has Changed
RIVISTA DI FOLKLORI E LITTIRATURA SICILIANI A R B A S I C U L A JOURNAL OF SICILIAN FOLKLORE & LITERATURE Diritturi-Editor GAETANO CIPOLLA CUNSIGGHIERI Ô DIRITTURI EDITORIAL BOARD Antina Lentini Babakhanian Antony F. Lazzara Salvatore Bancheri Antonio Pagano Alissandru Caldieru (CO-FOUNDER) Salvatore Paternò Cosimo Corsano Paolo Possiedi Nicolò d’Alessandro Antonino Provenzano Alfredo Danese Giuseppe Quatriglio Salvatore Di Marco Florence Russo Paolo Fiorentino Federico Vaccaro Mario Gallo Justin Vitiello Giovanna Jackson Jana Vizmuller-Zocco VOLUMI XXXII, NUMIRA 1 & 2, PRIMAVERA E STATI 2011 VOLUME XXXII, NUMBERS 1 & 2, SPRING & SUMMER 2011 © Copyright 2011 by ARBA SICULA, ISSN 0271-0730 Design and Camera-Ready Text by LEGAS ARBA SICULA è l’organu ufficiali dâ società siculu-americana dû stissu nomi ca si proponi comu obbiettivu principali di prisirvari, studiari, e promoviri a lingua e a cultura siciliani. ARBA SICULA è normalmenti pubblicata na vota l’annu in doppiu volumi versu settembri. Pi comunicari direttamenti cû diritturi, pi mannari materiali pâ rivista, pi l’abbunamenti e pi informazioni supra a nostra società, scriviti a Gaetano Cipolla, PO Box 149 Mineola, New York 11501. I materiali ricevuti non si restituisciunu si nun si manna puru na busta affrancata cû nomu e indirizzu. ABBUNAMENTI Cu si abbona a la rivista, diventa automaticamenti sociu di Arba Sicula. Cu n’abbunamentu annuali i soci ricivunu du nummira di Arba Sicula (unu, si pubblicamu un numiru doppiu) e dui di Sicilia Parra. Arba Sicula è na organizzazioni senza scopu di lucru. Abbunamenti fora dî Stati Uniti $40.00 Abbunamentu regolari $35.00 Anziani e studenti $30.00 ARBA SICULA is the official journal of the Sicilian-American organization by the same name whose principal objective is to preserve, study, and promote the language and culture of Sicily. -

PSR Sicilia 2007\2013 Bando 2009\2011 2^ Sottofase Misura 121 Avvio Procedimento Amministrativo Domande Di Aiuto
PSR Sicilia 2007\2013 Bando 2009\2011 2^ Sottofase Misura 121 Avvio procedimento amministrativo domande di aiuto DITTA NATO A PROV IL RECAPITO CODICE DOMANDA DENOMINAZIONE RAGIONE CUUA COGNOME NOME TIPO IMPRESA INDIRIZZO E NUMERO CIVICO CAP COMUNE PROV. SIAN N° SOCIALE N. O. 1 94750137690 LPCMSS78A45A494G LUPICA SPAGNOLO MELISSA AUGUSTA SR 05/01/78 INDIVIDUALE VIA R. SANZIO 103 94010 GAGLIANO CASTEFERRATO EN 2 94750179437 4538550825 POLIZZANO FRANCESCO PAOLO GANGI PA 16/02/35 SOCIETA' INTRONATA 3000 S.S. PIAZZA F. CRISPI 1 90100 PALERMO PA 3 94750187661 DNGMNN72E52H805B D'ANGELO MARIANNA SAN CONO CT 12/05/72 INDIVIDUALE VIA GIACOMO MATTEOTTI 36 95040 SAN CONO CT 4 94750188339 RNDCNO48M02H805M RANDAZZO CONO SAN CONO CT 02/08/48 INDIVIDUALE VIA S. GIUSEPPE 67 95040 SAN CONO CT 5 94750190830 PRPGSI65L61C351C TRUPIA GIUSI CATANIA CT 21/07/75 INDIVIDUALE VIA SOLDATO IGNOTO 4 95040 SAN CONO CT 6 94750190681 BRNBCN85R05C342J BRANCAFORTE VINCENZO ENNA EN 05/10/85 INDIVIDUALE VIA NINO MARTOGLIO 16 94012 BARRAFRANCA EN 7 94750224001 1153000862 PERRI DOMENICO BARRAFRANCA EN 15/06/71 SOCIETA' PERSEFONE S.S. AGRICOLA VIA POLONIA 4 94012 BARRAFRANCA EN 8 94750224100 DVNPTR54H30B381S DI VENTI PIETRO CALASCIBETTA EN 30/06/54 INDIVIDUALE C.DA SETTAFORA 94010 CALASCIBETTA EN 9 94750226469 BRCSTN54T12A202K BRUCATO SANTO ANTONIO ALIMENA PA 12/12/54 INDIVIDUALE VIA MASCELLINO 17 90020 ALIMENA PA 10 94750230057 RNDCML48B04C351V RANDAZZO CARMELO CATANIA CT 04/02/48 INDIVIDUALE VIA VIRGILIO 3 94019 VALGUARNERA EN 11 94750229422 01090590868 MICCICHE GIUSEPPE MAZZARINO CL 25/08/67 SOCIETA' BIOHORTOPALNT S.R.L. VIA GINO NOVELLI 20 94012 BARRAFRANCA EN 12 94750223664 MRNGPP37T06L448J MERENDA GIUSEPPE TROINA EN 06/12/37 INDIVIDUALE VIA NAZIONALE 179 94018 TROINA EN 13 94750223730 GRZMCR79C71C351L GRAZIANO MARIA CARMELA DORIANA CATANIA CT 31/03/79 INDIVIDUALE VIA A. -

Bollettino Trasferimenti
SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE : ENNA ELENCO DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2010/11 ATTENZIONE: PER EFFETTO DELLA LEGGE SULLA PRIVACY QUESTA STAMPA NON CONTIENE ALCUNI DATI PERSONALI E SENSIBILI CHE CONCORRONO ALLA COSTITUZIONE DELLA STESSA. AGLI STESSI DATI GLI INTERESSATI O I CONTROINTERESSATI POTRANNO EVENTUALMENTE ACCEDERE SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE SULLA TRASPARENZA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI. TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DEL COMUNE - CLASSI COMUNI 1. CASTIGLIONE ANGELO . 6/ 5/69 (EN) DA : ENEE05601Q - N. VACCALLUZZO (LEONFORTE) A : ENEE05701G - BRANCIFORTI (LEONFORTE) (SOPRANNUMERARIO TRASFERITO CON DOMANDA CONDIZIONATA) PUNTI 90 2. CICCIA LINA . 1/ 2/54 (EN) DA : ENCT703001 - C.TERR.(I.A.)S.M."PIRANDELLO" N A : ENEE061017 - CARMINE (NICOSIA) PRECEDENZA: EX PERDENTE POSTO NELLA SCUOLA PUNTI 109 3. LA GRECA MICHELA . 25/ 7/66 (EN) DA : ENEE062013 - S. DOMENICO (NICOSIA) A : ENCT703001 - C.TERR.(I.A.)S.M."PIRANDELLO" N PRECEDENZA: TRASFERITO D'UFFICIO PUNTI 62 4. MORELLO ANGELA MARIA . 3/12/58 (SR) DA : ENEE81002A - G. MARCONI (PIETRAPERZIA) A : ENEE81002A - G. MARCONI (PIETRAPERZIA) DA POSTO DI LINGUA :INGLESE PRECEDENZA: TRASFERITO NELL'AMBITO DELL'ORG. FUNZ. PUNTI 141 5. NICITA GIUSEPPA . 5/ 4/66 (EN) DA : ENEE05601Q - N. VACCALLUZZO (LEONFORTE) A : ENEE05701G - BRANCIFORTI (LEONFORTE) (SOPRANNUMERARIO TRASFERITO CON DOMANDA CONDIZIONATA) PUNTI 99 TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DEL COMUNE - POSTI DI LINGUA STRANIERA LINGUA INGLESE 1. LA BELLA SAVERIO . 30/ 8/66 (EN) DA : ENEE81401L - VILLADORO (FRAZ. DI NICOSIA) (NICOSIA) A : ENEE062013 - S. DOMENICO (NICOSIA) DA CLASSE COMUNE (SOPRANNUMERARIO TRASFERITO CON DOMANDA CONDIZIONATA) PUNTI 45 2.