Rilevanza-Storica-Delle-Raffigurazioni
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bells and Trumpets, Jesters and Musici: Sounds and Musical Life in Milan Under the Visconti
Lorenzo Tunesi – Bells and Trumpets, Jesters and Musici 1 Bells and Trumpets, Jesters and Musici: Sounds and Musical life in Milan under the Visconti Or questa diciaria, Now [I conclude] my speech, perché l’Ave Maria since the Ave Maria sona, is ringing, serro la staciona I shut up shop nén più dico1 and I won’t talk anymore These verses, written by the Milanese poet and wealthy member of the ducal chancellery Bartolomeo Sachella, refer to a common daily sound in late Medieval Milan. The poet is quickly concluding his poem, since the Ave Maria is already sounding. When church-bells rang the Ave Maria, every citizen knew, indeed, that the working-day was over; thus, probably after the recitation of a brief prayer in honour of the Virgin, shops closed and workers went home. Church-bells were only one of the very large variety of sounds characterising Medieval cities. Going back over six-hundred years, we could have been surrounded by city-criers accompanied by trumpet blasts, people playing music or singing through the streets, beggars ringing their bells asking for charity, mothers’ and children’s voices, horses’ hoofs and many other sounds. All these sounds created what musicology has defined as ‘urban soundscape’, which, since the pioneering study by Reinhard Strohm, Music in Late Medieval Bruges (1985), has deeply intrigued music historians. The present essay aims to inquire into the different manifestations of musical phenomena in late Medieval Milan, relating them to the diverse social, cultural and historical contexts in which they used to take place. My research will focus on a time frame over a century, ca. -

Galvano Fiamma, Francesco Petrarca E I Cavalli Dei
Immagini del Medioevo 17x24 ok_Layout 1 03/04/13 11.13 Pagina 199 GALVANO FIAMMA , F RANCESCO PETRARCA EICAVALLI DEI VISCONTI GRAZIANO ALFREDO VERGANI Banco di prova privilegiato per lo sviluppo del linguaggio rinascimentale quattrocentesco, il tema del monumento equestre ha avuto in Italia una notevole fortuna già nel Trecento, in relazione con il maturare delle istituzioni signorili e con il diffondersi di una nuova sensibilità, intrisa di contenuti cavallereschi e proto umanistici. Esemplare è il caso di Verona con il celebre complesso delle arche scaligere, su cui sfilano, in una parata cerimoniale tra cielo e terra, le statue a cavallo di Cangrande, Mastino e Cansignorio della Scala 1. Un altro caso è Milano, dove risulterebbero essere stati realizzati nel Trecento i monumenti equestri di almeno due Visconti, signori della città: Azzone e Bernabò. Il condizionale è d’obbligo, poiché mentre quello di Bernabò, sistemato sopra il suo sarcofago, fa ancora mostra di sé in una sala del Castello Sforzesco (figg. 1-2) – dove giunse nel 1898 dalla ex chiesa di Santa Maria di Brera, sede del Museo Patrio Archeologico, pro - venendo da quella di San Giovanni in Conca, per la quale era stato creato 2 –, del monumento equestre di Azzone non resta invece traccia alcuna ed è mia opinio - ne che l’unica fonte che lo ricordi non fornisca elementi sufficienti a comprovar - ne l’effettiva realizzazione. La fonte in questione è l’ Opusculum de rebus gestis ab Azone, Luchino et Johan - ne Vicecomitibus di Galvano Fiamma, amico e familiare dell’arcivescovo Giovan - ni Visconti, la cui redazione va fissata entro il 1342-43 3. -

Europa E Italia. Studi in Onore Di Giorgio Chittolini
Reti Medievali E-Book 15 Reti Medievali E-Book Comitato scientifico Pietro Corrao (Università di Palermo) Roberto Delle Donne (Università di Napoli “Federico II”) Stefano Gasparri (Università “Ca’ Foscari” di Venezia) Paola Guglielmotti (Università di Genova) Gian Maria Varanini (Università di Verona) Andrea Zorzi (Università di Firenze) Europa e Italia. Studi in onore di Giorgio Chittolini Europe and Italy. Studies in honour of Giorgio Chittolini Firenze University Press 2011 Europa e Italia : Studi in onore di Giorgio Chittolini / Europe Europa e Italia. Studi in onore di Giorgio Chittolini / Europe and Italy. Studiesand Italy in honour : Studies of Giorgio in honour Chittolini. of Giorgio – Chittolini. – Firenze : Reti Medievali E-book FirenzeFirenze : FirenzeUniversity university Press, press, 2011. 2011. – XXXI, 453 p. ; 24 cm (Reti(Reti Medievali. Medievali E-Book E-Book ; 15) ; 15) Reti Medievali E-book Accessohttp://digital.casalini.it/9788864532349 alla versione elettronica: http://www.ebook.retimedievali.ithttp://www.ebook.retimedievali.it Monografie Uno stato d’animo. Memoria del tempo e comportamenti ISBN 978-88-6453-234-9 Monografie1. Renato Bordone, ISBN 978-88-6453-234-9 (online) urbani nel mondo comunale italiano, 2002 1. Renato Bordone,“DareUno stato et habere”. d’animo. Il mondo Memoria di un del mercante tempo e comportamenti milanese del 2.urbani Marina nel Gazzini, mondo comunale italiano Quattrocento, 2002 , 2002 2. Marina Gazzini, “DareRicerche et habere”. sull’organizzazione Il mondo di un del mercante territorio milanese nella Liguria del me- 3.Quattrocento Paola Guglielmotti, dievale, 2005, 2002 3. Paola Guglielmotti, RicercheGovernare sull’organizzazione la città. Pratiche del sociali territorio e linguaggi nella Liguria politici me- a 4.dievale Giovanna Petti Balbi, Genova, in2005 età medievale, 2007 4. -

Reading the Dream Visions and Troilus and Criseyde
University of Tennessee, Knoxville TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange Doctoral Dissertations Graduate School 8-2006 Chaucer's Questioning Impulse: Reading the Dream Visions and Troilus and Criseyde Anita K. Bergeson University of Tennessee, Knoxville Follow this and additional works at: https://trace.tennessee.edu/utk_graddiss Part of the English Language and Literature Commons Recommended Citation Bergeson, Anita K., "Chaucer's Questioning Impulse: Reading the Dream Visions and Troilus and Criseyde. " PhD diss., University of Tennessee, 2006. https://trace.tennessee.edu/utk_graddiss/4290 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange. It has been accepted for inclusion in Doctoral Dissertations by an authorized administrator of TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange. For more information, please contact [email protected]. To the Graduate Council: I am submitting herewith a dissertation written by Anita K. Bergeson entitled "Chaucer's Questioning Impulse: Reading the Dream Visions and Troilus and Criseyde." I have examined the final electronic copy of this dissertation for form and content and recommend that it be accepted in partial fulfillment of the equirr ements for the degree of Doctor of Philosophy, with a major in English. Laura L. Howes, Major Professor We have read this dissertation and recommend its acceptance: Tom Heffernan, Tom Burman, Joe Trahern Accepted for the Council: Carolyn R. Hodges Vice Provost and Dean of the Graduate School (Original signatures are on file with official studentecor r ds.) To the Graduate Council: I am submitting herewith a dissertation written by Anita K. Bergeson entitled "Chaucer's Questioning Impulse: Reading the Dream Visions and Troi/us and Criseyde." I have examined the final paper copy of this dissertation for form and content and recommend that it be accepted in partial fulfillment of the requirements forthe degree of Doctor of Philosophy, with a major in English. -
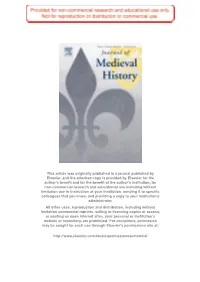
This Article Was Originally Published in a Journal Published by Elsevier
This article was originally published in a journal published by Elsevier, and the attached copy is provided by Elsevier for the author’s benefit and for the benefit of the author’s institution, for non-commercial research and educational use including without limitation use in instruction at your institution, sending it to specific colleagues that you know, and providing a copy to your institution’s administrator. All other uses, reproduction and distribution, including without limitation commercial reprints, selling or licensing copies or access, or posting on open internet sites, your personal or institution’s website or repository, are prohibited. For exceptions, permission may be sought for such use through Elsevier’s permissions site at: http://www.elsevier.com/locate/permissionusematerial Journal of Medieval History 33 (2007) 1e32 www.elsevier.com/locate/jmedhist Contra damnationis filios: the Visconti in fourteenth-century papal diplomacy Sharon Dale Humanities and Social Sciences, Penn State-Erie, The Behrend College, Station Road, Erie, PA 16363-1501, USA Abstract This article seeks to reappraise the relationship between the Avignon papacy and the Visconti lords of Milan during the fourteenth century. Avignon popes generally viewed the Visconti as the major obstacle to papal temporal power in Italy and thus fashioned propaganda that demonised them. This mythic portrayal, that was re-framed by Florence to justify its own imperialistic ambitions in Tuscany, has been accepted uncritically by modern historiography. Documents from the Vatican archive reveal a more complicated diplomacy. Papal policy toward the Visconti was far from consistent, as the curia welcomed Visconti money and Avignonese popes regularly granted the Visconti papal vicariates. -

Pavia, Italy 1-5 September 2010
IUCN XIth International Otter Colloquium IUCN Otter Specialist Group Pavia, Italy 1-5 September 2010 1st Circular Pavia 6 March 2009 Invitation We have pleasure in announcing that the XIth International Otter Colloquium will be held in Pavia (Lombardy Region), Italy, from the 1st to the 5th of September 2010. The principal host of the congress is the University of Pavia, in co-operation with the University of Molise and the IUCN/SSC Otter Specialist Group. The organisers look forward to welcome you to Italy and hope that you will enjoy your stay in Pavia, an attractive town near Milan. Claudio Prigioni - University of Pavia Anna Loy - University of Molise Jim Conroy – IUCN OSG e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] [email protected] Background The XIth International Otter Colloquium is an excellent opportunity to become familiar with current knowledge and on conservation status of the 13 otter species in the world. It is also an opportunity to exchange research experiences with colleagues from different countries. Following the success of the previous colloquia, it is now the turn of a Mediterranean country to host this stimulating event and to invite all otter researchers to the XIth I.O.C. in Pavia. Location and Dates The location of XIth I.O.C will be the “University of Pavia”, Strada Nuova 65, 27100 Pavia, Italy (www.unipv.eu). The Colloquium will begin with the registration on Tuesday, August 31, and will close on Sunday, September 5. An optional excursion is planned after the Colloquium. Organisers Claudio Prigioni - Dipartimento di Biologia Animale, Università degli Studi di Pavia, Piazza Botta 9, 27100 Pavia, Italy; tel. -

Ducks and Deer, Profit and Pleasure: Hunters, Game and the Natural Landscapes of Medieval Italy Cristina Arrigoni Martelli A
DUCKS AND DEER, PROFIT AND PLEASURE: HUNTERS, GAME AND THE NATURAL LANDSCAPES OF MEDIEVAL ITALY CRISTINA ARRIGONI MARTELLI A DISSERTATION SUBMITTED TO THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR IN PHILOSOPHY GRADUATE PROGRAM IN HISTORY YORK UNIVERSITY TORONTO ONTARIO May 2015 © Cristina Arrigoni Martelli, 2015 ii ABSTRACT This dissertation is an ample and thorough assessment of hunting in late medieval and Renaissance northern and central Italy. Hunting took place in a variety of landscapes and invested animal species. Both of these had been influenced by human activities for centuries. Hunting had deep cultural significance for a range of social groups, each of which had different expectations and limitations on their use of their local game animal-habitat complexes. Hunting in medieval Italy was business, as well as recreation. The motivations and hunting dynamics (techniques) of different groups of hunters were closely interconnected. This mutuality is central to understanding hunting. It also deeply affected consumption, the ultimate reason behind hunting. In all cases, although hunting was a marginal activity, it did not stand in isolation from other activities of resource extraction. Actual practice at all levels was framed by socio-economic and legal frameworks. While some hunters were bound by these frameworks, others attempted to operate as if they did not matter. This resulted in the co-existence and sometimes competition, between several different hunts and established different sets of knowledge and ways to think about game animals and the natural. The present work traces game animals from their habitats to the dinner table through the material practices and cultural interpretation of a variety of social actors to offer an original survey of the topic. -

Muoversi Nel Castello
MUOVERSI NEL CASTELLO 1 MUOVERSI NEL CASTELLO Ciao Piccolo Esploratore! Ciao Piccola Esploratrice! mi chiamo Ludovico e sono un discendente del famoso Ludovico il Moro, Duca di Milano! Lo sai che nei Musei del Castello Sforzesco di Milano ci sono delle opere straordinarie? Due miei amici ti accompagneranno in questa ricerca: Ottone, il serpente intelligente ti segnalerà le opere più importanti Gatton de Foix, il gattone curiosone con le sue orme ti indicherà le curiosità. 2 MUOVERSI NEL CASTELLO C'era una volta …il Castello Sforzesco, che non piaceva molto ai milanesi perché era il luogo dove -ad ogni battaglia persa- alloggiavano gli eserciti stranieri vincitori. Ci alloggiarono ad esempio gli Spagnoli, che hanno lasciato tracce nelle pitture murali e negli edifici (se guardi bene nella piantina c'è un'ala che si chiama Ex Ospedale Spagnolo). Ora invece c'è…sempre il Castello Sforzesco, oggi amato dai milanesi, uno dei luoghi più importanti della cultura e simbolo della città: contiene sette musei che hanno al loro interno opere di importanza internazionale. Attento, il Castello che vediamo oggi non è l'edificio originale, perché nei secoli è stato ricostruito e ampliato dai Visconti e dagli Sforza, poi distrutto dalle varie guerre, fino a che alla fine dell'Ottocento, non arrivò Luca Beltrami, il famoso architetto che lo restaurò. Ricordiamoci qualche data e qualche nome: 1360/1370 Galeazzo II Visconti mette la prima pietra 1447 Filippo Maria Visconti muore e nasce la Repubblica Ambrosiana. 1450 Francesco Sforza sale al potere. Fa realizzare la torre centrale dall’architetto Filarete (anche oggi la torre principale si chiama “Torre del Filarete” ma non è più l’originale, è stata rifatta da Luca Beltrami) Dal 1466 al 1476 Galeazzo Maria, figlio di Francesco, è Duca di Milano. -

Visconti, Sforza
Italie du Nord, Empire Armes : Milan (duché) : «D’argent, à une couleuvre ondoyante Ducs de Milan en pal d’azur, couronnée d’or, engloutissant un enfant de carnation, posé en fasce, les bras étendus» Visconti : «D’argent, au serpent d’azur ondoyant en pal & couronné d’or, engloutissant un enfant de carnation.» Visconti, Sforza Sforza (Francesco) : Milan «Ecartelé : au premier & au quatrième, d’or, à l’aigle éployée Milan (Visconti) de sable, lampassée de gueules & couronnée du champ, au deuxième & au troisième, d’argent, au serpent d’azur ondoyant en pal & couronné d’or engloutissant un enfant de carnation» Devise : «Rien ne m’est plus, plus ne m’est rien» (Valentina Visconti, duchesse d’Orléans, après l’assassinat de son mari) Symbole : le mûrier blanc, devise de sagesse ; un dragon et un lion cabrés près d’une branche de palme : «Prudentia Victoria Forza» (lors de ses noces avec Beatrice d’Este) Milan bannière et armes sculptées Milan (Sforza) Segni (Sforza) Teobaldo Visconti (Ludovice «Le More») pape Grégoire X Sources complémentaires : Italy / Milan Nobility (Medlands Project) dont : Necrologium soeldantalense (Regensburg Necrologies), Necrologium Austriacum gentis Habsburgicae Alterum (Passau Necrologies, II), Monumenta Necrologica raitenhslacensia, Liber defunctorum Genealogica (appendix, Salzburg Necrologies), Necrologium Scheftlariense (Freising Necrologies), Roglo, Euweb.cz, © 2008 Etienne Pattou Héraldique & Généalogie (alliance Montauban, branche de Saliceto), Cité et République Cité de Parme Cité de Sienne Lombardie- dernière mise à jour : 21/10/2019 "L'Entrée solennelle dans la ville de Lyon, de Monseigneur de Milan Vénétie sur http://racineshistoire.free.fr/LGN l'éminentissime Cardinal Flavio Chigi", 1664 1 Eriprando Milan + 1037 Origines Ottone + 1111 (Roma) Visconti visconte dell Arcivescovo di Milano ép. -

VISCONTI (I-II) Inkl De ROTARIIS (Aus Revigliasco D' Asti)
Nikolai Wandruszka: Un viaggio nel passato europeo – gli antenati del Marchese Antonio Amorini Bolognini (1767-1845) e sua moglie, la Contessa Marianna Ranuzzi (1771-1848) 2.8.2014, 6.10.2017, 30.1.2021, 4.4.2021 VISCONTI (I-II) inkl de ROTARIIS (aus Revigliasco d' Asti) XI.3455 Visconti Chiara, * (ex 1°)1, + post 1523, oo Pietro della Pusterla Signore di Frugarolo XII.6910 Visconti Galeazzo, * (ex 1°)2, + ca. 1530, oo (a) Antonia Mauruzi, figlia di Nicolò Conte della Stacciola (1440-1485), Patrizio di Tolentino, e di Lucia (1445-1510) dei Conti Palatini Castiglioni Signori di Garlasco, Tochter des Guarnerio C. u.d. Antonia Bussone; oo (b) Caterina de Masis, nobildonna francese. Consignore di Somma, Crenna e Agnadello e Patrizio Milanese; Consigliere ducale, Cavaliere dell’Ordine di Saint-Michel, feudatario di Castelnoceto, Valle e Busto dal 1506, feudatario di Piovera dal 1509 (investito nel 1530), Luogotenente delle truppe ducali nel 1515, ambasciatore francese a Venezia nel 1528 – ausführliche Biographie bei VOLPI, pp.256-264. XIII.13820 Visconti Guido, + Genova ca. 1478, oo (a) Eleonora, figlia di Princivalle de Rotariis, nobiluomo milanese bzw. “di Asti”; “am 8. Oktober 1421 verlieh ihm [dem Bernardo] Sigismund in Trentschin den Titel eines Familiars, zusammen mit Princivalus und Franciscus de Rotariis sowie Benedictus de Venturis aus Asti und Jacobus de Paganeli Aycante aus Pisa3; ein weiterer Familiare ist Bernhard, Sohn des Johannes de Rotariis aus Revigliasco (d'Asti)4; oo 1473 (b) Genova Leta Manfredi, figlia di Guidantonio Signore di Faenza e di Bianca Trinci dei Signori di Foligno (keine Kinder). Patrizio Milanese, Consignore di Somma, Crenna e Agnadello; armato Cavaliere dal Duca di Milano nel 1450, Coppiere della Duchessa di Milano, Commissario Generale di Novara nel 1462, Governatore di Genova nel 1466 e 1470, Commissario Generale di Alessandria e Citra Po nel 1467, giura fedeltà al Duca di Milano nel 1470, Governatore di Cremona nel 1473, Consigliere del Duca di Milano nel 1477. -

Ancora Sull'araldica Della Dominazione Francese Nel Ducato
ARCHIVES HÉRALDIQUES 2019 SUISSES SCHWEIZER ARCHIV FÜR HERALDIK ARCHIVIO ARALDICO SVIZZERO ARCHIVUM HERALDICUM SCHWEIZER ARCHIV FÜR HERALDIK – ARCHIVES HÉRALDIQUES SUISSES 2019 ARCHIVES HÉRALDIQUES SUISSES SCHWEIZER ARCHIV FÜR HERALDIK ARCHIVIO ARALDICO SVIZZERO ARCHIVUM HERALDICUM A° CXXXIII – 2019 Inhaltsverzeichnis – Sommaire – Sommario Hinweise – Avis 3 Aufsätze – Articles Horst Boxler: Die Aulendorfer Handschrift des Ulrich Richental zum Konstanzer Konzil und der familiäre Hintergrund ihres Auftraggebers 5 Aluis Maissen: Wappenfresken auf Schloss Salenegg – Die rhätischen Adelsgeschlechter 27 Hans Rüegg: Wappen mit Bezug zu Spitz- und Übernamen – Details zur Analyse der schweizerischen Kantons-, Bezirks- und Gemeindewappen 79 Michael Göbl: Von der Monarchie zur Republik – Die Veränderungen in den österreichischen Gemeindewappen 93 Josef Kunz: Pankraz Vorster – der letzte Fürstabt von St. Gallen – und seine Lebensjahre im Kloster Muri 103 Rolf Kälin: Wappengedenken Paracelsus zu Ehren an seiner Geburtsstätte 113 Michel Popoff: Officiers suisses au service des rois de France décorés de l’Ordre de Saint-Michel 1554–1665 123 Jean-Bernard de Vaivre: L’évolution de la figuration sculptée des armoiries du grand maître Pierre d’Aubusson (1476–1503) 133 Gianfranco Rocculi: Ancora sull’araldica della Dominazione Francese nel ducato di Milano 149 Miszellen – Miscellanées Ein Wappen für die neue Stadt Oberzent (Johannes Engels) 165 Gläserne Wappen – Vitraux héraldiques (Sarah Keller) 166 Ancora sull’araldica della Dominazione Francese nel ducato -
General Index
Cambridge University Press 978-0-521-26021-3 — Medieval European Coinage William R. Day, Jr , Michael Matzke , Andrea Saccocci , General editor Elina Screen Index More Information GENERAL INDEX Ordinary type indicates pages, bold type catalogue entries. The index covers mainly personal names and place names together with exceptional denomina- tions (e.g. pegione, bagattino, etc.) and references to speciic issues of individual mints. It does not cover more generic references to denominations such as denaro and grosso except where such terms are explained. Personal and place names are given in the forms and spellings used in the text, with cross-references where Latin or other forms diverge appreciably from these. Persons of the same name are placed in the customary sequence of saints, popes, emperors, sovereigns in alphabetical order of the states they ruled, and others in whatever order seems best adapted for easy reference. Names of modern scholars, and names in the section ‘Collectors, dealers and donors’ that precedes the main catalogue,have not been indexed.Coin hoards and inds are indexed in alphabetical order by ind type under the heading coin inds. Aachen (Germany), Peace (812), 627; renewal (840), 628 Adige, river and/or valley,65, 554, 606, 607, 618, 631, 653 Abati, lords, 101 administrative reforms, early tenth century,35; early Abbiategrasso (Lombardy), 484, 501 fourteenth century,80 Abundus or Abundius, saint, patron of Como, 84, 87, 365, Adolph of Nassau, king of Germany,3, 208 368, 369, 370, 710 Adorno, family,of Genoa, 298,