I Processi Di Formazione Degli Insediamenti
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Pubblicita' Ed Affissioni
COMUNE DI CAPALBIO (Provincia di Grosseto) Via G.Puccini,32 58011 Capalbio (GR) Tel . 0564897701 Fax 0564 897744 www.comune.capalbio.gr.it e-mail [email protected] STORIA DI CAPALBIO I Non si puo’ parlare della storia di Capalbio senza accennare al castello piu’ antico di Tricosto (oggi detto Capalbiaccio) di cui sono le rovine sul colle sito a Nord Ovest a due km dall’incrocio sulla S.S.Aurelia con accesso a Capalbio Scalo. Dall’alto del poggio e’ possibile abbracciare con un solo sguardo la Valle d’Oro. Esso ha all’incirca la forma di un triangolo, la cui base è rappresentata dai terreni impaludati che formano il prolungamento del lago di Burano verso Ansedonia, mentre i lati – piu’ o meno irregolari – sono costituiti da una serie di dolci rilievi collinosi che trovano il loro vertice in direzione del Monte Alzato. La Valle e’ oggi, e doveva essere anche in antico la pianura piu’ fertile dell’immediato retroterra della collina di Ansedonia. Allorquando (nel 273 a. C.) i romani fondarono su quella collina la colonia latina di Cosa, la Valle d’Oro entro’ a far parte del territorio della nuova citta’ e dovette essere divisa in piccoli lotti (probabilmente di un ettaro e mezzo di media) fra i primi coloni. L’indagine archeologica – tutt’ora in corso – ha rilevato tracce di insediamento deferibili al sistema di piccole fattorie unifamiliari che caratterizzo’ la proprieta’ e l’economia agricola del territorio per alcune generazioni fino a una data ancora imprecisata – ma da collocare certamente fra il II e la prima meta’ del I sec. -

La Viabilità in Provincia Di Grosseto Fra L’Età Romana E Il Medioevo
92 Guida agli edifici sacri della Maremma LA VIABILITÀ IN PROVINCIA DI GROSSETO FRA L’ETÀ ROMANA E IL MEDIOEVO Carlo Citter LA VIABILITÀ ROMANA L’area oggi delimitata dalla provincia di Grosseto fu attraversata da una fitta rete di strade costruite per lo più fra III e II secolo a.C., di cui le principali erano: l’Aurelia (Vetus e Nova e Aemilia Scauri) e, nel sovane- se, la Clodia. Le fonti documentarie per la ricostruzione della viabilità romana principale sono: la Cosmografia dell’Anonimo Ravennate, la Geografia di Guidone (che indicheremo da ora in poi rispettivamente AR e GG, edite in Schnetz a cura di, 1940); la Tabula Peutingeriana (da ora TP edita in Miller 1916) e l’Itinerarium Antonini Imperatoris (da ora IA in Cuntz 1929). Ai fini della ricostruzione della viabilità tardorepubblicana non pos- sono essere usate AR e GG che sono invece, rispettivamente, una fonte bizantina e del pieno Medioevo, che registrano le modifiche all’assetto tradizionale a seguito delle vicende belliche del VI secolo. La viabilità romana è stata oggetto di studi di diverso spessore scien- tifico, talora ai limiti della fantasia, più spesso del tutto privi di un ri- scontro topografico. È chiaro, infatti, che la sola ricostruzione ideale di tracciati, svincolata da ogni verifica sulla natura geografica dei territori che attraversavano, è comprensibile solo in assenza di un’archeologia del paesaggio. L’A URELIA Cominciamo con i tracciati dell’Aurelia. Ho già trattato altrove il pro- blema della sinossi delle proposte che la ricca letteratura sull’argomento offre e rimando senz’altro a quel contributo per tutti i dettagli. -

Vitozza: Un Insediamento Rupestre Nel Territorio Di Sorano
ROBERTO PARENTI VITOZZA: UN INSEDIAMENTO RUPESTRE NEL TERRITORIO DI SORANO Quaderni del Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti. Sezione archeologica Firenze - 1980 Ringraziamenti Il rilievo e lo studio del sito di Vitozza fa parte di una serie di ricerche sugli insediamenti rupestri, condotte e sviluppate da vari anni, nel quadro di un più generale interessamento per le sedi umane abbandonate della Toscana, dall'Insegnamento di Archeologia Medievale dell'Università di Siena, tenuto dal prof. Riccardo Francovich. I materiali ceramici raccolti a Vitozza sono stati studiati dal prof. Riccardo Francovich e dal dott. Sauro Gelichi, ai quali vanno i ringraziamenti per i chiarimenti avuti sul metodo di ricerca e sui problemi di datazione. Un primo risultato di questa ricerca è stato presentato al Convegno Internazionale “ Per una storia delle dimore rurali. Cuneo 8-9 dicembre 1979 ”, nella comunicazione collettiva: L'edilizia rurale minore della Toscana attraverso la documentazione materiale. Agli atti di tale Convegno, che saranno pubblicati da “ Archeologia Medievale ”, VII (1980), si rimanda per una più esauriente analisi del materiale ceramico. La pubblicazione è stata realizzata grazie all'interessamento e all'impegno, anche economico, delle Autorità Comunali di Sorano, e del Dipartimento Istruzione e Cultura della Regione Toscana, al fine di acquisire una conoscenza più approfondita per la salvaguardia dei Beni Architettonici e Ambientali del territorio. Desidero ringraziare per gli aiuti forniti, il sindaco, dott. Alberto Cerreti, i consiglieri comunali, particolarmente il dott. Angelo Biondi e il sig. Giorgo Nucci, i componenti l'Ufficio Tecnico e gli amici di san Quirico, Stefano Barzi e Renzo Rosati. BIBLIOGRAFIA AGOSTINI, G., LOPES PEGNA, M., 1971; Sorano nella storia e nell'arte, Firenze. -

Viva Xpress Logistics (Uk)
VIVA XPRESS LOGISTICS (UK) Tel : +44 1753 210 700 World Xpress Centre, Galleymead Road Fax : +44 1753 210 709 SL3 0EN Colnbrook, Berkshire E-mail : [email protected] UNITED KINGDOM Web : www.vxlnet.co.uk Selection ZONE FULL REPORT Filter : Sort : Group : Code Zone Description ZIP CODES From To Agent IT ITAOD04 IT- 3 Days (Ex LHR) Cities & Suburbs CIVITELLA CESI 01010 - 01010 CELLERE 01010 - 01010 AZIENDA ARCIONE 01010 - 01010 ARLENA DI CASTRO 01010 - 01010 FARNESE 01010 - 01010 LATERA 01010 - 01010 MONTEROMANO 01010 - 01010 ONANO 01010 - 01010 PESCIA ROMANA 01010 - 01010 PIANSANO 01010 - 01010 TESSENNANO 01010 - 01010 VEIANO 01010 - 01010 VILLA S GIOVANNI IN TUSC 01010 - 01010 MUSIGNANO 01011 - 01011 CELLENO 01020 - 01020 CHIA 01020 - 01020 CASTEL CELLESI 01020 - 01020 CASENUOVE 01020 - 01020 GRAFFIGNANO 01020 - 01020 LUBRIANO 01020 - 01020 MUGNANO 01020 - 01020 PROCENO 01020 - 01020 ROCCALVECCE 01020 - 01020 SAN MICHELE IN TEVERINA 01020 - 01020 SERMUGNANO 01020 - 01020 SIPICCIANO 01020 - 01020 TORRE ALFINA 01020 - 01020 TREVIGNANO 01020 - 01020 TREVINANO 01020 - 01020 VETRIOLO 01020 - 01020 ACQUAPENDENTE 01021 - 01021 CIVITA BAGNOREGIO 01022 - 01022 BAGNOREGIO 01022 - 01022 CASTIGLIONE IN TEVERINA 01024 - 01024 GROTTE SANTO STEFANO 01026 - 01026 MAGUGNANO 01026 - 01026 CASTEL S ELIA 01030 - 01030 CALCATA 01030 - 01030 BASSANO ROMANO 01030 - 01030 FALERIA 01030 - 01030 FABBRICA DI ROMA 01034 - 01034 COLLEMORESCO 02010 - 02010 COLLI SUL VELINO 02010 - 02010 CITTAREALE 02010 - 02010 CASTEL S ANGELO 02010 - 02010 CASTEL SANT'ANGELO 02010 -

Maremma a Guided Walking Adventure
ITALY Maremma A Guided Walking Adventure Table of Contents Daily Itinerary ........................................................................... 4 Tour Itinerary Overview .......................................................... 13 Tour Facts at a Glance ........................................................... 15 Traveling To and From Your Tour .......................................... 17 Information & Policies ............................................................ 20 Italy at a Glance ..................................................................... 21 Packing List ........................................................................... 26 800.464.9255 / countrywalkers.com 2 © 2016 Otago, LLC dba Country Walkers Travel Style This small-group Guided Walking Adventure offers an authentic travel experience, one that takes you away from the crowds and deep in to the fabric of local life. On it, you’ll enjoy 24/7 expert guides, premium accommodations, delicious meals, effortless transportation, and local wine or beer with dinner. Rest assured that every trip detail has been anticipated so you’re free to enjoy an adventure that exceeds your expectations. And, with our optional Flight + Tour Combo and Rome PrePre----tourtour Extension to complement this destination, we take care of all the travel to simplify the journey. Refer to the attached itinerary for more details. Overview Tuscany’s Maremma—a region of stunning land- and seascapes as well as historic riches—is a hidden treasure tucked along the Tyrrhenian coast -
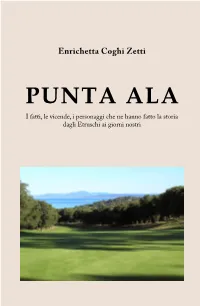
Comunità Di Punta
Enrichetta Coghi Zetti PUNTA ALA I fatti, le vicende, i personaggi che ne hanno fatto la storia dagli Etruschi ai giorni nostri 1 Enrichetta Coghi Zetti dalla provincia di Mantova, si stabilisce a Firenze nel 1955, dove ha vissuto fino alla fine del 2018. Iscritta all’Albo dei Giornalisti pubblicisti, ha collaborato in via continuativa con la RAI per il Gazzettino Toscano, con «Paese», «Paese Sera» e, occasionalmente, con altri quotidiani. Giunta a Punta Ala nell’estate del 1961 per un servizio giornalistico per conto di «Paese Sera», il 1° Febbraio 1962 accetta l’offerta della Punta Ala S.p.A. di restare con compiti di coordinamento vario e P.R. Può così vivere in prima persona tutte le vicende e gli avvenimenti progettuali, politici ed umani che hanno seguito la trasformazione di Punta Ala dalle sue origini agricole fino alla sua attuale realtà. Sposata con l’arch. Giancarlo Zetti, ha diviso il suo tempo fra le residenze di Punta Ala e Firenze. Enrichetta Coghi Zetti I fatti, le vicende, i personaggi che ne hanno fatto la storia Punta Ala dagli etruschi ai giorni nostri 1° edizione 1991 2° edizione 1998 Disegni Giancarlo Zetti Un ringraziamento a: Attilio Pernazza Franco Malatini Giulio Cavalsani Augusto Pini Francesco Ramazzotti INDICE pag. I. Castiglione della Pescaia 9 Il. I pirati 14 III. L'Arcipelago toscano 17 IV. Follonica 25 V. Piombino 27 VI. Punta Troia 33 VII. Lo Stato di Piombino 39 dagli ultimi Appiano ai Lorena VIII. La bonifica della Maremma 41 dal Granducato al Regno d'Italia IX. IX. Italo Balbo 55 X. -

Ambito 24 Costa Grossetana
QUADRO CONOSCITIVO Ambito n°24 COSTA GROSSETANA PROVINCE : Grosseto TERRITORI APPARTENENTI AI COMUNI : Castiglione della Pescaia, Grosseto, Magliano in Toscana, Orbetello, Scarlino OROGRAFIA La pianura costituisce la dominante morfologica, delimitata a sud dai Monti dell’Uccellina e a nord dai rilievi tra Castiglione della Pescaia e Punta Ala. La pianura di Grosseto è solcata dai canali costruiti per la bonifica, iniziata nel 1828 e terminata nel XX secolo. In estate la malaria costringeva la popolazione a trasferirsi in abitati situati più in alto. IDROGRAFIA L’area costituisce parte dei bacini dell’Ombrone (basso corso del fiume) e del Bruna, che drena le colline di Castiglione della Pescaia. INSEDIAMENTI Importanti zone archeologiche (Roselle e Vetulonia) e notevoli testimonianze storiche architettoniche sono diffuse su tutto il territorio con particolare riferimento al sistema difensivo delle torri costiere, alle architetture religiose (abbazie e monasteri), ai centri murati e alla città di Grosseto. RICCHEZZE STORICO -CULTURALI Grosseto è città medievale, originata da un castello sulla via Aurelia. Questa città ha ereditato le funzioni urbane di Rosaellae, “municipium”romano. Dopo il saccheggio effettuato dai saraceni nel 935, la sede della curia di Roselle veniva spostata a Grosseto, ma la modifica ebbe il riconoscimento ufficiale, da parte del papa Clemente III, solo nel 1138. Il territorio della curia era (ed è) quasi tutto in destra dell’Ombrone, e si estendeva a nord fino a Sassoforte (Monterotondo Marittimo) e Castel di Pari, a ponente fino a Capalbio, Scarlino e Gavorrano (compresi). Nel basso medioevo faceva capo a Grosseto una delle 5 contee in cui era divisa l’area attualmente della provincia: le altre in territorio oggi grossetano erano Populonia (Massa Marittima), Sovana, feudo aldobrandesco come Roselle, Ansedonia (poi Orbetello), feudo dell’Abbazia delle Tre Fontane di Roma, Agro Amiatino. -

Regione Toscana - Giunta Regionale Direzione Generale Competitivita’ Del Sistema Regionale E Sviluppo Delle Competenze
REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE AREA DI COORDINAMENTO SVILUPPO RURALE SETTORE SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE E DI VIGILANZA E CONTROLLO AGROFORESTAE . Relazione sul progetto esecutivo MiPAAF per la “ Realizzazione di due centri di moltiplicazione in Toscana ”, svolto nell’ambito del tavolo di filiera frutta in guscio – sezione castagne - (Anno di attività 2013) Premessa La descrizione delle attività che avverrà nei paragrafi successivi necessita di una opportuna premessa dettata dalla variazione sul programma di attività che questa Amministrazione ha presentato al MiPAAF e che è stata approvata con il successivo Decreto Direttoriale prot 16270 del 05/06/2013. Sostanzialmente nell’annata 2013 sono proseguite le introduzioni di Torymus sinensis in siti di rilascio idonei (attività cofinanziata in Toscana da fondi regionali con finanziamenti MiPAAF - Piano Castanicolo Nazionale – Progetto Bioinfocast ) e, relativamente alla realizzazione dei due centri di stoccaggio e moltiplicazione in Toscana in attesa del nulla osta alla variazione di Programma, sono stati consolidati gli accordi con le Associazioni castanicole. Ad esse verrà assegnato il finanziamento per attività di supporto tecnico organizzativo e di logistica che si sostanzierà nella raccolta, stoccaggio e mantenimento di galle di castagno dai siti nei quali si è riscontrato l’acclimatazione di Torymus sinensis. Il termine temporale per la realizzazione dei due Centri, inizialmente previsto per -

Maremma Grossetana
piano paesaggistico scheda d’ambito logo REGIONE TOSCANA livello d’ambito ambito 18 maremma grossetana Comuni di: Campagnatico (GR), Castiglione della Pescaia (GR), Cinigliano (GR), Civitella Paganico (GR), Grosseto (GR), Magliano in Toscana (GR), Scansano (GR). profilo dell’ambito 1. descrizione interpretativa 2. invarianti strutturali 3. interpretazione di sintesi 4. disciplina d’uso 5. informazioni relative al piano piano paesaggistico logo REGIONE TOSCANA livello d’ambito maremma grossetana Civitella Marittima Vetulonia Scansano Paganico Buriano Magliano Tirli Grosseto Alberese Castiglion della Pescaia Puntala Profilo dell’ambito 1 p. 3 maremma grossetana Profilo dell’ambito p. 4 piano paesaggistico logo REGIONE TOSCANA livello d’ambito maremma grossetana L’ambito Maremma grossetana si contraddistingue per un mosaico articolato di paesaggi generato dalla compresenza di ambienti di collina, di pianura e costieri. Ri- lievi di formazione geologica più antica (termine meridionale della Dorsale Medio-Toscana, Colline di Montepescali-Batignano, Monti dell’Uccellina) - dalla morfologia aspra e dominati da formazioni boschive (cerrete, leccete, macchia mediterranea, sugherete), rilievi più addolciti (nella restante parte collinare dell’ambito) - in cui il bosco si contrae a vantaggio di coltivi e pascoli, caratterizzano l’ampia compagine collinare. Il sistema insediativo della collina si struttura lungo la Valle del fiume Ombrone (borghi fortificati medievali, lo- calizzati in posizione strategica - sulla sommità o a mezza costa - e sviluppati lungo i percorsi collinari) e sulle Colline dell’Albegna (nuclei compatti medievali - rocche, edifici religiosi, castelli e borghi - arroccati sulle sommità dei versanti e lungo la viabilità di crinale). Qui i nuclei, spesso di impianto medievale - collocati in posizione dominante, dalla morfologia compatta, non di rado murati (Pereta, Magliano, Montiano, Pari, Casale di Pari, Cinigiano, Civitella Marittima, Sasso d’Ombrone, Campagnatico, Batignano), hanno visto salvaguardati i rapporti originari con l’intorno coltivato. -

Toscana Urlaub 2017
Toscana Urlaub 2017 Hier steckt Ihr Urlaub drin! URLAUB MIT IHREM HAUSTIER, BEI UNS KEIN PROBLEM!!! Toscana erleben - Urlaub für die Sinne DIE MIT ZYPRESSEN, PINIEN UND SONNENBLUMEN BEWACHSENEN HÜGELLANDSCHAFTEN SIND EINZIGARTIG. STÄDTE, WIE PISA, FLORENZ, SIENA UND LUCCA SIND WELT BE RÜHMT UND BIETEN KUNSTSCHÄTZE, DIE ZUM WELTKULTUR ERBE GEZÄHLT WERDEN. GESCHICHTE AUF SCHRITT UND TRITT, THERMAL-FREI BÄDER MITTEN IN DER NATUR, ÜBERALL DIESES MEDITERRA- NE FLAIR... UND DAS MEER IST MEIST NICHT WEIT. FREUEN SIE SICH AUF DIE KÖSTLICHEN SPEZIALITÄTEN UND DIE EDLEN TROPFEN – DIE TOSCANISCHE KÜCHE IST BE RÜHMT. DIE NÄHE ZUR NATUR SPIEGELT SICH AUCH IN DEN FREI ZEITMÖGLICH KEITEN WIEDER: WANDER- UND RAD TOUR EN, REITEN, TEILNAHME AN DER WEIN- UND OLIVEN ERNTE ODER PILZE- UND TRÜFFELSAMMELN. CHARAKTERISTISCH FÜR DAS LANDESINNERE SIND DIE HISTORISCHEN LAND GÜTER, ALTEN MÜHLEN, TRADITIONSREI- CHEN WEIN GÜTER, IDYLLISCHEN LANDHÄUSER UND STILVOLLEN VILLEN, DIE, LIEBEVOLL RESTAURIERT UND ORIGI- NELL EINGERICHTET WURDEN, HEUTE AN FERIENGÄSTE VERMIETET WERDEN. So erfahren Sie die Toscana hautnah. 2 LIEBE GÄSTE, LIEBE TOSCANAFREUNDE, der Inhalt dieses Katalogs gibt den Stand vom November 2016 mit den Preisen für die Saison 2017 wieder. Wir senden Ihnen auf Wunsch gerne auch Fotos zu den einzelnen Ferien do mizilen. Zusammen mit Freunden vermittle ich eine große Aus wahl an Ferienhäusern und Wohnungen, bei deren Aus wahl wir besonderen Wert darauf ge legt haben, für alle „Geschmacks rich tungen“ und Bedürfnisse etwas anzubieten. Ich bin mir sicher, dass auch für Sie etwas dabei sein wird. „Meine“ Feriendomizile kenne ich bis auf wenige Aus nah men alle persönlich. Fast jedes Haus habe ich schon mindestens einmal besichtigt. -

Il Territorio Di Roselle-Grosseto: Occupazione Del Suolo E Forme Insediative Dalla Preistoria Al Medioevo*
Carlo Citter 25 Il territorio di Roselle-Grosseto: occupazione del suolo e forme insediative dalla preistoria al medioevo* Il metodo adottato nella ricognizione di super - ma di ottimizzare il prodotto finale riducendo la f i c i e . superficie da indagare pur senza perdere in fatto La domanda storiografica primaria di questa di rappresentativtà. La scelta è stata per un’area a ricerca è capire la dinamica del popolamento forma di rettangolo di 11 x 22 km 2 che pone al suo nell’area circostante i due centri dominanti (Rosel- centro la città di Roselle, indagato per campioni. le e Grosseto) con particolare attenzione al periodo La scelta dei campioni sul terreno ha tenuto conto che va dalla tarda antichità al pieno medioevo, dei principali fattori che possono aver influenzato cioè i secoli in cui maturano le condizioni del “pas- la natura e la disposizione dell’insediamento3 ed in saggio di consegne” fra la città etrusca e la città particolare: moderna. 1) la formazione geologica del suolo4. I suoli La seconda questione in ordine di importanza è dell’era secondaria sono rappresentati in misura selezionare l’area da sottoporre ad indagine1. La del 21,9 % e sono concentrati nelle colline a nord di particolare situazione di questo territorio elimina Roselle, quelli relativi all’era terziaria costituisco- totalmente il problema posto per altri comprenso- no il 36,5 % e formano i due gruppi collinari che si ri: infatti la bassa valle dell’Ombrone, con i due affacciano sulla vallata dell’Ombrone (Roselle- spartiacque meridionale e settentrionale, costitui- Moscona-Montebrandoli e Poggio Cavolo). -

Ref: 0688 €3.400.000,00
Ref: 0688 Roccamare villa for sale near the beach €3.400.000,00 www.villecasalirealestate.com/en/property/688/Roccamare-villa-for-sale-near-the-beach Area Municipality Province Region Nation Arcipelago toscano Castiglione della Pescaia Grosseto Tuscany Italy Building Surface: Land Surface: Energetic class Status Agency 380Mq 5.000Mq Habitable Ville Casali Real Estate DESCRIPTION Villa for sale in Roccamare in Castiglione della Pescaia in the province of Grosseto on the Tuscan coast The property for sale is located in the famous and uncontaminated pine forest of Roccamare, just 3 km from the center of Castiglione della Pescaia, where there is also the municipality and all services for vacationers and people residing throughout the year . The villa boasts a strategic position near the sea with 2 gazebos and 2 beach huts. Roccamare is an area of luxury villas, guarded all year round thanks to the presence of the staff of the Roccamare staff who rotate in turn to provide a 24-hour service. The sea in this stretch of coast is particularly clean and transparent and the sandy beach is golden and well preserved by the Pineta di Roccamare consortium. The property is typical of the buildings of Roccamare and is a large well distributed villa surrounded by 5,000 square meters of garden. The villa measures 380 square meters. approximately and consists of a main body, arranged on a single level, consisting of an entrance hall into a double living room, with a dining area and sofa area, with a fireplace. The hall leads to the external porches, equipped with BBQ and several areas to eat outside with tables and chairs.