Percorso Tra Archeologia E Storia Nell'ecomuseo Delle Dolomiti
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
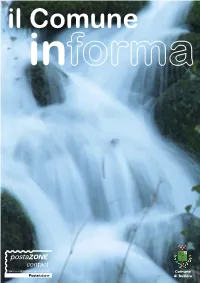
Il Comune In
il Comune in Comune di Budoia BILANCIO DI PREVISIONE 2013 Come diretta conseguenza dell’imposizione devono essere applicati interamente del Patto di stabilità a tutti i Comuni con in conto capitale, l’avanzo non può popolazione superiore ai 1000 abitanti (art. essere utilizzato per non allontanare 14, L.R. 27/2012), quest’anno il bilancio il Bilancio dall’obiettivo del Patto e il di previsione è stato approvato molto tardi trasferimento ordinario della Regione è (Delibera Consigliare n.18 del 22 luglio stato ridotto del 10%. L’obiettivo primario 2013). Una della implicazioni principali dell’Amministrazione è quello di continuare dell’applicazione del Patto è data dalla a garantire i servizi essenziali senza gravare necessità di pareggiare il flusso di cassa ulteriormente sui cittadini già provati dalla per la parte degli investimenti: ne deriva persistente crisi economica, cercando di che possono essere finanziate opere solo ottimizzare ulteriormente le spese correnti. a fronte di un’entrata in conto capitale nell’anno, mentre restano in sospeso gli Sul fronte delle imposte e delle tasse le investimenti finanziati da avanzo o da maggiori novità riguardano l’IMU e la TARES. contributi assegnati in conto interessi. Il Anche per il 2013 l’Amministrazione ha conseguimento del pareggio della parte scelto di mantenere l’aliquota base sia per corrente è stato particolarmente difficile l’imposta sulla prima casa (0,4%), sia per per la concomitanza di tre fattori: il l’imposta sulla seconda casa (0,76%). Il progetto S-fidiamoci è stato promosso dai Comuni di Aviano, Fontanafredda, Sacile, finanziamento del BIM e gli oneri Bucalossi La TARES è l’imposta che dal 2013 sostituisce Budoia e Polcenigo. -

Esercizio Prog. Sogg.Cognome Nome Cod
ESERCIZIO PROG. SOGG.COGNOME NOME COD. FISC. P. IVA INDIRIZZO CAP LOCALITA DESC. COMUNE SIOPE DESC. SIOPE IMPORTO 2016 20 FERROLI & C. SRL 290660935 IT 00290660935 VIA ROMA 6 33090 TRAMONTI DI SOTTO 2116 Altri beni immobili 10797 2016 33 SINA AUTO SPA 218470938 IT 00218470938 VIA PONTE ROITERO 1 33097 1332 Altre spese per servizi 394,02 2016 36 TECNO TRE SAS DI MARTIN E. & D'INNOCENTE D. 367340932 IT 00367340932 VIA MILAREDO, 2/B 33097 SPILIMBERGO 1329 Assistenza informatica e manutenzione software 706,77 2016 36 TECNO TRE SAS DI MARTIN E. & D'INNOCENTE D. 367340932 IT 00367340932 VIA MILAREDO, 2/B 33097 SPILIMBERGO 2116 Altri beni immobili 2989 2016 43 VERONA ELIGIO & C. SNC 801500307 IT 00801500307 LOCALITA' POLVARIES 33030 1306 Altri contratti di servizio 219,34 2016 44 PARROCCHIA S. MARIA MAGGIORE, S. ANTONIO AB., E S. NICOLO' VESCOVO 90002850932 IT 90002850932 VIA ROMA, 5 33090 1210 Altri materiali di consumo 400 2016 44 PARROCCHIA S. MARIA MAGGIORE, S. ANTONIO AB., E S. NICOLO' VESCOVO 90002850932 IT 90002850932 VIA ROMA, 5 33090 1583 Trasferimenti correnti ad altri 250 2016 63 PRO LOCO VALTRAMONTINA 247020936 IT 00247020936 VIA MEDUNO, 3 33090 1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 1000 2016 63 PRO LOCO VALTRAMONTINA 247020936 IT 00247020936 VIA MEDUNO, 3 33090 1583 Trasferimenti correnti ad altri 3250 2016 78 POLISPORTIVA VALTRAMONTINA 90000350935 IT 01198730937 LOC.TA' MATAN, 1 33090 TRAMONTI DI SOTTO 1210 Altri materiali di consumo 6500 2016 78 POLISPORTIVA VALTRAMONTINA 90000350935 IT 01198730937 LOC.TA' MATAN, -

A EMIGRAÇÃO DE FRIULI VENEZIA GIULIA PARA O BRASIL Javier Grossutti As Primeiras Notícias Relativas À Possibilidade, Para Os
A EMIGRAÇÃO DE FRIULI VENEZIA GIULIA PARA O BRASIL Javier Grossutti As primeiras notícias relativas à possibilidade, para os habitantes da atual região de Friuli Venezia Giulia, de alcançar como emigrantes as terras do interior do Brasil remontam a 1872. Em 8 de junho daquele ano, em fato, o Cônsul Geral do Brasil em Trieste Barão Mario de Morpurgo enviou ao excelentíssimo Governo Regente Imperial Marítimo da cidade giuliana alguns exemplares e relativas traduções do contrato subscrito em 31 de janeiro do mesmo ano em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, de Jeronymo Martiniano Figueira de Mello, presidente da província de São Pedro do Rio Grande do Sul e de Caetano Pinto & Irmão e Holtzweissig & Cia para a introdução de quarenta mil colonos no intervalo de dez anos [1]. Na carta que acompanha a cópia do contrato, o Cônsul Geral pede de tornar o acordo “de publicidade para ciência e conhecimento à quem possa interessar tais estipulações por parte daquele governo [brasileiro] para não ser eventualmente enganado por contratuários ou os seus encarregados”. Segundo o artigo primeiro do acordo, de fato, Caetano Pinto & Irmão e Holtzweissig & Cia. “se obrigam a introduzir naquela província [São Pedro do Rio Grande do Sul], no espaço de dez anos, até um número de quarenta mil colonos, distribuídos em famílias, de bons costumes, em perfeita saúde, jamais menores de dois anos e nem maiores de quarenta e cinco anos, exceto no caso de pai de família”. Os colonos, adiciona o contrato, “serão de três classes: operários, diaristas, e agricultores. Os colonos não agricultores não poderão exceder um número de dez porcento do total”. -

Distintivo D'oro
Distintivo d'oro donazioni: 50 per gli uomini e 40 per le donne FABRIS MONICA DEL SAVIO MENEGOZ FAGARO CESCUT NATALINO ARZENE OSVALDO ALDO AVIANO AVIANO AVIANO FORNASIER ELISABETTA AZ.RAUSCEDO BISUTTI DANIELA MALUTA SANDRO MARTINUZZO AZ. RAUSCEDO BRUGNERA FRANCESCO BRUGNERA ZAMAI AMBROGIO BRUGNERA DORIGO FABIO ZAMBON PIETRO POSOCCO RENATO BUDOIA CANEVA CANEVA ZANETTE CLAUDIO CANEVA PAGOTTO GIORGIO COMUZZI DIEGO ZANUSSO CLAUDIO CANEVA CANEVA CANEVA DAL MAS PIETRO SVETINA MARCO CANEVA DANDOLO PIFFARETTI ANTONIO CESCA ITALO CANEVA CASTELNOVO BOCUS SILVANA DARDAGO ROSSETTO DANIELA FANNA MARTINI ROMEO GRI BARBARA DOMANINS DOMANINS ANTONEL MARIO PIAZZA ENNIO DE GIUSTI RINO VENUTI ELDA MARON MARON MANIAGO MARON LUCCO ROBERTO PINZANO-VALERIANO MORO LUIGI FOGLI GIUSEPPE RIGO NELLI MONTEREALE POLCENIGO SACILE COLOMBERA GORGAZZI ITALO GIUSEPPE SACILE SACILE MARTINUZZI NADAL NATALINA SILVANO SACILE SACILE ROTA PATRICK MAGRI ALTEO ORLANDO FABIO ORLANDO IVAN SAN GIORGIO R. SAN GIORGIO R. SAN GIORGIO R. SAN GIORGIO R. BERTOIA FABIO SAN LORENZO D’ANDREA PAOLO TECCOLO ROBERTO SALVADOR ERIKA SAN MARTINO T. SAN MARTINO T. SAN MARTINO T. GATTEL GIANNI GALIAZZO CLAUDIO TOLDO CIPRIANO BAZZO GIORDANO SAN MICHELE R. SAN MICHELE R. SAN ODORICO SAN ODORICO TOPPAN MAURO NATALE SPILIMBERGO D’INNOCENTE DARIO ZANINI PIERLUIGI DI MEO NATASCIA SPILIMBERGO SPILIMBERGO SPILIMBERGO DE PELLEGRIN LORIS CATARUZZA DISMO LUCCHESE GIUSEPPE MAZZOLENI SAN QUIRINO SAN QUIRINO TAMAI AMERICO TAMAI PIETRAFESA CORONA FELICE LEONARDO VAJONT VAJONT PEGOLO GIANPAOLO TONELLO PAOLO TAMAI TRAVESIO COMISSO SILVIA GRI BARBARA SALVADORI GIOVANNI VIVARO CATTELAN EDY VALVASONE VALVASONE VIVARO . -

Anno 2008 Dicembre
dal campanile di Azzano Decimo Bollettino Parrocchiale di Azzano Decimo (PN) Italia Dicembre 2008 DON GIANFRANCO FURLAN Un dono per la comunità Don Gianfranco Furlan è arrivato tra i destinatari di un atteggiamento di di noi in una mite giornata settembrina, sponibilità e di servizio, da lui peraltro in coincidenza con l'ingresso nella sta espresso intensamente. Lo accoglie gione autunnale. Ma per la nostra co va con gratitudine una comunità che munità cristiana il dono del suo mini dopo la scomparsa contemporanea di stero sacerdotale e della sua giovi don Raffaello e di don Heider e, anni nezza ha segnato l'inizio di un tempo prima, dell'indimenticato mons. Cado primaverile ricco di speranza e di at re, era maturata nella consapevolez tese: sentimenti espressi dal profondo za della preziosità del sacerdozio. I nella gioia del primo incontro, lo scor pensieri reciprocamente offerti per la so 21 settembre. Don Gianfranco: un circostanza non racchiudevano usua- sacerdote tra noi e per noi, per tutta la continua a pag 3 parrocchia, in particolare per il mondo giovanile che atten deva la benedizione di una nuova figura sacerdotale da quando la scomparsa di don Raffaello aveva lasciato la sofferenza di un posto avvolto dal silenzio; un collaboratore deside rato e accolto con tanta gratitudine da don Dino che nel volgere di un lungo anno aveva guidato da solo la nostra comunità di novemila ani me. Un dono di Dio, quale forse non speravamo, che nella chiesa gre mita, in cui erano convenuti una moltitudine di fedeli e i rappresentanti dei gruppi e delle associazioni operanti in parrocchia, abbiamo salu tato con un grande abbraccio accogliente. -

Andrea Babolin
Curriculum Vitae ANDREA BABOLIN INFORMAZIONI PERSONALI ANDREA BABOLIN Via Bertossi, 9 – 33170 Pordenone (PN) 0434 392426 [email protected] Nome Skype: Servizio Viabilità PN Sesso M | Nazionalità Italiana ESPERIENZA PROFESSIONALE da maggio 2020 ad oggi Dipendente della P.A. Comune di Pordenone - Corso Vittorio Emanuele II, 64 – 33170 Pordenone (PN) ▪ Funzionario U.O.S. Ufficio Viabilità Attività o settore Gestione Patrimonio Viario dell’Ente da gennaio 2019 a aprile 2020 Dipendente della P.A. Comune di Polcenigo – Piazza Plebiscito, 1 – 33080 Polcenigo (PN) ▪ Istruttore tecnico Ufficio Manutenzioni Attività o settore Manutenzione ordinaria e straordinaria di beni mobili e immobili dell’Ente da marzo 2017 a dicembre 2018 Dipendente di Tempor S.p.A. per il Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia – Trieste) ed il raccordo Villesse – Gorizia Tempor S.p.A. Via del Gelso, 44 - 33100 Udine UD – www.tempor.it ▪ Assistente alla Direzione Lavori presso il cantiere Terza corsia A4 – III Lotto Alvisopoli-Gonars Attività o settore Opere pubbliche in Regione Friuli Venezia Giulia da settembre 2014 a dicembre Dipendente di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. 2016 Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste – www.fvgstrade.it ▪ Progettazione, Direzione Lavori e assistenza al RUP di infrastrutture strade pubbliche Attività o settore Ordinaria e straordinaria manutenzione delle strade della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia da gennaio 2014 ad agosto 2014 -

Disponibilità Supplenze I Grado
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Ufficio VI - Ambito territoriale per la Provincia di Pordenone Disponibilità per assunzioni a tempo determinato Scuole second. I grado a.s. 2014-15 A043 – ITAL.STORIA.ED.CIVICA GRADUATORIA ESAURITA Cattedre Ist. Scol. 1/C S.M.BRUGNERA 14/Co S.M. CHIONS + 4 S.M. PRAVISDOMINI 1/C S.M.PRAVISDOMINI 12/Co S.M. CORDOVADO + 6 S.M. SESTO 10/Co S.M.FIUME VENETO 8 S.M. ZOPPOLA 1/C S.M.MANIAGO A 1/C S.M.MANIAGO 12/Co S.M. MONTEREALE + 6 S.M. VIVARO A 1/C S.M. CLAUT A 12/Co S.M. PN RORAI + 6 PN CENTRO 14/Co S.M. ROVEREDO + 4 S.M. CORDENONS 1/C S.M. SACILE 1/C S.M. S. VITO AL TAGL. 1/C S.M. TRAVESIO 1/C S.M. ZOPPOLA ORE RESIDUE 9 ore S.M. AVIANO 17 ore S.M. AZZANO 9 ore S.M. MORSANO 7 ore S.M. FONTANAFREDDA 9 ore S.M. MEDUNO 12 ore S.M. PASIANO 11 ore S.M.PN SUD 9 ore S.M. PRATA 8 ore S.M. SACILE 9 ore S.M. VALVASONE 15 ore S.M. ZOPPOLA A059 –MATEM. E SCIENZE GRADUATORIA ESAURITA 1/C S.M. AVIANO A 1/C S.M. AVIANO A 1/C S.M. AZZANO A 1/C S.M. BRUGNERA A 1/C S.M. BRUGNERA A 1/C S.M. CANEVA A 1/C S.M. CANEVA A 12/Co S.M. POLCENIGO + 6 S.M. -

Numero Ente Descrizione Edificio Indirizzo Contributo
INDAGINI-SOLAI-FRIULI-VENEZIA-GIULIA.xlsx PORDENONE INDAGINI STATICHE - RIPARTO MINISTERIALE 10.12.2015 - PROVINCIA PORDENONE Numero Ente Descrizione Edificio Indirizzo Contributo 1 Comune di BRUGNERA Scuola elementare "N. Sauro" di Brugnera Brugnera - via SS. Trinità 41 € 7.000,00 2 Comune di PORCIA Scuola primaria di Palse G. Marconi VIA SAN MARTINO, 2/A € 2.300,00 3 Comune di PORCIA SCUOLA PRIMARIA DI RORAIPICCOLO VIA VITTORINO DA FELTRE, 1 € 2.300,00 4 Comune di MONTEREALE VALCELLINA SCUOLA MEDIA "GIOVANNI XXXIII" Via STAZIONE,32 MONTEREALE VALCELLINA (PN) € 3.105,00 5 Comune di BRUGNERA Scuola elementare "I.Santarossa" di Maron di Brugnera maron di brugnera piazza della Vittoria 15 € 7.000,00 6 Comune di BRUGNERA Scuola secondaria di primo grado "A. Canova" di Brugnera Brugnera via G. Galilei 5 € 7.000,00 7 Provincia di PORDENONE I.S.I.S. "L. ZANUSSI" Via VIA MOLINARI,46/A PORDENONE (PN) € 6.000,00 8 Comune di CANEVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E. FERMI VIA MARCONI, 77, CANEVA € 4.000,00 9 Comune di PRATA DI PORDENONE SCUOLA PRIMARIA "G. E. L. BRUNETTA" Via SAN SIMONE,8 PRATA DI PORDENONE (PN) € 735,00 10 Comune di PRATA DI PORDENONE SCUOLA MEDIA "G. UNGARETTI" Via MARTIRI DELLA LIBERTA,32 PRATA DI PORDENONE (PN) € 1.870,00 11 Comune di PRATA DI PORDENONE SCUOLA PRIMARIA "R. SERRA" Via MONDE,2 PRATA DI PORDENONE (PN) € 460,00 Comune di SAN VITO AL 12 "DE AMICIS" VIA MADONNA € 3.638,30 TAGLIAMENTO Comune di SAN VITO AL 13 "A.L.MORO" PIAZZALE GIRONE € 6.999,00 TAGLIAMENTO 14 Provincia di PORDENONE LICEO "G. -

Legenda 245 392 242
2350000 2351000 2352000 2353000 2354000 2355000 2356000 2357000 2358000 2359000 Cavasso Nuovo Travesio Castelnovo del Friuli ¡ Fanna ! Pinzano al Tagliamento Sequals Arba Meduno Maniago 5117000 5117000 Spilimbergo Vivaro S. R. 552 240 Castelnovo del Friuli Travesio Legenda 245 392 242 300 Cavasso Nuovo Confini amministrativi Confine comunale Sequals Solimbergo 300 Altri limiti comunali 241 361 200 247 COL PALOTTA 230 5116000 5116000 Individuazione delle aziende agricole S. P. 33 276 Iõ Aziende agricole 241 C.Paludo Classe acustica aggregata delle unità territoriali 239 319 194 192 304 Classe I Castello Canale Classe II Classe III COL PALIS 187 S.Antonio Classe IV 300 Collettore 192 Classe V Azienda Agricola 377 200 192 Casarotto Zona di interesse militare (non classificabile) 5115000 5115000 173 S. P. 22 190 Sequals 208 Molino Vecchio 205 Ancona da Fasce di decadimento acustico Vies 186 Pinzano al Tagliamento Bonifica 186 256 Fascia di decadimento acustico di classe II Sequals IL COLLE 195 S.Zenone Lestans Ancona Cantando Infrastrutture di trasporto 209 Stalla della Costa 349 186 Strada Regionale 204 208 Strada Provinciale Font.na della Povra C.Picchiutto 188 217 S. Matteo 192 Altre strade V.la Odorico S. P. 34 182 206 178 182 5114000 5114000 S.Giuseppe 214 S.Antonio 217 176 185 Il Capitel Mad.a della Maseres Ten.ta Emonia 197 199 177 S. R. 464 Azienda Agr.la Ancona di 175 211 170 170 la Madonnina Gamberel S.Urbano 190 173 Ancona di Giai 201 173 172 5113000 180 5113000 Fattoria 191 169 203 Progresso Arba 200 187 200 Azienda Agr.la Lis Gravis Sistema di riferimento: Gauss-Boaga fuso est - Base cartografica: Carta Tecnica Regionale al 1:25.000 193 193 REGIONE FRIULI - VENEZIA GIULIA PROVINCIA DI PORDENONE COMUNE DI SEQUALS 185 5112000 5112000 195 192 Azienda Agr.la 183 la Ghiaia 183 S. -

Avviso Art.11 E 16
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE Servizi Tecnici OGGETTO: Lavori di “Completamento 1° ANELLO CICLABILE con interventi nei Comuni di Andreis, Barcis, Frisanco, Meduno, Maniago e Montereale Valcellina”. AVVISO DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione pubblica utilità dell’opera (ai sensi dell’art. 11, commi 1 e 2 e dell’art. 16, commi 4, 5 e 8, del D.P.R. 08/06/2001 n. 327) IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI Visto il progetto definitivo relativo ai lavori di “Completamento del 1° anello ciclabile con interventi nei Comuni di Andreis, Barcis, Frisanco, Meduno, Maniago e Montereale Valcellina”; Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, commi 1 e 2 e dell’art. 16 commi 4, 5 e 8 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 7 e 8 della L.241/1990 e ss.mm.ii., l’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane, nella sua qualità di Autorità espropriante, A V V I S A che viene dato avvio al procedimento diretto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, all’approvazione del progetto definitivo equivalente a pubblica utilità dell’opera di cui all’oggetto, per la cui realizzazione si rende necessario l’esproprio e/o l’occupazione temporanea dei terreni di seguito elencati. Comune di Maniago : 1)CORRADINI EDDA prop.1/1: foglio 27 part.392 da espropriare per mq.28 e occupare per mq.60, foglio 27 part. 4 da espropriare per mq.112 e occupare per mq.78. -

AS 2018/2019 N. Cognome Nome 1 AKRAM HASSAN 2 ALDRIDGE
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO “PADRE DAVID MARIA TUROLDO” - Via Stazione n. 32 cap. 33086 Montereale Valcellina (Pn) Codice fiscale 81005490933 - Tel. n. 0427/79034 - Fax n. 0427/79067 E-mail [email protected] - [email protected] Comuni di Andreis – Barcis – Cimolais – Claut – Erto Casso – Montereale Valcellina – Vajont SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI MONTEREALE VALCELLINA 1^A – TEMPO NORMALE – A.S. 2018/2019 N. Cognome nome 1 AKRAM HASSAN 2 ALDRIDGE CALEB JAMES 3 ALZETTA ARIANNA 4 ALZETTA NIRVANA 5 BIASUTTI PAOLA 6 CASSAN MAGGIE 7 D’AGOSTINO NATASHA 8 DE LORENZI MARCO 9 FRANCESCON LINDA 10 GUSTAPANE IVAN 11 MATTIOZ EMILY 12 MATTIOZ EVELYN 13 MIGHIU ANDRA 14 PADOVAN FILIPPO 15 PAIER SIMONE 16 PARTENIO SIRIA 17 PROTTI MICHELA 18 TOFFOLO VIOLA 19 VENIER VALENTINA IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Carla FABBRO Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2°, D Lgs 39/93 ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO “PADRE DAVID MARIA TUROLDO” - Via Stazione n. 32 cap. 33086 Montereale Valcellina (Pn) Codice fiscale 81005490933 - Tel. n. 0427/79034 - Fax n. 0427/79067 E-mail [email protected] - [email protected] Comuni di Andreis – Barcis – Cimolais – Claut – Erto Casso – Montereale Valcellina – Vajont SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI MONTEREALE VALCELLINA 1^B TEMPO PROLUNGATO– A.S. 2018/2019 N. Cognome nome 1 AMEDODZIE MALCON KEWEL 2 BERTAGNO FILIPPO 3 BERTOIA VERONICA 4 BORGHESE GIULIA 5 CLAUT ELIA 6 DE LORENZI MORGAN 7 DELLA VECCHIA SWAMI 8 FABBRO ENRICO 9 FILIPPUTTI NOEMI 10 MAGRIS ANDREA 11 MANARIN EVA 12 MARCHIORI VALENTINA 13 MEHTA ANMOL 14 MEZZAROBBA GRETA 15 NGUEMEN FEUKEU SOFIA CHRISTY 16 PIANTA ANGELA 17 PIRAS LINDA 18 ROCCO CARMEN 19 SAHLI MANAR 20 TODESCO FILIPPO 21 VERRONE MATTEO IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Carla FABBRO Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. -

PN) Gg N ° 12 Gg
gg n° 12 progetto grafico: Servizi Editoriali srl - stampa: Areagrafica - Meduno (PN) gg 3 Il saluto del Sindaco are concittadine e concittadini, come consuetudine vi inviamo Quest’ultima opera ha sicuramen- nelle Vostre case la pubblicazione estiva di Qui Roveredo, che te creato alcuni disagi ai residen- Criporta le attività della nostra Comunità, molto numerose in ti, ma si rendeva necessaria per questi primi sei mesi. Su tutte, la celebrazione del 150° anniversario la sicurezza degli stessi. dell’Unità d’Italia che ci ha permesso di condividere le ragioni di quel- Seguiranno altre sistemazioni l’unità ed indivisibilità come fonte di coesione sociale e come base varie, anche in conseguenza alle essenziale del nostro futuro. In quell’occasione ci siamo ritrovati in modifiche che verranno apporta- piazza presso il Monumento per ricordare i caduti e poi nel Palazzetto te al percorso dell’autobus che (oltre 800 roveredani presenti) per l’esibizione dei nostri gruppi popo- raddoppierà le fermate in pae- lari: l’Artugna, il Coro Gialuth e la Filarmonica, che ringraziamo anche se e quindi migliorerà il servizio, in particola- in questa occasione per aver onorato al meglio l’impegno. re per gli studenti ed i lavoratori. La video sorveglianza entrerà defi- Diversi gli impegni culturali e sportivi che potrete scorrere nelle nitivamente in funzione dopo l’approvazione del relativo regolamento pagine seguenti e, tra questi, mi permetto di ricordare la prima da parte del Consiglio Comunale, convocato per metà luglio. volta di Pordenone Pensa a Roveredo, con la presenza della nota Anche in questa pubblicazione ritroverete i Servizi alla Persona che psicoterapeuta Maria Rita Parsi che ha tenuto incollate per alcune fanno capo al Comune e che possono essere richiesti in questo mo- ore nell’auditorium comunale oltre 300 persone analizzando le pro- mento di difficoltà generale.