Fausto Bertinotti – Andrea Ricciardi
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Il Parlamento E L'evoluzione Degli Strumenti Della Legislazione
Tavola rotonda su IL PARLAMENTO E L’EVOLUZIONE DEGLI STRUMENTI DELLA LEGISLAZIONE promossa dal Comitato per la legislazione in conclusione del secondo ciclo di Presidenza 12 gennaio 2010 Sala della Lupa Camera dei deputati Roma La tavola rotonda, promossa dal Comitato per la legislazione a conclusione del secondo ciclo di presidenza, riunisce personalità politiche che rivestono, o hanno rivestito, diverse posizioni di responsabilità nello svolgimento del processo legislativo. La tavola rotonda pone al centro della riflessione il ruolo fondamentale del Presidente di Assemblea, nell’esperienza dei presidenti della Camera dei deputati che si sono succeduti nelle ultime quattro legislature e che hanno tutti dovuto far fronte a rilevanti difficoltà nel procedimento legislativo. Nelle stesse quattro legislature il Comitato per la legislazione, istituito nel gennaio 1998, ha operato a supporto di tale impegnativa funzione presidenziale, svolgendo i suoi compiti di vigilanza sulla qualità dei testi legislativi, con particolare riferimento alle forme prevalenti di legislazione (deleghe e decreti legge). Presso entrambe le Camere, le Commissioni Affari costituzionali svolgono anch’esse un delicato ruolo di controllo con riferimento agli aspetti di costituzionalità, che investe non solo i contenuti ma anche le procedure e il sistema delle competenze. Inoltre, le due Commissioni sono al centro dei processi di riforma costituzionale. Sul versante governativo, il Ministro per i rapporti con il Parlamento svolge un ruolo altrettanto complesso nel misurarsi con le difficoltà del processo legislativo collegando un doppio fronte: l’insieme dei rapporti interni al Governo e quello con i diversi organi parlamentari in entrambe le Camere. Come base della discussione si offrono le analisi delle tendenze della legislazione elaborate di recente nell’ambito del Comitato: la “nota di sintesi” del Rapporto sulla legislazione 2009, edito dalla Camera dei deputati, e “Tendenze e problemi della decretazione d’urgenza”, presentato al Comitato per la legislazione il 12 novembre 2009. -

La Rivista Del Manifesto
la rivista del manifesto We publish below the article with which Lucio Magri, the editor of La Rivista del Manifesto, announced the suspension of the journal in December 2004. Magri, who joined the Italian Communist Party in the mid 1950s, soon revealed himself as its most original younger thinker, with critical essays on the Popular Front, the revolutionary party (see nlr i/60, 1970), and a striking book on ’68 in France, Considerazione sui fatti di Maggio. In 1969, he was expelled from the pci along with the group of dissidents—Rossana Rossanda, Luigi Pintor, Luciana Castellina, Aldo Natoli and others—who had founded the journal Il Manifesto, judged a dangerous threat by the leadership. Active in the independ- ent Left and the peace movement over the next two decades (see his articles ‘The Peace Movement and European Socialism’, nlr i/131, 1982, and ‘The European Left between Crisis and Refoundation’, nlr i/189, 1991), Magri became for a number of years one of the leaders of Rifondazione Comunista when the pci split, after jettisoning its name, in 1991. Four years later, he withdrew from the rc when it refused to support the formation of the Dini cabinet, created after the Northern League’s defection from Berlusconi’s first government. In 1996, after a narrow electoral victory, the Centre Left came to power. It was under the Prodi government, initially reliant on the rc’s parliamen- tary support, that the veterans of Il Manifesto, in collaboration with the rc leader Fausto Bertinotti and the former-pci intellectuals Pietro Ingrao and Aldo Tortorella, re-created the monthly journal of the 1960s, now (to distinguish it from the daily) as La Rivista del Manifesto, under Magri’s editorship. -
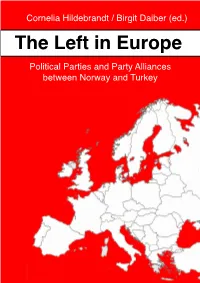
The Left in Europe
ContentCornelia Hildebrandt / Birgit Daiber (ed.) The Left in Europe Political Parties and Party Alliances between Norway and Turkey Cornelia Hildebrandt / Birgit Daiber (ed.): The Left in Europe. Political Parties and Party Alliances between Norway and Turkey A free paperback copy of this publication in German or English can be ordered by email to [email protected]. © Rosa Luxemburg Foundation Brussels Office 2009 2 Content Preface 5 Western Europe Paul-Emile Dupret 8 Possibilities and Limitations of the Anti-Capitalist Left in Belgium Cornelia Hildebrandt 18 Protests on the Streets of France Sascha Wagener 30 The Left in Luxemburg Cornelia Weissbach 41 The Left in The Netherlands Northern Europe Inger V. Johansen 51 Denmark - The Social and Political Left Pertti Hynynen / Anna Striethorst 62 Left-wing Parties and Politics in Finland Dag Seierstad 70 The Left in Norway: Politics in a Centre-Left Government Henning Süßer 80 Sweden: The Long March to a coalition North Western Europe Thomas Kachel 87 The Left in Brown’s Britain – Towards a New Realignment? Ken Ahern / William Howard 98 Radical Left Politics in Ireland: Sinn Féin Central Europe Leo Furtlehner 108 The Situation of the Left in Austria 3 Stanislav Holubec 117 The Radical Left in Czechia Cornelia Hildebrandt 130 DIE LINKE in Germany Holger Politt 143 Left-wing Parties in Poland Heiko Kosel 150 The Communist Party of Slovakia (KSS) Southern Europe Mimmo Porcaro 158 The Radical Left in Italy between national Defeat and European Hope Dominic Heilig 166 The Spanish Left -

The Radical Left Since 1989 : Decline, Transformation, and Revival Bull, MJ
The radical left since 1989 : decline, transformation, and revival Bull, MJ Title The radical left since 1989 : decline, transformation, and revival Authors Bull, MJ Type Book Section URL This version is available at: http://usir.salford.ac.uk/id/eprint/52681/ Published Date 2019 USIR is a digital collection of the research output of the University of Salford. Where copyright permits, full text material held in the repository is made freely available online and can be read, downloaded and copied for non-commercial private study or research purposes. Please check the manuscript for any further copyright restrictions. For more information, including our policy and submission procedure, please contact the Repository Team at: [email protected]. The Radical Left since 1989: Decline, Transformation and Revival Martin J. Bull Any assessment of the impact on the West of the Cold War in 1989 cannot fail to consider the question of what has happened to that political space to the left of social democracy occupied since the Russian Revolution by western communist parties. Indeed, the overthrow of the communist regimes in Central and Eastern Europe posed an immediate and dramatic question about these parties: whether they had any further relevance (albeit as opposition parties) in the western political systems of which they played a part. After all, their very creation and continued existence had been predicated on an equally monumental historical event: the Russian Revolution of 1917. That revolution had ushered in a long-term distinction between social democratic parties on the one hand and communist parties on the other, some of which (in the East) became rulers, while others (in the West) became long- term opposition parties to the capitalist system. -

Il Manifesto” Del 3 Ottobre 2004
«A queste ritorme diciamo mille no» di Micaela Bongi pubblicato su “Il Manifesto” del 3 ottobre 2004 I1 «richiamo» ai partiti del listone, che a Montecitorio si erano astenuti sull'articolo I delle riforme? «Ma..., mi è venuto spontaneo, non ho fatto un approfondimento particola- re. Mi son detto: che vuol dire è così per l'articolo 1'? Dopo 1'1 vengono il 2, il 3, il 4...». Salito nel pomeriggio sul palco del Gran Teatro romano dove l'associazione Astrid e Li- bertà giustizia hanno organizzato il convegno «Salviamo la Costituzione», Romano Prodi risponde alle domande di David Sassoli che poco prima al leader dei Ds Piero Fassino aveva chiesto: «Basta tentennamenti?». Per sentirsi rispondere che figurarsi, non se ne parla, «non abbiamo avuto tentennamenti nella battaglia parlamentare». II Professore, a scanso di equivoci, ribadisce il concetto. Alle riforme della Casa berlu- sconiana dice «no, no, no, tre volte no, mille volte no». II monito del presidente della repubblica, Carlo Azeglio Ciampi? E' la maggioranza a doverlo ascoltare, «è un richiamo che dovrebbe far meditare molto il legislatore, a questo punto il dibattito in parlamento non può più essere lo stesso». Ma poiché pur di tenersi insieme questo governo e questa maggioranza - che «hanno già fatto tanto danno all'Italia e agli italiani, li hanno condotti a una guerra senza sbocco, li hanno resi più poveri, più incerti e insicuri» - stanno anche «colpendo profondamente la democrazia». Prodi incalza: «bisogna opporsi a questa prepotenza e a questa violenza con tutte le armi a nostra disposizione appellandoci al popolo italiano». La strada, insomma, è quella dei referendum, condivisa da Fassino. -

Rifondazione and Europe: a Party Competition Analysis
Rifondazione and Europe: A party competition analysis Giorgos Charalambous Department of Politics University of Manchester [email protected] Paper prepared to be presented at the 58th Political Studies Association, Annual Conference, Swansea (UK), April 1-3. 1 Copyright PSA 2008 Abstract This paper adresses the attitude of Rifondazione Comunista on Europe (European Integration and the European Union) between 1992 and 2006. This is done through an analysis of its positions and institutional action in the Italian electoral arena and partly based on common assumptions and analytical frameworks of the prevailing literature; that is, party system analysis. Findings show that Rifondazione has achieved two things, that are almost in direct contradiction with each other. Firstly, it gradually increased the use of the issue of European integration to emphasise its radical identity, target the Eurosceptics and other radical sections of the electorate and differentiate itself as clearly as possible from the centre-left. Secondly, it underwent positional reallaignment towards a softer approach, mostly, throgh its voting behavior in the Italian parliament and its support for the centre-left governments. A broad discussion assesses the findings of this case study and illuminates larger questions about party attitudes towards European integration. 2 Copyright PSA 2008 INTRODUCTION Apart from being a study which attempts to provide insights into the tactical and strategic considerations of parties, when Europe is put on the agenda, a study of Rifondazione Comunista's electoral attitude towards European integration merits attention due to three main reasons. Firstly, Rifondazione Comunista's first fifteen years coincided with the 'intensive years' of European integration. -

Livio Maitan Bio-Bibliographical Sketch
Lubitz' TrotskyanaNet Livio Maitan Bio-Bibliographical Sketch Contents: Basic biographical data Biographical sketch Selective bibliography Sidelines, notes on archives Basic biographical data Name: Livio Maitan Other names (by-names, pseud. etc.): Claudio ; Domingo ; Fausto ; Claudio Giuliani ; L.M. ; Libero ; Livio ; Claudio Mangani ; Mario Date and place of birth: April 1, 1923, Venezia [Venice] (Italy) Date and place of death: September 16, 2004, Roma [Rome] (Italy) Nationality: Italian Occupations, careers, etc.: historian, lecturer, journalist, translator, editor, party leader, professional revolutionary Time of activity in Trotskyist movement: 1947 - 2004 (lifelong Trotskyist) Biographical sketch This short biographical sketch is chiefly based upon autobiographical notes which Livio Maitan sent to me on request in 1996 and on some of the obituaries listed below (see Selective bibliography: Books and articles about Maitan, below). Livio Maitan – together with Ernest Mandel and Pierre Frank the European top-leader and chief the- oretician of the Fourth International (International/United Secretariat) during the 1950s-1980s – was born in Venezia (Venice) on April 1, 1923 as a son of a teacher and a housewife. Maitan got married in 1954 and was divorced in 1983; he had two sons, Gianni (b. 1959) and Marco (b. 1963). In 1942, when studying classical literature (Greek and Latin) at the University of Padua, he became active in the anti-fascist resistance movement and in 1943 he joined the illegal PSIUP (Partito So- cialista Italiano di Unità Proletaria, Italian Socialist Party of Proletarian Unity). In 1944 he was sen- tenced by a fascist court, escaped to Switzerland and had to spent several months in internment camps there before he could return to Italy in May 1945. -

Ma Per Chi Vota Fausto?
Ma per chi vota Fausto? Per chi vota Fausto Bertinotti? Domanda e curiosità sono più che legittime. Tutti i leader appartati negli ultimi anni dalla politica attiva si sono già espressi: Romano Prodi, Francesco Rutelli, Walter Veltroni e altri ancora. Alle dichiarazioni pubbliche in questi ultimi giorni di campagna elettorale manca in effetti quella di Bertinotti. E pare che non ci sarà alcun atto pubblico da parte sua per riserbo e per evitare polemiche, pur se alcuni indizi indicano che l’ex segretario di Rifondazione voterà la lista di Potere al popolo. Tra i promotori di quest’ultimo raggruppamento, insieme a centri sociali e movimenti, ci sono del resto Maurizio Acerbo e Paolo Ferrero, attuale segretario ed ex segretario di Rifondazione, successori di Bertinotti alla guida del partito lasciato nel 2008. L’ex presidente della camera non ha tuttavia particolari rapporti con quest’area, ma ne ha sicuramente meno con i promotori di Liberi e uguali nonostante Nichi Vendola e Nicola Fratoianni (ex Sinistra ecologia e libertà, poi Sinistra italiana) siano stati a lungo in sintonia con le sue posizioni: gli scambi di opinione sono però diventati con il tempo sempre più rari. Stima e ancora più distanza da Pietro Grasso e Massimo D’Alema, verso i quali c’è una profonda divisione sull’analisi della portata della sconfitta storica della sinistra e sulle modalità di una possibile ricostruzione. Bertinotti avrebbe confidato solo agli amici più intimi le proprie intenzioni di voto. I suoi collaboratori più stretti – quelli del nucleo della rivista Alternative per il socialismo da lui diretta, per esempio – avrebbero lo stesso orientamento pro Potere al popolo. -

Rifondazione Comunista at Its 6Th National Conference : a Strategy of Textual and Semantic Analysis1
Rifondazione Comunista at its 6th National Conference : a strategy of textual and semantic analysis1 Fabio de Nardis1, Francesca della Ratta-Rinaldi2 1Università degli Studi di Lecce - Viale Gallipoli, 49 – 73100 – Lecce – Italia 2 Università degli Studi “La Sapienza”, Facoltà di Sociologia – Dip. DIES – Via Salaria 113 – 00198 – Roma – Italia Abstract In the last years the new Italian Communist party (Rifondazione Comunista) has acquired such a national and international importance to provoke the interest of political scientists. The 6th conference of the party (spring 2005) was very important because of the change from a traditional opposition attitude to the decision to form an alliance with the future Left government, in the case Romano Prodi wins the competition with Berlusconi. This change of perspective was long discussed within the party. As a matter of fact, during the 6th conference, five alternatives motions were discussed : the first was proposed by the secretary Fausto Bertinotti, who decided the alliance with the others Left wing parties, while the other four motions proposed alternative strategies. To analyse this process we have considered 72 articles, published before the conference in the party newspaper (Liberazione) to support the different motions (18 for each motion). The textual analysis we carried out with the new release of TaltaC2 allows us to describe the contents of five groups of articles, the specific language utilised, the kind of actors cited in the corpus and the negative language used. This description is carried out also in a multidimensional perspective. Keywords : Left wing party, political movement, Communism, semantic analysis, multidimensional textual analysis. Riassunto Negli ultimi anni il Partito della Rifondazione Comunista ha acquisito un ruolo di rilevanza nazionale e internazionale tanto da suscitare un crescente interesse da parte della comunità politologica. -

'Veniamo Da Lontano E Andiamo Lontano': the Italian Left and The
Bulletin of Italian Politics Vol. 1, No. 2, 2009, 211-32 ‘Veniamo da Lontano e Andiamo Lontano’: The Italian Left and the Problem of Transition Phil Edwards Manchester Metropolitan University Abstract: A key challenge for the Italian Left is the problematic of ‘transition’: the enduring perception that Italy has not yet attained a state of democratic normality. The Left has suffered a series of setbacks and crises since the formation of the Democratic Party (Partito Democratico, PD) in 2007, thanks in large part to the adoption by PD leader Walter Veltroni of a novelty-oriented strategy which failed to address the ‘transition’ agenda. Veltroni’s successor, Pierluigi Bersani, has mobilised a formidable nationwide coalition of support for a more conservative approach, cutting across the ideological divisions which persist within the PD. However, Veltroni’s strategy has created enduring problems for his party, including the effective delegitimation of the far Left; only when this is remedied will a revival of the broader Left, and a successful engagement with the problems of transition, become possible . Keywords: Italian politics, Democratic Party, transition, democratic consolidation, Second Republic, post-Communist parties. Introduction 2009 was a disastrous year for the Italian Left, within and outside the Democratic Party (Partito Democratico, PD). In this paper I relate the difficulties faced by the Italian Left to the short-term effects of Walter Veltroni’s leadership of the PD, and to the longer-term perspective of a ‘transition’ from the First Republic to a state of democratic normality – a perspective closely connected with the prospects for the PD. I argue, firstly, that Veltroni’s strategy as leader was dangerously mistaken, causing long- term damage to the prospects of the Left and the PD itself. -

Mark Gilbert and Gianfranco Pasquino
ItPol99_all 10/11/00 10:49 am Page 21 1 INTRODUCTION: THE FALTERING TRANSITION Mark Gilbert and Gianfranco Pasquino Unravelling the knots of Italian politics was as elusive a task as ever in 1999. But the key thread, if anywhere, is to be found in the interwoven themes of the creation of the D’Alema government in October 1998 (and its subsequent political fall-out), the difficulty of reforming the electoral law, and hence the hyperfragmented party system, and the short, sharp crisis of the D’Alema cabinet just before Christmas 1999. Short though the crisis was, it jumbled up politics once more and left new loose ends that will gradually unwind themselves in the coming year. Political Jostling Having become prime minister as the result of a traditional bout of parliamentary plotting,1 D’Alema spent most of the first half of 1999 beating off the sustained and insistent attacks on his leader- ship launched by the deposed former premier, Romano Prodi, and his supporters. Even after Prodi had been nominated to the Presi- dency of the European Commission on 24 March 1999, the Demo- cratici per Prodi (Democrats), which adopted a somewhat Disneyesque donkey as their electoral symbol, continued to jab at D’Alema from a distance. With a view to the looming European elections in June, the Democrats were anxious to raise their politi- ItPol99_all 10/11/00 10:49 am Page 22 22 Mark Gilbert and Gianfranco Pasquino cal profile with the very many people who had criticised both the manner and the fact of Prodi’s defenestration from Palazzo Chigi. -

Institutionalised Consensus in Europe's Parliament
Institutionalised Consensus in Europe’s Parliament Giacomo Giorgio Edward Benedetto College: London School of Economics and Political Science Thesis for the University of London Degree of Doctor of Philosophy in Government 1 Abstract Embedded consensus has characterised the behaviour of the European Parliament since its foundation in the 1950s. This research tests the path dependence of consensus during the period of 1994 to 2002, in the light of the changing institutional powers of the Parliament. It challenges existing theory and empirical evidence drawn mainly from roll call votes that has concluded that the European Parliament has become more competitive internally in response to increased institutional powers. There are three causal factors that reinforce consensus: the need to reconcile national and ideological divisions within a multinational political system; the pull of external institutional factors such as institutional change or the separation of powers; and internal incentives for collusion between political actors influenced by the need to accommodate the interests of the national elites present at the level of the European Union. Switzerland, a multiple cleavage system of decentralised federalism that includes consociational characteristics and a separation of powers, provides a comparative reference point for institutionalised consensus. The hypotheses of institutionalised consensus are tested empirically in four ways: 1) by roll call votes between 1994 and 2001, focusing on procedure, policy area, and the cut-off point of the 1999 elections; 2) competition and consensus in the distribution of policy-related office in the Parliament; 3) by Parliament’s use of its powers of appointment and censure over other institutions; and 4) by the internal consensus on the preparation of Parliament’s bids for greater powers when the European Union Treaties are reformed.