L'area Vasta Di Ancona
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Comune Di Sirolo
Comune di Sirolo DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (definitivo) 2019 2020 2021 DUP semplificato - principio contabile applicato alla programmazione all. 4/1 al D.lgs. 118.2011 Comune di Sirolo (AN) Premessa L'armonizzazione dei bilanci della Pubblica Amministrazione è divenuta realtà a decorrere dall’esercizio finanziario 2015 con l’approvazione della Legge Delega sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 5 maggio 2009) e della Legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 31 dicembre 2009). I principi ispiratori delle leggi delega sono finalizzati a garantire: AUTONOMIA DI ENTRATA E DI SPESA; SUPERAMENTO GRADUALE DEL CRITERIO DELLA SPESA STORICA A FAVORE DEI COSTI E FABBISOGNI STANDARD; ADOZIONE DI: • regole contabili uniformi; • comune piano dei conti integrato; • comuni schemi di bilancio articolati in MISSIONI E PROGRAMMI coerenti con la classificazione economico-funzionale; • sistema e schemi di contabilità economico-patrimoniale; • bilancio consolidato per aziende, società ed organismi controllati; • sistema di indicatori di risultato semplici e misurabili; RACCORDABILITA’ DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DEGLI ENTI TERRITORIALI CON QUELLI EUROPEI AI FINI DELLA PROCEDURA PER I DISAVANZI ECCESSIVI. Le leggi n. 196/2009 e n. 42/2009 sopramenzionate hanno delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, informati ai medesimi principi e criteri direttivi, per l’attuazione dell’armonizzazione contabile. Per gli enti territoriali la delega è stata attuata dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”. Il D.lgs. 118/2011 è stato successivamente coordinato ed integrato dal D.lgs. -

A1-Pievi Monasteri E Abbazie Dal Sec.X Al Sec
SECOLO X SENIGALLIA Monterado o an es C F. Castel Colonna a s i M . Ripe F Corinaldo PIEVI, MONASTERI E ABBAZIE NEL TERRITORIO Montemarciano DELLA PROVINCIA DI ANCONA Falconara Marittima DAL SEC. X AL SEC. XIII Ostra la Castelleone di Suasao ANCONA v e .N F Ostra Vetere Morro d'Alba Monte San Vito Chiaravalle Barbara a s DIC.1999 i .M F Belvedere Ostrense San Marcello Camerata Picena o in Monsano s .E A/1 F Serra de' Conti Agugliano Montecarotto Offagna Camerano JESI Polverigi Poggio San Marcello Sirolo F .A s p Numana Arcevia io F.Esino Castelplanio Santa Maria Nuova Castelbellino Rosora Monte Roberto OSIMO F.M Mergo Maiolati Spontini usone Castelfidardo San Paolo di Jesi Serra San Quirico Cupramontana Sassoferrato e n o s u M Loreto Genga Staffolo . Filottrano F T.Sentino o n i s E . F T.G iano Fabriano Cerreto d'Esi L E G E N D A Pievi Pievi Preesistenti Monasteri F O N T I Monasteri Preesistenti Dati: V. VILLANI - "I PROCESSI STORICI DI TRASFORMAZIONE DEL SISTEMA Ubicazione approsimata INSEDIATIVO - GLI INSEDIAMENTI RELIGIOSI IN ETÀ MEDIEVALE" SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE PROVINCIA DI ANCONA SECOLI XI E SEC.XII SECOLO XIII SENIGALLIA SENIGALLIA Monterado Monterado o no an a es es C .C F. F Castel Colonna Castel Colonna a a s s i i M M . Ripe F Ripe F Corinaldo Corinaldo Montemarciano Montemarciano Falconara Marittima Falconara Marittima ANCONA Ostra Castelleone di Suasa Ostra la la Castelleone di Suasao o ANCONA v v e e N .N . F Ostra Vetere F Ostra Vetere Morro d'Alba Monte San Vito Chiaravalle Morro d'Alba Monte San Vito Chiaravalle -

The Marche: Tips from Villa Gens Camuria
1 Caves of Camerano 5 Beach of Sirolo Repubblica di SAN LEO San Marino The Marche: GRADARA PESARO a Region FANO of many Faces SENIGALLIA 12 Bay of Portonovo URBINO 6 Offagna ACQUALAGNA 8 CORINALDO ANCONA PIOBBICO OFFAGNA 6 2 PORTONOVO SERRA S. QUIRICO OSIMO 1 Il Parco del Conero CAMERANO MONASTERO DI 5 SIROLO FONTE AVELLANA CASTELFIDARDO NUMANA 7 LORETO 3 GROTTE DI FRASASSI CINGOLI 4 RECANATI 3 Basilica of Loreto FABRIANO 7 Caves of Frasassi MONTECASSIANO ELCITO MONTELUPONE S. SEVERINO MARCHE MACERATA ABBADIA DI FIASTRA CAMERINO FERMO SARNANO AMANDOLA 4 Recanati 8 Ancona www.villagenscamuria.it OFFIDA VISSO Tel. +39 071 731602 MONTEMONACO ASCOLI PICENO Ideal for a holiday in the Marche and in the Riviera del Conero Tips from Villa Gens Camuria WHAT TO VISIT: CAMERANO (The Caves) 2 km far RECANATI 20 km far ANCONA 10 km far www.grottedicamerano.it www.giacomoleopardi.it Ancona, the county seat, is nowadays a crossroad of trade Camerano is a village situated between the hills of the Ri- Recanati rises from the famous Infinity Hills; known for being thanks to its tourist harbour. Because of its structure, which viera del Conero. Beneath the town streets runs a parallel the hometown of the Italian poet Giacomo Leopardi, whose geographically reminds you of an elbow, you can see both and secret city, composed of caves, tunnels and niches dig- house, where he was born and he conducted his studies, is dawn and sunset on the sea from San Ciriaco Cathedral in ged underground. now a museum situated in the charming historical center. -

Contributo Alla Conoscenza Della Flora Esotica D'italia: Le Specie Presenti
12 Viegi-Vangelisti 1 12-05-2005 16:01 Pagina 97 Atti Soc. tosc. Sci. nat., Mem., Serie B, 110 (2003) pagg. 97-162, figg. 2, tabb. 5 L. VIEGI (*), R. VANGELISTI (*), M.L. D’EUGENIO (**), A.M. RIZZO (***), A. BRILLI-CATTARINI (****) CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA DELLA FLORA ESOTICA D’ITALIA: LE SPECIE PRESENTI NELLE MARCHE Riassunto - Il presente studio è finalizzato alla conoscenza del- zione e la valutazione, quantitativa e qualitativa, della la flora esotica di un’altra regione dell’Italia Centrale, le componente esotica di questa regione, dalle più vecchie Marche, in continuità con la serie di contributi iniziata nel alle più recenti segnalazioni, e dall’altra l’esame del- 1974. Sono stati presi in considerazione sia campioni d’erbario l’impatto di alcune di esse, divenute infestanti, sia sulla (FI, PESA, PI, RO, URBI, ecc.), che dati bibliografici, dai pas- sati ai più recenti. I risultati ci hanno permesso di elencare per fisionomia del paesaggio che sulle colture. Seguendo le Marche 271 entità (tra l’8 ed il 12% della Flora della regio- una metodologia ormai consolidata per la nostra ricerca, ne), di cui 217 coltivate spontaneizzate, 33 avventizie natura- sono state esaminate tutte le pubblicazioni su flora e lizzate, 4 avventizie casuali e 17 dubbie. Rispetto ai dati del vegetazione delle Marche che ci è stato possibile reperi- 1974, le avventizie, soprattutto le naturalizzate, risultano re, a partire dal 1830; quindi campioni d’erbario relativi aumentate di 20 unità. Sono state anche raccolte informazioni alle Marche conservati a Firenze (FI), a Pesaro (PESA), su origine, distribuzione ed ecologia delle esotiche, oltre che a Urbino (URBI), a Pisa (PI; Herb. -

Discovery Marche.Pdf
the MARCHE region Discovering VADEMECUM FOR THE TOURIST OF THE THIRD MILLENNIUM Discovering THE MARCHE REGION MARCHE Italy’s Land of Infinite Discovery the MARCHE region “...For me the Marche is the East, the Orient, the sun that comes at dawn, the light in Urbino in Summer...” Discovering Mario Luzi (Poet, 1914-2005) Overlooking the Adriatic Sea in the centre of Italy, with slightly more than a million and a half inhabitants spread among its five provinces of Ancona, the regional seat, Pesaro and Urbino, Macerata, Fermo and Ascoli Piceno, with just one in four of its municipalities containing more than five thousand residents, the Marche, which has always been Italyʼs “Gateway to the East”, is the countryʼs only region with a plural name. Featuring the mountains of the Apennine chain, which gently slope towards the sea along parallel val- leys, the region is set apart by its rare beauty and noteworthy figures such as Giacomo Leopardi, Raphael, Giovan Battista Pergolesi, Gioachino Rossini, Gaspare Spontini, Father Matteo Ricci and Frederick II, all of whom were born here. This guidebook is meant to acquaint tourists of the third millennium with the most important features of our terri- tory, convincing them to come and visit Marche. Discovering the Marche means taking a path in search of beauty; discovering the Marche means getting to know a land of excellence, close at hand and just waiting to be enjoyed. Discovering the Marche means discovering a region where both culture and the environment are very much a part of the Made in Marche brand. 3 GEOGRAPHY On one side the Apen nines, THE CLIMATE od for beach tourism is July on the other the Adriatic The regionʼs climate is as and August. -

Servizio Extraurbano Feriale Invernale Scuole Aperte
SERVIZIO EXTRAURBANO FERIALE INVERNALE SCUOLE APERTE IN VIGORE DAL 14/09/2020 AL 31/10/2020 " DAL 03/11/2020 AL 23/12/2020 " DAL 07/01/2021 AL 31/03/2021 " DAL 07/04/2021 AL 05/06/2021 " 0 0 Scarica gli orari direttamente sul tuo smartphone ATMA Soc. Cons.p.A - Via Bocconi, 35 - 60125 Ancona - Tel. 071 2837 468 - www.atmaancona.it - [email protected] Linea T - Pianello Vallesina - Cupramontana - Staffolo - Cingoli ............ 32 Atma Extraurbano Linea - Fabriano - Giglioni - Genga - Nebbiano - Fabriano ......................33 Linea A - Ancona - Collemarino - Falconara ........................................... 7 Linea - Genga FS- San Fortunato - Giglioni - Fabriano ...........................33 Linea A - Falconara - Collemarino- Ancona ............................................ 7 Linea - Loreto capolinea - Loreto FS .....................................................34 Linea B - Ancona - Collemarino - Falconara - Marina - M.marciano .......... 8 Linea - Loreto FS - Loreto capolinea .....................................................34 Linea B - M.marciano - Marina - Falconara - Collemarino - Ancona ........ 10 Linea - Loreto Piazza Basili - Cimitero - Loreto Piazza Basili ..................34 Linea C - Ancona - Falconara - Castelferretti - Chiaravalle .....................12 Linea - Loreto Piazza Basili - Via Marconi - Via Maccari - Loreto .............34 Linea C - Chiaravalle - Castelferretti - Falconara- Ancona ..................... 13 Linea - Loreto - Via Matteotti - Piazza Basili - Loreto ..............................35 -
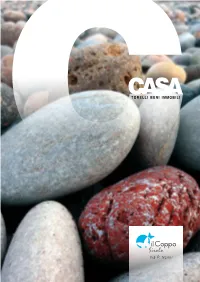
Sirolo Via P
CTORELLI BENI IMMOBILI Sirolo Via P. Nenni CTORELLI BENI IMMOBILI Sirolo Via P. Nenni Pag. 4/5 Presentazione Pag. 6/11 Rendering interni Pag. 12/13 Planimetria generale Pag. 14/21 Planimetrie Pag. 22/27 Il quartiere “il Coppo”, i servizi ed il Parco del Conero Le planimetrie e le immagini si intendono esem- plifictive e potranno essere modificate durante la realizzazione dell’opera 2 3 COMPLESSO RESIDENZIALE IL COPPO (SIROLO) Via P. Nenni CTORELLI BENI IMMOBILI SIROLO COPPO COMPARTO CARATTERISTICHE APPARTAMENTO VASELLI - DESCRIZIONE centro estetico, pizzeria, cartoleria Appartamenti con impianti di riscaldamento S COMPLESSO ABITATIVO ecc… Le sue accurate finiture esaltano autonomo completo di caldaia da incasso e valorizzano ancor di più lo stile e la posizionata all’esterno, predisposizione Nuovo Intervento immobiliare denominato qualità di queste costruzioni senza però aria condizionata, predisposizione “ IL COPPO SIROLO VIA P.NENNI ” sito tralasciare un ottimo rapporto qualità/ per impianto di irrigazione esterno, in Sirolo (AN), Via P. Nenni. Il complesso prezzo. predisposizione per impianto d’allarme, è formato da n°15 unità abitative in predisposizione per illuminazione esterna un contesto architettonico eseguito in DESCRIZIONE APPARTAMENTI giardino, impianto d’antenna per la chiave moderna che ben si immerge nello Le unità immobiliari tutte con ricezione satellitare, soglie e scale esterne spettacolare palcoscenico del Parco del ingresso indipendente sono poste in marmo, sportelloni esterni ed infisso in Conero e della sua Riviera. Situato a soli al piano terra e piano primo. Queste legno completi di vetrocamera ed apertura 15 minuti dal centro di Ancona ed a pochi presentano ampi giardini e terrazze anta e ribalta nelle cucine e nei bagni. -

Sistema Informativo Ministero Della Pubblica Istruzione
SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE : ANCONA ELENCO DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2013/14 ATTENZIONE: PER EFFETTO DELLA LEGGE SULLA PRIVACY QUESTA STAMPA NON CONTIENE ALCUNI DATI PERSONALI E SENSIBILI CHE CONCORRONO ALLA COSTITUZIONE DELLA STESSA. AGLI STESSI DATI GLI INTERESSATI O I CONTROINTERESSATI POTRANNO EVENTUALMENTE ACCEDERE SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLA LEGGE SULLA TRASPARENZA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI. TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DEL COMUNE - CLASSI COMUNI 1. ABOSINETTI STEFANIA . 2/11/61 (MC) DA : ANEE827017 - CERRETO D'ESI - CENTRO URBANO (CERRETO D'ESI) A : ANEE827017 - CERRETO D'ESI - CENTRO URBANO (CERRETO D'ESI) DA POSTO DI SOSTEGNO :MINORATI FISIOPSICHICI PUNTI 97 2. ALLEGREZZA ANNA RITA . 19/12/67 (AN) DA : ANEE84701C - SENIGALLIA G. PASCOLI (SENIGALLIA) A : ANEE848018 - SENIGALLIA "PUCCINI" (SENIGALLIA) PUNTI 67 3. ANIMALI LAURA . 21/10/70 (AN) DA : ANEE830013 - JESI "GARIBALDI" (JESI) A : ANEE84002P - JESI "CAPPANNINI" (JESI) (SOPRANNUMERARIO TRASFERITO CON DOMANDA CONDIZIONATA) PUNTI 74 4. BASSOTTI NADIA . 10/10/64 (AN) DA : ANEE82402R - FALCONARA "MARCONI" (FALCONARA MARITTIMA) A : ANEE82602C - FALCONARA M."A.MORO M.VIA FANI" (FALCONARA MARITTIMA) PUNTI 113 5. BELLABARBA LAURA . 5/ 1/78 (MC) DA : ANEE83101V - "CIALDINI" -CROCETTE (CASTELFIDARDO) A : ANEE84101D - CASTELFIDARDO "MAZZINI" (CASTELFIDARDO) (SOPRANNUMERARIO TRASFERITO CON DOMANDA CONDIZIONATA) PUNTI 48 6. BUCCI CRISTINA . 9/ 5/72 (AN) DA : ANEE835027 - PALAZZI (RIPE) A : ANEE835027 - PALAZZI (RIPE) DA POSTO DI SOSTEGNO :MINORATI FISIOPSICHICI PUNTI 85 TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DEL COMUNE - CLASSI COMUNI 7. CANALINI FRANCA . 9/ 1/53 (AN) DA : ANEE81802D - ANCONA "ELIA" (ANCONA) A : ANEE81302A - ANCONA "DE AMICIS" (ANCONA) PUNTI 124 8. -

Official Journal C 474 of the European Union
Official Journal C 474 of the European Union Volume 59 English edition Information and Notices 17 December 2016 Contents II Information INFORMATION FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2016/C 474/01 Non-opposition to a notified concentration (Case M.8300 — Hewlett Packard Enterprise Services/ Computer Sciences Corporation) (1) ......................................................................................... 1 2016/C 474/02 Non-opposition to a notified concentration (Case M.8247 — Aurelius Equity Opportunities/Office Depot (Netherlands)) (1) ......................................................................................................... 1 2016/C 474/03 Non-opposition to a notified concentration (Case M.8265 — Carlyle/KAP) (1) ................................. 2 2016/C 474/04 Non-opposition to a notified concentration (Case M.8096 — International Paper Company/ Weyerhaeuser Target Business) (1) ............................................................................................. 2 IV Notices NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2016/C 474/05 Euro exchange rates .............................................................................................................. 3 EN (1) Text with EEA relevance NOTICES FROM MEMBER STATES 2016/C 474/06 Reorganisation measures — Decision on measures to reorganise ‘International Life, Life Insurance AS’ (Publication made in accordance with Article 271 of Directive 2009/138/EC -

ENTE DEL PARCO DEL CONERO Via Peschiera N. 30 60020 SIROLO (AN)
ENTE DEL PARCO DEL CONERO Via Peschiera n. 30 60020 SIROLO (AN) DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 20N Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco Data: 28/10/2019 L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di Ottobre, nel proprio ufficio, Il Direttore Premesso che, ai sensi dell’art. 26 della Legge Regionale 28 Aprile 1994 n. 15 il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativi ad interventi, impianti od opere all’interno del parco è sottoposto a previo nulla osta dell’organismo di gestione del parco stesso secondo le modalità previste dall’art. 13 della legge 394/1991; con delibera di Consiglio Direttivo n.76 del 28/05/2015 è stato approvato il Regolamento del Parco del Conero Pubblicato sul supplemento n. 6 al BUR n.49 del 18/06/2015 che è entrato in vigore il 16/09/2015; il Regolamento del Parco del Conero all’art. 2 definisce le modalità di presentazione delle domande di rilascio del nullaosta e le procedure per il rilascio ovvero il non rilascio dei nullaosta; Considerato che, sono pervenute diverse domande per la richiesta di nullaosta e/o pareri e/o autorizzazioni comunque denominate a questo Ente; per i progetti e le opere da valutare è data per verificata dall’Amministrazione Comunale la conformità degli stessi alla normativa urbanistica, edilizia e di settore di propria competenza per effetto di quanto indicato al co. 3 dell’art. 2.3 del Regolamento del Parco; restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull’osservanza delle Norme urbanistico- edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località, nonché il controllo da parte dell’amministrazione comunale sullo stato attuale, il suo stato legittimato e la sua autorizzazione originaria; nel rispetto del co. -

Mappa Turistica
STABILIMENTI BALNEARI E SPIAGGE LIBERE LEGENDA seguici su via Avellaneda SPIAGGIA DEL FRATE o SOTTOSANTA Museo Antiquarium Ecosportello Bancomat centro storico 1 EDEN GIGLI 071 9330652 Informazioni Turistiche Farmacie Polizia Municipale via Montalbano 1 SPIAGGIA LIBERA TRA BALNEARE 1 e 2 di Numana Carabinieri Tennis Guardia Medica contrada Valcastagno SPIAGGIA NUMANA ALTA via Avellaneda via Valcastagno Panorama 2 LA SPIAGGIOLA 071 7360271 Impianti sportivi Chiesa 3 FIOR DI MARE 333 8121845 Via Montefreddo via Cavour Giardini / giochi Partenza escursioni SPIAGGIA LIBERA TRA BALNEARE 3 e PORTO Poste @turismonumana Via dei Tigli Marconi SPIAGGIA NUMANA BASSA Percorsi per spiagge Distributore acqua Parcheggi via Risorgimento via Leopardi via Colle Sereno 4 HOTEL SCOGLIERA 071 9330622 via Flaminia via Colle Ameno SIRENA 071 9330623 via Flaminia via Flaminia 5 Via dei Tigli ACQUA ORSA MAGGIORE 339 7764271 via Aurora 6 Via delle Margherite via Carducci via del Porto (30 NODI) Via dei Castagni via Risorgimento via Elia viavia la Fenice Pascoli via Matteotti Via dell’ Olivo Via dei Lillà P.zza STELLA MARINA 339 3614583 Piazza Girasoli Via dei Gelsi 7 via 4 Novembre via del Golfo Santuariovia Morelli 8 HOTEL SORRISO 0719330645 ANCONA A14 Via dei Tulipani La Costarella CASTELFIDARDO SVARCHI Via delle Azalee 9 CORALLO via del Pincetto SUMMER VILLAGE 071 9330279 OSIMO via Roma via del Musone Via Pescheria 10 DA MARINO 338 5688632 LORETO via Svarchi Alti 11 LIDO AZZURRO 071 9330218 RECANATI Via Via del Taunus P.zza Via dei Ciclamini 12 EUGENIO 071 -

Persone E Numeri
Provincia di Ancona Assessorato all’Ambiente Capitolo Nono PERSONE E NUMERI Il Piano di Azione Locale della Provincia di Ancona I 528 partecipanti alle 88 riunioni del forum della prima e seconda fase del processo di Agenda 21 della Provincia di Ancona 31. Federica Fossi - Comune di Senigallia ENTI TERRITORIALI 32. C. Frigio - Comune di Fabriano 33. Ermanno Frontaloni - Comune di Filottrano 1. Pierluigi Adorisio - Comune di Serra San Quirico 34. Federica Gabrielloni - Comune di Montemarciano 2. Rossana Albonetti - Comune di Ancona 35. Monia Gavetti - Provincia di Ancona 3. Luca Amico - Comune di Numana 36. Giorgiana Giacconi - Comune di Agugliano 4. Antonio Angeloni - Comune di Fabriano 37. Alberto Giovagnini - Comune di Filottrano 5. Pieramelio Baldelli - Comune di Serra dé Conti 38. Laura Giulianelli - Comune di Camerano 6. Sandro Barcaglioni - Comune di San Paolo di Jesi 39. Daniela Giuliani - Comune di Senigallia 7. Michela Barucca - Comune di Monsano 40. Fabrizio Giuliani - Comunità Montana Esino-Frasassi 8. Rossano Basili - Comune di Castelbellino 41. Vito Giuseppucci - Comunità Montana Esino-Frasassi 9. Renata Belli - Comune di Serra San Quirico 42. Marco Gnocchini - Comune di Ancona 10. Massimo Bello - Comune di Ostra Vetere 43. Giorgio Graziosi - Comune di Ostra 11. Maria Cristina Belogi - Comune di Montemarciano 44. Claudio Grendene - Provincia di Ancona 12. Walter Breccia - Comune di Senigallia 45. Pietro Lanari - Provincia di Ancona 13. Nedo Brugiamolini - Provincia di Ancona 46. Romeo Lanari - Provincia di Ancona 14. Graziano Candelaresi - Provincia di Ancona 47. Roberto Lancioni - Provincia di Ancona 15. Mario Capotondi - Comune di Barbara 48. Andrea Leoni - Comune di Ostra 16. Marco Cardinaletti - Comune di Ancona 49.