L'attività Di Francesco Solimena Dal 1674 Al 1706. Revisione E
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
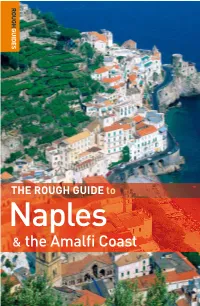
The Rough Guide to Naples & the Amalfi Coast
HEK=> =K?:;I J>;HEK=>=K?:;je CVeaZh i]Z6bVaÒ8dVhi D7FB;IJ>;7C7B<?9E7IJ 7ZcZkZcid BdcYgV\dcZ 8{ejV HVc<^dg\^d 8VhZgiV HVciÉ6\ViV YZaHVcc^d YZ^<di^ HVciVBVg^V 8{ejVKiZgZ 8VhiZaKdaijgcd 8VhVaY^ Eg^cX^eZ 6g^Zcod / AV\dY^EVig^V BVg^\a^Vcd 6kZaa^cd 9WfeZ_Y^_de CdaV 8jbV CVeaZh AV\dY^;jhVgd Edoojda^ BiKZhjk^jh BZgXVidHVcHZkZg^cd EgX^YV :gXdaVcd Fecf[__ >hX]^V EdbeZ^ >hX]^V IdggZ6ccjco^ViV 8VhiZaaVbbVgZY^HiVW^V 7Vnd[CVeaZh GVkZaad HdggZcid Edh^iVcd HVaZgcd 6bVa[^ 8{eg^ <ja[d[HVaZgcd 6cVX{eg^ 8{eg^ CVeaZh I]Z8Vbe^;aZ\gZ^ Hdji]d[CVeaZh I]Z6bVa[^8dVhi I]Z^haVcYh LN Cdgi]d[CVeaZh FW[ijkc About this book Rough Guides are designed to be good to read and easy to use. The book is divided into the following sections, and you should be able to find whatever you need in one of them. The introductory colour section is designed to give you a feel for Naples and the Amalfi Coast, suggesting when to go and what not to miss, and includes a full list of contents. Then comes basics, for pre-departure information and other practicalities. The guide chapters cover the region in depth, each starting with a highlights panel, introduction and a map to help you plan your route. Contexts fills you in on history, books and film while individual colour sections introduce Neapolitan cuisine and performance. Language gives you an extensive menu reader and enough Italian to get by. 9 781843 537144 ISBN 978-1-84353-714-4 The book concludes with all the small print, including details of how to send in updates and corrections, and a comprehensive index. -
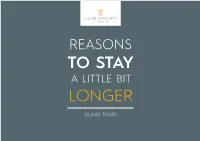
Reasons to Stay a Little Bit Longer
CÆSAR AVGVSTVS ISOLA DI CAPRI REASONS TO STAY A LITTLE BIT LONGER ISLAND TOURS CAPRI AND Walking around the alleys, overlooking seaviews, appreciating the natural wonders of a island that has it all! ANACAPRI Accompanied by your own private guide, strolling around the historical city center of Anacapri and Capri visiting the pedestrian centers. TOUR ISLAND ROAD TOUR Since Roman times, the unparalleled natural beauty of Capri has captured the imagination of travelers. Sporty guests can enjoy exciting walks such as the Sentiero dei Fortini, explore the magnificent villas of Emperor Tiberius and visit the legendary Blue Grotto, made famous by Lord Byron. Our experienced guide will introduce clients to Capri’s hidden treasures on foot or by car. Duration: 4hrs PRIVATE Very close to the Vesuvius still remain ancient Roman ruins: Pompeii. In these archaeological sites you will have the unique occasion to walk through narrow streets once passed by old roman people, admire their houses EXCURSION beautifully decorated and understand the way they lived. The visit can be done with or without a guide (you can require a specific language for your TO POMPEI tour), we suggest to book a guided one to appreciate better this excursion. Duration: 8hrs Tour includes: • Hydrofoil roundtrip tickets to Sorrento • Private car from the port of Sorrento to Pompeii and back. • Tickets for the entrance of the ruins The prices do not include lunch PRIVATE Very close to the Vesuvius still remain ancient Roman ruins: Pompeii. In these archaeological sites you will have the unique occasion to walk through narrow streets once passed by old roman people, admire their houses EXCURSION beautifully decorated and understand the way they lived. -
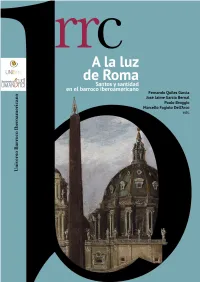
Texto Completo (3.573Mb)
A la luz de Roma Santos y santidad en el barroco iberoamericano © 2020 Universo Barroco Iberoamericano Comité Asesor 14º volumen Dora Arizaga Guzmán, arquitecta. Quito, Ecuador Alicia Cámara. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Madrid, España Elena Díez Jorge. Universidad de Granada, España Editores Marcello Fagiolo. Centro Studi Cultura e Immagine di Fernando Quiles García Roma, Italia José Jaime García Bernal Martha Fernández. Universidad Nacional Autónoma Paolo Broggio de México. México DF, México Marcello Fagiolo Dell’Arco Jaime García Bernal. Universidad de Sevilla, España María Pilar García Cuetos. Universidad de Oviedo, España Revisión de textos Lena Saladina Iglesias Rouco. Universidad de Miguel Molina Oliver Burgos, España Revisión de textos en inglés Ilona Katzew. Curator and Department Head of Latin Cristina Padilla American Art. Los Angeles County Museum of Art (LACMA). Los Ángeles, Estados Unidos Mercedes Elizabeth Kuon Arce. Antropóloga. Cusco, Perú Director de la colección Luciano Migliaccio. Universidade de São Paulo, Fernando Quiles García Brasil Coordinador editorial Víctor Mínguez Cornelles. Universitat Jaume I. Juan Ramón Rodríguez-Mateo Castellón, España Macarena Moralejo. Universidad de Granada, España Ramón Mújica Pinilla. Lima, Perú Francisco Javier Pizarro. Universidad de Imagen de portada Extremadura. Cáceres, España Viviano Codazzi. Exterior de san Pedro. Roma. h. Ana Cielo Quiñones Aguilar. Pontificia Universidad 1636. Museo Nacional del Prado. Madrid Javeriana. Bogotá. Colombia Fotografías y dibujos Delfín Rodríguez. Universidad Complutense de De los autores, excepto que se especifique el au- Madrid, España tor de la imagen Janeth Rodriguez Nóbrega. Universidad Central de Venezuela. Caracas, Venezuela Edición Olaya Sanfuentes. Pontificia Universidad Católica E.R.A. Arte, Creación y Patrimonio Iberoamericanos de Chile. -

Words, It Would Take Twice As Many the Bishop, Who Could Not Know He Was Ordaining the Future Patron Catechists, If Not More to Monitor the Children
18th Sunday in Ordinary Time 18th Sunday in Ordinary Time Mass Intentions for the Week Monday August 03: From 8:00 AM Judy Molina ~ Mary Hodges Father Joseph Tuesday August 04: St. John Vianney 8:00 AM Michael Dinh and Michelle Dinh Wednesday August 05: Dedication of the Basilica of St. Mary Major 7:00 PM † Ben Coletti, † Ron Ausmus, † Kathy Majek, † Matthew and Anna Bach, † Sister Purificacion Palis, † Cynthia De Leon, † Dominic Philip Nguyen, † Pedro Apiado † Bobby Almager, † Michael Maraist, † Hazel Joyce Nowotny, Davie and Danny Nguyen, Judy Molina, Misa Molina Healing: Debbie Garcia, Mary Dennehy Thursday August 06: The Transfiguration of the Lord Feeding People with Five Loaves and Two Fish 8:00 AM † Joseph Berner ~ Joan Deets Recalling the time that I was training to be a priest both in Friday August 07: St. Sixtus II and Companions;St. Cajetan; undergraduate and graduate schools, there were at least three First Friday levels of training. The level of the quest for the unknown future (discernment) is the first level. The second level is the level of doing 8:00 AM Huong and Thuy ~ Family ministries while we are in seminaries. The third level is that of Nineteenth Sunday in Ordinary Time engaging in a prayer life and the celebration of the Eucharist Saturday August 08 everyday of a week. 5:00 PM Deceased members of the Visosky Family~Janice Crocker When I first arrived at the undergraduate school, Saint Joseph Sunday August 09 Seminary in Covington LA, I asked myself, “What have I gotten 8:30 AM Altar and Rosary Society into?” I arrived at the school around 8:00 or 9:00 PM because I got 11:00 AM Parishioners of St. -

The Collecting, Dealing and Patronage Practices of Gaspare Roomer
ART AND BUSINESS IN SEVENTEENTH-CENTURY NAPLES: THE COLLECTING, DEALING AND PATRONAGE PRACTICES OF GASPARE ROOMER by Chantelle Lepine-Cercone A thesis submitted to the Department of Art History In conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Queen’s University Kingston, Ontario, Canada (November, 2014) Copyright ©Chantelle Lepine-Cercone, 2014 Abstract This thesis examines the cultural influence of the seventeenth-century Flemish merchant Gaspare Roomer, who lived in Naples from 1616 until 1674. Specifically, it explores his art dealing, collecting and patronage activities, which exerted a notable influence on Neapolitan society. Using bank documents, letters, artist biographies and guidebooks, Roomer’s practices as an art dealer are studied and his importance as a major figure in the artistic exchange between Northern and Sourthern Europe is elucidated. His collection is primarily reconstructed using inventories, wills and artist biographies. Through this examination, Roomer emerges as one of Naples’ most prominent collectors of landscapes, still lifes and battle scenes, in addition to being a sophisticated collector of history paintings. The merchant’s relationship to the Spanish viceregal government of Naples is also discussed, as are his contributions to charity. Giving paintings to notable individuals and large donations to religious institutions were another way in which Roomer exacted influence. This study of Roomer’s cultural importance is comprehensive, exploring both Northern and Southern European sources. Through extensive use of primary source material, the full extent of Roomer’s art dealing, collecting and patronage practices are thoroughly examined. ii Acknowledgements I am deeply thankful to my thesis supervisor, Dr. Sebastian Schütze. -

Il 'Poggio Delle Mortelle'
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” FACOLTÀ DI ARCHITETTURA DOTTORATO DI RICERCA IN STORIA DELL’ARCHITETTURA E DELLA CITTÀ XVII CICLO IL ‘POGGIO DELLE MORTELLE’ NELLA STORIA DELL’ARCHITETTURA NAPOLETANA COORDINATORE: PROF. ARCH. FRANCESCO SAVERIO STARACE TUTORE: PROF. ARCH. MARIA RAFFAELA PESSOLANO CANDIDATO: EMILIO RICCIARDI ANNO 2005 Introduzione Il “poggio delle Mortelle” è una piccola area a sud-ovest della collina di San Martino, tra Chiaia e Montecalvario, aperta sul mare in direzione di Posillipo e celebrata dai cronisti per la bellezza del sito e la salubrità dell’aria; prese questo nome, scriveva nella sua guida il canonico Carlo Celano, “perché da cento settant’anni fa vi erano boschi di mirti che noi chiamiamo mortelle, e le frondi di questi servivano per accomodare i cuoi”1. La spiegazione di Celano fu ripresa da tutti gli scrittori di cose napoletane, con la sola eccezione di Ludovico de la Ville sur-Yllon, che agli inizi del XX secolo, basandosi su un documento di compravendita ritrovato nel Grande Archivio di Napoli, formulò l’ipotesi che il toponimo derivasse dalla famiglia “de Trojanis y Mortela”, che abitava in questi luoghi agli inizi del Seicento2. Quale che ne fosse l’origine, la denominazione “delle Mortelle” si affermò con favore crescente a partire dalla metà del XVII secolo, cancellando la memoria dei nomi più antichi (“il Lucchesino”, “lo Ficaro”, “la Caiola”) che distinguevano i diversi fondi rustici e sostituendo indicazioni più generiche (“sopra Chiaia”, “sopra Toledo”, “sotto Sant’Elmo” oppure, dopo la fondazione della chiesa, “sotto Santa Maria Apparente”). I documenti cinque e secenteschi concordano nel chiamare “piazza delle 1 C. -

Giuseppe Porzio, Revue Du Louvre
siècle e XVII La Sainte Agathe en prison du musée de Nevers et les débuts de Bernardo Cavallino par Giuseppe Porzio La toile représentant Sainte Agathe en prison miracu leu sement soignée par saint Pierre conservée au Musée municipal de Nevers1 (fig. 1) n’a pas obtenu à ce jour la considération Provenant de la collection du qu’elle mérite de la part des spécialistes de la peinture napo- e marquis Campana au XIXe siècle, litaine du XVII siècle ; en conséquence – et malgré sa grande qualité – la question de sa paternité n’a pas encore reçu de cette œuvre des collections du solution convaincante et définitive. À l’évidence, la modestie Louvre est conservée depuis des reproductions dont elle a toujours fait l’objet lorsqu’elle 1962 au musée de Nevers. a été publiée a dû, elle aussi, contribuer à sa sous-évaluation Rattachée précédemment à ainsi qu’à sa position marginale dans les études sur le sujet et e en interdire de fait une lecture correcte2. l’école napolitaine du XVII siècle et plus précisément à l’œuvre de Francesco Guarino, elle reviendrait Les différentes attributions à son contemporain Cavallino, qui l’aurait peinte au moment des Le débat sur la paternité de cette Sainte Agathe se réduit, contacts stylistiques les plus étroits en substance, à une hésitation entre le nom de Francesco Guarino (1611-1651) 3 – assurément la référence qui a eu entre les deux artistes. le plus de succès, y compris parce qu’il s’agit de la plus cré- Résumés en anglais p. 107 et en allemand p. -

La Basilica Di San Domenico Maggiore in “Ricerche Sull'arte A
Ricerche sull’arte a Napoli in età moderna saggi e documenti 2015 FONDAZIONE GIUSEPPE E MARGARET DE VITO PER LA STORIA DELL’ARTE MODERNA A NAPOLI Ricerche sull’arte a Napoli in età moderna saggi e documenti 2015 Sommario Presentazione 82 Sabrina Iorio 7 Giancarlo Lo Schiavo Sull’arte marmorea di primo Seicento a Napoli: Iacopo Lazzari, Tommaso Montani, Per Giuseppe De Vito. Un ricordo Francesco Cassano, Giovan Marco Vitale 8 Renato Ruotolo e Giovan Domenico Monterosso 10 Riccardo Naldi 106 Luigi Abetti “ … son de madera incorruptible … ”. Bonaventura Presti architetto certosino Due Ladroni in legno di bosso di Gabriel Joly, “aquila” dimenticata del Rinascimento 133 Paola De Simone mediterraneo Dalla serenata Cerere placata a palazzo Perrelli. Nuovi documenti per le arti a 35 Eduardo Nappi Napoli La chiesa e il convento di San Domenico Maggiore di Napoli. Documenti 167 Renato Ruotolo L’architetto Orazio Angelini e il VII 54 Giuseppe Porzio Congresso degli Scienziati Italiani del 1845 Dagli spalti di Castel Sant’Elmo. Notizie su Didier Bar 193 Indice dei nomi a cura di Luigi Abetti 64 Marco Vaccaro Considerazioni sull’attività di Aert Mijtens in Abruzzo e sulla formazione dei fratelli Bedeschini Eduardo Nappi La chiesa e il convento di San Domenico Maggiore di Napoli. Documenti Gli oltre duecento documenti pubblicati di seguito mettono a disposizione degli studiosi una ricchezza di notizie, sia d’archivio che bibliografiche, utili per chiarire l’articolata vicenda costruttiva della cittadella conventuale di San Domenico Maggiore. Tali documenti, suddivisi topograficamente e ordinati crono- logicamente, coprono un arco temporale compreso tra il XVI e il XIX secolo. -

SANTA BARBARA.Pdf
02 03 Santa Barbara Francesco Guarino e bottega, 1640 ca Olio su tela, 62x50,5 Napoli, Convento di Santa Teresa degli Scalzi Il dipinto, considerato una Sant’Agnese ed attribuito a Francesco Guarino nell’archivio fotografico della Soprintendenza per i B.A.S. di Napoli, raffigura in realtà Santa Barbara, come si osserva dalla torre collocata a destra sullo sfondo, ed è il pendant della Santa Apollonia, altro olio su tela dello stesso Guarino. Si tratta di una replica di bottega della Santa Barbara. Nella sua monografia “FRANCESCO GUARINO DA SOLOFRA nella Pittura napoletana del Seicento (1611 - 1651)”, Riccardo Lattuada scrive: «Sono giunto a conoscenza del dipinto nel febbraio 1999, quando era ancora attribuito ad un anonimo pittore napoletano della cerchia di Massimo Stanzione. Tale attribuzione è comprensibile alla luce della stretta affinità stilistica e compositiva dell’opera con i modi della maturità di Stanzione. Nel presente dipinto si colgono infatti assonanze nella posizione del volto e della mano al petto rispetto alla Sant’Agnese di Stanzione a Barcellona, Museo d’Arte Catalunya, datata dalla critica agli inizi degli anni Quaranta. Il riferimento primario dell’opera è, in ogni caso, istituibile rispetto alla Santa Barbara nel Convento di Santa Teresa agli Studi, qui attribuito a Guarino e bottega, che forma pendant con la Santa Apollonia. Ma il quadro di Santa Teresa appare una replica prevalentemente eseguita da aiuti di Guarino, mentre il presente dipinto costituisce sicuramente l’originale della composizione. Se il gusto per le preziose stoffe seriche bianche e oro, rese con una materia spessa e per una volta intatta, avvicina il presente dipinto alle migliori espressioni dell’arte di Stanzione e di Cavallino, è poi di Guarino la capacità di sensibilizzare questa straordinaria immagine femminile mediante una ardente espressione devota, che può essere fatta risalire all’interesse dell’ambiente napoletano verso i modelli di Reni. -

Unity Sity … ¾ One R T R Bapt M!
The Transfiguration of the Lord Embracing the communities of Year B, 1 August, 2021 Cherbourg, Durong, Goomeri, Murgon, Proston and Wondai Unity sity … ¾ one rt r Baptm! August is the month of Transfiguration the Immaculate Heart It is said that the only constant in But is that a problem? of Mary life is change. In other words, the only thing that doesn’t change is that We reached out into the streets to Pope’s Prayer Intention for August the men. We journeyed with them things will change. When I arrived Universal intention: The Church at Corpus Christi Community – and invited them to come and Let us pray for the Church, that she Greenvale, it was run down. The care live with us. Their alcoholism was may receive from the Holy Spirit the and hygiene were not one would understood and no attempt was grace and strength to reform herself expect is a facility run for the care made to reform them – they were in the light of the Gospel. of the dying and homeless. accepted. The hymn, “Come as you are”, was the anthem. All staff caring for the men were volunteers. Each of the three wards But over the years the health care Masses Times – this week (wings) was overseen by a Mercy increased leaps and bounds. The Tuesday, 3 August sister. But these sisters were not professional care and protocols Gayndah, noon nurses, but retired teachers (the meant that the men were better youngest being in her mid-seventies). and more professionally cared for. Wednesday, 4 August The rest of the volunteers were from The place looked wonderful and Wondai, 5.00pm all walks of life. -

Avellino and Irpinia
Generale_INGL 25-03-2008 13:28 Pagina 148 Avellino and Irpinia 148 149 A mantle of woods covers the “green Irpinia”, from an environmental point of view, one of the most i beautiful and rich territories of Italy: it includes parks and naturalistic oases, mountains and high plains full of springs, grottoes, lakes, rivers, waterfalls, woods… The magic colours and scents invite walks in an unspoiled environment, long Ente Provinciale per il itineraries which at every step reveal spectacular Turismo di Avellino views of grandiose mountains, streams and wide via Due Principati 32/A valleys. Avellino tel. 0825 747321 Discovering Irpinia step by step, amidst the marvels www.eptavellino.it of the landscape, emerges its cultural and artistic heritage: Etruscans, Greeks, Romans, Goths, Provincia di Avellino Longobards…in three thousand years many peoples Assessorato al Turismo have passed by these lands and left their marks: in piazza Libertà 1 Avellino the Roman ruins, the severe catacombs, the tel. 0825 793058 Longobard ruins and Baroque monuments. There is no village in Irpinia without a story to tell. Irpinia is Ente Parco Regionale also world famous for its glorious wine growing del Partenio tradition: it is the land of the Docg wines: Taurasi, via Borgonuovo 1 Summonte (AV) Greco di Tufo and Fiano. These wines exalt the tel. 0825 691166 typical local cuisine: quality products and old www.parcopartenio.it recipes guarantee excellent dishes. Inns, trattorias and famous restaurants unite passion, experience Atripalda Palazzo dell’ex Dogana and innovation, and offer the possibility to savour dei Grani real culinary masterpieces. piazza Umberto I The choice of accomodations is wide and varied, for tel. -

L'impronta Di Andrea Vaccaro in Due Dipinti Di Angelo Solimena A
Sinestesieonline PERIODICO QUADRIMESTRALE DI STUDI SULLA LETTERATURA E LE ARTI SUPPLEMENTO DELLA RIVISTA «SINESTESIE» ISSN 2280-6849 L’IMPRONTA DI ANDREA VACCARO IN DUE DIPINTI DI ANGELO SOLIMENA A MERCOGLIANO Riccardo Sica Abstract Il saggio analizza due importanti dipinti del Seicento presenti in due chiese a Mercogliano e riconosce in essi l’impronta dello stile classicista che fu comune ad Angelo Solimena e ad Andrea Vaccaro, due pittori che si influenzarono spesso a vicenda e profondamente. Anche se in uno dei due dipinti appare un monogramma che è stato identificato con quello di Angelo Solimena, non sono del tutto dissipati i dubbi che esso sia stato alterato o manomesso e che all’origine possa essere stato il monogramma di Andrea Vaccaro, data la tipologia soprattutto della “A” iniziale. Basandosi su indiscutibili elementi di confronto, affinità ed identità iconografiche, stilistiche e tecniche, nonché su raffronti di immagini e su considerazioni storiche e documentarie varie, l’autore viene alla conclusione che idealmente le due opere possano essere attribuite ad entrambi i pittori in questione, uniti, in un momento particolare della loro attività (intorno al terz’ultimo decennio del Seicento), in un rapporto di innegabile collaborazione e scambi reciproci. Parole chiave Contatti [email protected] Nelle due splendide pale d’altare presenti nella Chiesa dei Ss. Pietro e Paolo a Mercogliano, la Sacra Famiglia con Santi e San Matteo, San Gennaro e San Lorenzo, recentemente restaurate, si possono cogliere inedite affinità iconografiche e stilistiche e sorprendenti identità espressive tra la pittura di Angelo Solimena e quella di Andrea Vaccaro. Pertanto la presenza del monogramma (per la verità consunto, incerto e confuso) di Angelo Solimena in entrambe le tele rende alquanto riduttiva, a mia avviso, ai fini di una completa comprensione delle opere, l’attribuzione delle stesse al solo Solimena Senior.