Texto Completo (3.573Mb)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
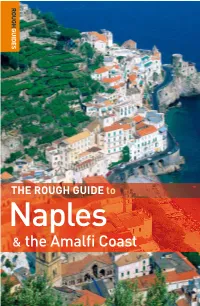
The Rough Guide to Naples & the Amalfi Coast
HEK=> =K?:;I J>;HEK=>=K?:;je CVeaZh i]Z6bVaÒ8dVhi D7FB;IJ>;7C7B<?9E7IJ 7ZcZkZcid BdcYgV\dcZ 8{ejV HVc<^dg\^d 8VhZgiV HVciÉ6\ViV YZaHVcc^d YZ^<di^ HVciVBVg^V 8{ejVKiZgZ 8VhiZaKdaijgcd 8VhVaY^ Eg^cX^eZ 6g^Zcod / AV\dY^EVig^V BVg^\a^Vcd 6kZaa^cd 9WfeZ_Y^_de CdaV 8jbV CVeaZh AV\dY^;jhVgd Edoojda^ BiKZhjk^jh BZgXVidHVcHZkZg^cd EgX^YV :gXdaVcd Fecf[__ >hX]^V EdbeZ^ >hX]^V IdggZ6ccjco^ViV 8VhiZaaVbbVgZY^HiVW^V 7Vnd[CVeaZh GVkZaad HdggZcid Edh^iVcd HVaZgcd 6bVa[^ 8{eg^ <ja[d[HVaZgcd 6cVX{eg^ 8{eg^ CVeaZh I]Z8Vbe^;aZ\gZ^ Hdji]d[CVeaZh I]Z6bVa[^8dVhi I]Z^haVcYh LN Cdgi]d[CVeaZh FW[ijkc About this book Rough Guides are designed to be good to read and easy to use. The book is divided into the following sections, and you should be able to find whatever you need in one of them. The introductory colour section is designed to give you a feel for Naples and the Amalfi Coast, suggesting when to go and what not to miss, and includes a full list of contents. Then comes basics, for pre-departure information and other practicalities. The guide chapters cover the region in depth, each starting with a highlights panel, introduction and a map to help you plan your route. Contexts fills you in on history, books and film while individual colour sections introduce Neapolitan cuisine and performance. Language gives you an extensive menu reader and enough Italian to get by. 9 781843 537144 ISBN 978-1-84353-714-4 The book concludes with all the small print, including details of how to send in updates and corrections, and a comprehensive index. -
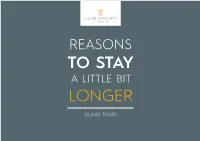
Reasons to Stay a Little Bit Longer
CÆSAR AVGVSTVS ISOLA DI CAPRI REASONS TO STAY A LITTLE BIT LONGER ISLAND TOURS CAPRI AND Walking around the alleys, overlooking seaviews, appreciating the natural wonders of a island that has it all! ANACAPRI Accompanied by your own private guide, strolling around the historical city center of Anacapri and Capri visiting the pedestrian centers. TOUR ISLAND ROAD TOUR Since Roman times, the unparalleled natural beauty of Capri has captured the imagination of travelers. Sporty guests can enjoy exciting walks such as the Sentiero dei Fortini, explore the magnificent villas of Emperor Tiberius and visit the legendary Blue Grotto, made famous by Lord Byron. Our experienced guide will introduce clients to Capri’s hidden treasures on foot or by car. Duration: 4hrs PRIVATE Very close to the Vesuvius still remain ancient Roman ruins: Pompeii. In these archaeological sites you will have the unique occasion to walk through narrow streets once passed by old roman people, admire their houses EXCURSION beautifully decorated and understand the way they lived. The visit can be done with or without a guide (you can require a specific language for your TO POMPEI tour), we suggest to book a guided one to appreciate better this excursion. Duration: 8hrs Tour includes: • Hydrofoil roundtrip tickets to Sorrento • Private car from the port of Sorrento to Pompeii and back. • Tickets for the entrance of the ruins The prices do not include lunch PRIVATE Very close to the Vesuvius still remain ancient Roman ruins: Pompeii. In these archaeological sites you will have the unique occasion to walk through narrow streets once passed by old roman people, admire their houses EXCURSION beautifully decorated and understand the way they lived. -

Words, It Would Take Twice As Many the Bishop, Who Could Not Know He Was Ordaining the Future Patron Catechists, If Not More to Monitor the Children
18th Sunday in Ordinary Time 18th Sunday in Ordinary Time Mass Intentions for the Week Monday August 03: From 8:00 AM Judy Molina ~ Mary Hodges Father Joseph Tuesday August 04: St. John Vianney 8:00 AM Michael Dinh and Michelle Dinh Wednesday August 05: Dedication of the Basilica of St. Mary Major 7:00 PM † Ben Coletti, † Ron Ausmus, † Kathy Majek, † Matthew and Anna Bach, † Sister Purificacion Palis, † Cynthia De Leon, † Dominic Philip Nguyen, † Pedro Apiado † Bobby Almager, † Michael Maraist, † Hazel Joyce Nowotny, Davie and Danny Nguyen, Judy Molina, Misa Molina Healing: Debbie Garcia, Mary Dennehy Thursday August 06: The Transfiguration of the Lord Feeding People with Five Loaves and Two Fish 8:00 AM † Joseph Berner ~ Joan Deets Recalling the time that I was training to be a priest both in Friday August 07: St. Sixtus II and Companions;St. Cajetan; undergraduate and graduate schools, there were at least three First Friday levels of training. The level of the quest for the unknown future (discernment) is the first level. The second level is the level of doing 8:00 AM Huong and Thuy ~ Family ministries while we are in seminaries. The third level is that of Nineteenth Sunday in Ordinary Time engaging in a prayer life and the celebration of the Eucharist Saturday August 08 everyday of a week. 5:00 PM Deceased members of the Visosky Family~Janice Crocker When I first arrived at the undergraduate school, Saint Joseph Sunday August 09 Seminary in Covington LA, I asked myself, “What have I gotten 8:30 AM Altar and Rosary Society into?” I arrived at the school around 8:00 or 9:00 PM because I got 11:00 AM Parishioners of St. -

Unity Sity … ¾ One R T R Bapt M!
The Transfiguration of the Lord Embracing the communities of Year B, 1 August, 2021 Cherbourg, Durong, Goomeri, Murgon, Proston and Wondai Unity sity … ¾ one rt r Baptm! August is the month of Transfiguration the Immaculate Heart It is said that the only constant in But is that a problem? of Mary life is change. In other words, the only thing that doesn’t change is that We reached out into the streets to Pope’s Prayer Intention for August the men. We journeyed with them things will change. When I arrived Universal intention: The Church at Corpus Christi Community – and invited them to come and Let us pray for the Church, that she Greenvale, it was run down. The care live with us. Their alcoholism was may receive from the Holy Spirit the and hygiene were not one would understood and no attempt was grace and strength to reform herself expect is a facility run for the care made to reform them – they were in the light of the Gospel. of the dying and homeless. accepted. The hymn, “Come as you are”, was the anthem. All staff caring for the men were volunteers. Each of the three wards But over the years the health care Masses Times – this week (wings) was overseen by a Mercy increased leaps and bounds. The Tuesday, 3 August sister. But these sisters were not professional care and protocols Gayndah, noon nurses, but retired teachers (the meant that the men were better youngest being in her mid-seventies). and more professionally cared for. Wednesday, 4 August The rest of the volunteers were from The place looked wonderful and Wondai, 5.00pm all walks of life. -

The Pennsylvania State University
The Pennsylvania State University The Graduate School Department of Art History THE DOCUMENTED PAINTINGS AND LIFE OF ANDREA VACCARO (1604-1670) A Thesis in Art History by Anna Kiyomi Tuck-Scala Ó 2003 Anna Kiyomi Tuck-Scala Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy December 2003 The thesis of Anna Kiyomi Tuck-Scala was reviewed and approved* by the following: Jeanne Chenault Porter Associate Professor of Art History Thesis Adviser Chair of Committee Roland E. Fleischer Professor Emeritus of Art History George L. Mauner Distinguished Professor Emeritus of Art History Alfred A. Triolo Associate Professor Emeritus of Italian and Spanish Craig Zabel Associate Professor of Art History Head of the Department of Art History *Signatures are on file in the Graduate School iii ABSTRACT This dissertation takes stock of what is known about Andrea Vaccaro (1604- 1670), one of the most prominent painters of Naples in the middle of the seventeenth- century. Although successful during his lifetime, Vaccaro currently suffers a reputation that is, at best, second rate. Due to the hundreds of paintings attributed to Vaccaro of dubious quality, modern art historians characterize his art as “eclectic” and “academic.” The sole monograph on Vaccaro, Maria Commodo Izzo’s Andrea Vacccaro pittore (1604-1670) published in 1951, is also sorely out of date. This study provides a new and more accurate portrayal of the artist. Rather than the customary all-inclusive approach, this study is based on the solid foundation of all known documents about the artist’s life and art, which are gathered and analyzed in one place for the first time. -

Patron Saint of a World in Crisis: Early Modern Representations of St
PATRON SAINT OF A WORLD IN CRISIS: EARLY MODERN REPRESENTATIONS OF ST. FRANCIS XAVIER IN EUROPE AND ASIA by Rachel Miller BA, Kenyon College, 2005 MA, University of Pittsburgh, 2010 Submitted to the Graduate Faculty of the Kenneth P. Dietrich School of Arts and Sciences in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy University of Pittsburgh 2016 UNIVERSITY OF PITTSBURGH KENNETH P. DIETRICH SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES This dissertation was presented by Rachel Miller It was defended on March 28, 2016 and approved by Christopher J. Nygren, Assistant Professor, History of Art and Architecture Mrinalini Rajagopalan, Assistant Professor, History of Art and Architecture Patrick Manning, Professor, History Dissertation Advisor: Kirk Savage, Professor, History of Art and Architecture Dissertation Advisor: Ann Sutherland Harris, Professor Emerita, History of Art and Architecture ii Copyright © by Rachel Miller 2016 iii PATRON SAINT OF A WORLD IN CRISIS: EARLY MODERN REPRESENTATIONS OF ST. FRANCIS XAVIER IN EUROPE AND ASIA Rachel Miller, PhD University of Pittsburgh, 2016 Recent historical studies have focused on the vital role that Catholic saints played after the Council of Trent, investigating how these holy figures were utilized to alleviate all manner of problems besetting the Post-Tridentine Church, emerging European nation states, and individual Catholics. My dissertation, however, approaches this issue from an art historical perspective, considering how images of St. Francis Xavier, the sixteenth-century Jesuit missionary, exercised considerable agency in an early modern world rife with global crisis. Specifically, I investigate Xaverian prints and paintings created in border zones of early modern Catholicism or in territories of the Iberian empires, particularly Antwerp, Goa, and Naples. -

Confraternal Gleanings from Post-Tridentine Piacenza: Bishop Paolo Burali D’Arezzo and the Confraternity of the Most Holy Sacrament
Confraternal Gleanings from Post-Tridentine Piacenza: Bishop Paolo Burali d’Arezzo and the Confraternity of the Most Holy Sacrament Serena Quagliaroli1 Summary: This article focuses on the situation in the diocese of Piacenza during the episcopate of Paolo Burali d’Arezzo (r. 1568–1576) by placing his work within the post-Tridentine context. One of the most important objectives of the Church after the Council of Trent was the recovery of a closer relationship between the clergy and the faithful and it was pursued through the establishment and renewal of confraternities. In Piacenza, Bishop Burali encouraged the founding of many lay associations and took care to amend and revitalize existing ones, such as the Confraternity of the Most Holy Sacrament. For the one in the cathedral, documentary sources give us much useful information that allows us to speculate on the decorations (no longer extant) in the chapel dedicated to the Most Holy Sacrament executed by Giulio Mazzoni (1519–ca. 1590). Archival sources and local historical-artistical guidebooks allow us to propose a comparison between what Mazzoni achieved in Piacenza and Rome. This article offers a first glimpse into the situation in the diocese of Piacenza in the post-Tridentine period through an analysis of the city’s lay confraternities. The decision to use confraternities as privileged sub- jects of analysis is founded on the awareness of the growing importance that confraternity studies has enjoyed over the last few decades, espe- cially in the lively academic discussions carried -

L'attività Di Francesco Solimena Dal 1674 Al 1706. Revisione E
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO DISPAC DOTTORATO DI RICERCA IN METODI E METODOLOGIE DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA, STORICO ARTISTICA E DEI SISTEMI TERRITORIALI XII CICLO TESI DI DOTTORATO L’attività di Francesco Solimena dal 1674 al 1706. Revisione e ampliamento del catalogo delle opere. Coordinatore: Candidata: Prof.ssa Angela Pontrandolfo Dott.ssa Simona Carotenuto Tutor: Prof. Mario Alberto Pavone Anno Accademico 2012/2013 INDICE INTRODUZIONE 1. ANGELO E FRANCESCO SOLIMENA: DAL DISCEPOLATO ALLA COLLABORAZIONE 1.1 Il contributo di Francesco nella produzione paterna 2. I NUOVI CICLI PITTORICI DI COLLABORAZIONE 2.1 L’oratorio della Madonna delle Grazie di Cava dei Tirreni 2.2 Il Convento della Santissima Trinità a Baronissi 3. LA PRODUZIONE AUTONOMA 4. L’AMPLIAMENTO DEL CIRCUITO DI COMMITTENZA: LA COMMITTENZA VENETA 4.1 Nuovi documenti sui rapporti di Francesco Solimena con la committenza veneta e una proposta per l’ Apollo e Dafne 5. L’ATTIVITÀ DI BOTTEGA IN RIFERIMENTO ALLA PRODUZIONE COEVA 5.1 Relazioni di bottega e orientamento didattico nell’ambito dell’Accademia del Solimena 6. APPENDICE DOCUMENTARIA 7. BIBLIOGRAFIA 2 INTRODUZIONE Con la presente ricerca si è inteso operare una revisione del percorso del Solimena tra gli anni 1674-1706, sia al fine di comprovare l’apporto delle fonti e degli studi dal ‘700 ai giorni nostri, sia al fine di integrare la conoscenza della produzione dell’artista attraverso l’introduzione di nuove opere ritenute degne di attenzione nell’ambito della sua produzione, a partire dagli anni giovanili fino alla sua maturità. Un ruolo primario ha avuto la ricerca documentaria, condotta presso l’Archivio di Stato di Napoli e l’Archivio Storico della Fondazione del Banco di Napoli, che ha consentito di ampliare l’analisi dei rapporti con la committenza napoletana e veneziana, soprattutto in relazione ai residenti veneti. -

Artists, Patrons, and Trust in Seventeenth-Century Naples: the Case of the Certosa Di San Martino
Artists, Patrons, and Trust in Seventeenth-Century Naples: The Case of the Certosa di San Martino J. Nicholas Napoli Introduction In his 1739 essay on commerce, “Del Commercio del Regno di Napoli,” presented as a letter addressed to Don Francesco Ventura, the newly appointed President of the Magistrate of Commerce under Charles of Bourbon, Paolo Mattia Doria reflected on the city’s economic development during the period of Spanish viceregal rule and suggested possibilities for present- day and future reform. He argued that the regime fostered several practices in the civil life of the kingdom—including usurious rates of interest, the inconsistent registration and enforcement of loans and contracts, and the resultant lawsuits of hopeless complexity and interminable duration—that fed widespread distrust of commerce in the realm.1 For Doria, trust in each of these exchanges was critical in establishing and maintaining commerce, and ultimately rendered civil life possible.2 In Lezioni di economia civile, Doria defined trust as the reciprocal confidence of one citizen in another. In terms of commerce, it was the voluntary participation in economic exchange made possible by freedom and security of contracts.3 Doria developed his thinking about trust in the academic circles of late seventeenth- century Naples where the Accademia degli Investiganti and the Accademia Medina Coeli fostered intellectual exchange and allowed for the dissemination of the emerging philosophical trends in Europe.4 As a member of the Accademia Medina Coeli, Doria presented and listened to papers, or lezioni, alongside Giuseppe Valletta, Luc’Antonio Porzio, and younger members who would become the most prominent thinkers in the Neapolitan Enlightenment, including Niccolò 1 Paolo Mattia Doria, “Del Commercio del Regno di Napoli,” Il Pensiero Civile di Paolo Mattia Doria negli Scritti Inediti, 1739, edited by Enrico Vidal (Milan: A Giuffrè Editore, 1953), 178-79, 205. -

LA CAPRAIA - YEAR 2 Research Reports from the Center for the Art and Architectural History of Port Cities 2019-2020
Vol. 2, 2020 LA CAPRAIA - YEAR 2 Research Reports from the Center for the Art and Architectural History of Port Cities 2019-2020 1 Vol. 2, 2020 Vol. 2, 2020 2 3 LA CAPRAIA - YEAR 2 Record of Activities and Research Reports from the Center for the Art and Architectural History of Port Cities September 2019 - June 2020 WELCOME Centro per la Storia dell’Arte e dell’Architettura delle Città Portuali (CSAACP) 07 Greetings from Michael Thomas a collaboration between 09 Greetings from Sylvain Bellenger the Museo e Real Bosco di Capodimonte 10 Mission The Edith O’Donnell Institute of Art History 12 Report from Sarah K. Kozlowski and Franklin University Switzerland 14 Report from Francesca Santamaria Museo e Real Bosco di Capodimonte / La Capraia Via Miano 2 Napoli 80131 +39 3494706237 REPORTS FROM RESEARCH RESIDENTS [email protected] Claire Jensen www.utdallas.edu/arthistory/port-cities 19 23 Lisa Malberg 27 Diana Mellon Research Report published by the 31 Nathan Reeves Centro per la Storia dell’Arte e dell’Architettura delle Città Portuali (CSAACP) ACTIVITIES REPORT 37 International Conference Caravaggio a Napoli. Ricerche in corso Attribution-Non Commercial-NoDerivs CC BY-NC-ND 41 Field Seminar From the museum to the city: a two-day field seminar Editor Sarah K. Kozlowski on the ciborium of Santa Patrizia at Capodimonte and Editorial Coordinator Francesca Santamaria the places and spaces of the saint’s cult in Naples 44 Scholarly programs Designed by Francesco Giordano 49 Advisory Group and Partners Photo of La Capraia by Luciano Romano Vol. 2, 2020 Greetings from the Director of the O’Donnell Institute In April 2019, just before I began my position as Director of the Edith O’Donnell Institute of Art History at UT Dallas, Rick Brettell and I helped lead a group of local Dallas EODIAH supporters on a trip to Naples. -

Natureandpeopleontheneapolitanvolcanoes.Pdf
The present guidebook was prepared for the International Workshop on Advanced Monitoring of Active Volcanoes. It reports information on the Partenopean volcanic area and illustrates the sites visited during the tour. The guidebook synthetically provides information on i) the major morphological and structural features of the volcanoes, ii) the deposits of the eruptions and their impact on the territory, iii) their present state and iv) the geophysical, petrologycal and geochemical networks operating at the Osservatorio Vesuviano. The tour will be devoted to illustrating the intimate relation among natural setting, archeology and urbanization of the high risk and deeply monitored Campi Flegrei and Vesuvius. It also presents the Osservatorio Vesuviano edifice that maintain the memory of the oldest volcanological observatory in the world and the earlier monitoring instruments. The refenceres used in this book will be useful to detail the knowlegde on the Campi Flegrei and Vesuvius volcanic area and to recover other interesting and more focused papers. This guidebook, finally, includes a list of churches and historical buildings, nearby the workshop location and that can be visited during your stay in Naples. Introduction Vesuvius and Campi Flegrei together with Ischia and Procida volcanoes are located in the Campanian Plain, (Fig 1). The Plain is a structural depression delimited by the Southern Apennines mountain chain to the east, south and north, and by the Tyrrhenian Sea, to the west. It is infilled by 2-3,000 m of Plio-Quaternary continental, deltaic, and marine sediments, intercalated with volcanic deposits, as detected by drilling and geophysical surveys (Piochi et al., 2005a and references therein). -

A European View on Ruins in Naples and Messina During the 17Th and 18Th Centuries
ArcHistoR anno V (2018) n. 9 A European View on Ruins in Naples and Messina during the 17th and 18th Centuries Massimo Visone [email protected] An analysis of iconography and a critical reading of sources allow to add new observations on the representation of cities in territories affected by the 1783 earthquake. The contribution aims to illustrate a slow cultural mutation and the symbolic, figurative meanings of this phenomenon. The philosophy of catastrophe puts the then prevailing optimism of reason into crisis and destroys the conviction that the present may be the best of all possible worlds. The Kingdom of Naples was one of the protagonists of that dynamism that pushed men to explore unusual territories along the Grand Tour route with the intent of acquiring new scientific tools of analysis. Southern Italy is a unique case in Europe due to the number of earthquakes during the modern age. In particular, the capital city, Naples, and Sicily were hit several times by earthquakes of varying intensity over a period from 1688 to 1783; that century was a fundamental passage in the history of earthquakes. AHR V (2018) n. 9 ISSN 2384-8898 DOI: 10.14633/AHR065 Uno sguardo dell’Europa sulle rovine a Napoli e Messina tra XVII e XVIII secolo Massimo Visone Nella lettera scritta da Francesco Petrarca al cardinale Giovanni Colonna, di cui si riporta un’ampia citazione, si legge la descrizione del terremoto e della tempesta che si verificò a Napoli il 25 novembre 1343, con ingenti danni alla città, in particolare nei quartieri bassi e nel porto.