Le Grotte Di Castelcivita Nei Monti Alburni
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ne Al Registro Imprese Di SALERNO 81000570655 N
ACQUEDOTTI DEL CALORE LUCANO SPA 2017 ACQUEDOTTI DEL CALORE LUCANO SRL Sede in Piazza della Repubblica c/o Casa Comunale – 84043 AGROPOLI(SA) Iscrizione al Registro Imprese di SALERNO 81000570655 N. REA 317231 PIANO INDUSTRIALE TRA SFORMAZIONE DELLA SOCIETA’ ACQUEDOTTI DEL CALORE LUCANO IN AZIENDA SPECIALE CONSORTILE calorelucano@ Pag. 1 ACQUEDOTTI DEL CALORE LUCANO SPA 2017 PREMESSA Il decreto legislativo n. 175/2016 recante “Testo Unico in materia di società partecipatedalla pubblica amministrazione”, rappresenta la nuova disciplina in materia. Il provvedimento è attuativo dell’articolo 18 della legge delega n. 124/2015, c.d. leggeMadia. Le disposizioni del decreto entrano in vigore il 23 settembre 2016. In relazione alle novità introdotte dal provvedimento è essenziale segnalare, in primis, le più significative : - partecipazioni delle PP.AA. limitate alle società di capitali, anche consortili; - espressa previsione ed elenco delle attività perseguibili attraverso le società; - nuove norme sulla governance delle società e limite ai compensi degliamministratori; - estensione della disciplina di crisi aziendale alle società a partecipazione pubblica; - specifiche procedure per costituzione, mantenimento ed alienazione dellepartecipazioni in società; - esclusione parziale delle società quotate, come definite nel testo, dall’applicazionedel decreto; - obbligo di dismissione per le società che non soddisfano specifici requisiti; - gestione transitoria del personale delle partecipate; - entro il 23 marzo 2017, revisione straordinaria obbligatoria -

CICOGNE INVADONO Roccadaspide CONTINUA a PAGINA 13 23 IL PUNTO
0828.720114 - unicosettimanale.it - [email protected] € 1,0 0 Editore: Calore s.r.l. Sede Legale: Via S. Giovanni, 86 - Villa Littorio - Laurino (Sa); Sede Redazionale: Via della Repubblica, 177 - Capaccio- Anno XIII Poste Italiane - Spedizione in a.p. - 45% - art. 2 comma 20/b legge 662/96 - Dir. Com. Business Salerno - Abb. annuale 25,00€ n° 31 del 03 Settembre 2011 L’EDITORIALE CAPACCIO INCHIESTA AULETTA/PERTOSA di Silvia De Luca COMUNALI DUE ROSCIGNO CALDORO, DI FILIPPO VOZAINCAMPO MOLTI POTENTATI E MARINO Cilento Outlet, ACONFRONTO un non luogo che ARTICOLO A PAG. 6 ARTICOLO A PAG. 3 ARTICOLO A PAG. 9 non è sviluppo A volte anche qualcosa di piacevole come un ritorno a casa può trasfor- marsi in un incubo. Mi è successo quattro settimane fa, quando ero in viaggio verso Vallo della Lucania, il mio paese di residenza, per trascor- rere qualche giorno di vacanza. Uscita dalla Salerno-Reggio a Battipa- glia, ho imboccato la Statale 18 e mi sono ritrovata subito imbottigliata in una fila interminabile di auto in coda. CICOGNE INVADONO Roccadaspide CONTINUA A PAGINA 13 23 IL PUNTO di Pasquale Di Perna Non c’è futuro se il fiume Calore è in secca “ La seguente petizione ha l’obiettivo di restituire il Deflusso Minimo Vitale FOTO MIRRO CAPO al fiume Calore Lucano con sorgente nel territorio del Comune di Piaggine Premesso che il fiume Calore si trova BATTIPAGLIA EBOLI in pieno Parco Nazionale del Cilento di Ernesto Giacomino di Francesco Faenza ed è tutelato a diversi livelli sia co- munale che sovracomunale, costi- tuendo un ecosistema di notevole Appuntamento Via dell’impatto pregio ambientale oltre che fonte di ambientale CONTINUA A PAGINA 2 al buio Anche per quest’estate caldo, allentamento delle pub- Il tormentone dell’estate ebolitana? Si chiama via. -

Approvazione Graduatorie Nidi Di Controne E Ottati
N°. 1169 R. G. del 12/11/2019 N°. 276 Registro del Settore del 12/11/2019 DETERMINAZIONE PZ PIANO DI ZONA - AMBITO S07 OGGETTO: SERVIZIO “IL NIDO – IL CALORE DELLE COCCOLE" COMUNE DI CONTRONE ED OTTATI. APPROVAZIONE GRADUATORIE - A.S. 2019/2020. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Vista - la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; - la Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000 e ss.mm.ii.; - la Deliberazione di giunta Regionale della Campania n. 372 del 07.08.2015 “Determinazione delle tariffe relative ai servizi residenziali e semiresidenziali” (BURC n. 49 del 10.08.2015); Considerato - che in data 09.11.2016, ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi, è stata stipulata apposita convenzione, ai sensi dell’art. 30 del DLgs 267/00, per mezzo della quale i citati enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il Piano di Zona dei servizi socio-sanitari istituendo, a tal fine, un ufficio sovra comunale di piano; - che il Comune di Roccadaspide con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 14 del 07.05.2014 è stato individuato come comune capofila dell’Ambito S07 “Calore salernitano – Alburni” così come costituito ai sensi della DGRC n. 320/2012 “Modifica degli ambiti territoriali sociali e dei distretti sanitari”; - che con Decreto del Sindaco di Roccadaspide prot. n. 448 del 14/01/15, consecutivo alla Deliberazione del Coord. Istituz. S07 n. 35 del 29/12/14 e alla Deliberazione di Giunta Comunale n. -

Comune Di Acerno [email protected]
Comune di Acerno [email protected] Comune di Agropoli [email protected] Comune di Albanella [email protected] Comune di Alfano [email protected] Comune di Altavilla Silentina [email protected] Comune di Amalfi [email protected] Comune di Angri [email protected] Comune di Aquara [email protected] Comune di Ascea [email protected] Comune di Atena Lucana [email protected] Comune di Atrani [email protected] Comune di Auletta [email protected] [email protected] Comune di Baronissi [email protected] Comune di Battipaglia [email protected] Comune di Bellizzi [email protected] Comune di Bellosguardo [email protected] Comune di Bracigliano [email protected] Comune di Buccino [email protected] Comune di Buonabitacolo [email protected] Comune di Caggiano [email protected] Comune di Calvanico [email protected] [email protected] Comune di Camerota [email protected] Comune di Campagna [email protected] Comune di Campora [email protected] Comune di Cannalonga [email protected] Comune di Capaccio [email protected] Comune di Casal Velino [email protected] Comune di Casalbuono [email protected] Comune di Casaletto -
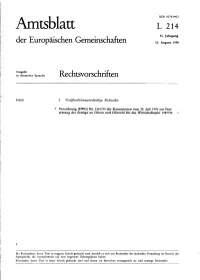
Page 1 ...ISSN 0376-9453 . .. L 214 Amtsblatt Der Europäischen Gemeinschaften -...33. Jahrgang 10. August 1990 H . a T ..!!! TE Lib...: Ausgabe in Deutscher Sprache Ante
ISSN 0376-9453 Amtsblatt L 214 33 . Jahrgang der Europäischen Gemeinschaften 10 . August 1990 Ausgabe in deutscher Sprache Rechtsvorschriften Inhalt I Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte * Verordnung (EWG) Nr. 2341/90 der Kommission vom 30 . Juli 1990 zur Fest setzung der Erträge an Oliven und Olivenöl für das Wirtschaftsjahr 1989/90 1 2 Bei Rechtsakten, deren Titel in magerer Schrift gedruckt sind, handelt es sich um Rechtsakte der laufenden Verwaltung im Bereich der Agrarpolitik, die normalerweise nur eine begrenzte Geltungsdauer haben . Rechtsakte , deren Titel in fetter Schrift gedruckt sind und denen ein Sternchen vorangestellt ist, sind sonstige Rechtsakte . 10. 8 . 90 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 214/ 1 I (Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte) VERORDNUNG (EWG) Nr. 2341/90 DER KOMMISSION vom 30 . Juli 1990 zur Festsetzung der Erträge an Oliven und Olivenöl für das Wirtschaftsjahr 1989/90 DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN Aufgrund der erhaltenen Angaben sind diese Erträge wie GEMEINSCHAFTEN — im Anhang I angegeben festzusetzen . gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen Wirtschaftsgemeinschaft, entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus schusses für Fette — gestützt auf die Verordnung Nr. 136/66/EWG des Rates vom 22. September 1966 über die Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation für Fette ('), zuletzt geän dert durch die Verordnung (EWG) Nr. 2902/89 (2), HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN : gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2261 /84 des Rates vom 17 . Juli 1984 mit Grundregeln für die Gewährung Artikel 1 der Erzeugungsbeihilfe für Olivenöl und für die Oliven ölerzeugerorganisationen (3), zuletzt geändert durch die ( 1 ) Für das Wirtschaftsjahr 1989/90 werden die Erträge Verordnung (EWG) Nr. 1 226/89 (4), insbesondere auf an Oliven und Olivenöl sowie die entsprechenden Erzeu Artikel 19, gungsgebiete im Anhang I festgesetzt. -

LE GROTTE DI PERTOSA-AULETTA Situate Nel Massiccio Dei Monti
LE GROTTE DI PERTOSA-AULETTA Situate nel massiccio dei Monti Alburni, le Grotte di Pertosa-Auletta sono uno dei geositi focali del Geoparco “Cilento” e presentano due unicità: • sono le uniche grotte in Italia dove è possibile navigare un fiume sotterraneo, il Negro; • sono le sole in Europa a conservare i resti di un villaggio palafitticolo risalente al II millennio a.C. Il fiume offre un affascinante ed inconsueto viaggio in barca , immersi in un silenzio magico, interrotto soltanto dal fragore degli scrosci della cascata sotterranea. LE VISITE GUIDATE Le Grotte si estendono per circa tremila metri nel massiccio dei Monti Alburni, in un percorso ricco di concrezioni, dove stalattiti e stalagmiti decorano ogni spazio con forme, colori e dimensioni diverse, suscitando stupore ed emozione. Due percorsi turistici di diversa durata accessibili a tutti (parziale e completo) e un percorso speleologico per i più avventurosi, vi permetteranno di esplorare caverne ed anfratti scavati nella natura in milioni di anni. Un viaggio di oltre un chilometro, con 400 metri da percorrere in barca navigando il fiume sotterraneo, giungendo alla cascata interna per visitare la Sala del Paradiso, per poi continuare sul ramo settentrionale scoprendo la maestosità della Grande Sala, le particolarità della Sala delle Spugne e il fascino del Braccio delle Meraviglie. La visita non è faticosa e l’accesso non presenta alcuna difficoltà, pertanto è adatta a persone di tutte le età . IL MUSEO DEL SUOLO UN’ESPOSIZIONE UNICA SUL SUOLO Una struttura museale unica in Italia e con pochi omologhi nel resto del mondo, inaugurata il 22 aprile 2016, nel giorno in cui le Nazioni Unite celebrano la Terra e che propone un singolare itinerario di conoscenza dedicato alla terra, e più precisamente a ciò che avviene in quei tre metri, fondamentali per la vita sul nostro pianeta, che dalla superficie si portano in basso. -

Provvedimento VIA Nell'ambito Del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale Ex Art 27 D.Lgs
COPIA COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA ■ CASTEL SAN LORENZO RELITTO - LAURINO - MAGLIANO VETERE - MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE ■ ROCCADASPIDE - SACCO ■ STIO - TRENTINARA - VALLE DELL'ANGELO 84069 ROCCADASPIDE(SA) Via Cesine 0828/941132 - 941000 AREA TECNICA E FINANZIARIA DETERMINA FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO OGGETTO: Conferenza dei servizi - CUP 8218 - Istanza rilascio provvedimento VIA nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art 27 D.Lgs. 152/2006 - Intervento derivazione acque sotterranee sorgenti Calore — Proponente Acquedotti del Calore Lucano S.p.A. — Rilascio parere svincolo idrogeologico — Determina a contrarre per INCARICO CONSULENZA TECNICA (CIG: Z4427A452B). 5 8 B 2U1h DETERMINA N° del 2 0 MAR, 2019 REGISTRO GENERALE N° del AREA TECNICA E FINANZIARIA FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E AGRICOLTURA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROPONE ai sensi dell'art. 6 della legge n° 241/90, l'adozione della seguente proposta di determinazione di cui si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza. OGGETTO: Conferenza dei servizi - CUP 8218 - Istanza rilascio provvedimento VIA nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 D.Lgs. 152/2006 - Intervento derivazione acque sotterranee sorgenti Calore - Proponente Acquedotti del Calore Lucano S.p.A.- Rilascio parere svincolo idrogeologico - Determina a contrarre per INCARICO CONSULENZA TECNICA(CIG: Z4427A452B). PREMESSO: - che la Direzione Generale regionale del Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazione e Autorizzazioni Ambientali, a seguito dell'istanza della Società Acquedotti del Calore Lucano S.p.A., finalizzata ad ottenere la concessione per la derivazione di acque sotterranee della sorgente del Fiume Calore in agro del Comune di Piaggine, ha avviato il procedimento per il rilascio autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. -

Salerno and Cilento
Generale_INGL 25-03-2008 13:27 Pagina 106 Salerno and Cilento 106 107 Salerno is a fascinating synthesis of what the Mediterranean can offer to those who want to know i it better. The city is continuously improving to better host tourists and visitors from all over the world. Its province is the largest of the Campania. Together with the Amalfi Coast, the archaeological areas of Paestum and the uncontaminated Cilento, it also Ente Provinciale per il includes the high plains crossed by the Sele River, Turismo di Salerno its tributaries and the Vallo di Diano. via Velia 15 tel. 089 230411 www.eptsalerno.it [email protected] informazioni e acc. turistica 089 231432 numero verde 800 213289 Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Salerno Lungomare Trieste 7/9 tel. 089 224744 Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Cava de’ Tirreni Corso Umberto I 208 tel. 089 341572 www.cavaturismo.sa.it Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo di Paestum via Magna Grecia 887 tel. 0828 811016 www.infopaestum.it Ente Parco del Cilento e del Vallo di Diano via O. De Marsilio Vallo della Lucania tel. 0974 719911 www.pncvd.it Comunità Montana Monti Picentini via Santa Maria a Vico Giffoni Valle Piana tel. 089 866160 Arconte Cove Cava de’ Tirreni the School of Medicine then universities of Bologna and Complesso dell’Abbazia functioning at Velia. In the Padova were founded. della SS Trinità - via Morcaldi 6 13th century it obtained the The School continued to tel. 089 463922 right to be the only School function until 1812, when it Paestum the School of Medicine of Medicine of the realm was finally closed by Parco Archeologico of Salerno from Emperor Frederick II: Joachim Murat. -
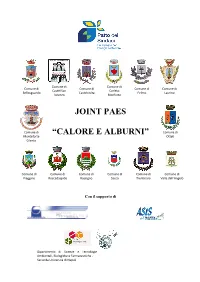
CALORE E ALBURNI” Comune Di Monteforte Ottati Cilento
Comune di Comune di Comune di Comune di Comune di Comune di Castel San Corleto Bellosguardo Castelcivita Felitto Laurino Lorenzo Monforte JOINT PAES Comune di “CALORE E ALBURNI” Comune di Monteforte Ottati Cilento Comune di Comune di Comune di Comune di Comune di Comune di Piaggine Roccadaspide Roscigno Sacco Trentinara Valle dell’Angelo Con il supporto di Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche ‐ Seconda Università di Napoli INDICE GENERALE 1. Contesto di Riferimento .................................................................................................................................................. 3 1.1 Il Patto dei Sindaci Congiunto “Calore e Alburni”: il percorso .................................................................................. 4 1.2 Obiettivi del PAES “Calore e Alburni” ....................................................................................................................... 7 1.3 Territorio di riferimento............................................................................................................................................ 9 1.3.1 Caratteristiche fisiche e demografiche d’insieme per i 14 comuni (anno 2007) ............................................. 10 1.3.2 Caratteristiche ambientali e paesistiche .......................................................................................................... 11 1.3.3 Caratteristiche urbanistiche e territoriali ....................................................................................................... -

Comunita' Montana “Alburni”
COMUNITA’ MONTANA “ALBURNI” Controne - SA CONVENZIONE D'INCARICO PROFESSIONALE Espletamento delle funzioni di medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria del personale in dotazione all’Ente L'Anno duemiladiciannove, il giorno _______________ del mese di ______________, presso la sede della Comunità Montana "Alburni", si sono costituiti: 1) Dott. agr. Serafino Pugliese, nato a Ottati il 29/03/1962, nella sua qualità di Datore di Lavoro e Responsabile dell’Area Foreste della Comunità Montana "Alburni" (P.I. 8200303 0655), in virtù della disposizione Presidenziale n. 2 del 15/01/2018, per conto, in nome e nell’interesse della quale interviene nel presente atto; 2) _______________________, nato ___________ (_____) il _________________, C.F. ________________________ in qualità di _______________________________della Società ____________________, con sede in via ____________________________ - ___________________ (____), Partita IVA. _________________. PREMESSO - che con Determina del Datore di Lavoro n. ____ del ____________ è stata indetta gara per l’appalto riguardante l’espletamento delle funzioni di medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria del personale in dotazione all’Ente; - che con Determina del medesimo Datore di Lavoro n. ____ del _________________, alla ____________________________________________, con sede in via _________________________ - ________________, è stato conferito l’incarico in argomento. TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE Art. 1) - La premessa è patto. Art. 2) - La Comunità Montana Alburni rappresentata dal dott. agr. Serafino Pugliese, Direttore Tecnico Urbanistico e Datore di Lavoro, conferisce alla __________________, con sede in via ____________________ - _______________ (____), di seguito denominata “incaricato”, che accetta, l’incarico per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria del personale in dotazione all’Ente e per gli adempimenti previsti dall’art. -

Miur - Usr Campania Ufficio X / Atp Salerno Coordinamento Educazione Fisica E Sportiva
MIUR - USR CAMPANIA UFFICIO X / ATP SALERNO COORDINAMENTO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA CALCIO a 11 Cadetti ENTRO IL 28 IL ENTRO MARZO SAIC80900T IST.COMPR. CAMEROTA* CAMEROTA SAIC8BL004 I.C. VALLO LUCANIA - NOVI VELIA VALLO DELLA LUCANIA R1 ENTRO IL 20 APRILE SAIC8AZ00C IST. COMPR. CAPACCIO PAESTUM CAPACCIO S1=VR1-VR2 SAIC8A200N COLLIANO* COLLIANO ENTRO IL 30 APRILE R2 SAIC8BP00B IST.COMPR. CASTELCIVITA CASTELCIVITA F1=VS1-VS2 SAIC8AE005 IST. C. FIORENTINO BATTIPAGLIA* BATTIPAGLIA R3 SAIC857007 IST. C. GIFFONI V.P. "LINGUITI" GIFFONI VALLE PIANA S2=VR3-VR4 SAIC8AX00R IST. COMPR. BELLIZZI BELLIZZI R4 SAIC8AF001 IST. COMPR. MAIORI* MAIORI CALCIO a 11 - I grado : tempi di gioco ridotti, 4 tempi da 7’ 30”.- Circolare 41 del 14 febbraio 2018 CALCIO a 5 Allieve ENTRO IL 20 IL ENTRO MARZO SAIS02600Q P.LETO* TEGGIANO ENTRO IL 7 APRILE R60 SAPS10000T "L. DA VINCI" VALLO DELLA LUCANIA S60=VR60-VR61 SAIS03600A "PARMENIDE"* ROCCADASPIDE SAPS11000C "A.GATTO" AGROPOLI R61 ENTRO IL 20 APRILE SAIS05700B IIS - IPSAR "G.B. PIRANESI" CAPACCIO F60=VS60-VS61 RITIRATO SAIS029007 "E. FERRARI"* BATTIPAGLIA COMPLETATO R62 SAIS024004 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE MONTECORVINO ROVELLA S61=VR62-VR63 COMPLETO E DA DISPUTARE SAPC040008 "F. DE SANCTIS"* SALERNO IN SCADENZA R63 SAPS18000P "B. RESCIGNO" ROCCAPIEMONTE NON PERVENUTO CALCIO a 5 - II grado: tempi di gioco ridotti, “4 tempi da 5 minuti”. - Circolare 41 del 14 febbraio 2018 L’organizzazione del raggruppamento è affidata ai docenti referenti dei CSS delle Istituzioni scolastiche indicate da un asterisco, con il compito di: a. concordare la data (raggruppamento a 3) o le date (raggruppamento a 4) e la/e sede/i con le altre istituzioni scolastiche del raggruppamento; b. -

Il Bacino Del Sele
Mio soltanto è il paese dell’anima mia. Marc Chagall IL BACINO DEL SELE J. P. Hackert: Veduta ideale di tempio, fiume, animali e Mercurio pastore, 1787. Museo Hermitage di Sanpietroburgo Silarus dovrebbe completare l’escursione bibliografica sui bacini fluviali della Campania interessati storicamente da opere di bonifica. Come per il Volturno, il Sebeto e il Sarno si proverà a fornire una traccia di ricerca storico-territoriale su quest’ambito geografico, a partire dalle fonti classiche e sino alle vicende dell’età contemporanea, sfiorando l’attualità e - inevitabilmente - le contraddizioni e le storie di degrado che ci riguardano. Il bacino del fiume Sele (75 Km dalle sorgenti di Caposele al mare, portata 69 m³/s), inclusi quelli dei due maggiori affluenti, Tanagro e Calore Lucano, ha una estensione di circa 3.300 Kmq, pari al 67% della superficie della Provincia di Salerno. Da questi pochi dati si desume la sua importanza territoriale nella geografia della regione. Oltre alla considerazione della notevole risorsa idrica, vorremo, per quanto detto, prendere avvio dalla valenza storica del fiume e della sua peculiare funzione di frontiera, linea di demarcazione sotto diversi aspetti tra le due aree segnate dal suo corso: - la zona di influenza etrusca (in destra) e quella greca e lucana (in sinistra); - la pianura storica dell’agricoltura intensiva (in destra) contrapposta alle propaggini collinari del Cilento storico e alla prevalente pastorizia; - i caratteri geomorfologici e la composizione chimica dei terreni, fertili e più asciutti in destra, salini e con maggiore tendenza all’impaludamento quelli in sinistra. FONTI BIBLIOGRAFICHE A. IL VICEREGNO A.1.