Tesi Di Laurea In
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

UC Santa Barbara UC Santa Barbara Electronic Theses and Dissertations
UC Santa Barbara UC Santa Barbara Electronic Theses and Dissertations Title Unstill Life: The Emergence and Evolution of Time-Lapse Photography Permalink https://escholarship.org/uc/item/2q89f608 Author Boman, James Stephan Publication Date 2019 Peer reviewed|Thesis/dissertation eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California UNIVERSITY OF CALIFORNIA Santa Barbara Unstill Life: The Emergence and Evolution of Time-Lapse Photography A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in Film and Media Studies by James Stephan Boman Committee in charge: Professor Janet Walker, Chair Professor Charles Wolfe Professor Peter Bloom Professor Colin Gardner September 2019 The dissertation of James Stephan Boman is approved. ___________________________________________________ Peter Bloom ___________________________________________________ Charles Wolfe ___________________________________________________ Colin Gardner ___________________________________________________ Janet Walker, Committee Chair March 2019 Unstill Life: The Emergence and Evolution of Time-Lapse Photography Copyright © 2019 By James Stephan Boman iii ACKNOWLEDGMENTS I would like to thank my friends and colleagues at UC Santa Barbara, including the fellow members of my cohort—Alex Champlin, Wesley Jacks, Jennifer Hessler, and Thong Winh—as well as Rachel Fabian, with whom I shared work during our prospectus seminar. I would also like to acknowledge the diverse and outstanding faculty members with whom I had the pleasure to work as a student at UCSB, including Lisa Parks, Michael Curtin, Greg Siegel, and the rest of the faculty. Anna Brusutti was also very important to my development as a teacher. Ross Melnick has been a source of unflagging encouragement and a fount of advice in my evolution within and beyond graduate school. -

L'arte Di Fare Teatro Fra Intuizione E Ragione
GIORGIO STREHLER ..................................................................................................................................................................................................................... L’arte di fare teatro fra intuizione e ragione testi di Alberto Bentoglio, Marco Blaser e Claudio Magris introduzione di Rita Levi Montalcini L’arte di fare teatro fra intuizione e ragione ..................................................................................................................................................................................................................... «Il teatro è l’attiva riflessione dell’uomo su se stesso»: una riflessione questa che un mae- stro, un regista quale Giorgio Strehler ha saputo conciliare al meglio con la sua vita. È riuscito, infatti, a contrapporre la vita alla scena, dove tutte le libertà sono possibili. La sua imponente produzione artistica è la testimonianza di una crescita culturale che vede unito il teatro italiano a quello della scena europea. La sua attività di cinquanta anni lo ha visto impegnato alla direzione del “Piccolo” di Milano da lui fondato nel 1947 con Paolo Grassi. Strehler è riuscito a sviluppare un lavoro teatrale legato al realismo poetico attraverso le opere di grandi autori, quali Shakespeare, Goldoni, Pirandello, Brecht, Bertolazzi, Cechov. Ha percorso non sol- tanto la strada del teatro con l’apporto di regista anche all’opera lirica, ma la sua conoscenza della musica ha fatto eccellere la sua “abilità” nell’aver saputo “svecchia- re” le arretrate tradizioni teatrali creando l’epifania di un metodo teatrale del tutto nuovo, offrendo agli spettatori di ogni estrazione sociale la proiezione di un calei- doscopio fantastico del mondo dell’arte, della poesia e della musica. Parole e musica hanno diretto la vita di A pagina I: Ritratto di Giorgio Giorgio Strehler così come egli stesso ha Strehler nel 1974. diretto la musica e il teatro. A sinistra: Una scena del Faust. -

Clay Paky Illuminates Milan’S Piccolo Teatro
Clay Paky illuminates Milan’s Piccolo Teatro | 1 Photo credits: Davide Barbetta Milan, Italy – the Piccolo Teatro in Milan was Italy’s first permanent theatre and was declared a theatre of major European importance by Ministerial Decree in 1991. It was founded in the immediate post-war period by Paolo Grassi, Giorgio Strehler, Mario Apollonio, Virgilio Tosi and Nina Vinchi. The “Piccolo” consists at present of three venues: the Sala Grassi, the 19th-century Teatro Fossati, which reopened in 1986 under the name Teatro Studio Melato, and the Teatro Strehler. The Teatro Studio Melato started life as an experimental theatre, a training ground for the young students from the Piccolo Theatre School, and home to the international master classes which are held there annually. Its circular design is greatly appreciated by directors from all over the world for the special relationship it allows actors to establish with their audience. The theatre was recently equipped with Clay Paky Alpha Profile 800s for the show “E io dico no: ogni notte ha un’alba” (And I say ‘no, every night has a dawn’). The lighting designer and lighting department manager Claudio De Pace explained how he made his choice: “I had recently used Clay Paky 700s in some shows staged outside our theatre, especially in conjunction with the Milan Furniture Fair for a production at the Teatro dell’Arte. I was very satisfied with their reliability and luminous efficiency. When it came to equipping the Teatro Clay Paky illuminates Milan’s Piccolo Teatro | 2 Piccolo with a new set of lights, I decided to do several tests on site with other brands, but in the end I opted for Alpha Profile 800s. -

Representaciones Fílmicas De Aparatos
Representaciones fílmicas de R ESUMEN / El presente trabajo busca A BST R ACT / This paper seeks to aparatos, responder cómo se ha relacionado el answer how cinema has related itself cine con aparatos, juguetes y espectácu- to devices, toys and optical spectacles juguetes y los ópticos anteriores a la invención that preceded the invention of the espectáculos del cinematógrafo. Para dar respuesta cinematograph. To answer this ques- a esta pregunta se realizó el rastreo tion we tracked the appearance of ópticos anteriores de la aparición de cámaras obscuras, dark cameras, shadow shows, magic espectáculos de sombras, linternas lanterns, panoramas, flip books, thau- al cine: un mágicas, panoramas, filoscopios, tau- matropes, phenakistoscopes, zoetropes, matropos, fenaquistoscopios, zoótropos, praxinoscopes, optical theaters and recurso de praxinoscopios, teatros ópticos y otros other artifacts and optical spectacles autorreflexividad artefactos y espectáculos ópticos en 70 in 70 films from different countries películas de distintos países producidas produced between 1903 and 2017. metaficcional entre 1903 y 2017. Además se efectuó In addition to this, we carried out the el microanálisis formal de secuencias de formal microanalysis of sequences of cinco casos de estudio para estudiar la five case studies in order to study the R OCÍO G ONZÁLEZ función retórica y simbólica que desem- rhetorical and symbolic function that peñan en estos filmes dichos aparatos y these devices and shows perform in DE A R CE A R Z AVE espectáculos. Los resultados -

Variations Et Continuité De L'arlequin, Serviteur De Deux Maîtres De
Métamorphoser la reprise : variations et continuité de l’Arlequin, serviteur de deux maîtres de Giorgio Strehler Aude Astier Giorgio Strehler, au cours de ses cinquante années à la tête du Piccolo Teatro de Milan, a mis sept fois en scène, chaque fois de manière différente, Arlequin, serviteur de deux maîtres de Carlo Goldoni. Cette reprise, d’une durée inédite dans l’histoire du théâtre, s’est poursuivie après sa mort en 1997, L’Arlequin étant toujours à l’affiche du Piccolo Teatro en 2013. Cette persévérance dans un geste de reprise conduit à en interroger les raisons et à en déplier les variations. La reprise de l’Arlequin permet de renouer avec l’héritage de la Commedia dell’arte dans un geste de réappropriation qui dépasse la reconstitution pour mener une recherche sur l’essence du jeu et sur l’évolution d’un geste artistique au fil des ans qui provoque la métamorphose de la reprise et la confronte aux enjeux de la mémoire, de l’invention scénique et de la programmation. 24 juillet 1947 : la saison inaugurale du Piccolo Teatro de Milan, fondé quelques mois auparavant1, se clôt par la création d’une pièce de Carlo Goldoni, symbole de la refondation d’un répertoire italien qui ne délaisse pas les dialectes et renoue avec un sentiment de fierté nationale, nécessaire dans cette période de reconstruction d’une nation et d’un répertoire étouffés par les années de fascisme. Rebaptisée Arlequin, serviteur de deux maîtres, pour indiquer plus clairement au public son appartenance à la Commedia dell’arte et son caractère comique, Le serviteur de deux maîtres est la première pièce de Goldoni, écrite à partir du répertoire dell’arte. -

New Findings and Perspectives Edited by Monica Dall’Asta, Victoria Duckett, Lucia Tralli Researching Women in Silent Cinema New Findings and Perspectives
in Silent Cinema New Findings and Perspectives edited by Monica Dall’Asta, Victoria Duckett, lucia Tralli RESEARCHING WOMEN IN SILENT CINEMA NEW FINDINGS AND PERSPECTIVES Edited by: Monica Dall’Asta Victoria Duckett Lucia Tralli Women and Screen Cultures Series editors: Monica Dall’Asta, Victoria Duckett ISSN 2283-6462 Women and Screen Cultures is a series of experimental digital books aimed to promote research and knowledge on the contribution of women to the cultural history of screen media. Published by the Department of the Arts at the University of Bologna, it is issued under the conditions of both open publishing and blind peer review. It will host collections, monographs, translations of open source archive materials, illustrated volumes, transcripts of conferences, and more. Proposals are welcomed for both disciplinary and multi-disciplinary contributions in the fields of film history and theory, television and media studies, visual studies, photography and new media. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ # 1 Researching Women in Silent Cinema: New Findings and Perspectives Edited by: Monica Dall’Asta, Victoria Duckett, Lucia Tralli ISBN 9788898010103 2013. Published by the Department of Arts, University of Bologna in association with the Victorian College of the Arts, University of Melbourne and Women and Film History International Graphic design: Lucia Tralli Researching Women in Silent Cinema: New Findings and Perspectives Peer Review Statement This publication has been edited through a blind peer review process. Papers from the Sixth Women and the Silent Screen Conference (University of Bologna, 2010), a biennial event sponsored by Women and Film History International, were read by the editors and then submitted to at least one anonymous reviewer. -

Lefã¨Bvre and Neorealist Cinematic Space As Practice
1 DOI: 10.14324/111.444.amps.2014v5i4.001 Title: Framing the Real: Lefèbvre and Neo- Realist Cinematic Space as Practice David Brancaleone Architecture_media_politics_society. vol. 5, no.4. October 2014 Affiliation: Limerick School of Art and Design, Ireland Abstract: In 1945 Roberto Rossellini’s Neo-realist Rome, Open City set in motion an approach to cinema and its representation of real life – and by extension real spaces – that was to have international significance in film theory and practice. However, the re-use of the real spaces of the city, and elsewhere, as film sets in Neo-realist film offered (and offers) more than an influential aesthetic and set of cinematic theories. Through Neo-realism, it can be argued that we gain access to a cinematic relational and multi- dimensional space that is not made from built sets, but by filming the built environment. On the one hand, this space allows us to “notice” the contradictions around us in our cities and, by extension, the societies that have produced those cities, while on the other, allows us to see the spatial practices operative in the production and maintenance of those contradictions. In setting out a template for understanding the spatial practices of Neo-realism through the work of Henri Lefèbvre, this paper opens its films, and those produced today in its wake, to a spatio-political reading of contemporary relevance. We will suggest that the rupturing of divisions between real spaces and the spaces of film locations, as well the blurring of the difference between real life and performed actions for the camera that underlies much of the central importance of Neo-realism, echoes the arguments of Lefèbvre with regard the social production of space. -

Il Teatro Ad Iniziativa Pubblica in Italia Premessa
Merli-fronte-350-7 9-11-2007 17:13 Pagina 1 STUDI E RICERCHE Chiara Merli IL TEATRO AD INIZIATIVA PUBBLICA IN ITALIA PREMESSA Il presente volume intende tracciare una panoramica storica e geogra- fica del teatro ad iniziativa pubblica in Italia, in un arco di tempo che dagli inizi del Novecento arriva fino ai giorni nostri. L’obiettivo non è quello di ricostruire la storia dell’intervento pub- blico nei confronti del teatro – che può essere comunque ripercorsa nelle sue tappe fondamentali attraverso il riferimento, nel testo e nelle note, ai principali provvedimenti legislativi attuati dallo Stato italiano in materia di spettacolo – bensì quello di studiare la storia, remota e recente, del sistema teatrale italiano nel Novecento, per evidenziare da un lato le trasformazioni e i progressivi approfondimenti dei concetti di ‘teatro pubblico’ e di ‘stabilità’, dall’altro l’evoluzione del nucleo costi- tuito dai teatri stabili a matrice pubblica. La prima parte del volume traccia quindi una prospettiva storica, mentre la seconda cerca di scattare una fotografia dei sedici 1 teatri stabili ad iniziativa pubblica, raggruppandoli per area geografica: di ciascuno stabile, sono riassunte le principali direttrici artistiche, pro- duttive e gestionali, con particolare attenzione alle personalità che ne hanno caratterizzato la storia ed uno sguardo critico alla più recente attività. Le ragioni della sproporzione esistente tra gli spazi dedicati nel volume a ciascuno stabile devono essere rintracciate anzitutto nel differente peso rivestito da ciascun -

Études Photographiques, 30 | 2012 Un Paese (1955) and the Challenge of Mass Culture 2
Études photographiques 30 | 2012 Paul Strand / Kodak / Robert Taft versus Beaumont Newhall Un Paese (1955) and the Challenge of Mass Culture Maria Antonella Pelizzari Electronic version URL: http://journals.openedition.org/etudesphotographiques/3483 ISSN: 1777-5302 Publisher Société française de photographie Printed version Date of publication: 20 December 2012 ISBN: 9782911961304 ISSN: 1270-9050 Electronic reference Maria Antonella Pelizzari, « Un Paese (1955) and the Challenge of Mass Culture », Études photographiques [Online], 30 | 2012, Online since 25 June 2014, connection on 04 May 2019. URL : http://journals.openedition.org/etudesphotographiques/3483 This text was automatically generated on 4 May 2019. Propriété intellectuelle Un Paese (1955) and the Challenge of Mass Culture 1 Un Paese (1955) and the Challenge of Mass Culture Maria Antonella Pelizzari The author wishes to thank Sally Stein, for her suggestions at an early stage of the manuscript; the staff at the Archive at the Center for Creative Photography, Tucson, Arizona, the Zavattini Archive in Rome, and the Getty Research Institute, where the Newhall Archive is conserved; and Amanda Bock and Peter Barberie, at the Philadelphia Museum of Art. 1 Un Paese, the first ever significant photobook in Italy, was launched in April 1955, by a left-leaning publisher in Turin, Giulio Einaudi.1 It was coauthored by the American photographer Paul Strand and the Italian screenwriter Cesare Zavattini. Un Paese was the first volume of a new series, titled Italia Mia, where Zavattini, renowned for films such as Shoeshine and The Bicycle Thief, intended to bring his neorealist credo, based on the everyday life of common people, into an editorial project centred on photography.2 The spirit of the series, and of this book in particular, reflected a much broader involvement on the part of postwar intellectuals towards a rediscovery of the country through regional narratives. -

Giorgio Strehler
GIORGIO STREHLER ..................................................................................................................................................................................................................... The art of making theatre, between intuition and intellect by Rita Levi Montalcini, Alberto Bentoglio and Marco Blaser with reminiscences by Claudio Magris The art of making theatre, between intuition and intellect ..................................................................................................................................................................................................................... “Theatre is man’s active reflection about himself” - active reflection that the stage director and grand master of theatre Giorgio Strehler always knew how to reconcile with his life’s work. In fact, he managed to counterpose life and the stage, where all liberties are possible. His impressive artistic output is the best tes- timony to the cultural growth that now unites Italian theatre with its European counterparts. For fifty years Strehler directed the Piccolo Teatro in Milan, which he and Paolo Grassi founded in 1947. Over the course of his career, Strehler managed to develop a theatre rich in poetic realism by staging the works of great playwrights such as Shakespeare, Goldoni, Pirandello, Brecht, Bertolazzi and Chekhov. Not only was he engaged in theatre and also opera, but his knowledge of music gave him plenty of opportunity to use his skill in “updating” certain old-fashioned theatrical -

Framing the Real: Lefèbvre and Neo
Title: Framing the Real: Lefèbvre and Neo- Realist Cinematic Space as Practice Authors: David Brancaleone Architecture_media_politics_society. vol. 5, no.4. October 2014 Fig. 1. Rossellini’s Paisà (1946) goes where “transient life manifests itself most conspicuously”. The viewer is made to wander through Naples in a fiction. Its mimesis enables the GI to describe to Pasquale the skyscrapers of New York, while sitting on a pile of rubble. Their seemingly erratic trajectory confronts the viewer with the real city. The wandering ceases when faced with a crowd of displaced people actually living in the caves of Mergellina who become fleeting screen presences in the Naples episode’s shocking denouement. Introduction In 1945 Roberto Rossellini’s Neo-realist Rome, Open City set in motion an approach to cinema and its representation of real life – and by extension real spaces – that was to have international significance in film theory and practice.1 However, the re-use of the real spaces of the city, and elsewhere, as film sets in Neo-realist film offered (and offers) more than an influential aesthetic and set of cinematic theories.2 Through Neo-realism, it can be argued that we gain access to a cinematic relational and multi-dimensional space that is not made from built sets, but by filming the built environment. On the one hand, this space allows us to “notice” the contradictions around us in our cities and, by extension, the societies that have produced those cities, while on the other, allows us to see the spatial practices operative in the production and maintenance of those contradictions. -
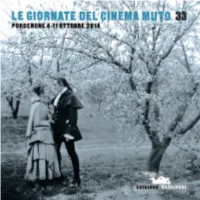
GCM2014 Catalogo Plus.Pdf
The 33rd Pordenone Silent Film Festival is dedicated to PETER VON BAGH (1943-2014) “We are the last generation which could know everything” ASSOCIAZIONE CULTURALE Italia: Aldo Bernardini; Irela Núñez Del Pozo, “LE GIORNATE DEL CINEMA MUTO” Franca Farina, Emiliano Morreale, Mario Musumeci (Centro Sperimentale di Cinematografia – Soci fondatori Cineteca Nazionale); Carmen Accaputo, Davide Paolo Cherchi Usai, Lorenzo Codelli, Pozzi (Cineteca di Bologna / L’Immagine Ritrovata); Piero Colussi, Andrea Crozzoli, Luciano De Giusti, Luisa Comencini, Matteo Pavesi (Cineteca Livio Jacob, Carlo Montanaro, Mario Quargnolo†, Italiana); Fotocinema; Sergio Mattiassich Germani; Piera Patat, Davide Turconi† Luca Giuliani; Alberto Barbera, Donata Pesenti Presidente Campagnoni, Claudia Gianetto (Museo Nazionale Livio Jacob del Cinema); Alessandra Montini (Orchestra Direttore San Marco); Federico Striuli; Fulvio Toffoli; Jay David Robinson Weissberg Olanda: Lotte Belice Baltussen; Rommy Albers, Ringraziamo per la collaborazione al programma: Sandra Den Hamer, Annike Kross, Marleen Labijt, Austria: Paolo Caneppele, Oliver Hanley, Alexander Mark-Paul Meyer, Elif Rongen-Kaynakçki (EYE Horwath (Österreichisches Filmmuseum) Filmmuseum); Oliver Gee; Nico de Klerk; Bregt Belgio: Nicola Mazzanti, Clémentine De Blieck Lameris (Cinémathèque Royale de Belgique) Norvegia: Tina Anckarman, Bent Kvalvik (Nasjonal- Finlandia: Antti Alanen, Peter von Bagh biblioteket) Francia: Mahboubi Fereidoun, Eric Le Roy Regno Unito: William Barnes; Bryony Dixon, Sonia (Archives françaises