Collalto Sabino)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Collalto Sabino - Varco Sabino
Ai comuni di - Ascrea - Castel di Tora - Paganico Sabino - Marcetelli - Collegiove - Nespolo - Rocca Sinibalda - Collalto Sabino - Varco Sabino Oggetto: richiesta di pubblicazione sul sito istituzionale Con la presente, si chiede di poter cortesemente pubblicare sul Vs sito istituzionale l'allegato avviso pubblico. Il Direttore Dott. Luigi Russo Via Roma 33, Varco Sabino (RI) – Tel. (+39) 0765 790002 – Fax(+39) 0765 790139 [email protected] – [email protected] Avviso Pubblico Procedura esplorativa di mercato per lavori di manutenzione straordinaria urgente presso l'ostello "IL GHIRO" di proprietà della Riserva Naturale Regionale Monti Navegna e Cervia sito in Marcetelli, va Teglieto snc. Il Responsabile unico del procedimento informa che essendovi la necessità di disporre della struttura entro e non oltre il 5 gennaio 2017 occorre, per motivazioni non dovute alla stazione appaltante Riserva Naturale Regionale Monti Navegna e Cervia effettuare un intervento urgente e improcrastinabile finalizzato alla messa in funzione della caldaia. In ragione dell'importo dei lavori e dell'improcrastinabilità ed urgenza degli stessi, è intenzione della Riserva Naturale effettuare la scelta del contraente tramite affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2 Dlgs 50/2016 nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione degli incarichi. Le lavorazioni necessarie sono le seguenti: 1) Fornitura e posa in opera, comprensiva del collegamento alla caldaia, di una canna fumaria esterna in acciaio INOX AISI316L a doppia parete coibentata Di=200mm e De= 250 mm per una lunghezza totale di 10 metri lineari. Ivi compresi i collegamenti murari e ogni altro onere e magistero per consegnare l'opera nella perfetta regola dell'Arte. -

The Long-Term Influence of Pre-Unification Borders in Italy
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics de Blasio, Guido; D'Adda, Giovanna Conference Paper Historical Legacy and Policy Effectiveness: the Long- Term Influence of pre-Unification Borders in Italy 54th Congress of the European Regional Science Association: "Regional development & globalisation: Best practices", 26-29 August 2014, St. Petersburg, Russia Provided in Cooperation with: European Regional Science Association (ERSA) Suggested Citation: de Blasio, Guido; D'Adda, Giovanna (2014) : Historical Legacy and Policy Effectiveness: the Long-Term Influence of pre-Unification Borders in Italy, 54th Congress of the European Regional Science Association: "Regional development & globalisation: Best practices", 26-29 August 2014, St. Petersburg, Russia, European Regional Science Association (ERSA), Louvain-la-Neuve This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/124400 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. -

Emergenza Coronavirus. Per Accedere Al PUA Un Nuovo
Ssa AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: [email protected] C.F. e P.I. 00821180577 DIREZIONE GENERALE Rieti, 02 Aprile 2020 Comunicato Stampa Emergenza coronavirus. Per accedere al PUA un nuovo servizio di Teleassistenza sociale Il nuovo Servizio della Asl di Rieti sarà attivo a partire da domani 3 aprile 2020. La Direzione Aziendale della Asl di Rieti comunica che da domani, 3 aprile 2020, sarà attivo un nuovo servizio rivolto a tutti i cittadini. Si tratta di una linea telefonica PUA, di Teleassistenza sociale, che offre informazioni, orientamento e sostegno a tutti coloro che devono accedere a prestazioni sociosanitarie. Il nuovo Servizio si interfaccia con la rete dei servizi di teleassistenza e/o ai numeri verdi dei Comuni, Associazioni ed Enti del terzo settore, curando l’aggiornamento e la mappatura di tutte le risorse disponibili sul territorio in questa fase emergenziale. Promuove l’integrazione con i servizi sociali, i coordinamenti operativi degli Enti Locali, le Associazioni di Volontariato, predisponendo anche gli interventi assistenziali a domicilio. Assicura il raccordo con il servizio sociale ospedaliero per fornire informazioni e sostegno ai familiari dei pazienti ricoverati e per facilitare la continuità assistenziale ospedale - territorio. L’obiettivo è quello di facilitare l’accesso a tutti i percorsi assistenziali e ai servizi socio-sanitari attivi sul territorio, ma anche il raccordo tra i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta e le persone o famiglie fragili in sorveglianza sanitaria al domicilio e in isolamento sociale. Le linee telefoniche attive sono: Distretto 1 Rieti, Antrodoco, S. -

Ministero Della Salute, Risultati Dell'analisi Condotta Sui Dati Sui Dati
Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA Ufficio di Statistica Oggetto: Regione Lazio – Analisi della rete assistenza ambulatoriale nelle aree interne. Le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili dal Servizio sanitario nazionale costituiscono il livello essenziale di assistenza garantito dal sistema di sanità pubblica in questo regime di erogazione. Si forniscono di seguito i risultati dell’analisi condotta sui dati sui dati relativi alla rete di assistenza ambulatoriale delle aree interne selezionate dalla Regione Lazio, rilevati per l’anno 2012 attraverso le seguenti fonti informative: - Modelli di rilevazione Decreto Ministro della salute 5 dicembre 2006 STS.11 - Dati anagrafici delle strutture sanitarie; STS.21 - Assistenza specialistica territoriale: attività clinica, di laboratorio, di diagnostica per immagini e di diagnostica strumentale. Le informazioni tratte dalle suddette fonti informative consentono di caratterizzare la rete di offerta di assistenza ambulatoriale dei Comuni oggetto di analisi, con riferimento alle strutture sanitarie presenti nelle aree interne (Fonte STS.11) e ai relativi dati di attività (Fonte STS.21 – quadro F). L’analisi è stata condotta sulla base dei dati trasmessi dalla Regione Lazio al Ministero della salute, relativamente ai Comuni ricompresi nelle seguenti aree del territorio regionale: ALTA TUSCIA: Acquapendente, Arlena di Castro, Canino, Capodimonte, Cellere, Farnese, Gradoli, Grotte di Castro, Ischia di -

Agenzia Autonoma Per La Gestione Dell'albo
AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL’ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - SEZIONE REGIONALE LAZIO - DELIBERAZIONE n. 65 del 20 maggio 2002 OGGETTO: CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI ROCCA SINIBALDA (RI), ASCREA (RI), COLLEGIOVE (RI), COLLALTO SABINO (RI), NESPOLO (RI) E TURANIA (RI). DETERMINAZIONI. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il giorno 20 maggio 2002, alle ore 14.00 e seguenti: nella sede di Via Arenula, 41 regolarmente convocato, presenti e assenti: presente assente CALABRESE Giosuè Presidente X CAFORIO Francesco v. Presidente X D’ANGELI Dante Componente X DIACETTI Enrico Componente X LA PADULA Benedetto Componente X MARINI Adriano Componente X MICHETTI Enrico Componente X TALAMO Valerio Componente X Presidente: Giosuè Calabrese Segretario verbalizzante: dr. M. Teresa Pilieci Vista la documentazione trasmessa a questa Sezione Regionale Lazio concernente la Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Rocca Sinibalda (RI), Ascrea (RI), Collegiove (RI), Collalto Sabino (RI), Nespolo (RI) e Turania (RI); Viste le proprie precedenti deliberazioni n. 56 e n. 60 adottate rispettivamente nelle sedute del 22 marzo u.s. e del 6 maggio u.s.; Esaminata la documentazione relativa allo scioglimento delle Convenzioni tra i Comuni di Ascrea–Paganico Sabino (RI) e Collalto Sabino- Nespolo (RI) inviata a seguito dell’ adozione da parte di questo Consiglio di Amministrazione delle sopra citate deliberazioni n. 56/2002 e n. 60/2002; Riscontrato che non si può procedere alla presa d’atto dello scioglimento delle predette Convenzioni in quanto non risulta documentato il rispetto delle procedure relative al suddetto scioglimento; Vista la deliberazione n. 135 adottata dal Consiglio Nazionale di Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2002 che al punto 3) del dispositivo testualmente recita: “Di esprimere, come indirizzo, che le convenzioni per l’ufficio di segreteria, disciplinate dall’art.10, D.P.R. -

Archivio Di Stato Di Rieti Elenco Dei Deceduti Nella Prima Guerra Mondiale Della Provincia Di Rieti
ARCHIVIO DI STATO DI RIETI ELENCO DEI DECEDUTI NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI . DATI TRATTI DAGLI ELENCHI DELL’ALLORA MINISTERO DELLA GUERRA DATI PER COMUNE COMUNE COGNOME NOME GRADO CORPO DATA NASCITA DISTRETTO DATA MORTE LUOGO MORTE CAUSA NOTE APPARTENENZA MORTE Accumoli Formichella Antonio Soldato 5° Regg. 1893, L’Aquila 1918, Accumoli Ferite in Alpini 5 giugno 18 aprile combattime nto Accumoli Gentili Carlo Soldato 17° Regg. 1889, L’Aquila 1917, Nel Bosco di Ferite in Fanteria 5 dicembre 18 maggio Castelnuovo combattime nto Accumoli Ghini Tullio Soldato 1° Regg. 1885, L’Aquila 1918, Accumoli Malattia artiglieria da 9 gennaio 31 ottobre campagna Accumoli Giovagnoli Giuseppe Soldato 11° Regg. 1897, L’Aquila 1917, Sul campo Ferite in bersaglieri 30 gennaio 25 maggio combattime nto Accumoli Luci Giacomo Soldato 262° Regg. 1885, L’Aquila 1917, Sul Monte Ferite in Fanteria 22 dicembre 20 maggio Vodice combattime nto Accumoli Luci Sabatino Soldato 69° Regg. 1898, L’Aquila 1918, Prigionia Malattia Fanteria 12 marzo 2 giugno Accumoli Michelini Emidio Caporal 6° Regg. 1893, L’Aquila 1915, Disperso a In e Fanteria 2 gennaio 26 giugno Kabao (Libia) combattime nto Accumoli Micozzi Umberto Soldato 155° Regg. 1893, L’Aquila 1915, Sul Monte In Fanteria 2 ottobre 22 ottobre San Michele combattime nto Accumoli Moretti Giovanni Soldato 17° Regg. 1889, L’Aquila 1916, Nella sezione Ferite in Fanteria 26 novembre 14 luglio di sanità della combattime 29^ divisione nto Accumoli Murù Francesco Soldato 14° Regg. 1892, L’Aquila1 1915, Disperso sul In Fanteria 22 ottobre 915, 20 ottobre Col di Lana combattime 20 nto ottobre Accumoli Organtini Pietro Soldato 13° Regg. -

Ordinanza Covid 19.Pdf
COMUNE DI NESPOLO PROVINCIA DI RIETI C. F. 00113150577 e-mail: [email protected] www.comunedinespolo.it Reg. Ord. n. 1 /2020 Prot. N.407 Data 11.03.2020 Ordinanza di chiusura al pubblico degli uffici comunali per l’emergenza Covid-19 IL SINDACO VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020, emesso per contenere e fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19; VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020, pubblicato in G.U. del 08.03.2020, emesso per contenere e fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid- 19; VISTA l’Ordinanza Regionale n. Z00005 del 09.03.2020 avente oggetto “Modifiche e integrazioni all'ordinanza Z00004 dell'8 marzo 2020, recante: "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione"; VISTI i precedenti DPCM, i provvedimenti regionali, le note della Prefettura e le altre comunicazioni degli enti competenti, in merito all’epidemia di Covid-19; VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e nello specifico gli artt. 50 e 54 del medesimo decreto; VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica; VISTI lo Statuto, i Regolamenti comunali e gli altri provvedimenti comunali, regionali e nazionali vigenti; CONSIDERATO che l’apertura -

T$LOMUNE DI RIVODUTRI
ìar t$L^ OMUNE DI RIVODUTRI No 3 DEL 14-01-2015 Oggetto: 2. Approvazione Regolamento del Seruizio Assistenza Domiciliare Distrettuale S.A.D. e di Assistenza Domiciliare Integrata Sociosanitaria A.D.I. L?nno duemilaquindici addi quattordici del mese di gennaio alle ore 19:00 e seguenti in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione con awisi spediti nei modi e termini di legge, si è riunito, in seduta Seconda, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: Presenti Assenti PELAGOTTI Barbara P PANICONI Michele P BOSI Marcello P ONOFRI Franco P PERAZZI Cristina P DAMIANI AndTea P ALFREDINI Massimiliano P VISCONTI Sara P LELLI Claudio P MICHELI Anselmo P BARBATO Valerio P Paftecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Modestino Il Sindaco, Barbara PELAGOTTI assunta la presidenza, invita Il Segretario Comunale a procedere alla verifica del numero legale' IL CONSIGLIO COMUNALE Vista la L. n.328 del 28 Novembre 2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"; Vista la legge regionale 9 settembre 1996,n.38 recante "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nelLazio" e successive modificazioni; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15512012 "L.R.38/96, art. 51 DGR n. 8812012 e DGR l10l10l2* programmazione 2012-2014 delle risorse per i Piani di Zona dei Distretti Socio Sanitari. Approvazion. do.rr*"nto concernente Linee guida per la programmazione degli interventi di politica sociale e familiare degli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'art. 4'/, comma 1, lettera c) della L.R. -

Azienda Sanitaria Locale Rieti Domanda Di Visita Fiscale
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: [email protected] C.F. e P.I. 00821180577 DOMANDA DI VISITA FISCALE Accertamento richiesto da Sig /Dr________________________________ (referente a cui inviare le comunicazioni) Ente cui inoltrare il pagamento: ______________________________________________ città:_________________cap___________via:_________________________________ Tel:___________ Pec/fax:_________________ cod. fisc. ________________________ Codice IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni)______________________________ Partita Iva_______________________________________________________________ Informazioni sul dipendente e indirizzo a cui inviare la visita fiscale: Nome_________________________Cognome__________________________________ nato/a:______________________________il_______________________sesso:_______ Codice Fiscale:___________________________________________________________ recapito:_______________cap____via:_______________________________n°_______ Assenza prevista Dal_____________________________________________________________________ Al______________________________________________________________________ Tipo di visita: o Ambulatoriale o Domiciliare In assenza di indicazioni verrà effettuata una visita domiciliare La domanda può essere inviata, entro le ore 10, alle competenti Sedi dei Distretti (vedi allegato) a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata (PEC) Firma e timbro del Responsabile __________________________ AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI Via del Terminillo, -
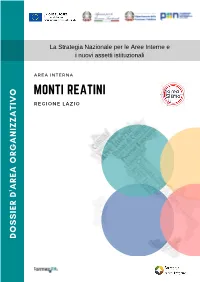
Lazio T a Z Z I N a G R O
La Strategia Nazionale per le Aree Interne e i nuovi assetti istituzionali AREA INTERNA O MONTI REATINI V I REGIONE LAZIO T A Z Z I N A G R O A E R A ' D R E I S S O D Nota introduttiva Le Aree Interne rappresentano una ampia parte del Paese. Si tratta di aree significativamente distanti dai centri di offerta di servizi essenziali (quali istruzione, salute e mobilità) ma ricche di importanti risorse ambientali e culturali, fortemente diversificate per natura e per processi di antropizzazione. Un quarto della popolazione italiana occupa queste aree, con un’estensione territoriale che supera il sessanta per cento del totale della superficie nazionale e interessa oltre quattromila comuni. Il Piano Nazionale di Riforma (PNR) ha individuato e messo in atto una Strategia che ha come obiettivo non solo la ripresa demografica, ma anche un miglioramento qualitativo di vita promuovendo per queste aree uno sviluppo intensivo (benessere e inclusione sociale) ed estensivo (lavoro e utilizzo di risorse locali) attraverso fondi ordinari della Legge di Stabilità e Fondi comunitari. La Strategia Nazionale per le Aree Interne, che coinvolge un quarto dei comuni classificati come aree interne, ha individuato e selezionato 72 aree progetto, ricadenti in ambiti territoriali omogenei, distribuite su tutto il territorio nazionale. Per esse si è avviato un processo di crescita e coesione territoriale. Il Dossier d’area organizzativo è un documento di sintesi (analitica e documentale) su alcune condizioni strutturali dell’area e sulle scelte che i comuni hanno effettuato per rafforzare la loro capacità di gestire i servizi pubblici locali e i progetti previsti dalla Strategia. -

Consorzio Sociale Ri/1
ORIGINALE CONSORZIO SOCIALE RI/1 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE DEL CONSORZIO RI/1 N. 5 DEL 30.11.2016 OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMA COMPRENDENTE IL CONTRATTO DI SERVIZIO 2016-2018 E RELATIVI ALLEGATI L’anno duemilasedici (2016), addì 30 Novembre alle ore 17.00, presso la sede dei Servizi Sociali del Comune di Rieti, Viale Morroni 28, sono presenti alla riunione i rappresentanti dei Comuni del Distretto Ri/1. COMUNE - ENTE PRESENTI ASSENTI ASCREA X BELMONTE X CANTALICE X CASTEL DI TORA X CITTADUCALE X COLLALTO SABINO X COLLE DI TORA X COLLEGIOVE X COLLI SUL VELINO X CONTIGLIANO X GRECCIO X LABRO X LEONESSA X LONGONE SABINO X MONTE S. GIOVANNI X MONTENERO SABINO X MORRO REATINO X NESPOLO X PAGANICO X POGGIO BUSTONE X RIETI X RIVODUTRI X ROCCASINIBALDA X TORRICELLA IN SABINA X TURANIA X ASL Dr. Tomassoni X Risultato legale il numero degli intervenuti ha assunto la Presidenza il Sindaco Alberto Micanti, quale Presidente dell’Assemblea del Consorzio; partecipa alla seduta il Segretario del Consorzio Sociale RI/1 Dott. Avv. Marco Matteocci; Il Sindaco dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto al presente punto dell’O.d.g., premettendo che sulla proposta di deliberazione il Segretario del Consorzio, in assenza dei Responsabili dei servizi, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ha espresso ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.lgs. n. 267 del 18/8/00, parere favorevole. L'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO PREMESSO CHE: - Il Consorzio Sociale RI/1 è stato costituito ai sensi dell'art. -

Modalita' Individuazione Contraente Tipologia Incarico Individuale N U M E R O R E P E R T O R Io C O N T R a T T O S in a L
MODALITA' CONTRATTO O INDIVIDUAZIONE TIPOLOGIA INCARICO INDIVIDUALE AFFIDAMENTO CONTRAENTE NOME OGGETTO LIQUIDAZIONE CIG CONTRAENTE DATA CO.CO.CO. UFFICIO AFFIDAMENTO SETTORE SETTORE CAPITOLO DIRIGENTE DIRIGENTE INCARICO PROFESSIONALE ASSESSORE DIRETTO RINNOVO CURRICULUM INCARICO STUDIO RICERCA E N. LIQUIDAZIONE NORMA O TITOLO NUMERO IMPEGNO NUMERO PROROGA IINCARICO IINCARICO LEGALE IMPORTO LIQUIDATO NUMERO DETERMINA NUMERO CONSULENZA DURATA CONTRATTO IMPORTO IMPEGNATO GARA ALTRA TIPOLOGIA INCARICO CONTRATTO NUMERO FATTURANUMERO DATA E CONTRIBUTO DATI FISCALI o( P.IVA C.F.) SINALLAGMATICO RESPONSABILE PROCEDIMENTO PROCEDIMENTO RESPONSABILE NUMERO REPERTORIO REPERTORIO NUMERO DOTT.SSA Rimborso spese chilometriche documentate alla DOTT.SSA MANUELA DE ADONELLA CASA DI 2102 DEL Dipendente Colasanti II STEFANIA signora COLASANTI Antonella – Periodo: 01.01.2012 1 03,01,2013 NON NON NON NON NON 516,00 2012/3064 381,30 2179/00 NON NON NON NON NON NON NON ALFIERI SCOPIGNO RIPOSO 30,08,2012 Antonella MARIANTONI – 31.12.2012. DOTT.SSA Liquidazione fattura alla Soc. Coop Sociale “NEMO” DOTT.SSA MANUELA DE PIAGNERELLI 2569 DEL Soc. Coop Sociale II Affari Generali STEFANIA a.r.l. per la gestione del Centro per minori “Il Nespolo” 2 08,01,2013 NON NON NON 114.000,00 2012/3778 28.500,00 2036/00 01053000573 26/2012 AFFIDAMENTO DIRETTO NON NON NON ALFIERI FABRIZIO 31,10,2012 “NEMO” a.r.l. MARIANTONI e progetto Semiautonomia - mese di Ottobre 2012 31,12,2012 L. 328/2000 L. 328/2000 17,09,2012 - 17,09,2012 ZCE07A0F2D UFFICIO DI DOTT.SSA Liquidazione fattura alla Soc. Coop Sociale “NEMO” DOTT.SSA MANUELA DE PIAGNERELLI 2557 DEL 2012/5424 Soc. Coop Sociale II PIANO STEFANIA a.r.l.