Pauli PUC Monserrato Documento Di Scoping
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Comune Di Quartu Sant'elena
Proto D. 2'rZ50 ~ Comune di Quartu Sant'Elena MODIFICA DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA I COMUNI DI MONSERRATO, QUARTU SANT'ELENA, QUARTUCCIU, SELARGIUS, SETTIMO SAN PIETRO E SINNAI, PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS MET ANO L'anno duemilaotto, addi venti del mese di Giugno aIle ore 09.50 nella sala Consiliare del Comune di Via Eligio Porcu, convocato dal Presidente con avvisi scritti, a termini dell'art.3 del Regolamento, e riunito in seduta Pubblica, in prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: CONSIGLIERI I PRESENTE CONSIGLIERI I PRESENTE MELIS Carlo SI MARINI Gabriele SI ANGIUS Federica SI MAZZUZZI Francesca SI ANGIUS Romina SI MURGIA Mario NO CANU Marco SI MURGIONI Rita SI CAREDDA Roberto SI ~AITANA Vincenzo SI CARTA Luisa SI ORRU' Gabriele NO COCCO Dino SI PORCEDDU Alfredo SI DE CAMPUS Giancarlo NO RUGGERI Luigi SI DESSI' Alfredo SI SARRITZU Graziano SI DESSI' Emanuele SI SARRITZU Guido SI FARRIS Maurizio SI SARRITZU Luisella NO GITANI Cristian NO SCARPA Ugo SI INZAINA Giovanni Maria SI SECCI Stefano SI LOBINA Antonio SI STOCCHINO Giuseppe SI MARCI Raffaele SI TOCCO Giovanni SI MARIANI Roberto SI Presenti: 26 Assenti: 5 Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale Prof. MELIS Carlo, ed assiste il Segretario Generale Dott. Renzo SERRA. II Presidente nomina scrutatori i Sigg. Consiglieri MARCI Raffaele, SECCI Stefano, SCARPA ~ Premesso: che I'lntesa Istituzionale di Programma Stato-Regione Sardegna del 21.04.1999 ha previsto quale primo Accordo di Programma Quadro la metanizzazione delia Sardegna; che con decreto del ministero delle Attivita Produttive 29.9.2005 sono stati impartiti indirizzi e criteri per la c1assificazione delle reti regionali di trasporto del gas e per I'allacciamento diretto di utenze aile stesse reti; che la Regione Autonoma delia Sardegna, con deliberazione G.R. -
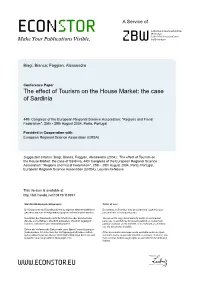
The Case of Sardinia
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Biagi, Bianca; Faggian, Alessandra Conference Paper The effect of Tourism on the House Market: the case of Sardinia 44th Congress of the European Regional Science Association: "Regions and Fiscal Federalism", 25th - 29th August 2004, Porto, Portugal Provided in Cooperation with: European Regional Science Association (ERSA) Suggested Citation: Biagi, Bianca; Faggian, Alessandra (2004) : The effect of Tourism on the House Market: the case of Sardinia, 44th Congress of the European Regional Science Association: "Regions and Fiscal Federalism", 25th - 29th August 2004, Porto, Portugal, European Regional Science Association (ERSA), Louvain-la-Neuve This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/116951 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. may exercise further usage rights as specified in the indicated licence. -

Avviso Di Avvio Del Procedimento
Mod. CDGT.C.18.10_1_01.07.2008 Anas SpA Società con Socio Unico Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 – Iscr. R.E.A. 1024951 – P.IVA 02133681003 – C.F. 80208450587 Sede legale: Via Monzambano, 10 – 00185 Roma – Tel. 06 44461 - Fax 06 4456224 Sede Compartimentale: Via Biasi, 27 - 09131 Cagliari - Tel. 070/52971 - Fax 070/5297268 Compartimento della Viabilità per la Sardegna ANAS S.P.A. COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER LA SARDEGNA Tel. 07052971 AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO Ai sensi e per gli effetti dei seguenti articoli di legge: • Art. 16 del DPR 327/01, mod. ed integrato dal Dlgs 302/02 • Art.7 e seguenti della Legge 241/90 e succ. mod. • D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; Oggetto: nuova S.S. 195 “Sulcitana” – Tratto Cagliari – Pula” , Lotti 1 e 3 e opera connessa Sud. Adeguamento idraulico L’ANAS S.p.A., nella qualità di Società espropriante delle aree occorrenti per l’esecuzione dei lavori di costruzione della nuova S.S. 195 “Sulcitana” – Tratto Cagliari – Pula” , Lotti 1 e 3 e opera connessa Sud, AVVISA dell’avvio del procedimento ai fini “dell’approvazione del progetto” e “ della dichiarazione di pubblica utilità ” relativo alle aree interessate ai lavori di adeguamento idraulicoindicati in oggetto. Si indica quale Responsabile del Procedimento l’Ing. Enrico Atzeni. Gli atti relativi al progetto dell’opera sono depositati presso i Comuni di Villa San Pietro, Capoterra e Sarroch presso l’Ufficio per le Espropriazioni del Compartimento suddetto dove potranno essere visionati nei giorni e negli orari di ricevimento al pubblico, nello specifico dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 13.00 e il mercoledì dalle 15.00 alle 16.00. -

Settimo San Pietro P I a N O S T R a T E G I C O
COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO P I A N O S T R A T E G I C O BOZZA N I S S A R D I A S S O C I A T I LUGLIO 2006 Indice 4.3. Il nuovo scenario nazionale per la politica di coesione nel periodo 2007-2013............................................................43 1. La gestione del processo .......................................... 2 4.4. Il contesto socio economico......................................47 1.1. Procedimento amministrativo.....................................2 4.4.1. Analisi demografica e tendenze evolutive.............47 1.2. Affidamento dell’incarico di elaborazione del Piano 4.4.2. Analisi della struttura economica locale ...............50 strategico comunale ed intercomunale...................................2 4.5. Valutazioni sugli elementi emersi dalle analisi svolte ....52 1.3. Organizzazione della struttura di lavoro.......................2 5. L’agenda strategica .................................................56 1.3.1. Gruppo di lavoro interno all’amministrazione .........2 5.1. L’ascolto del territorio..............................................56 1.3.2. Gruppo di lavoro esterno: ...................................3 5.1.1. Temi emersi da colloqui, interviste e incontri: 1.4. Cronoprogramma delle attività...................................3 Osservatori Privilegiati ....................................................57 2. Condivisione e comunicazione del piano strategico .. 4 5.1.2. Temi emersi da colloqui, interviste e incontri: 2.1. Il processo inclusivo .................................................4 Operatori -

Comune Di Settimo San Pietro Provincia Di Cagliari
COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO PROVINCIA DI CAGLIARI Rep. N. ____ del ________ CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, SCOLASTICA E SEGRETARIATO SOCIALE PER I COMUNI DEL PLUS 21. CIG: 5815114FDD L’anno duemila------ il giorno ---- del mese di ----, alle ore ----, in Settimo San Pietro nei locali del Municipio, in Piazza Sandro Pertini, davanti a me Dott. -----------, Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell’interesse del Comune ai sensi dell’art.97, comma 4. lettera c) del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si sono costituiti i Sigg.: - Donatella Pani, nata a Cagliari il 30/11/1967, Responsabile dell’Area Socio-culturale del Comune di Settimo San Pietro, la quale compare nel presente atto in qualità di Direttore del PLUS 21 di cui è capofila il Comune di Settimo San Pietro, codice fiscale e partita Iva 80004000925; - ------, nat-- a -- il -----, residente in ----, Via --- n.--, avente C.F.-----, il quale interviene e stipula, nella sua qualità di Rappresentante legale, nel nome e nell’interesse di ----- con sede a --- in via ---- n. ----, partita Iva ----. Della identità e della piena capacità delle sopra costituite parti io Segretario Comunale rogante sono personalmente certo. Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare all’assistenza dei testimoni. PREMESSO CHE - la programmazione del Plus 21 prevede la gestione associata del servizio di assistenza domiciliare e segretariato sociale a decorrere dal 2008; - con deliberazione della Giunta Comunale -

Assemini, Cagliari, Capoterra, Decimomannu, Elmas
Allegato alla Delib.G.R. n. 23/5 del 20.4.2016 CITTÁ METROPOLITANA DI CAGLIARI Assemini, Cagliari, Capoterra, Decimomannu, Elmas, Maracalagonis, Monserrato, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Sarroch, Selargius, Sestu, Settimo San Pietro, Sinnai, Uta, Villa San Pietro. PROVINCIA DI SASSARI Aggius, Aglientu, Alà dei Sardi, Alghero, Anela, Ardara, Arzachena, Badesi, Banari, Benetutti, Berchidda, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Bortigiadas, Borutta, Bottidda, Buddusò, Budoni, Bultei, Bulzi, Burgos, Calangianus, Cargeghe, Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, Codrongianos, Cossoine, Erula, Esporlatu, Florinas, Giave, Golfo Aranci, Illorai, Ittireddu, Ittiri, La Maddalena, Laerru, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Mara, Martis, Monteleone Rocca Doria, Monti, Mores, Muros, Nughedu San Nicolò, Nule, Nulvi, Olbia, Olmedo, Oschiri, Osilo, Ossi, Ozieri, Padria, Padru, Palau, Pattada, Perfugas, Ploaghe, Porto Torres, Pozzomaggiore, Putifigari, Romana, San Teodoro, Santa Maria Coghinas, Santa Teresa Gallura, Sant'Antonio di Gallura, Sassari, Sedini, Semestene, Sennori, Siligo, Sorso, Stintino, Telti, Tempio Pausania, Tergu, Thiesi, Tissi, Torralba, Trinità d'Agultu e Vignola, Tula, Uri, Usini, Valledoria, Viddalba, Villanova Monteleone. PROVINCIA DI NUORO Aritzo, Arzana ,Atzara, Austis, Bari Sardo, Baunei, Belvì, Birori, Bitti, Bolotana, Borore, Bortigali, Cardedu, Desulo, Dorgali, Dualchi, Elini, Fonni, Gadoni, Gairo, Galtellì, Gavoi, Girasole, Ilbono, Irgoli, Jerzu, Lanusei, Lei, Loceri, Loculi, Lodè, Lodine, Lotzorai, Lula, Macomer, -

La Sardegna Cresce Con L'europa
La Sardegna cresce con l’Europa Cagliaritano Territory Basilica of Archaeological area Project jointly funded by the European Union San Saturnino of Sant’Eulalia Operational programme ERDF 2007 – 2013 Cagliari Cagliari EUROPEAN UNION ERDF - European Regional Development Fund - Axis I, Activity line 1.2.3.a. REPUBBLICA ITALIANA P.O.R. ERDF Sardinia 2007-2013, Line 1 “Information Society”, Specific Goal 1.2. “Promoting and developing the information society with a particular attention to those key aspects that will sustain the development of the territory and the quality of life, as health, education and the promotion of culture”, Operational Goal 1.2.3. “Increasing the production of the digital contents”, Action Line of 1.2.3.a. “Actions for the production, publication and sharing on the web and on new media (DTV, mobile T, etc.) of digital contents concerning Sardinia’s culture, literature, music, territory and images for a social fruition”. Cultural heritage Cagliaritano We thank the Superintendence for the Architectural, Landscape, Historical, Artistic and Ethno-An - thropological Heritage for the metropolitan city of Cagliari and for the provinces of Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias and Ogliastra, for the kind cooperation. Territory Basilica of San Saturnino | Cagliari Archaeological area of Sant’Eulalia | Cagliari Cultural heritage Unicity Srl: Sardegna Virtual Archaeology Coordination and Production 3D and 3D Render Reconstruction Cagliaritano and Production Virtual Guided Territory Visits and Virtual Views Production Communication and Multimedia Basilica of San Saturnino Testaluna Srl: Text: Mrs. Lucia Mura 3D Planning and Interactivity Mrs. Rossana Martorelli Polonord Adeste Srl: Archeological area USB Pendrive Production of Sant’Eulalia Text: Mrs. -

090131 Cagliari
CURRICULUM VITAE Cuccu Michele Nato a Cagliari il 02/04/1953 Residente in Via M. Bandello n. 15 - 090131 Cagliari Stato di servizio • Segretario Generale iscritto nella Fascia A** (corso SE.F.A. del 2004; segretario provinciale) Servizi fascia 4^: dal 23.1.1981 al 30.6.98: Ruinas (OR), Armungia, Goni, Silius, Suelli; fascia 3^: Burcei (CA) dall‘ 1.7.98 al 31.12.2000; segreteria generale Monserrato dall'1.1.2001 al 14.9.2011; segreteria generale Iglesias dal 15.9.2011 al 30.9.2013 (acquisizione dell’abilitazione a fascia superiore); segreteria generale Assemini dal 9.10.2013 al 3.8.2015; segreteria generale Provincia Ogliastra dal 4.8.2015 al 27.4.2016; reggente presso la segreteria del Comune di Serramanna dal 23.5.2016 al 20.7.2016; segretario a scavalco presso il Comune di Elmas dal 19 al 21.7.2016; segreteria convenzionata dei Comuni di Sarroch e Siliqua il 4.7.2016; Teulada: 3.2/16.2.2018; 26.2/2.3.2018; 5.3/9.3.2018; supplente a tempo pieno presso la segreteria convenzionata dei Comuni di Samassi e Serrenti dal 7 al 20.7.2016; dal 21 al 25.7.2016; dal 16.8.2016 al 31.7.2017; responsabile dei servizi interni presso il Comune di Serrenti nei suddetti periodi (decreti sindacali nn.9/19.8.2016 e 3/24.2.2017); responsabile dell’area gestione territorio ed ambiente presso il Comune di Samassi nell’ambito della segreteria convenzionata suddetta (decreto sindacale n.11/19.8.2016) e dell’area tecnica dal 3.7.2017 al 16.7.2017 (decreto sindacale n.8/3.7.2017); reggente a tempo pieno presso la segreteria del Comune di Teulada dal 7.8.2017 al 4.10.2017; a scavalco dal 3.2.2018 al 16.2.2018; dal 26.2.2018 al 2.3.2018; dal 5.3.2018 al 9.3.2018; dal 26.3.2018 al 30.3.2018; dal10.4.2018 al 20.4.2018; dal 13.5 al 20.5.2018. -

RIVISTA ANMS DEF 19/05/15 16.19 Pagina 28
4_Spano, Cappai_PAG 28-32_RIVISTA ANMS DEF 19/05/15 16.19 Pagina 28 MUSEOLOGIA SCIENTIFICA MEMORIE • N. 14/2015 • 28-32 ISSN 1972-6848 Il patrimonio culturale dei musei scientifici Firenze 14-16 novembre 2012 a cura di Giovanni Pratesi, Filippo Ceccolini, Stefania Lotti Collezioni private di fossili e siti di provenienza: due realtà da coniugare. L’esempio dell’istituendo “Centro Didattico Museale Geopaleontologico del Territorio” di Monserrato (Provincia di Cagliari) Carlo Spano Università di Cagliari, Via Aritzo, 9. I-09042 Monserrato (CA). E-mail: [email protected] Cristina Cappai Associazione Culturale TANAIS, Via della Pineta, 1. I-09125 Cagliari. E-mail: [email protected] RIASSUNTO Recentemente, il Comune di Monserrato, già sede della Cittadella dell’Università di Cagliari, ha deliberato, su richiesta di C. Spano, di realizzare un “Centro Didattico Museale Geopaleontologico del Territorio”. Fra le atti - vità strategiche del Centro figura la predisposizione di itinerari tematici sugli eventi geologici e sulla conseguen - te paleodiversità documentati nell’Isola. In particolare, i depositi tirreniani sardi costituiscono un bene di grande valore per la ricerca scientifica, per la didattica delle scienze naturali e per il turismo culturale. La struttura autoecologica delle comunità a molluschi presenti nei numerosi siti paleontologici lungo le coste sarde può essere confrontata con quella delle malacofaune attuali e/o spiaggiate. È opportuno progettare e rea - lizzare in Sardegna itinerari tematici che colleghino strettamente il territorio alle scuole, ai musei e ai turisti per una corretta gestione e fruizione dei beni culturali. Parole chiave: Tirreniano, bene geopaleontologico, ricerca, didattica, turismo. ABSTRACT Private fossil collections and sites of origin: two different worlds to be conjugated. -

PLUS 21 Programmazione 2007 – 2009 - Aggiornamento 2009
PLUS 21 Programmazione 2007 – 2009 - Aggiornamento 2009 - SOMMARIO PARTE PRIMA Pag. Premessa 7 Attori coinvolti 8 Procedure attivate per l’implementazione e l’aggiornamento 9 Le Conferenze di Programmazione 9 I Tavoli tematici 9 Le Conferenze dei Sindaci ed i lavori del Gruppo Tecnico di Piano 14 PARTE SECONDA Profilo d’ambito 17 Il quadro Legislativo 17 Il territorio 19 La Popolazione 22 La Famiglia 25 I Tassi di Mortalità 27 Il Lavoro 29 L’Istruzione 33 − Ricognizione dati Scuole 34 − Note sulla frequenza scolastica e sul disagio scolastico nei Comuni 36 dell’Ambito PLUS 21 Risorse del Territorio 39 Risorse umane dei settori politiche sociali dei Comuni 39 Ricognizione offerta Servizi Sociali 43 Ricognizione dei servizi e degli interventi comunali 46 Piano degli interventi di contrasto della povertà 63 Ricognizione strutture socio-assistenziali, sociosanitarie e scolastiche 64 Scheda dei servizi e interventi dell’Assessorato Politiche Sociali alla famiglia e 67 all’immigrazione della Provincia di Cagliari Gruppo tecnico di Piano – PLUS 21 - 2 - Dati assistiti dai Servizi Sanitari 70 Risorse pubbliche dell’ambito 74 Ricognizione delle risorse del privato sociale 84 PARTE TERZA Bilancio sociale del PLUS riferito all’anno 2008 101 Azioni di Sistema 101 - Azione 1 Ufficio di Piano 101 - Azione 1 bis Inserimento di Volontari del Servizio Civile Italia presso l’Ufficio di 103 Piano - Azione 2 Formazione ed aggiornamento 104 - Azione 3 Favorire l’ informazione e la partecipazione 105 - Azione 4 Realizzazione di un -

Armungia Maracalagonis Senorbi' Assemini Monastir
COMUNI DELLA SARDEGNA RIPARTITI SU OTTO TERRITORI PROVINCIALI COMUNI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI ARMUNGIA MARACALAGONIS SENORBI' ASSEMINI MONASTIR SERDIANA BALLAO MONSERRATO SERRI BARRALI MURAVERA SESTU BURCEI NURAGUS SETTIMO SAN PIETRO CAGLIARI NURALLAO SEULO CAPOTERRA NURAMINIS SILIQUA CASTIADAS NURRI SILIUS DECIMOMANNU ORROLI SINNAI DECIMOPUTZU ORTACESUS SIURGUS DONIGALA DOLIANOVA PIMENTEL SOLEMINIS DOMUS DE MARIA PULA SUELLI DONORI QUARTU SANT'ELENA TEULADA ELMAS QUARTUCCIU USSANA ESCALAPLANO SADALI UTA ESCOLCA SAMATZAI VALLERMOSA ESTERZILI SAN BASILIO VILLA SAN PIETRO GERGEI SAN NICOLO' GERREI VILLANOVATULO GESICO SAN SPERATE VILLAPUTZU GONI SAN VITO VILLASALTO GUAMAGGIORE SANT'ANDREA FRIUS VILLASIMIUS GUASILA SARROCH VILLASOR ISILI SELARGIUS VILLASPECIOSA MANDAS SELEGAS COMUNI DELLA PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS BUGGERRU IGLESIAS SAN GIOVANNI SUERGIU CALASETTA MASAINAS SANT'ANNA ARRESI CARBONIA MUSEI SANT'ANTIOCO CARLOFORTE NARCAO SANTADI DOMUSNOVAS NUXIS TRATALIAS FLUMINIMAGGIORE PERDAXIUS VILLAMASSARGIA GIBA PISCINAS VILLAPERUCCIO GONNESA PORTOSCUSO COMUNI DELLA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO ARBUS PABILLONIS SIDDI BARUMINI PAULI ARBAREI TUILI COLLINAS SAMASSI TURRI FURTEI SAN GAVINO MONREALE USSARAMANNA GENURI SANLURI VILLACIDRO GESTURI SARDARA VILLAMAR GONNOSFANADIGA SEGARIU VILLANOVAFORRU GUSPINI SERRAMANNA VILLANOVAFRANCA LAS PLASSAS SERRENTI LUNAMATRONA SETZU COMUNI DELLA SARDEGNA RIPARTITI SU OTTO TERRITORI PROVINCIALI COMUNI DELLA PROVINCIA DI NUORO ARITZO LOCULI OROTELLI ATZARA LODE' ORTUERI AUSTIS LODINE ORUNE BELVI' -

Comune Provincia Rt Cagliari CA 0,45 Assemini CA Capoterra CA Decimomannu CA Elmas CA Maracalagonis CA Monserrato CA Pula CA
Comune Provincia Rt Cagliari CA Assemini CA Capoterra CA Decimomannu CA Elmas CA Maracalagonis CA Monserrato CA Pula CA Quartu Sant'Elena CA 0,45 Quartucciu CA Sarroch CA Selargius CA Sestu CA Settimo San Pietro CA Sinnai CA Uta CA Villa San Pietro CA Aritzo NU NC Arzana NU NC Atzara NU NC Austis NU NC Bari Sardo NU NC Baunei NU NC Belvì NU NC Birori NU NC Bitti NU NC Bolotana NU NC Borore NU NC Bortigali NU NC Cardedu NU NC Desulo NU NC Dorgali NU NC Dualchi NU NC Elini NU NC Fonni NU NC Gadoni NU NC Gairo NU NC Galtellì NU NC Gavoi NU NC Girasole NU NC Ilbono NU NC Irgoli NU NC Jerzu NU NC Lanusei NU NC Lei NU NC Loceri NU NC Loculi NU NC Lodè NU NC Lodine NU NC Lotzorai NU NC Lula NU NC Macomer NU NC Mamoiada NU NC Meana Sardo NU NC Noragugume NU NC Nuoro NU NC Oliena NU NC Ollolai NU NC Olzai NU NC Onanì NU NC Onifai NU NC Oniferi NU NC Orani NU NC Orgosolo NU NC Orosei NU NC Orotelli NU NC Ortueri NU NC Orune NU NC Osidda NU NC Osini NU NC Ottana NU NC Ovodda NU NC Perdasdefogu NU NC Posada NU NC Sarule NU NC Silanus NU NC Sindia NU NC Siniscola NU NC Sorgono NU NC Talana NU NC Tertenia NU NC Teti NU NC Tiana NU NC Tonara NU NC Torpè NU NC Tortolì NU NC Triei NU NC Ulassai NU NC Urzulei NU NC Ussassai NU NC Villagrande Strisaili NU NC Abbasanta OR NC Aidomaggiore OR NC Albagiara OR NC Ales OR NC Allai OR NC Arborea OR NC Ardauli OR NC Assolo OR NC Asuni OR NC Baradili OR NC Baratili San Pietro OR NC Baressa OR NC Bauladu OR NC Bidonì OR NC Bonarcado OR NC Boroneddu OR NC Bosa OR NC Busachi OR NC Cabras OR NC Cuglieri OR NC Curcuris