Cenni Biografici
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
Ferrara Di Ferrara
PROVINCIA COMUNE DI FERRARA DI FERRARA Visit Ferraraand its province United Nations Ferrara, City of Educational, Scientific and the Renaissance Cultural Organization and its Po Delta Parco Urbano G. Bassani Via R. Bacchelli A short history 2 Viale Orlando Furioso Living the city 3 A year of events CIMITERO The bicycle, queen of the roads DELLA CERTOSA Shopping and markets Cuisine Via Arianuova Viale Po Corso Ercole I d’Este ITINERARIES IN TOWN 6 CIMITERO EBRAICO THE MEDIAEVAL Parco Corso Porta Po CENTRE Via Ariosto Massari Piazzale C.so B. Rossetti Via Borso Stazione Via d.Corso Vigne Porta Mare ITINERARIES IN TOWN 20 Viale Cavour THE RENAISSANCE ADDITION Corso Ercole I d’Este Via Garibaldi ITINERARIES IN TOWN 32 RENAISSANCE Corso Giovecca RESIDENCES Piazza AND CHURCHES Trento e Trieste V. Mazzini ITINERARIES IN TOWN 40 Parco Darsena di San Paolo Pareschi WHERE THE RIVER Piazza Travaglio ONCE FLOWED Punta della ITINERARIES IN TOWN 46 Giovecca THE WALLS Via Cammello Po di Volano Via XX Settembre Via Bologna Porta VISIT THE PROVINCE 50 San Pietro Useful information 69 Chiesa di San Giorgio READER’S GUIDE Route indications Along with the Pedestrian Roadsigns sited in the Historic Centre, this booklet will guide the visitor through the most important areas of the The “MUSEO DI QUALITÀ“ city. is recognised by the Regional Emilia-Romagna The five themed routes are identified with different colour schemes. “Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali” Please, check the opening hours and temporary closings on the The starting point for all these routes is the Tourist Information official Museums and Monuments schedule distributed by Office at the Estense Castle. -

Cna85b2317313.Pdf
THE PAINTERS OF THE SCHOOL OF FERRARA BY EDMUND G. .GARDNER, M.A. AUTHOR OF "DUKES AND POETS IN FERRARA" "SAINT CATHERINE OF SIENA" ETC LONDON : DUCKWORTH AND CO. NEW YORK : CHARLES SCRIBNER'S SONS I DEDICATE THIS BOOK TO FRANK ROOKE LEY PREFACE Itf the following pages I have attempted to give a brief account of the famous school of painting that originated in Ferrara about the middle of the fifteenth century, and thence not only extended its influence to the other cities that owned the sway of the House of Este, but spread over all Emilia and Romagna, produced Correggio in Parma, and even shared in the making of Raphael at Urbino. Correggio himself is not included : he is too great a figure in Italian art to be treated as merely the member of a local school ; and he has already been the subject of a separate monograph in this series. The classical volumes of Girolamo Baruffaldi are still indispensable to the student of the artistic history of Ferrara. It was, however, Morelli who first revealed the importance and significance of the Perrarese school in the evolution of Italian art ; and, although a few of his conclusions and conjectures have to be abandoned or modified in the light of later researches and dis- coveries, his work must ever remain our starting-point. vii viii PREFACE The indefatigable researches of Signor Adolfo Venturi have covered almost every phase of the subject, and it would be impossible for any writer now treating of Perrarese painting to overstate the debt that he must inevitably owe to him. -

14 GIOVANNI MARIA BOTTALLA Detto RAFFAELLINO Savona, 1613 - Milano, 1640
Maison d ’Art Tableaux anciens - Objets d ’art S.C.S. Corsini & Cie Park Palace - 27, avenue de la Costa - MC 98000 Monaco Tel (377) 97 97 11 60 Fax (377) 97 97 11 61 Internet site: http://www.oldmasters.com E-mail Monaco: [email protected] Maison d ’Art Presenta / Presents LE MERAVIGLIE DELL’ARTE IMPORTANT OLD MASTER PAINTINGS 25 marzo - 25 aprile 2005 25 March - 25 April 2005 Maison d’Art - Monaco (Monte Carlo) In copertina Cover illustration GIOVANNI MARIA BOTTALLA detto RAFFAELLINO Bacco e Arianna nell’isola di Nasso Bacchus and Ariadne on the Island of Naxus Catalogo n. 14 Catalogue no. 14 © Copyright 2005 by Edizioni Maison d’Art Monaco Tutti i diritti riservati All rights reserved LE MERAVIGLIE DELL’ARTE IMPORTANT OLD MASTER PAINTINGS Maison d’Art - Monaco (Monte Carlo) 25 marzo - 25 aprile 2005 25 March - 25 April 2005 Consulenza scientifica Consultative Committee Hugh Brigstoke Maria Cristina Chiusa Arabella Cifani Frank Dabell Gigetta Dalli Regoli Daniele de Sarno Prignano Mina Gregori Sir Denis Mahon Camillo Manzitti Franco Monetti Filippo Pedrocco Annalisa Scarpa Sonino Robert B. Simon Nicola Spinosa David Stone Marco Tanzi Marietta Vinci-Corsini Tiziana Zennaro Autori delle schede del catalogo Authors of Catalogue Entries Hugh Brigstoke [H.B.] Maria Cristina Chiusa [M.C.C.] Arabella Cifani [A.C.] Frank Dabell [F.D.] Gigetta Dalli Regoli [G.R.] Daniele de Sarno Prignano [D.S.P.] Mina Gregori [M.G.] Camillo Manzitti [C.M.] Franco Monetti [F.M.] Filippo Pedrocco [F.P.] Annalisa Scarpa Sonino [A.S.S.] Robert B. Simon [R.B.S.] Nicola Spinosa [N.S.] Marco Tanzi [M.T.] Marietta Vinci-Corsini [M.V.C.] Coordinamento della mostra Exhibition Coordinator Silvia Bonfante - 5 - Cura e redazione del catalogo Catalogue edited by Frank Dabell Tiziana Zennaro Traduzioni Translation Frank Dabell (Italiano-Inglese): cat. -

Guidafe Pietre.Pdf
Pietre di F. Scafuri III n giro per Ferrara tra Palazzi, Chiese, Conventi e Musei Castello Estense 1 Il castello venne realizzato a partire dal 1385 per volontà del marchese Nicolò II d’Este, su progetto dell’architetto militare Il Castello Estense Bartolino Ploti da Novara. Costruito essenzialmente a fini militari, per contrastare insurrezioni interne alla città ed attacchi esterni, già dalla fine del XV secolo diverse stanze venivano utilizzate come residenza dagli Estensi. Un passaggio sopraelevato, la cosiddetta Via Coperta, ancora esistente, univa l’edificio militare al Palazzo Ducale (oggi Palazzo Comunale), rendendo particolarmente agevoli gli spostamenti della corte da un complesso all’altro. Tuttavia, soltanto a seguito dell’incendio del 1554 il duca Ercole II d’Este ordinò che il castello fosse radicalmente trasformato da fortezza a palazzo, sede della corte 1 6 MMMusei,usei, ChieseChiese ee PalazziPalazzi MM ducale. Gli imponenti lavori furono condotti principalmente dall’architetto Girolamo da Carpi, che sopraelevò di un piano l’edifico, fece abbattere le merlature e realizzò le balconate marmoree, gli appartamenti ducali e le altane; dopo la morte di Girolamo, avvenuta nel 1556, le opere furono poi terminate da Alberto Schiatti. Piuttosto suggestivo il cortile, nonostante gli interventi novecenteschi, che hanno cancellato in gran parte l’intonaco e gli affreschi che lo caratterizzavano, di cui oggi rimangono solo poche tracce; si pensi che tutta la parte alta sopra il cornicione era dipinta con i ritratti degli Estensi e di -

Ligorio E Vasari Si Odiavano, Lo Sappiamo Bene. Ma Di Un Odio
LIGORIO E VASARI. SULLA PAZIENZA DI ERCOLE II D’ESTE E SU GIROLAMO DA CARPI CARMELO OCCHIPINTI Ligorio e Vasari si odiavano, lo sappiamo bene. Ma di un odio talmente forte che ancora oggi chi studia Vasari, per rispetto forse di una così pervicace volontà di damnatio memoriæ nei con- fronti di Ligorio, evita con cura di affrontare l’argomento dete- stato. Viceversa, chi studia Ligorio perlustrando i territori scon- finati dell’erudizione antiquaria riesce, solitamente, a tirarsi fuori da questioni di arte contemporanea: ma è questa, di certo, una delle conseguenze delle attuali, non sempre comunicanti, spe- cializzazioni disciplinari. Ora, ai nostri occhi è proprio l’odio re- ciproco ad attrarre perdutamente i due: giacché un’attrazione tanto conflittuale tra Ligorio e Vasari ci permetterà di ragionare sui modi loro, così diversi, di guardare all’arte contemporanea, di considerare la storia artistica nei suoi avvicendamenti epocali, di valutare la statura dei più grandi maestri dell’età moderna, da Raffaello a Correggio fino a Michelangelo. Ebbene, lo spazio di questo articolo ci consente di affrontare una vicenda che vide Ligorio e Vasari conflittualmente coinvol- ti: quando, tra il 1552 e il 1553, entrambi parteciparono al con- corso indetto dal duca di Ferrara Ercole II d’Este che stava al- lora cercando «l’opinione di tutti i letterati e sottili ingegni» d’Italia perché gli inventassero un’immagine allegorica della Pa- Horti Hesperidum, VI, 2016, I CARMELO OCCHIPINTI zienza.1 Il favore accordato dal principe estense, com’è noto, a Vasari produsse la grande indignazione di Ligorio. Prima, però, di ripercorrere la vicenda per ricavarne le nostre opportune considerazioni, ci sarà utile tornare indietro di poco: risalire, precisamente, al 1550, nella Roma sotto l’esordiente pontificato di papa Giulio III del Monte, quando le ragioni del conflitto tra Ligorio e Vasari dovettero per la prima volta accendersi.2 1. -

Lampi Sublimi È La Concisa Descrizione Con Cui Roberto Longhi (In Officina Ferrarese, 1934) Tradusse Sia L’Essenza Di Alfonso II, 1985; La Mostra a Cura Di A
Michelangelo e Tiziano ad un tempo» (Arcangeli). A terra, tra gli strumenti musicali, lo spartito ha un San Lorenzo ostenta una nudità pagana che reinterpreta quella dei Sapienti. Anche Bastianino dilata ternita del Buon Amore dipinta negli anni ottanta dove i raggi di luce divina sono pennellate diritte e sottili Sebastiano Filippi detto il Bastianino, nasce a Ferrara intorno al 1528, come si evince dal fatto che l’8 dicembre titolo singolare, «Canone. Chi capisce legga»: chi conosce la musica saprà interpretare il testo enig- l’anatomia eroica di Michelangelo, la gonfia e infine quasi la dissolve, velandola come la superficie di un di colore che scendono dalla colomba. Dai vapori, dai lampi, dalla ruggine preziosa aggallano il cestino da 1548 risulta iscritto alla Confraternita della Morte i cui soci dovevano avere compiuto vent’anni. Alla pari del matico dove compare una sola voce, saprà quante sono le altre, quali le entrate e le altezze. Il vecchio vetro appannato dal vapore di un alito. lavoro, il libro, il leggio. Del possibile modello tizianesco (Annunciazione, Venezia, chiesa di San Salvador) è fratello Cesare, apprende il mestiere nella bottega del padre Camillo, attivo nella decorazione delle residenze Bastianino prosegue per la sua strada, anche lui enigmatico oracolo che non rappresenta tutto ma Quali erano le riflessioni di Bastianino su temi scottanti che agitavano il suo tempo?Dialoghi , Vite di pit- scartato tutto ciò che vi è di fragoroso e macchinoso. estensi. Il vuoto documentario e di opere (perdute le pitture del 1546 nel palazzo estense di Copparo e il Gonfa- lascia interpretare e immaginare. -

Inventario Del Fondo Pallucchini
FONDAZIONE GIORGIO CINI ONLUS FONDI FOTOGRAFICI Inventario del Fondo Pallucchini TRECENTO 1) ALTICHIERO ANDREA DA BOLOGNA ANONIMI VENEZIANI DEL ‘300 BARNABA DA MODENA BARTOLOMEO E JACOPINO DA REGGIO BARNABA DA MODENA CRISTOFORO DA FERRARA CRISTOFORO DA FERRARA DALMASIO 2) GUARIENTO GIOVANNETTI, MATTEO FRANCESCO DA RIMINI ANTONIO ALBERTI DA FERRARA GIUSTO DE’ MENABUOI GIOVANNI DA MODENA 3) ALLEGRETTO NUZI GUGLIEMO DA VENEZIA I LORENZETTI LIPPO DI DALMAZIO LORENZO DI BICCI LORENZO VENEZIANO MADONNA DI MAZZOLANO MAESTRO DI SANT’ELSINO MAESTRO VENCESLAO MARTINO DA VERONA MARTINO DA VERONA PITTORE FRIULANO DI FINE ‘300 RIMINESI RIMINESI – CICLO DI TOLENTINO SAN FERMO MAGGIORE – VERONA – ATTRIBUITO A PAOLO VENEZIANO SCUOLA VENEZIANA SEC. XIV SEMITECOLO SENESI DEL ‘200 E ‘300 SERAFINO DE SERAFINI FONDAZIONE GIORGIO CINI ONLUS SIMONE DEI CROCEFISSI TOMMASO DA MODENA TURONE VERONESI DEL ‘300 VITALE DA BOLOGNA 4) [LE BUSTE CONTINUANO LA NUMERAZIONE DEL 3] MAESTRO MEMENTO MORI ANTONIO VENEZIANO CATARINO CATARINO E DONATO STEFANO DI SANT’AGNESE LORENZO VENEZIANO LORENZO VENEZIANO 2 GIOVANNI DA BOLOGNA JACOBELLO ALBEREGNO GUARIENTO 5) PAOLO VENEZIANO 6) PAOLO VENEZIANO QUATTROCENTO 7) ALAMANNI PIETRO (anche con CRIVELLI) ALBERTI ANTONIO ALUNNO NICOLO’ (anche con CRIVELLI) ANDREA DI BARTOLO ANDREA DEL CASTAGNO ANDREA DE LITIO ANDREA DA MURANO ANTONIAZZO ROMANO ANTONIO DA CARPI ANTONIO DA FABRIANO ANTONIO DI JACOPO (DA FIRENZE) ANTONIO DA NEGROPONTE ANTONIO DA PAVIA ARCANGELO DI COLA ARVARI RANUCCIO 8) ANTONELLO DA MESSINA ANTONELLO DA SALIBA 9) BADILE -

Italian Art at the Utah Museum of Fine Arts (UMFA) Spans Several Centuries, from the Late 1300S to the 1900S
Ursula M. Brinkmann Pimentel ITALIAN ART AT THE UTAH MUSEUM OF FINE ARTS A GUIDE TO THE COLLECTION Contributors: Elizabeth A. Peterson Martha A. Seiner Madelyn D. Garrett 1 Copyright © Ursula M. Brinkmann Pimentel 2000 All Rights Reserved Published by the Utah Museum of Fine Arts, University of Utah, Salt Lake City, UT 84112, USA. This publication is made possible, in part, by generous support from Friends of the Art Museum and the Salt Lake City Arts Council. Accredited by the 2 CONTENTS Page Foreword ………………………………………………………..………………………………………………..9 Acknowledgments………………………………………………………………..………………………………10 Catalogue………………………………………………………………………………………………………...11 Explanation of Cataloguing Practices ………………...…………………………………………………………12 Cat. 1 Unknown Italian, Madonna and Child with Angels……………………………………………………..14 2 Unknown Italian, possibly Tuscan, Parchment Leaf from the Proper of Saints, Feast of the Nativity of St. John the Baptist (24 June), Matins, Third Nocturn…………………..……..18 3 Unknown Italian, possibly Tuscan, Parchment Leaf from the Common of Saints, Common of Several Martyrs, Matins, Second-Third Nocturns………………………...………………..21 4 Fra Filippo di Tomaso Lippi, Madonna and Child………………………………………………………23 5 Unknown Italian, Saint Cecilia…………………………………………………………………………..27 6 School of Andrea Mantegna, Entombment with Three Birds……………………………………………31 7 Daniel Hopfer, Battle between Two Tritons, after Andrea Mantegna…………………………………...35 8 Polidoro di Bartolomeo, Crucifixion with Saints (Virgin Mary, Mary Magdalen, St. John the Apostle, St. Francis of Assisi, -

Pannelli Delle Sale
SALA 1 Lo Stato estense. Mito, genealogia e territorio Discendenti da una nobile stirpe germanica stabilitasi in Toscana al seguito di Carlo Magno nel IX sec., gli Este rivendicarono sempre con orgoglio l’antichità delle proprie radici. Il tema dinastico ricorre infatti in molte opere letterarie e figurative commissionate dalla Casa. Primo esempio del genere, la Genealogia estense (1474) raffigura in 169 medaglioni miniati i principi regnanti e le loro mogli e figli, dal capostipite del ramo ferrarese Alberto Azzo (XI sec.) a Ercole I. Nella seconda metà del Cinquecento le rivendicazioni dinastiche assunsero particolare rilevanza nella disputa che vide gli Este contrapporsi ai Medici per ottenere la preminenza diplomatica presso le corti europee. Ne nacquero diversi trattati, fra i quali la storia dei principi di Ferrara pubblicata dal Pigna nel 1569-70. Al testo si ispirò Pirro Ligorio per disegnare la serie degli avi estensi che servì da modello per i perduti affreschi nel cortile del castello di Ferrara nel 1577 e per il ciclo di tele poste nella residenza ducale di Modena nel 1627-28. Genealogia Ferrara: Ercole I (1471 – 1505) Alfonso I (1505 – 1534) Ercole II (1534 – 1559) Alfonso II (1559 – 1597) Modena: Cesare (1597 – 1628) Alfonso III (1628 – 1629) Francesco I (1629 – 1658) Alfonso IV (1658 – 1662) Reggenza di Laura Martinozzi (1662 – 1674) Francesco II (1674 – 1694) SALA 2 La grande eredità del Quattrocento Il Rinascimento prese avvio a Ferrara con il marchesato di Leonello d’Este (1441-50). Allievo del grande umanista Guarino Veronese, egli chiamò i maggiori rappresentanti della nuova arte: Pisanello, Leon Battista Alberti, Piero della Francesca, Mantegna. -
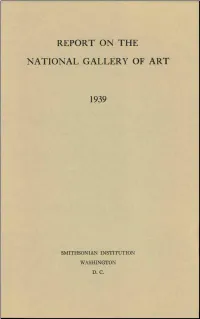
Annual Report 1939
REPORT ON THE NATIONAL GALLERY OF ART 1939 SMITHSONIAN INSTITUTION WASHINGTON D. C. REPORT ON THE NATIONAL GALLERY OF ART FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 1939 From the Smithsonian Report for 1939 Pages 32-46 IPERX UNITED STATES GOVERNMENT PRINTING OFFICE WASHINGTON : 1940 APPENDIX 2 REPORT ON THE NATIONAL GALLERY OF ART SIR : Pursuant to the provisions of section 5 (D) of Public Resolu- tion No. 14, Seventy-fifth Congress, approved March 24, 1937,1 have the honor to submit, on behalf of the Board of Trustees of the Na- tional Gallery of Art, the second annual report of the Board covering )its operations for the fiscal year ended June 30,1939. Under the aforementioned joint resolution, Congress appropriated "to the Smithsonian Institution the area bounded by Seventh Street, ^Constitution Avenue, Fourth Street, and North Mall Drive (now Madison Drive) Northwest, in the District of Columbia, as a site for a National Gallery of Art; authorized the Smithsonian Institu- tion to permit The A. Mellon Educational and Charitable Trust, a public charitable trust, established by the late Hon. Andrew W. Mellon, of Pittsburgh, Pa., to construct thereon a building to be designated the "National Gallery of Art"; and created, in the Smith- sonian Institution, a bureau to be directed by a board to be known as the "Trustees of the National Gallery of Art," charged with the maintenance and administration of the National Gallery of Art. The Board is comprised of the Chief Justice of the United States, the Secretary of State, the Secretary of the Treasury, and the Secre- tary of the Smithsonian Institution, ex officio, and five General Trustees. -

The Renaissance Addition
THE RENAISSANCE Parco urbano G. Bassani ADDITION Via Riccardo Bacchelli Throughout the Middle Ages and almost Porta degli th Angeli to the end of the 15 century, the north- Viale Orlando Furioso ern boundary of the city ran along the current road System of viale Cavour-cor- so Giovecca. To the north of this bound- Via Isabella d’Este ary there were a number of buildings, even prestigious ones, some of which Via Azzo Novello Viale XXV Aprile Via S. Maria degli Angeli CIMITERO were owned by the Duke. In 1492 Ercole I commissioned Biagio Rossetti to include Via Lionello d’Este DELLA CERTOSA this vast area in the centre (thus doubling the surface area of the city) and the great Via Santa Caterina da Siena Via Leopardi architect and town-planner designed Corso Ercole I d’Este Viale Certosa 7 a plan which, due to its original and ra- Via Pavone 6 tional nature, made Ferrara “the first Via Arianuova modern city in Europe”. In honour of the Duke who ordered its building this great 5 Via Guarini district is known as Addizione Erculea. THE itinerary IN BRIEF Via Ariosto Parco Via Pavone Massari CIMITERO CASTELLO ESTENSE EBRAICO Starting point of the route 4 Corso Ercole I d’Este Via Borso Corso B. Rossetti 9 Via Erbe 1 Palazzo di Giulio d’Este Via Vigne 2 Museo del Risorgimento Corso Porta Mare 3 e della Resistenza 8 Corso Porta Mare 3 Palazzo dei Diamanti Piazza Via Cosmè Tura 2 Ariostea 4 Palazzo Prosperi Sacrati 1 Via Renata di Francia Diversion from the itinerary 5 Casa di Ludovico Ariosto Via Mascheraio 6 Palazzina degli Angeli Via Montebello Piazza Via Borgo dei Leoni Via Borsari Direction Parco Urbano G. -

Printed for the Burlington Fine Arts Club. 1894
Sto&bS:>-,..·.->? · ·.* ·S. hHHBS 3HH»5m£ mmmmmm φmm tMrnwaj^iEtm mMmm^i wmmfm sSlS •x -·«! • s r 1 • •v.'·-- pTS - ·*Η5 ^sr^wpvrvywp^i» "Su ,ijk w,. - • jagra»»* • ssr -- ft * ' V -<£9 * <··-.,·-·. PRINTED FOR THE BURLINGTON FINE ARTS CLUB. 1894. /Λ tm: M^wm w mm -.-ν- sifts*aaeKwasfafcuns Mifi tf&ttilii .·-,·/ ,/V Burlington fine Huts Club. EXHIBITION OF PICTURES, DRAWINGS & PHOTOGRAPHS OF WORKS OF THE SCHOOL OF FERRARA-BOLOGNA, 14:4:0-154:0, Also of MEDALS of MEMBERS of the HOUSES of ESTE and BENTIVOGLIO. LONDON: PRINTED FOR THE BURLINGTON FINE' ARTS CLUB. 1894. EXHIBITION COMMITTEE. CAVALIERE PROFESSORE ADOLFO VENTURI. WALTER ARMSTRONG, ESQ. R. H. BENSON, ESQ. SIDNEY COLVIN, ESQ. HERBERT F. COOK, ESQ. EDWARD J. POYNTER, ESQ., R.A. LIST OF CONTRIBUTORS. HER MAJESTY THE QUEEN. THE TRUSTEES OF THE IRISH NATIONAL GALLERY, DUBLIN. THE COMMITTEE OF THE CORPORATION GALLERIES OF ART, GLASGOW. THE TRUSTEES OF THE ROYAL INSTITUTION, LIVERPOOL. THE CURATORS OF THE UNIVERSITY GALLERIES, OXFORD. THE COUNCIL OF THE ARUNDEL SOCIETY, LONDON. LORD ASHBURTON. *JAMES KNOWLES, ESQ. *SIR HICKMAN BACON, BART. *THE RIGHT HON. SIR HENRY LAYARD, G.C.B. HERR VON BECKERATH, OF BERLIN. THE EARL OF LEICESTER, K.G. *R. H. BENSON, ESQ. *LUDWIG MOND, ESQ., F.R.S. BERNHARD BERENSON, ESQ., OF FLORENCE. J. WINGFIELD MALCOLM, ESQ., OF POLTALLOCII. THE EARL BROWNLOW. C. FAIRFAX MURRAY, ESQ. THE DUKE OF BUCCLEUGH, K.T. *THE EARL OF NORTHBROOK, G.C.S.I. *CHARLES BUTLER, ESQ. THE MARQUIS OF NORTHAMPTON, K.G. SLGNOR CAVALIERI, OF FERRARA. MRS. OMAN. MISS COHEN. CLAUDE PHILLIPS, ESQ. *W. MARTIN CONWAY, ESQ.