Carpeneto.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Sub Ambito 01 – Alessandrino Istat Comune 6003
SUB AMBITO 01 – ALESSANDRINO ISTAT COMUNE 6003 ALESSANDRIA 6007 ALTAVILLA MONFERRATO 6013 BASSIGNANA 6015 BERGAMASCO 6019 BORGORATTO ALESSANDRINO 6021 BOSCO MARENGO 6031 CARENTINO 6037 CASAL CERMELLI 6051 CASTELLETTO MONFERRATO 6052 CASTELNUOVO BORMIDA 6054 CASTELSPINA 6061 CONZANO 6068 FELIZZANO 6071 FRASCARO 6075 FRUGAROLO 6076 FUBINE 6078 GAMALERO 6193 LU E CUCCARO MONFERRATO 6091 MASIO 6105 MONTECASTELLO 6122 OVIGLIO 6128 PECETTO DI VALENZA 6129 PIETRA MARAZZI 6141 QUARGNENTO 6142 QUATTORDIO 6145 RIVARONE 6154 SAN SALVATORE MONFERRATO 6161 SEZZADIO 6163 SOLERO 6177 VALENZA SUB AMBITO 02 – CASALESE ISTAT COMUNE 6004 ALFIANO NATTA 6011 BALZOLA 6020 BORGO SAN MARTINO 6023 BOZZOLE 6026 CAMAGNA 6027 CAMINO 6039 CASALE MONFERRATO 6050 CASTELLETTO MERLI 6056 CELLA MONTE 6057 CERESETO 6059 CERRINA MONFERRATO ISTAT COMUNE 6060 CONIOLO 6072 FRASSINELLO MONFERRATO 6073 FRASSINETO PO 6077 GABIANO 6082 GIAROLE 6094 MIRABELLO MONFERRATO 6097 MOMBELLO MONFERRATO 5069 MONCALVO 6099 MONCESTINO 6109 MORANO SUL PO 6113 MURISENGO 6115 OCCIMIANO 6116 ODALENGO GRANDE 6117 ODALENGO PICCOLO 6118 OLIVOLA 6120 OTTIGLIO 6123 OZZANO MONFERRATO 6131 POMARO MONFERRATO 6133 PONTESTURA 6135 PONZANO MONFERRATO 6149 ROSIGNANO MONFERRATO 6150 SALA MONFERRATO 6153 SAN GIORGIO MONFERRATO 6159 SERRALUNGA DI CREA 6164 SOLONGHELLO 6171 TERRUGGIA 6173 TICINETO 6175 TREVILLE 6178 VALMACCA 6179 VIGNALE MONFERRATO 6182 VILLADEATI 6184 VILLAMIROGLIO 6185 VILLANOVA MONFERRATO SUB AMBITO 03 – NOVESE TORTONESE ACQUESE E OVADESE ISTAT COMUNE 6001 ACQUI TERME 6002 ALBERA LIGURE 6005 -

Curriculum Vitae Eleonora BUFFA
Curriculum Vitae Eleonora BUFFA INFORMAZIONI PERSONALI Eleonora Buffa Via Pittavino 31 15010 VISONE (AL) Via Giordano Bruno 15 15011 ACQUI TERME (AL) 3478290377 avvocatobuffa@gmail; [email protected] Sesso F | Data di nascita 06/11/1974 | Nazionalità Italiana ESPERIENZA PROFESSIONALE dal 25/03/2004 ad oggi Provincia di Alessandria Piazza Libertà 17 15121 ALESSANDRIA Appalti e Contratti ora Direzione Risorse e Supporto Istituzionale. -Incarico di co.co.co. ex art. 2222 c.c. dal 25/03/2004 al 30/11/2007; -Rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (e a tempo pieno) con la qualifica di Specialista in attività amministrative (ex Istruttore Direttivo Amministrativo - qualifica funzionale settimo livello) cat. D - Responsabile Ufficio Forniture e Servizi (dal 28/12/2007 al 31/05/2008); -Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (e a tempo pieno) con la qualifica di Specialista in attività amministrative (ex Istruttore Direttivo Amministrativo qualifica funzionale settimo livello) cat. D (dal 01/06/2008 al 03/11/2014) Responsabile Ufficio Gare Pubbliche e dal 03/11/2014 Responsabile Ufficio Gare Pubbliche, Subappalti, Alienazioni Immobiliari e Contratti. Centrale di Committenza. Incarico di consulenza (dal 1° marzo al 30 giugno 2014) presso il Servizio di Polizia della Provincia di al codice della strada. dal 25/03/2004 ad oggi Consulente in materia di contrattualistica pubblica e Membro esperto in Commissioni di gara per di lavori, servizi e forniture e concessioni di lavori e servizi presso: Provincia di Alessandria; -

Alessandria & Monferrato a To
Always stay connected AlessAndriA & monferrAto Discover the area on: alexala.it one land, a thousand stories web app social www.alexala.it Art, History and Castles ∕ The Holy Ways ∕ Golf and Wellbeing ∕ Nature and Sport ∕ The Taste Trails Art, History and Castles ∕ The Holy Ways ∕ Golf and Wellbeing ∕ Nature and Sport ∕ The Taste Trails InFo InFo UnESCo World Heritage Alexala Piazza Santa Maria di Castello 14, Alessandria [email protected] Sites Info Ph +39 0131 288095 ∙ Fax +39 0131 220546 www.alexala.it Vineyard Landscape of Piedmont: Langhe-Roero and Monferrato www.paesaggivitivinicoli.it ALEXALA was created with the specific aim of giving the province the tools The full programme of our initiatives is with which the tourism potential of the area could be developed. packed with meetings, events, exhibitions and shows. To be kept up to date and not ALEXALA wants to make a positive contribution to the development of tourism miss anything visit our site: in the Alessandria area using two specific routes. www.alexala.it On one hand create a marketing oriented tourism programme which is able to satisfy, or better, anticipate the requests and demands of today’s tourists having always in mind customer satisfaction. On the other hand we try and promote synergy between institutions and private businesses. our Tourism Information offices (IATs) Alessandria Il Monferrato degli Infernot IAT di Piazza della Libertà, 1 Ph. +39 0131 51 51 11 www.ecomuseopietracantoni.it [email protected] www.cultural.it The Sacred Mounts of Piemonte and of Lombardia www.sacri-monti.com Acqui Terme Casale Monferrato Novi Ligure IAT di piazza Levi, 12 IAT di Piazza Castello di Casale M. -

Wines Come Together in Perfect Harmony
Where we are How - exits from the A21, A26 and A7 motorways - railway stations at Acqui Terme, Alessandria, Casale www.alexala.it to find us Monferrato, Novi Ligure, Ovada, Tortona and Valenza www.provincia.alessandria.it Alessandria is at the crossroads between regions, cultures and culinary Distances: cities traditions that have different origins but the same prestige. We have taken all 95km from Milan the most precious elements of these different sources and have melded them 90km from Turin together in a cradle of tastes, aromas and sensations that is rare, even for Italy. 85km from Genoa We are in the south-east corner of Piedmont, at the centre of a triangle formed Distances: airports by the cities of Turin, Milan and Genoa, all three being easily reached by car, 150km from Bergamo Orio al Serio our district being criss-crossed by the A21 Turin-Piacenza, A26 Santhià-Genoa 120km from Milan Malpensa and A7 Milan-Genoa motorways. 110km from Milan Linate 105km from Turin Caselle 80km from Genoa Cristoforo Colombo 1 The region Alessandria - 3560km2 surface area, 435,000 inhabitants www.alexala.it and Province - Mediterranean climate www.provincia.alessandria.it The Province of Alessandria has a surface area of 3,560km2 and some Our district 435,000 inhabitants. Its Mediterranean climate and geographic make up of plain (35%), hill (53%) and mountain (12%), gives visitors an ample choice 12% when they come to experience the natural beauty of this special corner of Piedmont. The pleasant weather of spring and summer makes this the ideal spot for people who are keen on sporting activities, whilst the autumn and winter are for those who enjoy the pleasures of the table, where good food and splendid 35% wines come together in perfect harmony. -

This New Light Which Now I See…
This new light which now I see… From the writings of Saint Paul of the Cross John Baptist Gorresio and John Mary Cioni 1 Foreword It is true that it is only in the last 30 years or so that the spirituality of Saint Paul of the Cross and the history of the Passionist Congregation which he founded has become available to the Passionist religious of the English-speaking world, thanks to linguistically gifted persons within the Congregation who were generous to devote their time and talents to the work of translation. All of the written documents (mainly letters) of St Paul of the Cross and the testimonies written by his contemporaries have been in the Italian language. These were a little more easily translated into the major European languages of French and Spanish. However it was a long time coming in English. Ever since translations of these beautiful documents have become available in English, a new light dawned in the minds and hearts of many Passionists, particularly in the English- speaking world. There has been a real hunger and thirst amongst these Passionists to want to delve into the character and personality of their spiritual Father, Paul of the Cross, and to be enriched by the spirituality of him who has been described as the greatest mystic of the eighteenth century. The documents contained in this book contributes eminently to this desire and adds to the growing volumes of resources now available to English readers. The slow, tedious and pain-staking work of translation is perhaps easily overlooked by readers when this book is picked up and devoured. -

Carta in Formato
VerolengoVerolengo PAVIAPAVIA 11 -- LOMELLINALOMELLINA OVESTOVEST LaLaLa CassaCassaCassa CaselleCaselle TorineseTorinese VolpianoVolpiano ChivassoChivasso FontanettoFontanettoFontanetto PoPoPo PAVIAPAVIA 11 -- LOMELLINALOMELLINA OVESTOVEST LaLaLa CassaCassaCassa RobassomeroRobassomero CaselleCaselle TorineseTorinese BrandizzoBrandizzo ChivassoChivasso CrescentinoCrescentino TrinoTrinoTrino BalzolaBalzola MottaMotta de'de' ContiConti BrandizzoBrandizzo MonteuMonteu dada PoPo BalzolaBalzola CandiaCandia LomellinaLomellina LeinìLeinìLeinì MonteuMonteu dada PoPo CandiaCandia LomellinaLomellina ZemeZemeZeme LeinìLeinìLeinì VerruaVerrua SavoiaSavoia CaminoCamino CastagnetoCastagneto PoPo ValleValle LomellinaLomellina OttobianoOttobiano TORINOTORINO 2-2- IMPIANTOIMPIANTO DIDI TORINOTORINO LaurianoLaurianoLauriano BrusascoBrusasco GabianoGabiano ValleValle LomellinaLomellina SettimoSettimoSettimo TorineseTorineseTorinese LaurianoLaurianoLauriano MoncestinoMoncestino GabianoGabiano ConioloConiolo SemianaSemianaSemiana SanSanSan GillioGillioGillio BorgaroBorgaro TorineseTorinese SemianaSemianaSemiana ValVal delladella TorreTorre VenariaVenaria RealeReale BorgaroBorgaro TorineseTorinese CasalborgoneCasalborgone VillamiroglioVillamiroglio PontesturaPontestura FrassinetoFrassinetoFrassineto PoPoPo ValVal delladella TorreTorre VillamiroglioVillamiroglio SolonghelloSolonghelloSolonghello BremeBreme GassinoGassino TorineseTorinese RivalbaRivalba MoransengoMoransengo PianezzaPianezza GassinoGassino TorineseTorinese RivalbaRivalba MoransengoMoransengo -

Deliberazione Della Giunta Regionale 21 Febbraio 2020, N. 24-1043 D.P.R
REGIONE PIEMONTE BU10 05/03/2020 Deliberazione della Giunta Regionale 21 febbraio 2020, n. 24-1043 D.P.R. n. 616/1977 art. 70 - D.Lgs. n. 102/2004 e s.m.i. - l.r. n. 63/1978 artt. 54 e 55 - Delimitazione delle zone danneggiate e riconoscimento eccezionalita' delle piogge alluvionali avvenute tra il 19 ottobre e il 25 novembre 2019 nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Torino e Vercelli. A relazione dell'Assessore Protopapa: Premesso che: l’art. 5 del D.Lgs. n. 102/2004 e s.m.i. “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38” , prevede la possibilità per la Giunta regionale di adottare misure volte a favorire la ripresa dell'attività produttiva delle imprese agricole nonché al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica; l’art. 6 dello stesso decreto, stabilisce inoltre che la Giunta regionale deliberi, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, prorogabile di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso. Dato atto che: come evidenziato da Arpa Piemonte, nei giorni dal 19 al 24 ottobre e tra il 22 ed il 25 Novembre 2019 il Piemonte è stato interessato da due prolungate fasi di maltempo, caratterizzate da piogge alluvionali, che hanno determinato diffuse condizioni di criticità idro-geologica; l’entità diffusa delle piogge ed i fenomeni di esondazione dei principali fiumi e dei corsi d’acqua secondari hanno prodotto danni eccezionali alle aree agricole in tale periodo occupate da cereali autunno vernini o da colture foraggere permanenti ovvero in riposo o con le prime lavorazioni di preparazione alla semina primaverile, alle strutture aziendali ed alle infrastrutture con particolare riferimento ai canali irrigui, alle relative opere di presa, nonché a strade interpoderali di accesso ai fondi. -

Castelli Da Fiaba
Castelli da Fiaba Questo itinerario può essere percorso interamente oppure utilizzando solo alcune parti del tracciato che da Ovada arriva fino al comune di Castelnuovo Scrivia in una cornice ricca di castelli e fortezze secolari. Durata: 4 giorni e 3 notti Livello difficoltà: medio Km di percorrenza: circa 100 km Percorrenza media giornaliera: circa 30 km Tipo di bicicletta: city bike, mtb Tipo di terreno: asfaltato, sterrato; collinare (anche con alti dislivelli), a tratti pianeggiante Sistemazione: hotel, agriturismo e B&B Periodo consigliato: settembre-prima metà di ottobre; aprile-giugno PARTENZA: Ovada ARRIVO: Castelnuovo Scrivia ITINERARIO: 1° giorno: Arrivo a Ovada, punto di partenza del percorso in bicicletta, nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 2° giorno: Si attraversa il centro cittadino e si lascia Ovada in direzione di Alessandria: oltrepassato il torrente Orba, si percorre la strada che conduce a Rocca Grimalda: la prima parte del percorso è pianeggiante, ma poi la strada sale con ampi tornanti fino a raggiungere questo borgo caratteristico, raggruppato attorno al castello dei Malaspina e dei Grimaldi (foto a sinistra), con la sua torre circolare, i suoi fantasmi e il giardino all’italiana. Percorrendo il crinale delle colline ovadesi, coltivate a Dolcetto, si raggiunge un altro borgo di origine medioevale dominato da un antico castello con torre quadrata e mura di difesa: Carpeneto. Con saliscendi fra le colline, si arriva a Trisobbio (foto a destra), col suo castello in pietra, dove è possibile salire sulla torre e ammirare il paesaggio circostante. Sosta per il pranzo nelle sale del castello. Nel pomeriggio, ancora saliscendi piuttosto impegnativi conducono a Cremolino, un borgo in pietra raggruppato attorno al castello medioevale. -

Cri Cassine.Indd
Questo prodotto è un servizio gratuito del Stampato dai tipi della Stamperia21 di Alessandria, settembre 2019. Si ringraziano il Dott. Mauro Pianese per la consulenza storica e Gabriele Curato per l’impaginazione e la cura stilistica del presente Bollettino. Saluto del Sindaco di Cassine e Presidente della Provincia di Alessandria L’attività della Croce Rossa Italiana si svolge nel silenzio della quotidianità, cir- costanza che da un lato favorisce lo sviluppo della professionalità degli operatori, ma che dall’altro occulta alla cittadinanza la consapevolezza di un prezioso servi- zio offerto con grande dedizione. Per questo motivo, ogni iniziativa finalizzata a diffondere lo spirito che anima le persone della Croce Rossa, a far conoscere i loro Principi fondamentali e le loro attività è la benvenuta, soprattutto se approfondisce il tema con uno sguar- do di ampia veduta. Nel nostro caso, questo “bollettino” ripercorre 130 anni di vita della Croce Rossa di Cassine, ricostruendo i fatti salienti che ne hanno caratterizzato l’evolu- zione e richiamandone le vicende storiche e umane. Siamo in presenza di un diario di viaggio, i cui protagonisti sono le centinaia di Volontari che - nel tempo - si sono impegnati nell’Associazione, nel quale sono fedelmente riportate le attività svolte in tempo di pace e di guerra. Una particolare attenzione è dedicata all’Ospedale Militare Territoriale Stic- ca, operativo, a cura della Croce Rossa, a partire da fine ‘800, con 178 posti letto per la degenza dei feriti provenienti dai fronti di guerra e ampiamente utilizzato per i feriti del conflitto 1915-1918, ed alla descrizione delle attività e delle ini- ziative attuali che da alcuni anni sono in costante sviluppo. -
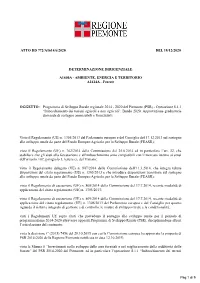
Atto Dd 772/A1614a/2020 Del 18/12/2020
ATTO DD 772/A1614A/2020 DEL 18/12/2020 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO A1614A - Foreste OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale regionale 2014 - 2020 del Piemonte (PSR) - Operazione 8.1.1 “Imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli”. Bando 2020. Approvazione graduatorie domande di sostegno ammissibili e finanziabili. Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25.6.2014 ed in particolare l’art. 32, che stabilisce che gli aiuti alla forestazione e all'imboschimento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato; visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11.3.2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR); visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17.7.2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1305/2013; visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17.7.2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure -

ALESSANDRIA Vai a Votare Qui: Via Inviziati, 14 Presso Sede PD ALESSANDRIA
COMUNE DI RESIDENZA vai a votare qui: INDIRIZZO SEGGIO presso SEDE DEL SEGGIO COMUNE DOVE VAI A VOTARE ALESSANDRIA vai a votare qui: via Inviziati, 14 presso Sede PD ALESSANDRIA Acqui Terme vai a votare qui: Via Emilia, 29 presso Circolo PD - Galleria Volta ACQUI TERME Albera Ligure vai a votare via Roma, 14 presso Polifunzionale VIGNOLE BORBERA Alfiano Natta vai a votare presso Biblioteca Comunale ROSIGNANO MONFERRATO Alice Bel Colle vai a votare qui: Via Emilia, 29 presso Circolo PD - Galleria Volta ACQUI TERME Altavilla Monferrato vai a votare presso Biblioteca Comunale ROSIGNANO MONFERRATO Alzano Scrivia vai a votare qui: via Zenone, 20 presso Circolo PD TORTONA Arquata Scrivia vai a votare qui: via Libarna 136 presso Circolo PD ARQUATA SCRIVIA Avolasca vai a votare qui: via Zenone, 20 presso Circolo PD TORTONA Balzola vai a votare qui: vai Capello, 14 a CASALE MONFERRATO via Paolo Giacometti, 61 Basaluzzo vai a votare presso Circolo PD NOVI LIGURE (largo Valentino) Bassignana vai a votare qui: via Pellizzari, 36 presso Circolo PD VALENZA Belforte vai a votare qui: via Roma, 12 presso Circolo PD TAGLIOLO Bergamasco vai a votare qui: via Inviziati, 14 presso Sede PD ALESSANDRIA berzano di Tortona vai a votare qui: via Zenone, 20 presso Circolo PD TORTONA Bistagno vai a votare qui: Via Emilia, 29 presso Circolo PD - Galleria Volta ACQUI TERME Borghetto Borbera vai a votare via Roma, 14 presso Polifunzionale VIGNOLE BORBERA COMUNE DI RESIDENZA vai a votare qui: INDIRIZZO SEGGIO presso SEDE DEL SEGGIO COMUNE DOVE VAI A VOTARE Borgo San -

Provincia Località Zona Climatica Altitudine ALESSANDRIA ACQUI
Provincia Località Zona climatica Altitudine ALESSANDRIA ACQUI TERME E 156 ALBERA LIGURE E 415 ALESSANDRIA E 95 ALFIANO NATTA E 280 ALICE BEL COLLE E 418 ALLUVIONI CAMBIÌ E 77 ALTAVILLA MONFERRATO E 256 ALZANO SCRIVIA E 77 ARQUATA SCRIVIA E 248 AVOLASCA E 425 BALZOLA E 119 BASALUZZO E 149 BASSIGNANA E 96 BELFORTE MONFERRATO E 297 BERGAMASCO E 125 BERZANO DI TORTONA E 270 BISTAGNO E 175 BORGHETTO DI BORBERA E 295 BORGO SAN MARTINO E 107 BORGORATTO ALESSANDRINO E 105 BOSCO MARENGO E 121 BOSIO E 358 BOZZOLE E 91 BRIGNANO-FRASCATA E 288 CABELLA LIGURE E 510 CAMAGNA MONFERRATO E 261 CAMINO E 252 CANTALUPO LIGURE E 383 CAPRIATA D'ORBA E 176 CARBONARA SCRIVIA E 177 CARENTINO E 160 CAREZZANO E 300 CARPENETO E 329 CARREGA LIGURE F 958 CARROSIO E 254 CARTOSIO E 230 CASAL CERMELLI E 102 CASALE MONFERRATO E 116 CASALEGGIO BOIRO E 321 CASALNOCETO E 159 CASASCO E 398 CASSANO SPINOLA E 191 CASSINE E 190 CASSINELLE E 360 CASTELLANIA E 400 CASTELLAR GUIDOBONO E 144 CASTELLAZZO BORMIDA E 104 CASTELLETTO D'ERRO E 544 CASTELLETTO D'ORBA E 200 CASTELLETTO MERLI E 268 CASTELLETTO MONFERRATO E 197 CASTELNUOVO BORMIDA E 123 CASTELNUOVO SCRIVIA E 85 CASTELSPINA E 116 CAVATORE E 516 CELLA MONTE E 268 CERESETO E 280 CERRETO GRUE E 251 CERRINA MONFERRATO E 225 CONIOLO E 252 CONZANO E 262 COSTA VESCOVATO E 305 CREMOLINO E 405 CUCCARO MONFERRATO E 232 DENICE E 387 DERNICE E 600 FABBRICA CURONE F 712 FELIZZANO E 114 FRACONALTO F 725 FRANCAVILLA BISIO E 160 FRASCARO E 124 FRASSINELLO MONFERRATO E 261 FRASSINETO PO E 104 FRESONARA E 143 FRUGAROLO E 112 FUBINE E 192 GABIANO