M. VALENTI, Il Patrimonio Archeologico Sommerso Del
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

SIENA Alelargoro En
SUGGESTED ROUTE FROM SIENA TO RADICONDOLI map downloaded from www.radiconventosservanza.it or From Siena follow the signposts for the dual www.ethoikos.it cariageway Siena-Firenze towards Firenze and stay Graphic design by Alessandro Belli and on this route until you reach the exit for Roberto Cozzolino Monteriggioni. Here turn left and follow the road for about 50 metres when you will come to a junction ©2002-2004 all rights reserve with a bar on your right. Take the right turn towards Colle di Val d’Elsa and proceed for just over 1 Km where you will take a left turn sign-posted to Abbadia Isola–Strove. Follow on this road until you Poggibonsi reach the SP541 route where you will turn sharp left over a bridge sign-posted to Grosseto. Stay on this road for about 10 km until you reach a right turn towards Radicondoli. You will recognise this turning as it is soon after a small petrol station also on your right. Follow the direction for Radicondoli which you SP 541 SS 2 will reach after about 13 km. Siena-Firenze Colle SP 5 Val D’Elsa MONTERIGGIONI exit Siena-Firenze SP 74 To w ards To w ards COLLE GROSSETO VAL D’ELSA Badesse SS 2 To w ards ABBADIA ISOLA- SP 541 STROVE SIENA Mensano Fuel station Pievescola SS 326 SP 541 Sovicille SP 3 To w ards SP 73 RADICONDOLI SS 2 Rosia SP 35 SP 3 SS 223 RADICONDOLI To w ards Chiusdino, Roccastrada How to get to the Convent Once you reach the village, past the Post Office, follow the road down to your left which is sign-posted to Castelnuovo Val di Cecina do not head for the town centre). -

Successe in Valdichiana
Successe in Valdichiana Copyright - © - 2010 - Thesan & Turan S.r.l. Via San Donato, 12 - 53045 Montepulciano (Si) www.thesaneturan.it ISBN 9 Alessandro Angiolini SUCCESSE IN VALDICHIANA Storie, luoghi e personaggi THESAN & TURAN EDITORE Prefazione dell’autore Ho raccolto in questo libro quasi un decennio di scritti nati dalla passione per la storia della mia terra, la Valdichiana. Una ela- borazione di una parte dei testi pubblicati negli anni su giornali e periodici toscani ai quali ancora oggi collaboro, o meglio, una dovuta rielaborazione con aggiunte di notizie e approfondimenti descrittivi resi possibili dalla libertà di battute che ti può concede- re una pubblicazione. Forse non leggerete nulla di nuovo di quello che è già stato scritto su questa terra da autori illustri negli anni e nei secoli pas- sati, ma nonostante questo credo di essere riuscito, senza lode e senza infamia, in modo scorrevole e semplice, a descrivere una serie di avvenimenti con una visione diversa dal solito raccontare, con qualche piccola ed inedita scoperta e con la consapevolezza che la storia, a volte, è anche intuizione. In queste pagine ho riversato il mio amore per la storia studiata in centinaia di libri e documenti, vecchi e nuovi, validi e meno validi, intonsi e strappati, appunti scarabocchiati da chissà chi, magari alcuni rarissimi recuperati per volontà del destino dall’oblio della spazzatura della carta straccia. E i protagonisti che troverete nei trentadue capitoli di questo libro saranno i nomi di vecchie strade e i loro millenari percorsi, i toponimi dimenticati che indicano ancora il passaggio di perdute vie etrusche e romane, le vicende di antichi luoghi abitati e oggi sconosciuti, le pionieristiche ferrovie con le loro stazioni nate e abbandonate, sognate o mai realizzate. -

Piano Di Prelievo Dei Cervidi E Bovidi Nelle Aziende Faunistico Venatorie Della Provincia Di Siena
Allegato “B” parte integrante e sostanziale del Decreto Deliberativo del Presidente n._______del_________ PROVINCIA DI SIENA SERVIZIO RISORSE FAUNISTICHE PIANO DI PRELIEVO DEI CERVIDI E BOVIDI NELLE AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE DELLA PROVINCIA DI SIENA Stagione venatoria 2015 -2016 Tab. 1 - Piano di prelievo dei caprioli all'interno delle Aziende Faunistico Venatorie per la stagione venatoria 2015/2016 suddiviso per classi di età e sesso Superficie Piano di A.F.V. A.T.C. MA MG Tot. M FA FG Tot. F PIC aziendale prelievo Abbadia a Sicille 19 417,33 30 7 6 13 7 6 13 4 Anqua 17 661,87 25 6 5 11 6 5 11 3 Arceno 18 445,60 25 6 5 11 6 5 11 3 Bagnaia 18 841,37 12 3 2 5 3 2 5 2 Campriano 18 400,65 12 3 2 5 3 2 5 2 Casabianca 18 503,03 20 5 4 9 5 4 9 2 Casale del Bosco 18 437,70 10 3 2 5 2 2 4 1 Casale S. Andrea 18 519,01 10 3 2 5 2 2 4 1 Castell'in Villa 18 639,63 30 7 6 13 7 6 13 4 Castelvecchio 19 724,47 25 6 5 11 6 5 11 3 Castiglion del Bosco 18 675,97 15 4 3 7 3 3 6 2 Cavaglioni 17 404,65 5 1 1 2 1 1 2 1 Celamonti 19 488,37 18 5 4 9 4 4 8 1 Chiatina Malandrine 18 952,29 Altesi 25 6 5 11 6 5 11 3 Cinciano le Fonti 17 463,02 14 3 3 6 4 3 7 1 Curiano Suvignano 18 632,42 10 3 2 5 2 2 4 1 Fagnano 18 623,02 18 5 4 9 4 4 8 1 Felsina 18 562,69 36 8 7 15 8 7 15 6 Gaiole Sud 18 979,09 50 12 10 22 12 10 22 6 Il Castello 19 508,89 10 3 2 5 2 2 4 1 Il Grillo 18 1.312,88 60 14 12 26 14 12 26 8 Il Monte 17 633,62 40 10 7 17 10 7 17 6 La Campana 18 713,58 10 3 2 5 2 2 4 1 Le Rote 17 534,68 22 4 5 9 4 5 9 4 Lecchi-Poggiarello 17 761,49 40 10 7 17 10 7 17 6 -

Modello Europeo Di Curriculum Vitae Pallecchi
MODELLO EUROPEO DI CURRICULUM VITAE Raccomandazione della Commissione Europea del 11/03/2002 (GU L.79 del 22/03/2002) F ORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome PALLECCHI FRANCO Indirizzo VIA V. ALFIERI, 14 – 53019 CASTELNUOVO BERARDENGA, SI - ITALIA Telefono 0577 270820 Fax E-mail [email protected] Nazionalità Data di nascita [ 25 ottobre 1968 ] ESPERIENZE LAVORATIVE IN MATERIA SERVIZI (solo in materia di consulenze Specialistiche / TIC / CertificazionI) • Date (da – a) [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto. ] • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore • Tipo di impiego • Principali mansioni e responsabilità ISTRUZIONE E FORMAZIONE • Date (da – a) [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente frequentato con successo. ] • Nome e tipo di istituto di istruzione o UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE – FACOLTA’ DI ARCHITETTURA formazione Laurea conseguita nel 1995 con la votazione di 102/110 • Principali materie / abilità professionali SPECIALIZZAZIONE IN RECUPERO E TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO- oggetto dello studio ARCHITETTONICO • Qualifica conseguita LAUREA IN ARCHITETTURA – ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO (anno 1997) • Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) (nel caso di laurea indicare la tipologia: triennale, specialistica,..) LAUREA QUINQUENNALE CAPACITÀ E COMPETENZE [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state -

Passion for Cycling Tourism
TUSCANY if not HERE, where? PASSION FOR CYCLING TOURISM Tuscany offers you • Unique landscapes and climate • A journey into history and art: from Etruscans to Renaissance down to the present day • An extensive network of cycle paths, unpaved and paved roads with hardly any traffic • Unforgettable cuisine, superb wines and much more ... if not HERE, where? Tuscany is the ideal place for a relaxing cycling holiday: the routes are endless, from the paved roads of Chianti to trails through the forests of the Apennines and the Apuan Alps, from the coast to the historic routes and the eco-paths in nature photo: Enrico Borgogni reserves and through the Val d’Orcia. This guide has been designed to be an excellent travel companion as you ride from one valley, bike trail or cultural site to another, sometimes using the train, all according to the experiences reported by other cyclists. But that’s not all: in the guide you will find tips on where to eat and suggestions for exploring the various areas without overlooking small gems or important sites, with the added benefit of taking advantage of special conditions reserved for the owners of this guide. Therefore, this book is suitable not only for families and those who like easy routes, but can also be helpful to those who want to plan multiple-day excursions with higher levels of difficulty or across uscanyT for longer tours The suggested itineraries are only a part of the rich cycling opportunities that make Tuscany one of the paradises for this kind of activity, and have been selected giving priority to low-traffic roads, white roads or paths always in close contact with nature, trying to reach and show some of our region’s most interesting destinations. -

Inventario 215
Inventario 215 ELENCO DELLE TESI conservate presso l'archivio di stato di Siena* a cura di Clara Sanelli e Patrizia Taddei Continuato dal 1 gennaio 2019 da Anna Scognamiglio Aggiornato al 23 gennaio 2021 Le tesi di laurea possono essere consultate dopo 5 anni, salvo diversa indicazione dell'autore. (Circ. 249/97 del 26.11.1997 dell'Ufficio Centrale Beni Archivistici) Le tesi di laurea non possono essere fotocopiate * Le tesi di seguito elencate risultano mancanti fin dal controllo effettuato il 12 ottobre 1991: 1945/46, LENTI LILIANA, I Pannocchieschi; 1956/57, MARIANI […], Il prestito ad interesse a Siena nel Medioevo; 1958/59, HICKS DAVID, The rise of Pandolfo Petrucci; 1960/61, MARRARA DANILO, Storia Istituzionale della Maremma senese; 1969/70, GIANNELLA PAOLA, L’applicazione del Concilio di Trento nella Diocesi di Siena; 1989/90, BRUNO VALERIA, La nazione ebraica senese nella giustizia criminale del settecento. 1 1 1941/1942 CAMBIASO P. VITTORIO "De observantia regulari” in conventu Silvae Lacus apud Senas, sec. XIV vertente 2 1944/1945 PETRONI VITTORIO Il magistrato di Balia nella Repubblica di Siena, dalle sue origini all’avvento della Signoria dei Petrucci 3 1945/1946 CIACCI DINA Un triennio poco noto di storia senese, ed una ambasceria inedita della Repubblica a Martino V in Firenze 4 1945/1946 PONTICELLI CATERINA L’espansione di Siena, l’antagonismo con Firenze dal 1141 alla pace del 1235 5 1945/1946 UMICINI ANNA L’abbazia di Monte Oliveto Maggiore 6 1946/1947 COCONI SARA L’espansione della Repubblica di Siena nella Maremma e la sottomissione di Massa Marittima 7 1946/1947 GIUGGIOLI BUSACCA PAOLA Il Comune di Siena alla metà del secolo XIII, e il tentativo di signorìa di Provenzano Salvani 8 1947/1948 BARTALINI BIGI PIETRO Il Governo dei Ventiquattro dalla battaglia di Montaperti a quella di Colle Val d’Elsa 9 1947/1948 CHICCON ANGELA MARIA L’espansione dello Stato Senese nella Maremma grossetana dalla metà del sec. -

Azienda Usl Toscana Sud Est Locazioni E Comodati Al 31/12/2016
30/12/2016 AZIENDA USL TOSCANA SUD EST LOCAZIONI E COMODATI AL 31/12/2016 AREA ARETINA - LOCAZIONI PASSIVE Denominazione-attività Indirizzo Comune Locatore Scadenza Canone 2016 prevalente RSA Ninci Loc. Mugliano,208 Arezzo Fraternita dei Laici 31/12/2007 € 21.950,87 Alloggio Sanitario Socio-Riab. a bassa Via Malpighi, 12/4 Arezzo Arezzo Casa case popolari senza scadenza € 2.177,11 intensità assistenziale Alloggio Sanitario Socio-Riab. a bassa Villaggio Colombo, 1 Arezzo Arezzo Casa case popolari senza scadenza € 3.653,22 intensità assistenziale Alloggio Sanitario Socio-Riab. a bassa Via Montale, 44 Arezzo Arezzo Casa case popolari senza scadenza € 3.428,18 intensità assistenziale Alloggio Sanitario Socio-Riab. a bassa Villaggio Gattolino, 11 Arezzo Arezzo Casa case popolari senza scadenza € 4.015,92 intensità assistenziale Alloggio Sanitario Socio-Riab. a bassa Piazza Andromeda, 54 Arezzo Arezzo Casa case popolari senza scadenza € 2.353,37 intensità assistenziale Alloggio Sanitario Socio-Riab. a bassa Via Libia, 1/3 Arezzo Arezzo Casa case popolari senza scadenza € 4.098,10 intensità assistenziale Centro Diurno Via La Nave, 6/H Bibbiena sig.ri T.M. e T.I. 30/11/2017 € 8.469,48 Casa Famiglia di Camucia Via Aldo Capitini/piazzale Europa n. 12 Camucia di Cortona Sig. F. F. 28/02/2018 € 5.760,00 28/02/2014 prorogato e in corso di Centro Socio Sanitario Cortona Vicolo Mancini, 4 Cortona Misericordia di Cortona € 18.000,00 rinnovo Centro Socio Sanitario di Mercatale Via Mazzini Mercatale Sigg. B.A. - B.M. e B.Z. 31/08/2018 € 7.948,08 31/12/2020 senza ulteriore rinnovo delib Residenza Protetta DSM Via Boccaccio, 3 Montevarchi Comune di Montevarchi € 67.653,28 DG nr. -

Guida-Inventario Dell'archivio Di Stato
MINIS TERO PER I BENI CULTURALI E AM BIENTALI PU B BLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO XCII ARCHIVIO DI STATO DI SIENA GUIDA-INVENTARIO DELL'ARCHIVIO DI STATO VOLUME TERZO ROMA 1977 SOMMARIO Pag. Prefazione VII Archivio Notarile l Vicariati 77 Feudi 93 Archivi privati 105 Bandini Policarpo 106 Bologna-Buonsignori-Placidi 108 Borghesi 140 Brancadori 111 Brichieri-Colombi 113 Busacca Raffaele 115 Canonica (la) 116 Nerazzini Cesare 118 Pannocchieschi-D'Elci 120 Petrucci 140 Piccolomini-Clementini 123 Piccolomini-Clementini-Adami 128 Piccolomini-Naldi-Bandini 131 Piccolomini (Consorteria) 134 Sergardi-Biringucci 137 Spannocchi 141 Tolomei 143 Useppi 146 Venturi-Gallerani 148 Particolari 151 Famiglie senesi 152 Famiglie forestiere 161 PR EFAZIONE Nella introduzione al primo volume della guida-inventario dell'Archivio di Stato di Siena furono esposti gli intenti con i quali ci si accinse alla pub blicazione di quell'importante mezzo di corredo che consistevano nel valorizzare il materiale documentario di ciascun fo ndo archivistico per facilitare agli stu diosi la via della ricerca storica. Il caloroso e benevolo accoglimento riservato dagli interessati dice chiaramente quanto fe lice sia stata l'iniziativa e quanto brillanti siano stati i risultati raggiunti, che si sono palesati anche maggiori di quelli previsti. Infa tti la valorizzazione del materiale, oltre all'ordinamento ed alla inventariazione degli atti, presupponeva anche lo studio accurato delle ori gini e delle competenze dell'ufficio o dell'ente che quegli atti aveva prodotto. Per cui, essendo stati illustrati nei primi due volumi 1 ottanta fondi appartenenti alle più importanti magistrature dello Stato, insieme alla storia di ogni singolo ufficio è emersa in breve sintesi anche la storia del popolo senese. -

Piano Di Protezione Civile Comunale
Piano di Protezione Civile del Comune di Monteriggioni Luglio 2017 COMUNE DI PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE INTRODUZIONE MONTERIGGIONI PAGINA 2 DI 26 Il Piano di Protezione Civile del Comune di Monteriggioni è impostato secondo il Metodo Augustus e segue quindi i concetti di semplicità, flessibilità e facile consultazione delle procedure operative definite per ogni rischio previsto nel territorio comunale. Il Piano è composto da due sezioni: la Parte Strutturale e gli Allegati. La Parte Strutturale è approvata dal Consiglio Comunale, mentre gli Allegati possono essere aggiornati dal Responsabile di Protezione Civile, senza l’approvazione del Consiglio Comunale, con una semplice delibera di Giunta di presa d’atto. La Parte Strutturale è divisa in tre parti: A – Parte generale, contiene l’indicazione degli Enti preposti al monitoraggio e le procedure per recepire le attività di monitoraggio previsionale probabilistico del Centro Funzionale della Regione Toscana, i riferimenti alla cartografia di base e a quella tematica e degli scenari di rischio, l’individuazione delle aree di emergenza (attesa, ricovero, ammassamento) eseguita dalla Amministrazione Comunale nei territori non a rischio. B – Lineamenti della Pianificazione, sono elencate: le Componenti e le Strutture Operative (artt. 6 e 11, L. 225/1992) del Servizio Nazionale della Protezione Civile presenti nel territorio comunale e che a vario titolo partecipano al Piano Comunale; le priorità d’intervento rispetto agli obiettivi da raggiungere per la risposta di protezione civile comunale dall'attivazione del Centro Operativo Comunale in poi. Le procedure generali di intervento per ogni rischio sono allegate al Piano. C – Modello di Intervento, è descritto il luogo e il funzionamento del Centro Operativo Comunale, le Funzioni di Supporto organizzate, i flussi della comunicazione interna ed esterna al C.O.C. -
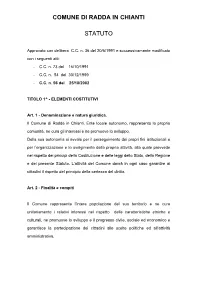
Comune Di Radda in Chianti Statuto
COMUNE DI RADDA IN CHIANTI STATUTO Approvato con delibera C.C. n. 36 del 20/6/1991 e successivamente modificato con i seguenti atti: - C.C. n. 73 del 16/10/1991 - C.C. n. 54 del 30/12/1999 - C.C. n. 56 del 25/10/2002 TITOLO 1^ - ELEMENTI COSTITUTIVI Art. 1 - Denominazione e natura giuridica. Il Comune di Radda in Chianti, Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l’organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto. L’attività del Comune dovrà in ogni caso garantire ai cittadini il rispetto del principio della certezza del diritto. Art. 2 - Finalità e compiti Il Comune rappresenta l’intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all’attività amministrativa. Il Comune promuove e incoraggia in particolare l’agricoltura e l’artigianato locale, favorisce il turismo e promuove e incentiva lo sviluppo del commercio e del terziario e della piccola e media industria per assicurare la qualificazione e l’occupazione. Nell’ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con gli altri Enti pubblici attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane, produttive, ambientali , storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita , il tutto secondo i principi della sussidiarietà e dell’omogeneità delle funzioni, dell’economicità ed efficacia della gestione e dell’adeguatezza organizzativa. -

LDC2018 Classifica Definitiva Toscana.Xlsx
9° CENSIMENTO NAZIONALE I LUOGHI DEL CUORE CLASSIFICA REGIONALE TOSCANA POS. POS. REGIONE PROVINCIA COMUNE LUOGO TOTALE VOTI REGIONALE NAZIONALE 1 1 TOSCANA PISA CALCI MONTE PISANO 114.670 2 7 TOSCANA PISA PISA CHIESA DI SAN FRANCESCO A PISA 24.997 3 26 TOSCANA PRATO PRATO ORATORIO DI SAN BARTOLOMEO 14.162 4 35 TOSCANA PISTOIA PISTOIA IL PARTERRE DI PISTOIA 11.030 5 44 TOSCANA PISA SAN GIULIANO TERME ROCCA DI RIPAFRATTA 8.922 6 46 TOSCANA FIRENZE GREVE IN CHIANTI PIEVE DI SAN PIETRO A SILLANO 8.536 LA GUALCHIERA DI COIANO, O MULINO 7 55 TOSCANA PRATO PRATO NALDINI 7.180 GIARDINO ATELIER DI SCULTURA DEL 8 59 TOSCANA PISA SAN GIULIANO TERME MAESTRO SPOSITO 6.838 9 61 TOSCANA FIRENZE VINCI SAN DONATO IN GRETI-VINCI 6.651 10 71 TOSCANA GROSSETO MONTE ARGENTARIO TORRE DI CAPO D'OMO 5.617 11 130 TOSCANA LUCCA CASTELNUOVO DI GARFAGNANA FORTEZZA DI MONTALFONSO 3.573 12 136 TOSCANA PISA CAPANNOLI MARGINETTE, LE VIE DEL CUORE 3.372 13 137 TOSCANA FIRENZE BAGNO A RIPOLI GUALCHIERE DI REMOLE 3.360 14 143 TOSCANA FIRENZE VICCHIO EX STAZIONE DI FORNELLO 3.312 15 183 TOSCANA PISTOIA PESCIA CARTIERA LE CARTE 2.611 16 186 TOSCANA MASSA CARRARA TEATRO POLITEAMA 2.485 17 193 TOSCANA FIRENZE REGGELLO CASTELLO E PARCO DI SAMMEZZANO 2.382 18 208 TOSCANA PISA CALCI CERTOSA DI CALCI 2.001 19 209 TOSCANA GROSSETO ROCCASTRADA CRIPTA DELL'ABBAZIA GIUGNANO 1.982 20 228 TOSCANA FIRENZE FIRENZE GALLERIA RINALDO CARNIELO 1.512 21 230 TOSCANA GROSSETO ARCIDOSSO STRIBUGLIANO 1.486 22 242 TOSCANA LUCCA BAGNI DI LUCCA CHIESA DI SAN CASSIANO IN CONTRONE 1.253 23 245 TOSCANA -

Deliberazione Del Direttore Generale
Delibera firmata digitalmente DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 200 DEL 09/03/2017 Il Direttore Generale, Dott. Enrico Desideri su proposta della struttura aziendale DIPARTIMENTO TECNICO adotta la seguente deliberazione: OGGETTO: PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÁ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MONTEPULCIANO (SIENA): NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE Responsabile della struttura proponente: Stecchi Giuliano Responsabile del procedimento: Stecchi Giuliano Pagina 1 di 34 Delibera firmata digitalmente Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di delibera di pari oggetto con num. Provv. 832 Hash .pdf (SHA256): 55fc87dcb61d62ec2a5f78117ba24aa184d5a2069ce53c86c87fd214f0d057d6 Hash .p7m (SHA256): d4c58a81ab419db5e34d9dd58189641cda9461a1a48a321a910f25f2a2660421 Pagina 2 di 34 Delibera firmata digitalmente IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TECNICO RICHIAMATA la Deliberazione D.G. n. 872 del 22 luglio 2016 “Approvazione schema dello Statuto dell'Azienda USL TOSCANA SUD EST”; RICHIAMATA la Deliberazione D.G. n. 873 del 22 luglio 2016 “Approvazione schema del Regolamento di Organizzazione Azienda USL TOSCANA SUD EST”; VISTA la Deliberazione D.G. n. 876 del 22 luglio 2016 “Seconda applicazione del Regolamento Aziendale di Organizzazione. Nomina incarichi di staff, amministrativi e tecnici” con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali delle strutture professionali e funzionali apicali secondo quanto indicato negli atti regolamentari di cui alle Deliberazioni D.G. n. 872 e n. 873 del 22 luglio 2016, a decorrere dal 1 agosto 2016, e, in particolare, è stato conferito al sottoscritto l'incarico di direzione del Dipartimento Tecnico; RICHIAMATE: - la Deliberazione D.G.