Piano Faunistico Venatorio Regionale (Pvfr) 2010/2020
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ne Al Registro Imprese Di SALERNO 81000570655 N
ACQUEDOTTI DEL CALORE LUCANO SPA 2017 ACQUEDOTTI DEL CALORE LUCANO SRL Sede in Piazza della Repubblica c/o Casa Comunale – 84043 AGROPOLI(SA) Iscrizione al Registro Imprese di SALERNO 81000570655 N. REA 317231 PIANO INDUSTRIALE TRA SFORMAZIONE DELLA SOCIETA’ ACQUEDOTTI DEL CALORE LUCANO IN AZIENDA SPECIALE CONSORTILE calorelucano@ Pag. 1 ACQUEDOTTI DEL CALORE LUCANO SPA 2017 PREMESSA Il decreto legislativo n. 175/2016 recante “Testo Unico in materia di società partecipatedalla pubblica amministrazione”, rappresenta la nuova disciplina in materia. Il provvedimento è attuativo dell’articolo 18 della legge delega n. 124/2015, c.d. leggeMadia. Le disposizioni del decreto entrano in vigore il 23 settembre 2016. In relazione alle novità introdotte dal provvedimento è essenziale segnalare, in primis, le più significative : - partecipazioni delle PP.AA. limitate alle società di capitali, anche consortili; - espressa previsione ed elenco delle attività perseguibili attraverso le società; - nuove norme sulla governance delle società e limite ai compensi degliamministratori; - estensione della disciplina di crisi aziendale alle società a partecipazione pubblica; - specifiche procedure per costituzione, mantenimento ed alienazione dellepartecipazioni in società; - esclusione parziale delle società quotate, come definite nel testo, dall’applicazionedel decreto; - obbligo di dismissione per le società che non soddisfano specifici requisiti; - gestione transitoria del personale delle partecipate; - entro il 23 marzo 2017, revisione straordinaria obbligatoria -

CICOGNE INVADONO Roccadaspide CONTINUA a PAGINA 13 23 IL PUNTO
0828.720114 - unicosettimanale.it - [email protected] € 1,0 0 Editore: Calore s.r.l. Sede Legale: Via S. Giovanni, 86 - Villa Littorio - Laurino (Sa); Sede Redazionale: Via della Repubblica, 177 - Capaccio- Anno XIII Poste Italiane - Spedizione in a.p. - 45% - art. 2 comma 20/b legge 662/96 - Dir. Com. Business Salerno - Abb. annuale 25,00€ n° 31 del 03 Settembre 2011 L’EDITORIALE CAPACCIO INCHIESTA AULETTA/PERTOSA di Silvia De Luca COMUNALI DUE ROSCIGNO CALDORO, DI FILIPPO VOZAINCAMPO MOLTI POTENTATI E MARINO Cilento Outlet, ACONFRONTO un non luogo che ARTICOLO A PAG. 6 ARTICOLO A PAG. 3 ARTICOLO A PAG. 9 non è sviluppo A volte anche qualcosa di piacevole come un ritorno a casa può trasfor- marsi in un incubo. Mi è successo quattro settimane fa, quando ero in viaggio verso Vallo della Lucania, il mio paese di residenza, per trascor- rere qualche giorno di vacanza. Uscita dalla Salerno-Reggio a Battipa- glia, ho imboccato la Statale 18 e mi sono ritrovata subito imbottigliata in una fila interminabile di auto in coda. CICOGNE INVADONO Roccadaspide CONTINUA A PAGINA 13 23 IL PUNTO di Pasquale Di Perna Non c’è futuro se il fiume Calore è in secca “ La seguente petizione ha l’obiettivo di restituire il Deflusso Minimo Vitale FOTO MIRRO CAPO al fiume Calore Lucano con sorgente nel territorio del Comune di Piaggine Premesso che il fiume Calore si trova BATTIPAGLIA EBOLI in pieno Parco Nazionale del Cilento di Ernesto Giacomino di Francesco Faenza ed è tutelato a diversi livelli sia co- munale che sovracomunale, costi- tuendo un ecosistema di notevole Appuntamento Via dell’impatto pregio ambientale oltre che fonte di ambientale CONTINUA A PAGINA 2 al buio Anche per quest’estate caldo, allentamento delle pub- Il tormentone dell’estate ebolitana? Si chiama via. -

Scarica Il Report Fiume Calore
in collaborazione con Comune di Taurasi WWF Sannio Presentazione Il 97,4% delle acque terrestri è costituito da acque salate (mari ed oceani), il 2% da ghiacciai concentrati soprattutto ai poli e solo lo 0.6% da acque dolci, correnti o stagnanti in fiumi, laghi e falde acquifere, e da nubi o vapore atmosferico. L’acqua è estremamente importante dal punto di vista ecologico, essendo il vettore di ogni forma di vita, indispensabile all’uomo per la sopravvivenza e l’igiene, essenziale allo sviluppo dell’economia e della civiltà umana, perché senza acqua non c’è agricoltura e perché è fonte di energia e materia prima nei processi produttivi, via per i trasporti e base delle attività ricreative. Perciò, nel corso del processo di civilizzazione dell’uomo, si è gradualmente ampliato il ventaglio degli utilizzi delle acque , oltre che moltiplicata in misura esponenziale la quantità consumata, e di conseguenza gli annessi interventi sui sistemi idrici naturali. Tuttavia, non sempre l’uso e la gestione di questa risorsa sono avvenuti in maniera oculata, fondata cioè su un’organica ed approfondita conoscenza idrogeologica del territorio, con un approccio rispettoso dei contesti idrodinamici ed antropici esistenti. Nel corso dello sfruttamento millenario del territorio, l’uomo ha finito con il compromettere le risorse idriche sia qualitativamente che quantitativamente, così come ha stravolto anche indirettamente i sistemi idrici, dal momento che il suo lavoro non sempre si è svolto in armonia con l’ambiente naturale, di cui le acque costituiscono parte integrante. L’acqua, da risorsa abbondante ed incontaminata, è diventata oggi sempre più scarsa e di cattiva qualità, costituendo così un problema non più rinviabile neanche in Irpinia. -

100 Dpi) 0 0 1:31000 0 0 6 6 6 6 5 5
454000 456000 458000 460000 462000 464000 466000 468000 470000 472000 474000 14°27'0"E 14°28'0"E 14°29'0"E 14°30'0"E 14°31'0"E 14°32'0"E 14°33'0"E 14°34'0"E 14°35'0"E 14°36'0"E 14°37'0"E 14°38'0"E 14°39'0"E 14°40'0"E 14°41'0"E ! GLIDE number: N/A Activation ID: EMSR141 Product N.: 02TELESE, v0, English N " 0 ' ! 7 Cerreto Sannita N " 1 ° 0 ' 1 7 4 1 TELESE - ITALY ° 1 0 0 4 0 0 0 0 Flood - 14/10/2015 0 0 7 7 5 5 4 £ 4 Grading Map ! " £ £ Austria Hungary £ San Lorenzello £ Switzerland " ! " Isernia MoliSsloevenia " France £ " Croatia " Serbia Tite ^Roma Adriatic rno Sea Tyrrhenian Sea N " £ Ionian 0 ' N 6 " Sea 1 0 ° " ' 1 6 Italy 4 1 ° £ 1 Algeria Tunisia Mediterranean " 4 BenevenStoea 0 0 0 £ 0 0 0 8 " 8 6 6 5 ! 5 (! 02 4 San Lupo 4 Telese 03 ¨ ¨ 04 01 Guardia ltu 05 Vo rno !Sanframondi Caserta £ Campania Tyrrhenian " Sea Avellino N " 0 ' N 5 " 1 0 Napoli ° ' 1 5 4 1 ° 1 ¨ 4 ¨ Cartographic Information ! ¨ 0 ¨ San Lorenzo Maggiore 0 Full color ISO A1, low resolution (100 dpi) 0 0 1:31000 0 0 6 6 6 6 5 5 4 4 0 0.5 1 2 km "£ Grid: WGS 1984 UTM Zone 33N map coordinate system £ Tick marks: WGS 84 geographical coordinate system ± " ! San Salvatore Telesino £ Legend N ! " 0 £ ' " N 4 Castelvenere " 1 0 ° ' 1 £ " 4 Crisis Information Settlements Industry / Utilities 4 1 ° 1 "£ 4 ! " 16 Landslide (18/10/2015) Populated Place DU U Power Substation £ £ 16 Flooded Area Residential " " (18/10/2015 10:07 UTC) Quarry 0 16 0 Flooded Area Cemetery Transportation 0 0 0 0 (17/10/2015 04:53 UTC) £ 4 4 6 6 £ Commercial " Bridge 5 5 ¨ £ Affected by flood -

Provvedimento VIA Nell'ambito Del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale Ex Art 27 D.Lgs
COPIA COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA ■ CASTEL SAN LORENZO RELITTO - LAURINO - MAGLIANO VETERE - MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE ■ ROCCADASPIDE - SACCO ■ STIO - TRENTINARA - VALLE DELL'ANGELO 84069 ROCCADASPIDE(SA) Via Cesine 0828/941132 - 941000 AREA TECNICA E FINANZIARIA DETERMINA FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO OGGETTO: Conferenza dei servizi - CUP 8218 - Istanza rilascio provvedimento VIA nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art 27 D.Lgs. 152/2006 - Intervento derivazione acque sotterranee sorgenti Calore — Proponente Acquedotti del Calore Lucano S.p.A. — Rilascio parere svincolo idrogeologico — Determina a contrarre per INCARICO CONSULENZA TECNICA (CIG: Z4427A452B). 5 8 B 2U1h DETERMINA N° del 2 0 MAR, 2019 REGISTRO GENERALE N° del AREA TECNICA E FINANZIARIA FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E AGRICOLTURA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROPONE ai sensi dell'art. 6 della legge n° 241/90, l'adozione della seguente proposta di determinazione di cui si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza. OGGETTO: Conferenza dei servizi - CUP 8218 - Istanza rilascio provvedimento VIA nell'ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 D.Lgs. 152/2006 - Intervento derivazione acque sotterranee sorgenti Calore - Proponente Acquedotti del Calore Lucano S.p.A.- Rilascio parere svincolo idrogeologico - Determina a contrarre per INCARICO CONSULENZA TECNICA(CIG: Z4427A452B). PREMESSO: - che la Direzione Generale regionale del Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazione e Autorizzazioni Ambientali, a seguito dell'istanza della Società Acquedotti del Calore Lucano S.p.A., finalizzata ad ottenere la concessione per la derivazione di acque sotterranee della sorgente del Fiume Calore in agro del Comune di Piaggine, ha avviato il procedimento per il rilascio autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. -

Relazione Idrogeologica
A.T.O. N. 1 (Calore Irpino) AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 1 (Calore Irpino) REGIONE CAMPANIA – Legge 5 gennaio 1994 n. 36 PIANI FINANZIARI DELLE OPERE DEGLI IMPIANTI DI ACQUEDOTTI E FOGNATURE NEL MEZZOGIORNO D’ITALIA ART. 11. COMMA 3 LEGGE DEL 05/01/1994 N. 36 ART. 8, L.R. DEL 21/05/1994 N. 14 Relazione idrogeologica IL CONSULENTE GEOLOGO Prof. Dott. Pietro Bruno CELICO Ordinario di Idrogeologia Università di Napoli “Federico II” con la collaborazione di: INDICE dott. geol. Vincenzo ALLOCCA 1. PREMESSA pag. 3 2 2. PRINICPALI ELEMENTI DI GEOLGOIA REGIONALE pag. 4 3. INQUADRAMENTO IDROGEO LOGICO DEL TERRITORIO pag. 8 3.1 CORPI IDRICI CARBONATICI pag. 8 Monte Tre Confini pag. 8 Monti del Matese pag. 10 Monte Moschiaturo pag. 17 Monte Camposauro pag. 18 Monte Taburno pag. 19 Monte Tifata pag. 21 Monti di Durazzano pag. 23 Monti di Avella – Vergine – Pizzo d’Alvano pag. 25 Monti Accellica – Licinici – Mai pag. 27 Monti Terminio – Tuoro pag. 30 Monte Cervialto pag. 33 3.2 CORPI IDRICI ALLUVIONALI (PIANE INTERNE) pag. 35 Piana della Media Valle del Calore pag. 35 Piana di Benevento pag. 37 Piana dell’Isclero pag. 40 Piana dell’Ufita pag. 41 Piana dell’Alta Valle del Solofrana pag. 43 Piana dell’Alta Valle del Sabato pag. 45 4. VALUTAZIONE DELLE RIS ORSE IDRICHE SOTTERRANEE E CONFRONTO CON GLI ATTUALI PRELIEVI (BILANCIO IDRICO) pag. 47 5. CONCLUSIONI pag. 56 BIBLIOGRAFIA pag. 59 3 1. PREMESSA Nel presente lavoro vengono riportati i risultati di uno studio idrogeologico finalizzato alla valutazione della “potenzialità idrica sotterranea” (bilancio idrologico) del territorio di competenza dell’A.T.O. -

Relazione Tecnica Partecipate.Pdf
COMUNE DI MORRA DE SANCTIS Provincia di AVELLINO MEDAGLIA D’ORO AL VALORE CIVILE Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, commi 611 e ss “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” Legge di stabilità 2015 RELAZIONE TECNICA PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE POSSEDUTE 1 PREMESSA Alla data di redazione del Piano il Comune di Morra De Sanctis partecipa al capitale delle seguenti società: A) Irpinianet soc. Cons. a r.l. B) Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino (ASI) C) Patto Baronia s.r.l. IRPINIANET SOC. CONS. a R.L. “Irpinianet società consortile a r.l.” è stata costituita ai sensi dell’art. 2615 ter del codice civile con un capitale sociale di euro 10.000,00 interamente versato. La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga o scioglimento anticipato. La società è stata costituita per i seguenti scopi: realizzazione Centri servizi territoriali (CST) che garantiscano la diffusione di servizi innovativi; sostegno al processo di erogazione dei servizi di e - governement degli enti locali attraverso la messa a disposizione ai medesimi di risorse tecnologiche di know-how specialistico. In particolare, le attività che costituiscono l’oggetto sociale sono, a titolo esemplificativo: - servizi ai Comuni aggregati ed alle altre Pubbliche Amministrazioni residenti sul territorio; - servizi gratuiti ai cittadini e alle imprese; - servizi al consumo ai cittadini e alle imprese; - interscambio delle informazioni e condivisioni delle competenze -
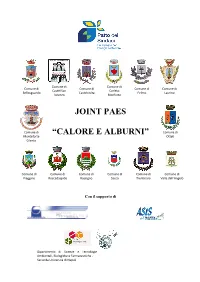
CALORE E ALBURNI” Comune Di Monteforte Ottati Cilento
Comune di Comune di Comune di Comune di Comune di Comune di Castel San Corleto Bellosguardo Castelcivita Felitto Laurino Lorenzo Monforte JOINT PAES Comune di “CALORE E ALBURNI” Comune di Monteforte Ottati Cilento Comune di Comune di Comune di Comune di Comune di Comune di Piaggine Roccadaspide Roscigno Sacco Trentinara Valle dell’Angelo Con il supporto di Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche ‐ Seconda Università di Napoli INDICE GENERALE 1. Contesto di Riferimento .................................................................................................................................................. 3 1.1 Il Patto dei Sindaci Congiunto “Calore e Alburni”: il percorso .................................................................................. 4 1.2 Obiettivi del PAES “Calore e Alburni” ....................................................................................................................... 7 1.3 Territorio di riferimento............................................................................................................................................ 9 1.3.1 Caratteristiche fisiche e demografiche d’insieme per i 14 comuni (anno 2007) ............................................. 10 1.3.2 Caratteristiche ambientali e paesistiche .......................................................................................................... 11 1.3.3 Caratteristiche urbanistiche e territoriali ....................................................................................................... -

Il Bacino Del Sele
Mio soltanto è il paese dell’anima mia. Marc Chagall IL BACINO DEL SELE J. P. Hackert: Veduta ideale di tempio, fiume, animali e Mercurio pastore, 1787. Museo Hermitage di Sanpietroburgo Silarus dovrebbe completare l’escursione bibliografica sui bacini fluviali della Campania interessati storicamente da opere di bonifica. Come per il Volturno, il Sebeto e il Sarno si proverà a fornire una traccia di ricerca storico-territoriale su quest’ambito geografico, a partire dalle fonti classiche e sino alle vicende dell’età contemporanea, sfiorando l’attualità e - inevitabilmente - le contraddizioni e le storie di degrado che ci riguardano. Il bacino del fiume Sele (75 Km dalle sorgenti di Caposele al mare, portata 69 m³/s), inclusi quelli dei due maggiori affluenti, Tanagro e Calore Lucano, ha una estensione di circa 3.300 Kmq, pari al 67% della superficie della Provincia di Salerno. Da questi pochi dati si desume la sua importanza territoriale nella geografia della regione. Oltre alla considerazione della notevole risorsa idrica, vorremo, per quanto detto, prendere avvio dalla valenza storica del fiume e della sua peculiare funzione di frontiera, linea di demarcazione sotto diversi aspetti tra le due aree segnate dal suo corso: - la zona di influenza etrusca (in destra) e quella greca e lucana (in sinistra); - la pianura storica dell’agricoltura intensiva (in destra) contrapposta alle propaggini collinari del Cilento storico e alla prevalente pastorizia; - i caratteri geomorfologici e la composizione chimica dei terreni, fertili e più asciutti in destra, salini e con maggiore tendenza all’impaludamento quelli in sinistra. FONTI BIBLIOGRAFICHE A. IL VICEREGNO A.1. -

NATURA 2000 Dir. 92/43/CEE E 79/409/CEE
Bagnoli Irpino Calvanico 52_01 Monte Cervialto e Montagnone di Nusco Fisciano Laviano Calabritto Monte Mai e Monte Monna Valva Giffoni Sei Casali Monte Accellica Acerno Senerchia 65001_01 Castiglione dei Genovesi Giffoni Valle Piana 65043_04Massiccio del Monte Eremita L 65118_01 Assessorato ai Rapporti con il Consiglio Regionale - Sport - Lavori Pubblici - Picentini Massiccio del Monte Eremita Colliano Opere Pubbliche - Parcheggi - Cave e Torbiere, Acque Minerali, Termali e Miniere San Cipriano Picentino Commissario ad Acta 65073_02 Monti di Eboli, Monte Polveracchio, Monte Boschetiello e Vallone della Caccia di Senerchia San Mango Piemonte PIANO REGIONALE ATTIVITA' ESTRATTIVE 65121_03 65073_01 Oliveto Citra Ordinanza T.A.R. Campania - Napoli - Prima sezione - n. 719 del 18/5/05 Montecorvino Rovella 65120_03 65056_05 65043_02 65073_03 65083_02 65089_01 65120_02 65072_11 65073_08 65083_01 San Gregorio Magno 65056_01 65089_02 65043_01 65072_10 65022_15 65022_03 Ricigliano 65072_09 Olevano sul Tusciano 65089_04 Campagna 65022_17 65022_10 65072_04 65072_06 65089_07 65022_09 Salerno Montecorvino65072_08 Pugliano 65022_07 65120_01 Palomonte I 16_17 65072_01 65072_07 65089_09 Contursi Terme 65017_01 65072_02 65089_10 65120_04 65017_05 65014_06 65073_15 65050_07 Buccino 65014_01 65050_06 65017_03 Romagnano al Monte PIANO REGIONALE ATTIVITA' ESTRATTIVE Pontecagnano Faiano 65014_04 65014_03 65022_14 Fiumi Tanagro e Sele Bellizzi 65014_08 65050_05 65014_02 65050_02 65017_06 65050_01 65017_09 65014_07 65140_01 65050_03 Salvitelle Medio Corso del Fiume Sele-Persano Battipaglia 65140_02 65012_01 65143_04 65012_02 C Tavola n. 2 - SA/2: NATURA 2000: Aree SIC e ZPS Dir.92/43/CEE e 79/409/CEE 65019_02 Sicignano degli Alburni Provincia di Salerno Serre Postiglione 65143_02 Eboli Caggiano Auletta Il Commissario ad Acta delegato Pertosa (Decreto Ass. Reg. LL.PP. n. 439 del 6/9/05) A Coordinatore A.G.C. -

De Bonis Siluro Volturno.Indd
Biologia Ambientale, 29 (1): 62-67 (2015) Presenza di Silurus glanis Linnaeus, 1758, nel bacino del fi ume Volturno (Campania) Salvatore De Bonis1*, Antonella Giorgio1, Fernando Sirignano2, Sergio Di Donato2, Fabio Di Placido3, Marco Guida1 1 Dipartimento di Biologia Università degli Studi di Napoli Federico II, via Cinthia 4, Napoli 2 Libero Professionista 3 Responsabile acque F.I.P.S.A.S. Avellino * Referente per la corrispondenza: [email protected] Pervenuto il 30.7.2014; accettato il 10.9.2014 RIASSUNTO Il siluro (Silurus glanis L., 1758) si sta espandendo molto velocemente in tutta la penisola italiana, a partire dalla prima segnalazione in Italia del 1937; nelle acque dei fi umi rappresenta una minaccia sempre più imponente per le popolazioni ittiche autoctone. Con questa nota si intende segnalare la presenza del siluro nelle acque del bacino del fi ume Volturno evidenziando una presenza massiva di individui giovani nelle acque del fi ume Calore Irpino in provincia di Avellino e Be- nevento, e nel fi ume Sabato in provincia di Benevento (maggio 2014). PAROLE CHIAVE: specie aliene / Volturno / Calore Irpino / Silurus glanis Presence of Silurus glanis Linnaeus, 1758, in the Volturno Basin. The wels catfi sh, also called sheatfi sh (Silurus glanis L.) is expanding very rapidly throughout the italian peninsula, com- pared to the fi rst case in Italy in 1937; in the waters of the rivers represent a real threat to native fi sh populations. The main purpose is to report the presence of Silurus glanis in the waters of the basin of the river Volturno. Here we indicate a mas- sive presence of young fi shes in the waters of the river Calore Irpino in the province of Avellino and Benevento, and in the river Sabato in the province of Benevento (May 2014). -

“Basilicata 2012”
PROTEZIONE CIVILE PREFETTURA PROVINCIA DI POTENZA U.T.G. DI POTENZA Esercitazione Nazionale di Protezione Civile Rischio Sismico “Basilicata 2012” 14 - 15 Dicembre 2012 Schema di documento d’impianto a livello provinciale Provincia di Potenza Schema di impianto a livello provinciale: provincia di Potenza pag. 1/64 Esercitazione Nazionale “Basilicata 2012” INDICE PREMESSA 1. INQUADRAMENTO CONOSCITIVO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA 1.1 GEOMORFOLOGIA 1.2 GEOLOGIA 1.3 IDROGEOLOGIA 1.4 IDROGRAFIA SUPERFICIALE 1.5 ASSETTO DELLA POPOLAZIONE ED ASPETTI CARATTERISTICI 1.6 IL SISMTEMA INDUSTRIALE 1.7 SERVIZI ED INFRASTRUTTURE DI RILIEVO 1.8 IL SISTEMA SANITARIO E SOCIO-ASSISTENZIALE 1.9 LE STRUTTURE RICETTIVE 2. RETI DI COMUNICAZIONE 2.1 CARATTERISTICHE FUNZIONALI E PRESTAZIONALI DELLA RETE STRADALE 2.2 RETE FERROVIARIA 3. IL MODELLO DI PROTEZIONE CIVILE A LIVELLO PROVINCIALE 4. TIPO D’ESERCITAZIONE 4.1 OBIETTIVI 4.2 LIVELLO COMUNALE 4.3 LIVELLO INTERCOMUNALE 4.4 LIVELLO PROVINCIALE 4.5 LIVELLO REGIONALE 5. EVENTO SISMICO 5.1 L’EVENTO DI RIFERIMENTO 5.2 L’EVENTO SIMULATO 6. I LIVELLI DI COMANDO E COORDINAMENTO 6.1 IL CENTRO COORDINAMENTO SOCCORSI (CCS) 6.2 I CENTRI OPERATIVI MISTI (COM) 6.3 I CENTRI OPERATIVI COMUNALI (COC) 6.4 SALA OPERATIVA REGIONALE (SOR) 7. PARTECIPANTI 8. SCENARI ESERCITATIVI DI EMERGENZA ATTIVATI 8.1 EVOLUZIONE DELLO SCENARIO DI DANNO 8.2 MONITORAGGIO 8.3 VULNERABIITA’ INFRASTRUTTURE 8.4 RISCHI INDOTTI 8.5 ACCESSIBILITA’ 8.6 CENTRI COORDINAMENTO ED AREE AMMASSAMENTO SOCCORRITORI 8.7. MODELLO DI INTERVENTO SANITA’ 8.8. CRISI DI ALCUNI SERVIZI ESSENZIALI 8.9. TELECOMUNICAZIONI 8.10. LOGISTICA VOLONTARIATO 8.11 FORMAZIONE – DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE 8.12 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 8.13.