04 Impa Pressana Quarta OK
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

INTERVENTI CONCLUSI 2006-2014 in Lavorazione
INTERVENTI DI PIANO D'AMBITO DELL'ATO VERONESE COMPLETATI NEL PERIODO 2006-2014 CODICE IMPORTO PROGETTO IMPORTO COMUNE REALIZZATORE AREA TITOLO INTERVENTO SERVIZIO AATO (€) CONTRIBUTI (€) AFFI COMUNE DI AFFI G Adeguamento acquedotto zona Centro Commerciale B.1-A-51 A€ 155.000 AFFI AGS G Fognatura Mezzacasa Incaffi B.1-A-52 F€ 275.000 AFFI AGS G Adeguamento funzionale Impianto di depurazione di Affi D€ 137.000 Realizzazione rete idrica e fognaria in zone sprovviste del capoluogo - 1° ALBAREDO D'ADIGE ACQUE VERONESI V AF€ 125.000 stralcio B.1-B-08a ALBAREDO e ARCOLE CISIAG V Fognatura Via Venezia (albaredo) e Via Padovana e Nogarole (Arcole) F€ 325.000 B.1-B-09a ALBAREDO, ARCOLE, BONAVIGO, BOSCHIS.A., COLOGNA VENETA, Estensione rete idrica nei comuni di Albaredo, Arcole, Bonavigo, Boschi LEGNAGO, MINERBE, PRESSANA, ACQUE VERONESI V Sant'Anna, Cologna v., legnago, Minerbe, pressana, Roveredo, terrazzo, vari A€ 1.200.000 ROVEREDO, TERRAZZO, VERONELLA, Veronella, Zimella - 1° stralcio ZIMELLA ALBAREDO, ARCOLE, BONAVIGO, BOSCHIS.A., COLOGNA VENETA, Rifacimento rete idrica in Albaredo, Arcole, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi LEGNAGO, MINERBE, PRESSANA, ACQUE VERONESI V S.A., Cologna Veneta, legnago, Minerbe, Pressana, Roveredo di Guà, vari A€ 1.558.000 € 1.145.000 ROVEREDO, TERRAZZO, VERONELLA, Terrazzo, Veronella, Zimella - 1° stralcio ZIMELLA ALBAREDO, ARCOLE, BONAVIGO, BOSCHIS.A., COLOGNA VENETA, Rifacimento rete idrica in Albaredo, Arcole, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi LEGNAGO, MINERBE, PRESSANA, ACQUE VERONESI V S.A., Cologna Veneta, legnago, -

PROVINCIA DI VERONA Servizi Turistico-Ricreativi
PROVINCIA DI VERONA Servizi Turistico-Ricreativi Allegato A) alla determinazione dirigenziale n. 3818/13 del 26/08/2013 – sostituisce l'allegato A) alla determinazione n. 2914 del 24/06/2013 ALBO PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO ANNO 2013 COMUNE DI N. PRO LOCO INDIRIZZO APPARTENENZA 1 Albaredo d'Adige ALBAREDO D'ADIGE Piazza A. Moro, n. 3 37041 Albaredo d’Adige 2 Badia Calavena SPREA CUM PROGNO Via Zami, n. 1 37030 Badia Calavena 3 Belfiore BELFIORE Piazza della Repubblica, n. 7/8 37050 Belfiore 4 Bonavigo BONAVIGO Via Trieste 37040 Bonavigo 5 Bosco Chiesanuova BOSCO CHIESANUOVA Piazza Chiesa, n. 34/A 37021 Bosco Chiesanuova 6 Bovolone BOVOLONE Via Ospedale, n. 13 37051 Bovolone 7 Brenzone PER BRENZONE Via XX Settembre, n. 12 37010 Brenzone 8 Buttapietra BUTTAPIETRA V.le dell'Agricoltura, n. 1 37060 Buttapietra 9 Caldiero CALDIERO Piazza Vittorio Veneto 37042 Caldiero 10 Caprino Veronese CAPRINO VERONESE Via S.Pertini, n. 1 37013 Caprino Veronese 11 Casaleone CARPANEA Via Roma, n. 4 37052 Casaleone 12 Castagnaro CASTAGNARO Via Stazione, n. 1 37043 Castagnaro 13 Cavaion Veronese S. MICHELE Via Fracastoro, n. 1 37010 Cavaion Veronese 14 Cazzano di Tramigna CAZZANO DI TRAMIGNA Piazza Matteotti, n. 11 37030 Cazzano di Tramignia 15 Cerea CEREA Via XXV Aprile, n. 52 37053 Cerea 16 Cerro Veronese CERRO VERONESE Piazza Don A. Vinco n. 3 37020 Cerro Veronese 17 Cologna Veneta CITTA' DI COLOGNA VENETA Via Cavour n. 72 37044 Cologna Veneta 18 Colognola ai Colli COLOGNOLA AI COLLI Via S. Biagio n. 7 37030 Colognola ai Colli 19 Concamarise CONCAMARISE IN CAMMINO Via Piazza, n. -

Una Storia Di Verona Tra Sette E Ottocento
Nell’ultimo scorcio del Settecento, con l’irrompere dell’armata francese in Italia, si assiste a un proliferare di cronache, memorie, diari, nei quali i Una storia di Verona contemporanei fissano gli avvenimenti, epocali, che andavano accadendo sotto i loro occhi. Alcuni di questi scritti, lungi dall’essere mere elencazio- a cura di Fabrizio Bertoli ni di fatti, superano lo stile cronachistico, indagando e interpretando le tra sette e ottocento cause e le connessioni tra gli accadimenti, talvolta con una certa consape- volezza metodologica. La cronaca di Girolamo de’ Medici, nobile veronese È questo sicuramente il caso della cronaca del veronese conte Girolamo de’ Medici, il cui manoscritto originale, autografo, è conservato presso la Biblioteca Civica di Verona. Si tratta di una delle fonti più importanti per la ricostruzione della storia di Verona alla fine del Settecento, che merita a cura di Fabrizio Bertoli di essere letta e conosciuta oltre la stretta cerchia degli specialisti. Le vi- cende della “grande storia” sono registrate velocemente dalla penna del- l’autore, insieme con le vicende quotidiane: dalla partenza del conte di Lilla (il futuro Luigi XVIII) da Verona all’arrivo del generale Bonaparte, ombre corte dalle varie battaglie alle “Pasque veronesi”, dalla proclamazione della Municipalità democratica alle vicende della Sala di istruzione pubblica. A tra sette e ottocento Una storia di Verona queste, egli aggiunge poi commenti, anche sapidi, su alcune personalità cittadine del tempo, in un fascicoletto a parte di “Annotazioni secrete”. È una testimonianza ricca e vivace della vita cittadina negli ultimi anni del Settecento e, al tempo stesso, un testo da leggere non solo per ricavare in- formazioni sui fatti, ma anche per ricostruire mentalità, concezioni, sim- patie, timori, idiosincrasie dell’autore, frutto, in parte, della sua apparte- nenza a un determinato ambiente socioculturale. -

PROVINCIA DI VERONA Servizi Turistico-Ricreativi
PROVINCIA DI VERONA Servizi Turistico-Ricreativi Allegato A) alla determinazione dirigenziale n. 3102 del 08.06.2010che si compone di n. 5 pagine. Il Diri ALBO PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO ANNO 2010 COMUNE DI N. PRO LOCO INDIRIZZO APPARTENENZA 1 Albaredo d'Adige ALBAREDO D'ADIGE Piazza A. Moro, n. 3 37041 Albaredo d’Adige 2 Angiari ANGIARI Piazza Municipio, n. 441 37050 Angiari 3 Badia Calavena SPREA CUM PROGNO Via Zami, n. 1 37030 Badia Calavena 4 Belfiore BELFIORE Piazza della Repubblica, n. 7/8 37050 Belfiore 5 Bonavigo BONAVIGO Via Trieste 37040 Bonavigo 6 Bosco Chiesanuova BOSCO CHIESANUOVA Piazza Chiesa, n. 34/A 37021 Bosco Chiesanuova 7 Bovolone BOVOLONE Piazza Costituzione, n. 1 37051 Bovolone 8 Brenzone PER BRENZONE Via XX Settembre, n. 12 37010 Brenzone 9 Buttapietra BUTTAPIETRA V.le dell'Agricoltura, 1 37060 Buttapietra 10 Caldiero TERME DI GIUNONE Piazza Vittorio Veneto 37042 Caldiero 11 Caprino Veronese CAPRINO VERONESE Via Pertini, n. 1 37013 Caprino Veronese 12 Casaleone CASALEONE CARPANEA Via Battisti, n. 4 37052 Casaleone 13 Castagnaro CASTAGNARO Via Stazione, n. 1 37043 Castagnaro 14 Castel d'Azzano CASTEL D'AZZANO Via Marconi, n. 47 37060 Castel d'Azzano 15 Castelnuovo del Garda CASTELNUOVO DEL GARDA Piazza Angelini, n. 1 37014 Castelnuovo del Garda 16 Cavaion Veronese S. MICHELE Via Fracastoro, n. 1 37010 Cavaion Veronese 17 Cazzano di Tramigna CAZZANO DI TRAMIGNA Piazza Matteotti, n. 11 37030 Cazzano di Tramignia 18 Cerea CEREA Via XXV Aprile, n. 52 37053 Cerea 19 Colognola ai Colli COLOGNOLA AI COLLI Via S. Biagio, n. 7 37030 Colognola ai Colli 20 Concamarise CONCAMARISE IN CAMMINO Via Piazza, n. -

Determina 4471 Del 23/09/2019 Oggetto
Protocollo 0315984/2019 , num. registro 4471 Copia cartacea conforme all'originale digitale. Documento firmato digitalmente da PIGNATELLI ALESSANDRO. Verona, 24/09/2019. Il Funzionario Incaricato POLITICHE EDUCATIVE SCOLASTICHE E GIOVANILI DETERMINA 4471 DEL 23/09/2019 OGGETTO: PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER LE BAMBINE E I BAMBINI DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI – CONTRIBUTO STATALE DA DISTRIBUIRE AGLI ASILI NIDO PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VERONA - ALLEGATO C DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1548 DEL 22 OTTOBRE 2018 – IMPEGNO DI € 28.760,30 IL DIRIGENTE DIREZIONE POLITICHE EDUCATIVE SCOLASTICHE E GIOVANILI Premesso che: - con la legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” in particolare il comma 181, lettera e) è stato istituito per la prima volta il “sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell’offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie”; - con D. Lgs 13 aprile 2017 n. 65 è stato previsto, per l’attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione ed istruzione 0/6 anni, l’istituzione di un fondo per gli anni 2017, 2018 e 2019; Considerato che i Comuni sono chiamati ad erogare la quota dei fondi statali spettanti alle strutture presenti sul proprio territorio; Visto che, ai sensi dell’Allegato C della Deliberazione di Giunta Regionale n. -

The Energy of the School Siamo Tre Alunni Di Prima Media E a Parte Il
Siamo tre alunni di prima media e a parte il salto dalle elementari, ci ha colpito molto fin dall’inizio dell’anno l’impegno che il nostro insegnante di musica metteva nel insegnarci a differenziare al meglio i rifiuti e a impegnarci a riciclare il più possibile. Questo ci ha spinto a conoscere meglio come funziona la raccolta differenziata nella nostra città. Abbiamo intervistato un loro referente di servizio, il sig. Davide Bertelli, al quale abbiamo chiesto alcune informazioni su come si svolge la raccolta. Ecco in sintesi cosa abbiamo imparato: La SIVE è nata nel 2003, ed è la società che svolge il servizio di igiene urbana nei seguenti 10 Comuni della Bassa Con il rifiuto organico (umido) di Legnago oltre al terriccio Veronese:Legnago, Cerea, Boschi Sant'Anna, Minerbe, viene prodotta energia elettrica, a seguito del processo di Pressana, Sanguinetto, Roveredo di Guà, Veronella, digestione anaerobica, che avviene per mezzo di batteri. Zimella, Cologna Veneta . La SIVE è un’azienda pubblica, ed oggi conta più di cinquanta dipendenti. I lavoratori dell’azienda si alzano alle 5 del mattino e cominciano a raccogliere i rifiuti urbani. Ci ha spiegato subito che anni fa tutti i rifiuti, indistintamente, venivano portati in discarica a loro volta bruciati, mentre oggi vengono divisi per tipo e poi riciclati. I rifiuti, dopo che ne è stata verificata la corretta separazione, vengono portati in vari consorzi a noi limitrofi. Ecco dove Legnago deposita i vari materiali dopo averli divisi e pressati: Abbiamo scoperto che in Italia ci sono pochi inceneritori La PLASTICA al Consorzio di Cerea mentre all’estero tanti. -

Regolamento Di Adesione Al Coordinamento Intercomunale Per Lo Sport
REGOLAMENTO DI ADESIONE AL COORDINAMENTO INTERCOMUNALE PER LO SPORT ART. 1 I Comuni di Albaredo d’Adige, Arcole, Belfiore, Cologna Veneta, Isola Rizza, Oppeano, Minerbe, Palù, Pressana, Roverchiara, Roveredo di Guà, Veronella, Zevio e il CONI – Comitato Provinciale di Verona, riconoscono l’alta valenza sociale che le attività sportive possono svolgere nel campo dell’educazione, della prevenzione, della salute, del sociale. ART. 2 Riconoscendo lo Sport come servizio sociale, i sopracitati Enti intendono promuovere e sostenere ogni iniziativa sportiva affinché la pratica delle attività motorie e sportive sia accessibile a tutti i cittadini e possa essere strumento di educazione e formazione personale e sociale, di tutela e miglioramento della salute, di sano impiego del tempo libero. ART. 3 I sopracitati Enti riconoscono la necessità che le associazioni e società sportive debbano essere condotte in modo professionale e che i loro dirigenti, allenatori e tecnici possano seguire un percorso comune di formazione e aggiornamento in quei settori in cui sono quotidianamente coinvolti: sportivo, amministrativo, fiscale, sanitario. ART. 4 Per raggiungere tali scopi è istituito il “Coordinamento Intercomunale per lo Sport”, organismo propositivo, consultivo e luogo di partecipazione e confronto tra le forze sportive, politiche, sociali e culturali dei Comuni che lo compongono. Al Coordinamento Intercomunale per lo sport potranno aderire solo i Comuni facenti capo all’attuale zona 9 del Coni Provinciale. ART. 5 Il Coordinamento Intercomunale per lo Sport potrà proporre e coordinare: a) iniziative tese a rendere la pratica motoria, sportiva e ricreativa accessibile a tutti i cittadini; b) sviluppo dell’associazionismo sportivo; c) iniziative rivolte alla formazione e alla qualificazione degli operatori sportivi; d) promuovere studi e ricerche in materia di realizzazione, ampliamento ammodernamento di impianti e servizi sportivi; e) promozione e propaganda di tutte le iniziative dei Comuni aderenti; f) modifica delle norme al presente regolamento. -

Comando Provinciale Carabinieri Di Verona
Prefettura di Verona Briefing situazione area di Legnago 1 Prefettura di Verona 1. Territorio 2. Presidi delle Forze di Polizia 3. Popolazione 4. Stranieri residenti e migranti 5. Imprese 6. Delittuosità 2 Prefettura di Verona Territorio 3 Prefettura di Verona Suddivisione del territorio dei Comuni dell’area di Legnago in Kmq SANGUINETTO 13,51 ANGIARI 13,47 BEVILACQUA 12,2 ROVEREDO DI GUA' 10,16 BOSCHI S.ANNA 8,97 S.PIETRO DI MORUBIO LEGNAGO 79,27 16,12 ISOLA RIZZA 16,68 PRESSANA 17,39 CEREA 70,3 BONAVIGO 17,99 TOTALE ROVERCHIARA 19,65 730,56 kmq ZIMELLA 20,1 TERRAZZO 20,53 GAZZO VERONESE 56,66 VERONELLA 20,88 ALBAREDO D'ADIGE 28,25 VILLA BARTOLOMEA 52,99 MINERBE 29,65 CASTAGNARO 34,8 OPPEANO 46,73 CASALEONE 38,61 COLOGNA V. 42,83 RONCO ALL'ADIGE 42,82 Fonte: Camera di Commercio di Verona 2019 4 Prefettura di Verona Rapporto delittuosità /superficie del territorio in kmq 9 PER KMQ 9 8 7 6 5 PER KMQ 5 4 3 2 1 0 COMUNI DELL’ AREA DI LEGNAGO PROVINCIA DI VERONA 5 Prefettura di Verona Principali arterie viarie Ronco Zimella 5 all’Adige 4 4 2 5 3 9 SS 12 1 SS 434 1 1 SR 10 1 2 INC. MORTALI INC. CON FERITI 3 1 2 3 2 INCIDENTI 14 1 STRADALI 28 ANNO 2019 1 2 3 NR. 169 3 4 INCIDENTI 1 4 STRADALI 5 1 2 MORTALI ANNO 2019 4 NR. 8 6 Prefettura di Verona Presidi delle Forze di Polizia 7 Prefettura di Verona Reparti Forze di Polizia – Area di Legnago 1 Sezione Polstrada 1 Sezione Polfer 1 Comando Compagnia 9 Comandi Stazione 1 Comando Compagnia 8 Prefettura di Verona Popolazione 9 Prefettura di Verona Suddivisione del numero di abitanti dei Comuni dell’area di Legnago ROVEREDO DI GUA' TERRAZZO 2188 BONAVIGO 2009 BEVILACQUA 1692 1601 BOSCHI S.ANNA 1391 ANGIARI 2265 PRESSANA 2523 TOTALE ROVERCHIARA 2672 133.627 S.PIETRO DI MORUBIO 2975 ISOLA RIZZA 3242 LEGNAGO 25380 CASTAGNARO 3687 SANGUINETTO 4097 CEREA 16602 MINERBE 4617 ZIMELLA 4880 VERONELLA 5120 OPPEANO 10097 ALBAREDO D'ADIGE 5263 COLOGNA V. -

Albo 2009 Con Integrazione Luglio
ALBO PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO ANNO 2009 COMUNE DI N. PRO LOCO INDIRIZZO APPARTENENZA 1 Albaredo d'Adige ALBAREDO D'ADIGE Via Moro, n. 3 37041 Albaredo d’Adige 2 Angiari ANGIARI Piazza Municipio, n. 441 37050 Angiari 3 Badia Calavena SPREA CUM PROGNO Via Xami, n. 1 37030 Badia Calavena 4 Belfiore BELFIORE Piazza della Repubblica, n. 7/8 37050 Belfiore 5 Bonavigo BONAVIGO Via Trieste 37040 Bonavigo 6 Bosco Chiesanuova BOSCO CHIESANUOVA Piazza Chiesa, n. 34/A 37021 Bosco Chiesanuova 7 Bosco Chiesanuova CORBIOLO CLUB 5 CORTI Via Del Casalin, n. 10 37021 Bosco Chiesanuova 8 Bovolone BOVOLONE Piazza Costituzione, n. 1 37051 Bovolone 9 Brenzone PER BRENZONE Via XX Settembre, n. 12 37010 Brenzone 10 Buttapietra BUTTAPIETRA Piazza Roma, n. 24 37060 Buttapietra 11 Caldiero TERME DI GIUNONE Piazza Vittorio Veneto 37042 Caldiero 12 Caprino Veronese CAPRINO VERONESE Via Pertini, n. 1 37013 Caprino Veronese 13 Casaleone CASALEONE CARPANEA Via Battisti, n. 4 37052 Casaleone 14 Castagnaro CASTAGNARO Via Stazione, n. 1 37043 Castagnaro 15 Castel d'Azzano CASTEL D'AZZANO Via Marconi, n. 47 37060 Castel d'Azzano 16 Castelnuovo del Garda CASTELNUOVO DEL GARDA Piazza Angelini, n. 1 37014 Castelnuovo del Garda 17 Cavaion Veronese S. MICHELE Via Fracastoro, n. 1 37010 Cavaion Veronese 18 Cazzano di Tramigna CAZZANO DI TRAMIGNA Piazza Matteotti, n. 11 37030 Cazzano di Tramignia 19 Cerea CEREA Via XXV Aprile, n. 52 37053 Cerea 20 Cologna Veneta COLOGNA VENETA Via Corso Buà, n. 41 37044 Cologna Veneta 21 Colognola ai Colli COLOGNOLA AI COLLI Via S. Biagio, n. 7 37030 Colognola ai Colli 22 Concamarise CONCAMARISE IN CAMMINO Via Piazza, n. -

VERONA 2 – PIANURE VERONESI ATEM –Ambito Territoriale Minimo
VERONA 2 – PIANURE VERONESI ATEM –ambito territoriale minimo Nota informativa sulla organizzazione della gara per la concessione della rete gas 1. Situazione normativa in sintesi Il periodo di transizione e le successive proroghe riguardanti le concessioni del servizio di distribuzione del gas, di cui alla disciplina stabilita dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (c.d. Decreto Letta) e dai successivi interventi normativi, sono da tempo giunti a compimento: i Comuni interessati avrebbero potuto procedere alle gare ad evidenza pubblica per l’affidamento delle nuove concessioni, a norma della legislazione richiamata, già da diversi anni. In questa situazione sono tuttavia sopravvenuti – in applicazione dell’art. 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222 – prima il Decreto Ministeriale (MiSE) del 19 gennaio 2011, pubblicato sulla GU del 31 marzo successivo, poi il Decreto Legislativo del 1 giugno 2011, n. 93, pubblicato sulla GU il successivo 28 giugno. In particolare l’art. 24 del citato Decreto Legislativo n. 93/11 stabilisce che le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione sono effettuate unicamente per ambiti territoriali minimi (177 sul territorio nazionale), come definiti dal D.M. 10.10.11 e secondo i criteri e procedure del D.M. 226 del 12.11.11. 3. Ambito Territoriale VERONA 2 – PIANURE VERONESI AVERONAMBITO 2 - PIANURE VERONESI Superficie 1.442 Kmq Popolazione 366.244 abitanti (2008) 374.307 abitanti (2010) Numero comuni 49 in totale di cui 49 metanizzati Lunghezza rete di 2322 (Km) distribuzione (anno 2008) Clienti 144.321 in totale (anno 2008) Gas distribuito 324.089 (migliaia di mc) (anno 2008) Province a cui Verona appartengono i comuni costituenti l'ambito L’ATEM VERONA 2 – PIANURE VERONESI include i Comuni sotto indicati: 1. -

PRESSANA (VR) Via Mazzini, 29/F Tel
Periodico di informazione a cura dell’Amministrazione Comunale Dicembre 2013 PRESSANA Comune di Pressana Informa Targa al merito a Fabrizio Di Donato Decio Corubolo illustre pressanese Festa Bavarese - terza edizione SEDE E LABORATORIO DI PRODUZIONE INTEGRATORI ALIMENTARI A BASE DI ESTRATTI VEGETALI CON SPACCIO AZIENDALE APERTO AL PUBBLICO Siamo produttori di integratori a base di piante officinali, probiotici ... e non solo... piante officinali, tisane e cosmesi funzionale Vi aspettiamo nel nostro SPACCIO AZIENDALE! Idee per il Natale! PRESSANA (VR) Via Mazzini, 29/f Tel. +39 (0) 442 411196 - 412471 Fax +39 (0) 442 419616 [email protected] - www.naturfarma.it 1 PRESSANAInforma Periodico di informazione a cura dell’Amministrazione Comunale di Pressana Anno 14 numero 2 Sommario Autorizzazione del Tribunale di Verona n. 1388/99 del 23/12/99 Tiratura 1200 copie Saluto del Sindaco 3 Opere pubbliche 4 PIAR del Colognese presto il via ai lavori 5 Aiuti nel Comune 5 Dalla Provincia... 6 Sempre all’erta, sempre pronti 6 Papa Francesco è cattolico 7 Decio Corubolo uomo di cultura e ispiratore dell’Hellas 8 Posata una targa nel centenario della scomparsa 9 10 Aloise Vecchiato, eclettico musicista nato a Pressana 10 Frutti della nostra terra 11 Fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te 12 Quando la maternità è difficile 13 Hilda De Grandi 14 Direttore Responsabile: Consulta Giovanile: Marco Scarmagnani Attività della Consulta 15 Fotografando 15 Editore: In 2000 alla Festa bavarese 16 Comune di Pressana (Vr) 12 Direzione e Redazione: Novità al “Girotondo” 18 Municipio di Pressana Piazza Garibaldi n.1 Un riconoscimento guadagnato.. -
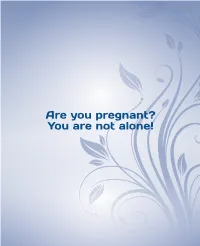
Are You Pregnant? You Are Not Alone! with the Partecipation Of
Are you pregnant? You are not alone! With the partecipation of Municipalities Partner Badia Calavena Legnago San Martino B.Albergo Belfiore Montecchia di Crosara San Pietro di Morubio Boschi Sant’Anna Mozzecane Selva di Progno Bovolone Negrar Sommacampagna Caldiero Nogara Terrazzo Castagnaro Nogarole Rocca Tregnago Castel d’Azzano Peschiera del Garda Valeggio sul Mincio Castelnuovo del Garda Povegliano Veronese Verona Cerea Pressana Vigasio Cologna Veneta Roncà Villafranca di Verona Costermano San Bonifacio Grezzana San Giovanni Ilarione GENERAL INDEX IF YOU ARE AN EMPLOYEE/WORKING MOTHER p. 25 IF YOU WORK IN BLACK (WITHOUT ANY LEGAL CONTRACT) p. 26 MATERNITY BENEFITS FOR NON WORKING MOTHERS p. 28 IF YOU ARE A FOREIGNER AND NOT COMPLIED WITH THE RULES OF ENTRY AND STAY p. 29 ENGLISH IF YOU ARE AN EUROPEAN UNION CITIZEN WITHOUT HEALTH CARE ASSISTANCE p. 30 IF YOU THINK YOU CANNOT OVERCOME YOUR DIFFICULTIES AND YOU ARE NOT ALLOWED TO KEEP YOUR BABY IN THAT CASE p. 32 WHO CAN HELP YOU? PUBLIC FAMILY PLANNING/COUNSELLING CENTRES p. 33 A list of family counselling centres of the three ULSS in reference with specific services A list of private family counselling centres in the province SOCIAL SERVICES OF YOUR MUNICIPALITY OF RESIDENCE p. 36 CENTRO AIUTO VITA (VOLONTERY ASSOCIATIONS) p. 37 What is "CENTRO AIUTO VITA" ? A list of local CAV centres Chapter 1 You have realized that you are pregnant Maybe your pregnancy was unexpected,not chosen or maybe you don’t consider now the appropriate moment to have a baby,or maybe you desire to have it but you find it difficult to accept him because this will complicate your life more..