Guida Naturalistica Del S.I.C
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
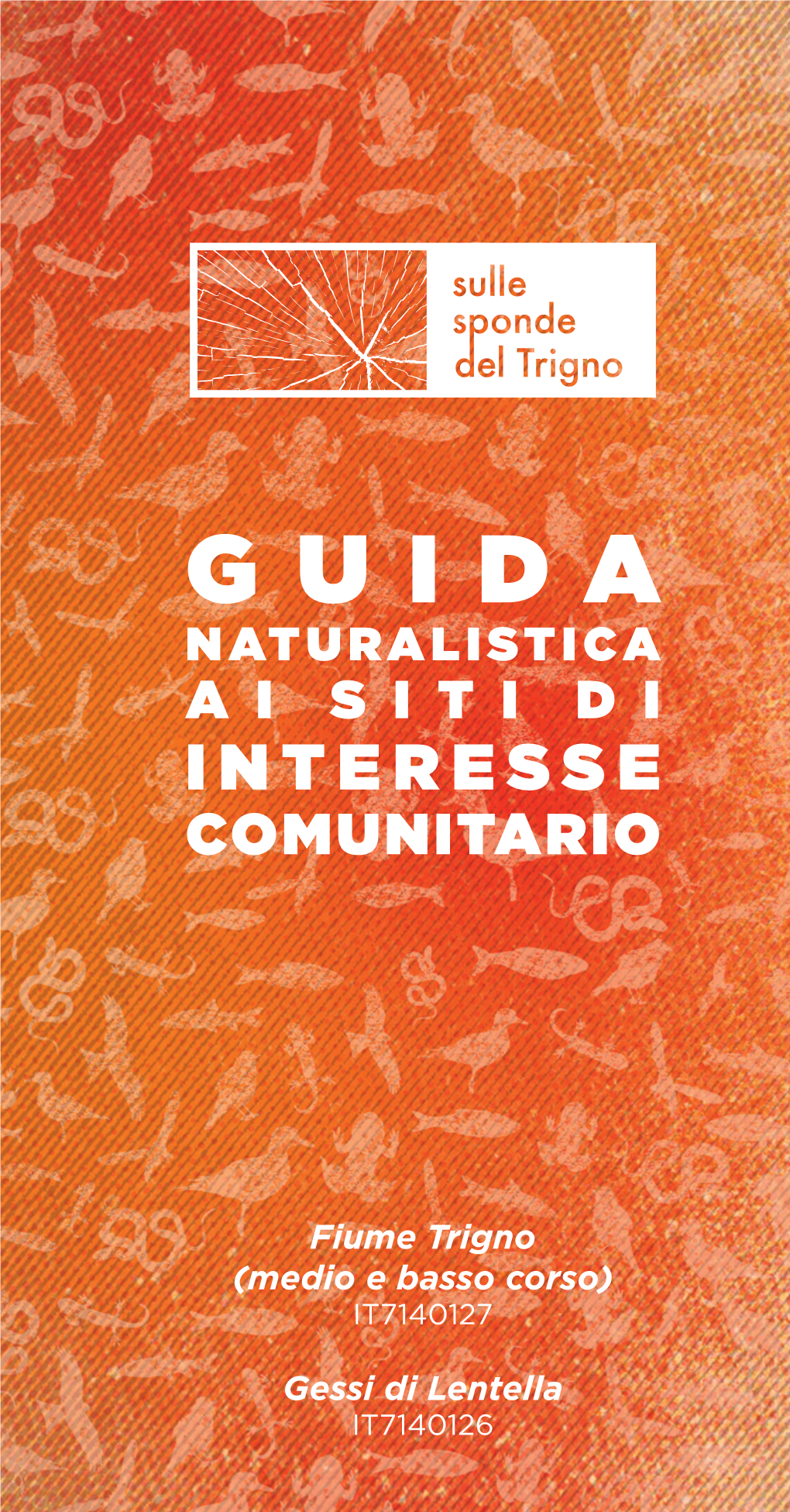
Load more
Recommended publications
-
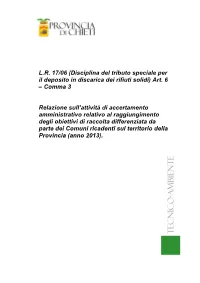
L.R. 17/06 (Disciplina Del Tributo Speciale Per Il Deposito in Discarica Dei Rifiuti Solidi) Art. 6 – Comma 3 Relazione Sull A
L.R. 17/06 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) Art. 6 – Comma 3 Relazione sull’attività di accertamento amministrativo relativo al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata da parte dei Comuni ricadenti sul territorio della Provincia (anno 2013). 1 – Provincia di Chieti. Ambiente ed Energia. Osservatorio Provinciale Rifiuti. Indice PREMESSA ......................................................................................... 3 ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE ................................................................. 4 CONTRIBUTO AMBIENTALE .................................................................. 8 ANALISI DATI RACCOLTA DIFFERENZIATA ............................................. 9 ANALISI FINANZIARIA........................................................................14 2 – Provincia di Chieti. Ambiente ed Energia. Osservatorio Provinciale Rifiuti. Premessa 1. ai sensi dell’art. 6, comma 5 della Legge Regionale n. 45/07: “ I comuni sono tenuti mensilmente a fornire alla Provincia i dati della raccolta e produzione dei rifiuti urbani e assimilati nonché tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti, per consentirne l’elaborazione e la trasmissione all’ORR, all’ONR e all’ARTA ”; 2. la Regione Abruzzo con D.G.R. n. 474 del 26 maggio 2008 (Metodo standard di certificazione delle percentuali di raccolta differenziata e di riciclo dei rifiuti urbani. Modalità di trasmissione dei dati ed elaborazione delle informazioni. Direttive regionali. ) ha approvato il metodo -

Regione Abruzzo
REGIONE ABRUZZO GIUNTA REGIONALE DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE Servizio Gestione e Qualità delle Acque Servizio Emergenze Protezione Civile e Centro Funzionale RAPPORTO SULLA SITUAZIONE IDRICA (Aggiornamento Settembre 2020) OSSERVATORIO PERMANENTE SUGLI UTILIZZI DELLE RISORSE IDRICHE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL’APPENNINO CENTRALE REGIONE ABRUZZO DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE Servizio Emergenze Protezione Civile e Centro Funzionale - Ufficio Idrologia, Idrografico, Mareografico GIUNTA REGIONALE REGIONE ABRUZZO DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE Servizio Emergenze Protezione Civile e Centro Funzionale - Ufficio Idrologia, Idrografico, Mareografico GIUNTA REGIONALE REGIONE ABRUZZO DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE Servizio Emergenze Protezione Civile e Centro Funzionale - Ufficio Idrologia, Idrografico, Mareografico GIUNTA REGIONALE REGIONE ABRUZZO DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE Servizio Emergenze Protezione Civile e Centro Funzionale - Ufficio Idrologia, Idrografico, Mareografico GIUNTA REGIONALE REGIONE ABRUZZO DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE Servizio Emergenze Protezione Civile e Centro Funzionale - Ufficio Idrologia, Idrografico, Mareografico GIUNTA REGIONALE REGIONE ABRUZZO DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE Servizio Emergenze Protezione Civile e Centro Funzionale - Ufficio Idrologia, Idrografico, Mareografico GIUNTA REGIONALE REGIONE ABRUZZO DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE Servizio Gestione e Qualità delle Acque GIUNTA REGIONALE Organizzazione territoriale del Servizio Idrico Integrato nella Regione Abruzzo -

CLUSTER B Tirocinanti ALLEGATO a DA 1 APRILE a 30 Aprilex
1 ALLEGATO “A” Cluster B - Prima linea - Interventi A2 e B2 “TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO” Elenco dei tirocinanti ammessi in relazione a domande inviate dal 01/04/2010 al 30/04/2010 2 INTERVENTO A2 DATA DI AMMESSO/A NR. COGNOME E NOME NASCITA RESIDENZA CON RISERVA BOLOGNA VERONICA 31/08/1988 VASTO * 1 BOZZI NICOLA 16/09/1988 LETTOPALENA 2 BUONTEMPO GIANNI 03/01/1982 MONTAZZOLI 3 DE SIPIO GABRIELLA 07/05/1987 ORTONA * 4 CARBONELLI FEDERICA 19/07/1983 SAN SALVO 5 FAIELLA ANNA 01/08/1988 ORTONA 6 GRIMALDI DAMIANO 05/10/1989 ROCCASPINALVETI * 7 IEZZI MASSIMO 23/04/1985 ORTONA 8 PALMITESTA LUCA 02/11/1984 FRANCAVILLA AL MARE 9 URBANO TIZIANA 04/07/1980 LANCIANO 10 * VERIFICA QUALIFICA PROFESSIONALE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DOTT. MICHELE MODESTI 3 INTERVENTO B2 AMMESSO/A CON NR COGNOME E NOME DATA DI NASCITA RESIDENZA RISERVA ANGELUCCI VALERIA 29/10/1983 CHIETI 1 ANTONUCCI ADA 01/07/1982 VACRI 2 BEZHANI JOLA 17/01/1987 ORTONA ** 3 BUZZELLI SILVIA 21/08/1988 ORTONA 4 CANNAVA’ CONCETTA 25/09/1985 ORTONA 5 CARMINATI GABRIELE 27/07/1982 CARPINETO SINELLO 6 CASTIGLIONE MARIA FRANCESCA 01/09/1984 LANCIANO 7 CIANCI ENNIO 21/10/1984 SAN SALVO 8 CIPRIANI MARIO PAOLO 26/06/1985 FRANCAVILLA AL MARE 9 D’ALANNO EMANUELA 03/01/1987 TARANTA PELIGNA 10 D’ANGELO FABIOLA 15/05/1982 FRISA 11 DE INNOCENTIS VERONICA 19/06/1987 FRESAGRANDINARIA 12 DEL GROSSO MARZIA 28/11/1990 CASALINCONTRADA * 13 D’ERCOLE ADRIANA 22/08/1984 CUPELLO 14 DI CECCO MARIA 07/01/1989 FARA SAN MARTINO 15 4 DI CAMPLI SILVIA 23/02/1987 LANCIANO 16 DI MEO SARA 16/05/1983 CHIETI -

Combatt. a Tufillo
La II Guerra Mondiale. I combattimenti a Tufillo (2-4 novembre 1943) a cura di Giovanni Artese Le operazioni dell’8ª Divisione indiana tra la fine di ottobre e l’8 novembre 1943 (da D. PAL, The Campaign in Italy 1943-45). 1 Dal 10 giugno 1940 all’8 settembre 1943 La notizia dell'entrata in guerra dell’Italia nel secondo conflitto mondiale giunse anche nelle località della valle del Trigno con i comunicati radio del 10 giugno 1940. Tra incredulità e preoccupazione, essa fu accolta dalla gente con fatalismo, come una sorta di prova obbligata attraverso cui si trattava di passare, magari il più in fretta possibile (come del resto le stesse autorità promettevano). Ma le cose andarono diversamente. Per ben tre anni i soldati italiani dovettero battersi, spesso in condizioni di inferiorità, sui fronti della Francia (1940), dell'Africa Settentrionale e Orientale (1940-43), della Grecia, Albania e Jugoslavia (1940-43) e nella infausta tragica campagna di Russia (1941-1943), per rinviare una sconfitta che soltanto l’aiuto militare tedesco aveva impedito che giungesse già dal 1941. E questo mentre l’intera nazione era costretta ad una “economia di guerra” che aggravava le già precarie condizioni di vita di gran parte della popolazione. L’invasione alleata della Sicilia (10 luglio 1943) e la conseguente caduta di Mussolini e del fascismo (il successivo 25 luglio) furono pertanto salutate con sollievo da chi non vedeva prospettive nel conflitto; ma neppure tali avvenimenti posero fine alla guerra, che anzi stava per coinvolgere direttamente la penisola italiana e per percorrerla poi, dal Sud al Nord, fino all’aprile 1945. -

Comune Di Palmoli Provincia Di Chieti
COPIA COMUNE DI PALMOLI PROVINCIA DI CHIETI Determinazione del Responsabile del Servizio Settore Tecnico Numero 344 LAVORI DI INTERVENTI PER RIDURRE LA FRAMMENTAZIONE DEGLI HABITAT E MANTENERE IL COLLEGAMENTO ECOLOGICO E FUNZIONALE - BANDO PUBBLICO DI ATTUAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO POR FESR ABRUZZO 2014 - 2020 - ASSE VI - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTURALI - Data LINEA DI AZIONE 6.5.A.2 - PARTE D'OPERA PALMOLI. DETERMINA 09.11.2018 A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DELLA FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE. CUP: B59B18000050002 - CIG: ZDB25AFF29. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO L’anno duemiladiciotto il giorno nove del mese novembre, nella sede municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del Servizio, Antonini Maurizio, nell’esercizio delle proprie funzioni; PREMESSO che la Regione Abruzzo ha approvato con la determinazione n° DPH004/129 del 30/11/2016 l’Avviso Pubblico Bando POR FESR 2014-2020, ASSE VI – Tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali - Linea di azione 6.5.A.2 “Interventi per ridurre la frammentazione degli habitat e mantenere il collegamento ecologico e funzionale” ; CHE il Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette della Regione Abruzzo intende sostenere interventi finalizzati ad incrementare la conservazione degli habitat tutelati e la valorizzazione delle aree SIC. Si prevede, infatti, di sviluppare sinergie e integrazioni con la complessiva offerta naturalistica e culturale. A questo fine la Regione Abruzzo sostiene interventi che sviluppano entrambe le componenti, secondo una logica integrata, favorendo, per quanto attiene agli aspetti di fruizione, azioni integrate e coordinate tra due o più siti. -

AMELIO PEZZETTA Via Monteperalba 34 – 34149 Trieste; E-Mail: [email protected]
Atti Mus. Civ. Stor. Nat. Trieste 58 2016 57/83 XII 2016 ISSN: 0335-1576 LE ORCHIDACEAE DELLA PROVINCIA DI CHIETI (ABRUZZO) AMELIO PEZZETTA Via Monteperalba 34 – 34149 Trieste; e-mail: [email protected] Riassunto – Il territorio della provincia di Chieti (regione Abruzzo) misura 2.592 km² e occupa da nord a sud l'area com- presa tra le valli dei fiumi Pescara e Trigno, mentre da sud-ovest a nord-ovest lo spartiacque di vari massicci montuosi lo separa da altre province. Nel complesso è caratterizzato da una grande eterogeneità ambientale che consente l'attec- chimento di molte specie vegetali. Nel presente lavoro è riportato l’elenco floristico di tutte le Orchidacee comprendenti 88 taxa e 21 ibridi. A sua volta l'analisi corologica evidenzia la prevalenza degli elementi mediterranei seguita da quelli eurasiatici. Parole chiave: Chieti, Orchidaceae, check-list provinciale, elementi floristici. Abstract – The province of Chieti (Abruzzo Region) measuring 2,592 square kilometers and from north to south occupies the area between the valleys of the rivers Trigno and Pescara while from the south-west to north-west the watershed of several mountain ranges separating it from other provinces. In the complex it is characterized by a great diversity envi- ronment that allows the engraftment of many plant species. In this paper it contains a list of all the Orchids flora including 88 taxa and 21 hybrids. In turn chorological analysis highlights the prevalence of Mediterranean elements followed by those Eurasian. Keywords: Chieti, Orchidaceae, provincial check-list, floristic contingents. 1. - Inquadramento dell'area d'indagine Il territorio della provincia di Chieti copre la superficie di 2.592 km², com- prende 104 comuni e la sua popolazione attuale e di circa 397000 abitanti. -

Trabocchi, Dalla Terra Al Mare
G A L COSTA DEI TRABOCCHI TRABOCCHI, DALLA TERRA AL MARE PIANO DI SVILUPPO LOCALE DEFINITIVO PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 ABRUZZO MISURA 19 Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER SOMMARIO Descrizione dell’areale GAL ........................................................................................................................ 4 Cartografia area gal e area ex leader ................................................................................................................. 5 Tabella con informazioni a livello comunale .............................................................................................. 6 Altre strategie di sviluppo locale che intervengono nell'area .................................................................... 6 Analisi di contesto .............................................................................................................................................. 7 Analisi SWOT .................................................................................................................................................... 15 Caratteristiche del partenariato proponente ................................................................................................... 18 Caratteristiche della societa’ proponente ........................................................................................................ 23 Caratteristiche del soggetto proponente in sede di candidatura..................................................................... 23 Strategia di Sviluppo Locale -

Le Abitazioni Non Occupate in Provincia Di Chieti* Testo Della
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE Le abitazioni non occupate in provincia di Chieti* Testo della relazione * Testo della relazione ed elaborazione statistica e cartografica, a partire da dati di fonte ISTAT, di Gerardo MASSIMI. 2 Sommario Il contesto nazionale 3 Il contesto regionale e le specificità della provincia per grandi aggregati 5 Il campo informativo dell'indagine per comune al censimento 1991 10 Osservazioni sull’attività edilizia posteriore al censimento 1991 13 Principali risultati 14 I riferimenti cartografici e statistici 14 Distribuzione territoriale delle abitazioni non occupate 17 Superficie e implicazioni ambientali delle abitazioni non occupate 19 Utilizzo delle abitazioni non occupate 20 Abitazioni non occupate e mercato 23 Età di costruzione dei fabbricati delle abitazioni occupate 24 Figure nel testo Figura 1 Quote percentuali delle abitazioni non occupate nelle province italiane alla data del censimento 1991. 4 Figura 2 Confronto delle tendenze evolutive, nel periodo 1961-1991, tra le province abruzzesi delle abitazioni non occupate. 5 Figura 3 Frequenze relative, percentuali e percentuali cumulate, delle abitazioni non occupate per numero delle stanze (intervallo da 1 stanza a 9 stanze e oltre) al censimento 1991. 7 Figura 4 Consistenza della collaborazione delle amministrazioni comunali con l'ISTAT nel rilevamento dell'attività edilizia in riferimento all'anno 1997. 13 Figura 5 Aggregazione in regioni agrarie dei comuni della provincia di Chieti. 15 Figura 6 Stima (fonte CRESA, 1997) della variazione della popolazione residente nel periodo 1996-2005 a confronto con le percentuali di abitazioni occupate in edifici costruiti prima del 1945. 24 Tabelle nel testo Tabella 1 Elementi caratteristici per grandi aggregati delle abitazioni in provincia di Chieti ai censimenti dal 1961 al 1991. -

Livello Speditivo (Versione 1.0)
Comune di : FARA FILIORUM PETRI(CH) PIANO DI EMERGENZA COMUNALE (Piano di Protezione Civile) livello speditivo (versione 1.0) Aggiornamento: 31/12/2016 1 INDICE 1 PREMESSA ................................................................................................................. 3 2 PARTE GENERALE ..................................................................................................... 4 2.1 IL TERRITORIO COMUNALE ............................................................................... 4 2.2 ORGANIGRAMMA COMUNALE ........................................................................... 5 2.3 MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA ..................... 6 3 RISCHIO IDROGEOLOGICO ....................................................................................... 7 3.1 SISTEMA DI ALLERTAMENTO ............................................................................ 7 3.2 SCENARI DI EVENTO .......................................................................................... 8 3.3 PROCEDURE OPERATIVE PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO .................... 12 4 RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO .............................................................................. 55 4.1 SISTEMA DI ALLERTAMENTO .......................................................................... 55 4.2 SCENARI DI EVENTO ........................................................................................ 56 4.3 PROCEDURE OPERATIVE PER IL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI .................. 57 5 RISCHIO SISMICO .................................................................................................. -

Elenco in Ordine Alfabetico Delle Candidature Ammesse
Regione Abruzzo ALLEGATO 1 Dipartimento Politiche del Lavoro, dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università PON IOG PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE REGIONE ABRUZZO 2014-2015 Manifestazione di interesse per la presentazione delle candidature dei Soggetti Ospitanti per i Tirocini Elenco in ordine alfabetico delle candidature ammesse Comuni sedi delle N. Soggetto Ospitante candidato posizioni di Prov. Plico tirocinio offerte 1238 2 BITE SRL L'Aquila AQ 77 2M SERVICE SRL Pineto TE 1148 365 CAFE' SRLS Altino CH 1170 3DP SRL Chieti CH 1687 4U SRL Teramo TE 252 7HOST S.R.L. Pescara PE 1275 80 VOGLIA DI PASTA SAS DI IOVACCHINI ROSANNA & C. Atessa CH 167 A&V SRL UNIPERSONALE - RONZITTI VITTORIO Vasto CH S. Nicolò a Tordino - 1095 A.&P. DI BARTOLONE ANTIMO TE Teramo 1532 A.B.A. ANXANUM SRL Lanciano CH 1004 A.B.A.C.O.S. SOC COP SOCIALE Vasto CH 1163 A.C.N.D. SRL L'Aquila AQ 1318 A.G.C.I. ABRUZZO Pescara PE 1048 A.G.M. TOUR SRL Lanciano CH 1773 A.I.A.S. ONLUS SEZ. SULMONA Sulmona AQ 72 A.P.A. ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI Lanciano CH 125 A.R.E.E. SOC. COOP. Fallo CH 1465 ABICERT SAS DI BIANCO A.&C. Cocullo AQ 1349 ABRUZZO CIBUS SRL Carunchio CH 102 ABRUZZO GOMME SAS DI GOBEO PAOLO Francavilla al Mare CH 1224 ABRUZZO ISOLANTI SRL Castilenti TE 1524 ABRUZZO LAMIERE SRL Montesilvano PE 248 ABRUZZO NATURA SRL Guardiagrele CH 1610 ABRUZZO PARK SRL Monteodorisio CH 929 ACCADEMIA PROFESSIONAL ADVICE SRL Pescara PE 49 ACCOUNT SRL Teramo TE 305 ACQUA DI D'ANDREA ANNA RACHELE TERESA Pratola Peligna AQ PON IOG - Manifestazione di interesse Soggetti Ospitanti Tirocini - Elenco delle candidature ammesse Pubblicazione del 30/01/2015 1 Regione Abruzzo Dipartimento Politiche del Lavoro, dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università Comuni sedi delle N. -

This Regulation Shall Be Binding in Its Entirety and Directly Applicable in All Member States
12. 8 . 91 Official Journal of the European Communities No L 223/ 1 I (Acts whose publication is obligatory) COMMISSION REGULATION (EEC) No 2396/91 of 29 July 1991 fixing for the 1990/91 marketing year the yields of olives and olive oil THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Whereas the measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Management Having regard to the Treaty establishing the European Committee for Oils and Fats, Economic Community, Having regard to Council Regulation No 136/66/EEC of 22 September 1966 on the establishment of a common HAS ADOPTED THIS REGULATION : organization of the market in oils and fats ('), as last amended by Regulation (EEC) No 1720/91 (2) ; Article 1 Having regard to Council Regulation (EEC) No 2261 /84 of 17 July 1984 laying down general rules on the granting 1 . For the 1990/91 marketing year, yields of olives and of aid for the production of olive oil and of aid to olive oil olive oil and the relevant production zones shall be as producer organizations (3), as last amended by Regulation specified in Annex I hereto . (EEC) No 3500/90 (4), and in particular Article 19 thereof, 2. The production zones are defined in Annex II . Whereas Article 18 of Regulation (EEC) No 2261 /84 provides that yields of olives and olive oil should be fixed for each homogeneous production zone on the basis of Article 2 information supplied by the producer Member States ; This Regulation shall enter into force on the third day Whereas, in view of the information received, it is appro following its publication in the Official Journal of the priate to fix these yields as specified in Annex I hereto ; European Communities. -

5.0 Curriculum Studio Giamberardino S.R.L
5.0 CURRICULUM STUDIO GIAMBERARDINO S.R.L. I titolari dello studio sono: - geol. Camillo Giamberardino; - ing. Angelo Giamberardino; - arch. Rosanna Giamberardino. Si fa presente che l’attività professionale risulta coperta da polizza assicurativa di responsabilità civile rilasciata da primaria compagnia nazionale. Di seguito vengono riportati l’elenco degli incarichi professionali espletati dalla GIAmberardino s.r.l. e i curricula dei singoli soci. Tali curricula concorrono a formare le referenze generali della GIAMBERARDINO s.r.l Ambito: progettazioni - direzioni lavori – sicurezza lavori appartenenti ad altre classi e categorie Campo: verifiche progettuali Ottobre · Direzione Regionale INPS Puglia: Affidamento del servizio di Verifica, ai sensi 2017/ In dell’art. 26 del d. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del progetto esecutivo dei lavori corso di “Ristrutturazione edilizia con modifica dei prospetti, rip ristino e rinnovo degli elementi costitutivi e impianti per la trasformazione di un sito secondario destinato a deposito degli atti cartacei INPS – capannone di proprietà INPS – Taranto – strada provinciale per Montemesola, Contrada Torre Rossa” - Importo dei Lavori: Euro 5.448.688,99 - Importo del Progetto: Euro 5.608.383,41 - Importo del Servizio: Euro 15.504,30 Febbraio · CONSAC Gestioni Idriche S.p.A.: Conferimento di incarichi per lo svolgimento 2017 – Luglio di servizi tecnici relativi alla verifica de l Progetto esecutivo" relativo agli 2017 “Interventi di ristrutturazione e potenziamento del sistema di adduzione idrica nell’area