“Volti E Momenti Di Una Vita”
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

"A Multi-Stemmed Flower": Reading Sandro Penna in Search of Modernity Livio Loi University of Wollongong, [email protected]
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Research Online University of Wollongong Research Online Faculty of Law, Humanities and the Arts - Papers Faculty of Law, Humanities and the Arts 2015 "A multi-stemmed flower": reading Sandro Penna in search of modernity Livio Loi University of Wollongong, [email protected] Publication Details Loi, L. ""A multi-stemmed flower": reading Sandro Penna in search of modernity." Italica 92 .4 (2015): 836-856. Research Online is the open access institutional repository for the University of Wollongong. For further information contact the UOW Library: [email protected] "A multi-stemmed flower": reading Sandro Penna in search of modernity Abstract Sandro Penna's poetry (1906-1977), is a delicate combination of melancholy and exhilaration, and shows innovation and modernity inside the Italian lyrical tradition. Critically stereotyping Penna's poetry as a flower with no evident stem, meaning no external influences, narrows the depth of his literary corpus. In his notes Penna reveals himself as a voracious reader of modern international literature and critics Roberto Deidier and Pierfranco Bruni pointed out that his evident European influences completely lack investigation. Most criticism though do not seem to acknowledge how close Penna's poetry is to the ideas of "modern" and "new" as fostered by Modernists and Imagists. This essay challenges the literary commonplace that Penna is a miracle out of history and time and, investigating Penna's archives and poems, discloses connections, references and similarities between his poetry and the major movements - French Symbolism, Modernism, Imagism - and literary personalities of the twentieth century. -

Indice Del Volume
Santagata7_00_romane_00 04/02/12 17.15 Pagina III INDICE DEL VOLUME Dal secondo dopoguerra agli inizi degli anni Sessanta 1 Le coordinate storiche, culturali e letterarie 2 Le coordinate storiche l1 La situazione internazionale tra il 1945 e i primi anni Sessanta 3 D1 Il rapporto segreto di Kruscev sul “culto della personalità” di Stalin [Adriano Guerra, Il giorno che Kruscev parlò: dal XX congresso alla rivoluzione ungherese] 5 D2 La missione degli Stati Uniti [John F. Kennedy, Obiettivo mondo nuovo] 6 l2 La situazione in Italia dopo il 1945 6 Le coordinate culturali l3 La cultura nel secondo dopoguerra 8 FOCUS La riflessione sulla guerra e sulle sue conseguenze 8 FOCUSCINEMA I modelli dello starsystem 10 l4 La nascita dello strutturalismo 11 FOCUSARTE La pittura italiana tra Neorealismo e protesta 12 Le coordinate letterarie l5 Le arti e la letteratura tra Realismo e Neorealismo 13 FOCUSARTE L’architettura del “Movimento Moderno” statunitense 14 FOCUS Impegno 15 Sintesi, p. 17 • Bibliografia, p. 17 2 Le letterature straniere 18 l1 Le tendenze della poesia sino agli inizi degli anni Sessanta 19 FOCUS Il beat e il ribelle 20 l2 La narrativa sino agli anni Sessanta 21 l3 La narrativa in Francia 22 ANTOLOGIA Albert Camus 24 T1 Un dramma senza drammaticità [Lo straniero, Parte I, cap. 6; Parte II, cap. 1] 25 Lettura guidata, p. 28 • Esercizi, p. 29 l4 La narrativa in Germania e in Unione Sovietica 29 ANTOLOGIA Günter Grass 30 T2 Scegliere di non crescere [Il tamburo di latta] 31 Lettura guidata, p. 34 • Esercizi, p. 35 l5 La narrativa negli Stati Uniti 36 l6 La narrativa sudamericana. -

Lista 20 Settembre 2020 LIBRERIA ANTIQUARIA PONTREMOLI | Milano | Tel +39 02 58103806 | [email protected] | SETTEMBRE 2020
Lista 20 settembre 2020 LIBRERIA ANTIQUARIA PONTREMOLI | Milano | Tel +39 02 58103806 | [email protected] | www.libreriapontremoli.it SETTEMBRE 2020 1. Accrocca, Elio Filippo (prefazione di Giuseppe Ungaretti). Portonaccio Esemplare XXXVIII / L, in ottime condizioni. [TIRATURA DI TESTA] € 250 Milano, All'Insegna del Pesce d'Oro (Off. Grafiche “Esperia”), 1949 (17 aprile), — in 16°, brossura con sovracoperta risvoltata a —. tamburo, pp. 51 [9]. EDIZIONE ORIGINALE, TIRATURA DI TESTA. — Rara opera prima nella serie delle cinquanta copie su carta di pregio numerate I-L (tiratura comune in cinquecento es. numerati). Raccolta di poesie con prefazione di Giuseppe Ungaretti. https://www.libreriapontremoli.it/20875.pontremoli https://www.libreriapontremoli.it/20875.pontremoliGUARDA E ACQUISTA ONLINE 2. Angioletti, Giovanni Battista. La terra e l’avvenire Esemplare pregiato dall’invio autografo dell’autore. In più che buone condizioni, in Piacenza, Società Tipografica Editoriale Porta, 1923, —. gran parte intonso (contenute lacerazioni alla PRIMA EDIZIONE. — Rara opera prima, «contiene per la maggior parte scritti già copertina). apparsi su riviste e giornali, descrizioni e notazioni di ambienti, paesi e costumi € 400 europei e lombardi» (Lucia Strappini, voce DBI, 1988). — in 8°, brossura avorio stampata in nero (titolo in rosso al piatto anteriore); pp. 112. https://www.libreriapontremoli.it/526.pontremoli https://www.libreriapontremoli.it/526.pontremoliGUARDA E ACQUISTA ONLINE 3. [Atlas; Langlois, Guthrie, Arrowsmith, d’Anville]. Nouvel Atlas Normale usura del tempo al cartonato élémentaire, pour la dixième édition de l’Abrégé de géographie de originale; foxing alla carta di frontespizio; mappe in più che buone quando non ottime Guthrie, contenant 15 cartes enluminées, par Arrowsmith et d’Anville condizioni, in parte profilate a colori. -

ITA 322 Syllabus
Black, Queer, Jewish Italy This seminar approaches the two most studied phases of Italian history, the Renais- sance and the Twentieth century, by placing otherness at the center of the picture rather than at its margins. The main aim is to challenge traditional accounts of Italian culture, and to look at pivotal events and phenomena (the rise of Humanism, the rise of fascism, courtly culture, the two World Wars, Sixteenth century art, the avant- garde) from the point of view of non-white, non-christian, non-heterosexual witness- es, authors, and fictional characters. In class, we will adopt a trans-historical, intersec- tional, and interdisciplinary perspective: themes and issues will be analyzed at the crossing of the two historical phases and of the three topics in exam, and the material will include historical and theoretical analyses, narrative texts of different genres, po- ems, films, and works of visual art. Class Codes: Reading/Writing Expectations: · 40-80 pages of selected required readings per week ITA 322 · GSS 339 · JDS 327 · ECS 332 · Additional suggested readings available (mostly secondary sources) · Take-home Midterm paper (6-8 pp.). Final essay (10-12 pp.) Instructor: Alessandro Giammei Concentrators in Italian (Certificate or Major) Will: (he, him, his · lui, tu) · Participate in the Italian Precept · Read selected texts in the original language (5-15 pages per week) Office Hours: · Write three short response-papers in Italian Wed 1:30 - 3:00 and by appoint- · Write the Midterm paper in Italian ment 205 Scheide Caldwell House Assessment components: MidTerm Paper · 25 % (609) 258 - 9053 Final Essay · 40 % Oral Presentation(s) · 20 % [email protected] Participation · 15 % Page 1 of 11 Page 1 of 11 MATERIAL All required readings will be on blackboard. -

Corsair Writings – Pier Paolo Pasolini
Corsair Writings – Pier Paolo Pasolini Introductory Note The reconstruction of this book is entrusted to the reader. It is the reader who must reunite the fragments of a scattered and incomplete work. It is the reader who must piece together these widely dispersed parts that nonetheless constitute a whole. It is the reader who must organize their contradictory moments in search of their essential unity. It is the reader who must weed out the occasional inconsistencies (that is, tentative probes or abandoned hypotheses). It is the reader who must replace the repetitions with their sporadic variants (or else accept the repetitions as impassioned anaphors). The reader has before him two “series” of writings, which, arranged chronologically, correspond approximately to: 1) a “series” of primary writings; and 2) a “series” of more humble complementary, corroborative, documentary writings. The reader will obviously have to shift from one “series” to the other. Except for this book of journalistic writings, I have never demanded such a necessary degree of philological devotion from my readers. Such devotion is hardly common these days. Naturally, the reader is also invited to refer to other writings besides those contained in the “series” of writings in this book. For example, to the texts of the interlocutors with whom I engaged in polemical exchanges or to whom I replied or answered so stubbornly. In addition to the work that the reader must reconstruct, this book is totally lacking certain materials that are, however, essential. I am referring -

Apollinaire Guillaume, UNA POESIA SOLO PER LOU Euro 14,00
Apollinaire Guillaume, UNA POESIA SOLO PER LOU Euro 14,00 LIBRO - Cod. 48891 - Elsinore editrice, Roma, 1966 - 13 x 20,5, brossura, Apparso sulla rivista ELSINORE N: 21-22 ANNO TERZO GIIUGNO - LUGLIO 1966 (pagine 5-12). Nello stesso numero scritti di MARIO LUCI (Moderni o contempporanei), MARIA LUISA SPAZENI (poesia : Utilità della memoria), MARCELLO VENTUROLII (arti figurative), ecc. ecc. ARIA D'ITALIA, straordinaria rivista di letteratura ed arte - TUTTO IL Euro 4.800,00 PUBBLICATO IN SETTE QUADERNI TRA IL 1939 ED IL 1941 POI NEL 1954. RIVISTA - Cod. 48780 - Guarnati Daria, Milano, 1939 - ARIA D'ITALIA usciva a Milano in anni tempestosi di guerra, tra il 1939 ed il 1941, come utopico progetto di combinata "valorizzazione del patrimonio artistico italiano" e dal nuovo stile che prendeva forma tanto nell'arte quanto nella letteratura italiana di allora. In ARIA D'ITALIA finezze d'avanguardia e di tecnica grafica e tipografica si coniugarono a un'idea nobile di divulgazione, facendone una sorta di anello di congiunzione, assolutamente originale, tra DOMUS e STILE, le riviste di GIO PONTI decisive per la formulazione di quanto poi è stato definito "Italian Style". Al Grande artista milanese (a riconoscimento della rilevanza del suo contributo) verrà dedicato un numero monografico OTTAVO QUADERNO "ESPRESSIONI" con numerose delle sue fantastiche opere, stampato nel 1954 a distanza di più' di 12 anni dal settimo quaderno, che cosi' concluderà la collezione stessa. Ogni quaderno è di cm. 26 x 35,5 : il numero delle pagine è variabile e molte non sono numerate, anche con le tantissime splendide tavole a colori e vere e proprie creazioni artistiche tipografiche ed artistiche (geniali). -

Italian-Writers-Petition-For-Pound.Pdf
1 DOCUMENTARY –––––––––––––––––––– Italian Writers Petition for Pound, 1956-1957 by Carlo Pulsoni [Carlo Pulsoni published the short essay "Liberate il poeta Pound" in the 20 March issue of Atlante, for which Massimo Bacigalupo has very graciously provided a translation into English. The original essay can be read at http://www.treccani.it/magazine/atlante/cultura/Liberate_il_poeta_Pound.html. Many thanks to the author for permission to reproduce the piece here.] Twenty years have passed since the death of Vanni Scheiwiller, a "useless publisher of books and micro-books," as he loved to define himself. If his editorial merits are well known, perhaps less known is his role as promoter of the Italian petition to free Ezra Pound from the St. Elizabeths criminal asylum, where Pound had been imprisoned since the end of 1945. Thanks to the archival papers of the Fondo Scheiwiller stored in the APICE Center of the University of Milan, the salient stages of the story can be reconstructed. The appeal should have come out on Pound's seventieth birthday (October 30, 1955), but various circumstances prevented this. The failure was mitigated by the publication in the Corriere della Sera of an article by Giovanni Papini with an eloquent title: “We ask for the pardon of a poet.” In the following months Vanni goes back to work on the petition, hoping to deliver it to the American embassy, as he writes to Giuseppe Ungaretti in the first days of April 1956. In reality the delivery was to take place only in the month of August and was to have, in addition to Diego Valeri and Sergio Solmi as promoters, the following signatories: G. -
Selected Poems of Sandro Penna
University of Calgary PRISM: University of Calgary's Digital Repository Graduate Studies The Vault: Electronic Theses and Dissertations 2014-01-20 Selected Poems of Sandro Penna Giovannone, Aaron Giovannone, A. (2014). Selected Poems of Sandro Penna (Unpublished doctoral thesis). University of Calgary, Calgary, AB. doi:10.11575/PRISM/27741 http://hdl.handle.net/11023/1280 doctoral thesis University of Calgary graduate students retain copyright ownership and moral rights for their thesis. You may use this material in any way that is permitted by the Copyright Act or through licensing that has been assigned to the document. For uses that are not allowable under copyright legislation or licensing, you are required to seek permission. Downloaded from PRISM: https://prism.ucalgary.ca UNIVERSITY OF CALGARY Selected Poems of Sandro Penna by Aaron Giovannone A THESIS SUBMITTED TO THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY DEPARTMENT OF ENGLISH CALGARY, ALBERTA JANUARY 2014 © Aaron Giovannone 2014 Abstract This dissertation is a selection and translation of the poetry of Sandro Penna (1906 Perugia – 1977 Rome), an important figure in Italian twentieth-century literature who remains largely unknown to English-language readers. Penna’s poems are brief but complete, desirous but self- possessed, traditional but transgressive. In his lifetime, Penna was infamous but intensely private, well-known in Italian literary circles but a non-participant in most aspects of literary and social life. In 1970, Pier Paolo Pasolini named Penna “perhaps the greatest and happiest Italian poet alive,” while the same year Amelia Rosselli described Penna’s behaviour as “a social suicide”. -
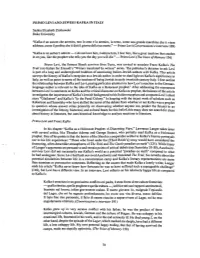
PRIMO LEVI and JEWISH KAFKA in ITALY Saskia
PRIMO LEVI AND JEWISH KAFKA IN ITALY Saskia Elizabeth Ziolkowski Duke University "Kafka e un autore che ammiro, non lo amo e lo ammiro, lo temo, come una grande macchina che ti viene addosso, come ii profeta che ti dira ii giomo de Ila tua morte." - Primo Levi ( Conversazioni e interviste 189) "Kafka is an author I admire - I do not love him, I admire him, I fear him, like a great machine that crashes in on you, like the prophet who tells you the day you will die." - Primo Levi (The Voice ofMemory 156) Primo Levi, the famous Shoah survivor from Turin, was invited to translate Franz Kafka's The Trial into Italian for Einaudi's "Writers translated by writers" series. The publisher's decision to ask Levi is part of a long and underexplored tradition of associating Italian Jewish authors with Kafka. This article surveys the history of Kafka's reception as a Jewish author in order to shed light on Kafka's significance in Italy, as well as point to some of the tensions of being Jewish in early twentieth-century Italy. I first outline the relationship between Kafka and Levi, paying particular attention to how Levi's reaction to the Gennan language author is relevant to the idea of Kafka as a Holocaust prophet. 1 After addressing the resonances between Levi's comments on Kafka and the critical discourse on Kafka as prophet, the balance of the article investigates the importance of Kafka's Jewish background to his Italian reception and compares Levi's short story "Gladiators" and Kafka's "In the Penal Colony." In keeping with the recent work of scholars such as Robertson and Samolsky who have shifted the terms of the debate from whether or not Kafka was a prophet (a question whose answer relies primarily on discovering whether anyone can predict the future) to an investigation of the literary, historical, and cultural bases for this belief, this essay does not search for clues about history in literature, but uses historical knowledge to analyze reactions to literature. -

'Resistance' to Fame and the Search for Happiness of Italian Modern
International Journal of Arts and Commerce Vol. 4 No. 8 October, 2015 Fame or Freedom? ‘Resistance’ to Fame and the search for Happiness of Italian modern poet Sandro Penna Dr Livio Loi Honorary Fellowhip, University of Wollongong, Australia Member of AATI: American Association of Teachers of Italian, US Member of IATI: Illawarra Association of Teachers of Italian, Wollongong, Australia Email: [email protected] Abstract A troublesome and thorny poet, Sandro Penna (1906-1977) elected individual freedom as his Gospel. Although his reputation as a distinguished lyric poet and a unique literary phenomenon seems unquestioned among readers and critics, recognition of his work has been both tardy and problematic. Having the difficult task of writing poetry in Italy at a time of Nobel Prize recipients such as Salvatore Quasimodo and Eugenio Montale, Penna remained an outsider, difficult to label, subject to the harsh censorship of the Italian Fascist regime for the homoerotic subject of his oeuvre. This paper investigates Penna’s peculiar kind of ‘resistance’ to the common concept of literary fame and to the commodification of art. His lack of interest in publishing and his craving for personal and artistic freedom are the main factors responsible for the delayed literary recognition of a poet deeply admired by contemporary fellow writers and readers. Keywords: Italian modern literature, Sandro Penna, fame, censorship, bohemianism, freedom. [A]s a poet he was more loved than studied, his poetry worshipped - by some - as a religion. (Pier Vincenzo Mengaldo, 1990)1 Penna is the only poet of the Novecento who has quietly refused - without outburst - the ideological, moral, political and intellectual reality of the world we live in … rejected by him as a worthless world, a little vulgar, a little miserable, made of ridiculous cheating and notorious vanity. -

I Quaderni Di Poesia 6
i quaderni di poesia 6 «i quaderni di poesia» è una pubblicazione dell’Istituto Italiano di Cultura per i Paesi Bassi Keizersgracht 564 1017 EM - Amsterdam tel. +31 - (0)20 - 6263987 e-mail: [email protected] internet: www.iicamsterdam.esteri.it direttore responsabile: Carmela Natalina Callea curatore della collana: Gandolfo Cascio segretaria di redazione: Gisella Brouwer-Turci «i quaderni di poesia», 6, 2018: «Ma che bellezza c’è nella poesia?». Saggi su Sandro Penna ISBN 978-94-6375-271-8 © Copyright by Istituto Italiano di Cultura, Amsterdam, 2018 All rights reserved. No portion of this book may be reproduced by any process without the formal consent of the publisher In copertina: Mario Marcucci, Ragazzo al mare, 1945, collezione privata Courtesy Carla Marcucci e Associazione ‘Amici di Mario Marcucci’ Stampa: Ridderprint BV, Ridderkerk «Ma che bellezza c’è nella poesia?» Saggi su Sandro Penna a cura di Gandolfo Cascio e Roberto Deidier Istituto Italiano di Cultura LA LEZIONE DI ESTETICA «Ma che bellezza c’è nella poesia?» Ascolta, quando vedi un forte amico pieno di donne intorno, quando preso sei dall’orchestra, e sotto il riflettore risplendono i colori di una diva che seminuda scende giù in platea, dove tu trasalisci, e sei nascosto da tanta gente!, quando in una notte buia e serena in una piazza amici ballano senza donne al suono d’una fisarmonica e tu non sei di loro; ebbene questo non è bello per te? È anche bello per un vecchio signore che si chiama critico e trova molte cose belle, è andato anzi più avanti nel trovare al mondo e forse fuori, belle cose sempre più belle; eppure dice con amore: «quanto è bella questa poesia». -
Scarica L'e-Book in Formato .Pdf
bibliografica | due 1 2 Aldo Lo Presti VIVERE DENTRO LA LETTERATURA Per una bibliografia per immagini di Leone Piccioni Postfazione di Nino Alfiero Petreni Un pittore di Orvieto in India CENTRO STUDI3 PIENTINI Sardegna. Rassegna di turismo,4 arte, spettacolo e sport | 1958 VIVERE DENTRO LA LETTERATURA. PER UNA BIBLIOGRAFIA PER IMMAGINI DI LEONE PICCIONI Credo che la mia generazione sia stata l’ultima ad avere buone ragioni per nutrirsi, forse, appagarsi, vivere dentro o intorno alla letteratura. L. Piccioni In questo primo tentativo di rubricare gli scritti di Leone Piccioni, si sottolinea che sono state registrate soltanto le opere originali1 del critico torinese (compresi gli estratti), contrasse- gnate da un asterisco a precedere la data di pubblicazione, non- ché i libri curati, presentati o testimoniati da Piccioni, ad esclu- sione, pertanto, dei suoi articoli, con alcune – peraltro corpose - eccezioni;2 sono state esplicitate, inoltre, tra parentesi quadre, tutte le dichiarazioni di autorità, di curatela ed ogni altra infor- mazione bibliografica utile a individuare ogni singola voce nel “Servizio Bibliotecario Nazionale” o nei siti specializzati nella compravendita di libri oppure nei sempre più residuali catalo- ghi a stampa delle librerie antiquarie. Sono stati presi in considerazione, infine, sia alcuni “fasci- coli” di periodici per il loro carattere - quasi - “monografico”, sia i volumi che raccolgono la “corrispondenza” picciana. E 1 Si utilizza la medesima definizione adottata da Edmondo Cione nell’“avvertenza” alla Bi- bliografia crociana edita in prima edizione dalla casa editrice milanese Fratelli Bocca nel 1956, p. [71]. 2 Mancano, tra gli altri, anche i contributi che Leone Piccioni ha firmato per “L'Approdo” nella versione radiofonica settimanale confluiti nei fascicoli ciclostilati prodotti ad uso re- dazionale come il Ricordo di Cavafy di Giuseppe Ungaretti andato in onda nella puntata di lunedì 7 gennaio 1957 (Sede di Firenze, Sezione Programmi) pubblicato nel fascicolo n.