Studi E Saggi – 93 –
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Israeli Violations' Activities in the Opt 9 October 2017
Israeli Violations' Activities in the oPt 9 October 2017 The daily report highlights the violations behind Israeli home demolitions and demolition threats The Violations are based on in the occupied Palestinian territory, the reports provided by field workers confiscation and razing of lands, the uprooting and\or news sources. and destruction of fruit trees, the expansion of The text is not quoted directly settlements and erection of outposts, the brutality from the sources but is edited for of the Israeli Occupation Army, the Israeli settlers clarity. violence against Palestinian civilians and properties, the erection of checkpoints, the The daily report does not construction of the Israeli segregation wall and necessarily reflect ARIJ’s opinion. the issuance of military orders for the various Israeli purposes. Brutality of the Israeli Occupation Army • Israeli occupation Army (IOA) deployed at the Qalandiya military crossing between Jerusalem and the occupied West Bank opened fire at two Palestinian women who attempted to cross through the checkpoint on foot using the vehicle lane. The IOA detained the two women and took them in for interrogation. (Maannews 9 October 2017) • Palestinian families from the besieged Gaza Strip were prevented by Israeli authorities from visiting their imprisoned relatives inside Israel. Families stated that they were denied entry to Israel due to border 1 closures for ongoing Jewish holidays in Israel. (Maannews 9 October 2017) • The Israeli occupation army (IOA) targeted and destroyed an outpost in the besieged Gaza Strip, said to be used by the Hamas movement as an observation post. The site targeted by the Israeli shelling was located in the Abu Safiya area east of al-Maghazi refugee camp in the central Gaza Strip. -

Israel's National Religious and the Israeli- Palestinian Conflict
Leap of Faith: Israel’s National Religious and the Israeli- Palestinian Conflict Middle East Report N°147 | 21 November 2013 International Crisis Group Headquarters Avenue Louise 149 1050 Brussels, Belgium Tel: +32 2 502 90 38 Fax: +32 2 502 50 38 [email protected] Table of Contents Executive Summary ................................................................................................................... i Recommendations..................................................................................................................... iv I. Introduction ..................................................................................................................... 1 II. Religious Zionism: From Ascendance to Fragmentation ................................................ 5 A. 1973: A Turning Point ................................................................................................ 5 B. 1980s and 1990s: Polarisation ................................................................................... 7 C. The Gaza Disengagement and its Aftermath ............................................................. 11 III. Settling the Land .............................................................................................................. 14 A. Bargaining with the State: The Kookists ................................................................... 15 B. Defying the State: The Hilltop Youth ........................................................................ 17 IV. From the Hills to the State .............................................................................................. -

Intensification of Environmental Conflicts Resulting from Rural to Urban Transformation: the Case of Arab Localities in a Changing Galilee
Intensification of Environmental Conflicts Resulting from Rural to Urban Transformation: The Case of Arab Localities in a Changing Galilee Hussein Tarabeih* Rassem Khamaisi* Deborah F. Shmueli* University of Haifa The present study investigates the relationship between atmospheric conditions in Arab society in Israel is a traditional one, undergoing rapid urbanization processes within their communities. This is transformative for both individual and com- munity lifestyles (i.e., changes in demographics, education, economics, agriculture, industry, residential patterns, and expansion of built-up areas), and at the same time creates environmental problems and conflicts. Hazards are emerging and existing environmental problems are worsening impacting land, water, sanitation and animal-husbandry.This paper examines and characterizes the environmental conflicts that develop within Arab localities and in interface zones within which the Arab and Jewish populations converge. Fundamental failures are exposed in planning policy, licensing and enforcement, and lack of an established environ- mental administrative structure within Arab towns. The intricacies of planning within the localities, disregard of environmental issues, and the failure of local and central government decision makers to recognize that environmental hazards extend across town borders, perpetuate environmentally-unfriendly planning solu- tions within and adjacent to Arab localities. Keywords: Urbanization in Arab Communities, Environmental Conflicts, En- vironmental Planning and Administration, Land Acquisition, Contact Zones. Arab communities in Israel are undergoing a process of rapid urbanization. The population growth within these localities, the expansion of their built up areas, and their socio-economic and geo-political transformation have been documented and analyzed widely, while the environmental aspects of such urbanization within Arab communities and in the areas between them and adjacent Jewish localities have at- tracted less attention. -

Absentee Property Law of 1950 Was Meant to Serve As the Legal Basis to Transfer the Property of Palestinian Refugees Into the Possession of the State of Israel
Absentees against Their Will – Property Expropriation in East Jerusalem under the Absentee Property Law July 2010 Introduction The Absentee Property Law of 1950 was meant to serve as the legal basis to transfer the property of Palestinian refugees into the possession of the State of Israel. The law says that the land and property of Palestinian residents and nationals of Arab countries who, from November 29, 1947 until a declaration that the state of emergency declared in 1948 ended [which has not yet happened] were in one of the Arab countries, or "in any part of the Land of Israel that is outside of the area of Israel," would revert to the possession of the Custodian of Absentee Property, meaning, to the possession of the State.1 Following the annexation of East Jerusalem in 1967, and as a result the application of all of the laws of Israel -- including the Absentee Property Law -- to the annexed area, a problematic situation arose in which the property of almost all the Palestinian residents of the city became, in fact, absentee property, because those residents were at the time to which the law refers citizens of Jordan, then an enemy country, who resided in "a part of the Land of Israel that [was] outside of the area of Israel." To contend with this problematic situation, section 3 of the Law and Administration Ordinance 5730-1970 provides that the law does not apply to residents of East Jerusalem who "on the day of the incidence of the order of application of the law was in the area of its application and was a resident thereof."2 Therefore, only residents who were physically present in East Jerusalem on the day of annexation are not considered absentees. -

Committee, “Has Replace Engineering Library
1, .... I. .. THETUFTS DAILY ~~~ - [Where You Read It First Wednesday, January 24,1996 Volume XXXII, Numbe A Bryan Krause, for its involvement mothers and Families Gtke they Lufkin Library, located in the College of Engineering, mav become a state-of-the-art study space - - I, ” .- with the extension of the library’s get back on their feet due to guidehours, to the Tufts, creation the development of the pocketof MacPhersonvariety of said.circumstances,” High-tech study facility may the City Line Bus Service, and its Verdier said that the Cultural effortsThe for Services financial Committee,aid. chairedand Ethnic by AlexisAffairs Acerdo, Committee, “has replace Engineering Library chaired by Brooke Jamison, was done a tremendous iob.”The com- by EPSTEIN the fact that all of the plans are still to a different level,” he said. mittee has begun KAREN Daily Editorial Board in an initial thought phase. He said the three important work on a forum to The College of Engineering is Hesaid he wants a facility where abilitiesEngineeringstudents must address issues con- considering building a state-of- students can have access to the develop are “teamwork, commu- cerning prospec- the-art study center in Anderson World Wide Web, reference books, nication skills, [and a] global per- tiveculture groups, Hall in the space currently occu- and information which can be spective.” in addition to sev- pied by Lufkin Engineering Li- found in journals electronically. Miaoulis said there is no set eral other projects. brary, Engineering Dean Ioannis He also envisions study areas sepa- timeline for this project, adding Verdier also sug- Miaoulis said Monday. -

On International Legal Paradigms and the Legal Status of the West Bank
Washington University Global Studies Law Review Volume 14 Issue 3 2015 The Astro-Nomos: On International Legal Paradigms and the Legal Status of the West Bank Orna Ben-Naftali Haim Striks School of Law, the College of Management Academic Studies Rafi Reznik Tel-Aviv University Follow this and additional works at: https://openscholarship.wustl.edu/law_globalstudies Part of the International Law Commons, and the Law and Politics Commons Recommended Citation Orna Ben-Naftali and Rafi Reznik, The Astro-Nomos: On International Legal Paradigms and the Legal Status of the West Bank, 14 WASH. U. GLOBAL STUD. L. REV. 399 (2015), https://openscholarship.wustl.edu/law_globalstudies/vol14/iss3/6 This Article is brought to you for free and open access by the Law School at Washington University Open Scholarship. It has been accepted for inclusion in Washington University Global Studies Law Review by an authorized administrator of Washington University Open Scholarship. For more information, please contact [email protected]. THE ASTRO-NOMOS: ON INTERNATIONAL LEGAL PARADIGMS AND THE LEGAL STATUS OF THE WEST BANK ORNA BEN-NAFTALI RAFI REZNIK ABSTRACT The continuous Israeli occupation of the Palestinian territory may well have exhausted the international community and exasperated the Palestinians, but it still stimulates the Israeli legal imagination. In 2012, the Israeli government established an expert committee to examine the status of Jewish construction in the West Bank. The committee’s report concluded that from an international legal perspective, the West Bank is not occupied territory; the law of belligerent occupation is not applicable to the area; the “prevailing view” is that Jewish settlements are lawful; and that Israel has a valid claim to sovereignty over the territory. -

Wim Kortenoeven
De activistisch anti-Israelische AIV verduistert de werkelijkheid van het Arabisch/islamitisch conflict met Israel een becommentariëring van "Tussen Woord en Daad" Perspectieven op Duurzame Vrede in het Midden-Oosten Advies nr. 83, 21 maart 2013 van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (officieel gepresenteerd op 16 april 2013) Wim Kortenoeven Midden-Oosten specialist en voormalig lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal juni/september 2013 2 Leden Adviesraad Internationale Vraagstukken Voorzitter Mr. F. Korthals Altes Vicevoorzitter Prof.dr. W.J.M. van Genugten Leden Mw. prof.dr. J. Gupta Mw. dr. P.C. Plooij-van Gorsel Prof.dr. A. van Staden LGen b.d. M.L.M. Urlings Mw. mr. H.M. Verrijn Stuart Prof.dr.ir. J.J.C. Voorhoeve Secretaris Drs. T.D.J. Oostenbrink [email protected] Postbus 20061 2500 EB Den Haag telefoon 070 - 348 5108/6060 fax 070 - 348 6256 www.AIV-Advies.nl Leden gecombineerde Commissie Midden-Oosten Voorzitter Prof.dr. A. van Staden Leden Dr. B.S.M. Berendsen Dr. N. van Dam Prof.dr. W.J.M. van Genugten Mr. F. Korthals Altes Mw. mr. H.M. Verrijn Stuart Secretaris Mw. drs. A.M.C. Wester Drs. T.D.J. Oostenbrink 3 Inhoudsopgave Inleidende citaten AIV 5 Inleidende informatie Kortenoeven 6 Voorwoord bij de becommentarieerde versie 11 Samenvatting van de kritiek op het AIV-advies 12 Woord vooraf (AIV) 13 I Het Israëlisch-Palestijnse conflict in perspectief 61 I.1 Het vredesproces 61 I.2 Het juridisch kader 95 II Veranderingen in de regionale en mondiale context 113 II.1 De regionale context 113 II.2 De mondiale context 120 III Scenario’s en mogelijkheden voor toenadering 123 IV Actoren en initiatieven 135 V De rol van Nederland 145 VI Samenvatting en aanbevelingen 151 Bijlage I Adviesaanvraag 158 Bijlage II Kaart van Israël en de bezette Palestijnse gebieden 160 Bijlage III Lijst van gebruikte afkortingen 161 Eindnoten 162 4 ‘… my definition of a tragedy is a clash between right and right. -
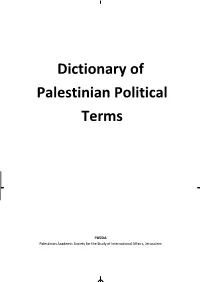
Dictionary of Palestinian Political Terms
Dictionary of Palestinian Political Terms PASSIA Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs, Jerusalem PASSIA, the Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs, is an Arab, non-profit Palestinian institution with a financially and legally indepen- dent status. It is not affiliated with any government, political party or organization. PASSIA seeks to present the Question of Palestine in its national, Arab and interna- tional contexts through academic research, dialogue and publication. PASSIA endeavors that research undertaken under its auspices be specialized, scientific and objective and that its symposia and workshops, whether interna- tional or intra-Palestinian, be open, self-critical and conducted in a spirit of har- mony and cooperation. Copyright PASSIA 3rd updated and revised edition, December 2019 ISBN: 978-9950-305-52-6 PASSIA Publication 2019 Tel.: 02-6264426 | Fax: 02-6282819 E-mail: [email protected] Website: www.passia.org PO Box 19545, Jerusalem Contents Abbreviations ……………………………………………………………………………………………. i Foreword …………………………………………………………………….….…………..……………. iii Dictionary A-Z ………………………………………………………………………….………………. 1 Main References Cited…………………………………………..……………………………… 199 Abbreviations ACRI Association for Civil Rights in PCBS Palestinian Central Bureau of Israel Statistics AD Anno Domini PFLP Popular Front for the Liberation AIPAC American Israel Public Affairs of Palestine Committee PFLP-GC Popular Front for the Liberation ALF Arab Liberation Front of Palestine – General ANM -

1 Table of Contents Editorial – Levy's Bombshell William Mehlman
Summer 2012—Issue #256 PUBLISHED BY AMERICANS FOR A SAFE ISRAEL 42st Year of Publication Table of Contents Editorial – Levy's Bombshell William Mehlman Page 2 From the Editor Rael Jean Isaac Page 4 Israel - A Peacetime War or a Wartime Peace Daniel Greenfield Page 6 Nine Lives Of Israel Edward Alexander Page 8 Peres on 'Tomorrow' - Yesterday and Today Martin Sherman Page 10 France's Shame Rita Kramer Page 12 Daniel Gordis and the Prestige of Israel Emmanuel Navon Page 14 Let's Talk About the Real Illegal Settlements Ruth King Page 16 1 Levy's Bombshell William Mehlman “In a time of universal deceit,” George Orwell wrote, "to tell the truth is a revolutionary act.” The opening note in just such a revolution in Israel may have been struck with the issuance in July of an 89-page investigative report confirming beyond reasonable doubt the international legality both of Israel’s presence in Judea and Samaria and that of its 120 communities beyond the 1949 armistice lines. The report is the product of a three-member blue-ribbon panel headed by retired High Court of Justice magistrate Edmond Levy and including former Foreign Ministry legal advisor Alan Baker and former Tel Aviv District Court Deputy President Tchia Shapira. It was Edmond Levy commissioned by Prime Minister Netanyahu in January, ostensibly to guide him through the legal thickets raised by the allegedly unauthorized “Outpost” construction which has fueled the demolition of Jewish homes in places like Amona and Ulpana. The resultant Levy Report, as it has become known, went a lot further. -

État D'urgence Vs. Démocratie
Université Lille II INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES DE LILLE Master de recherche, section Systèmes politiques comparés État d’urgence vs. Démocratie Le rôle de la Cour suprême israélienne dans le maintien de la démocratie Sharon WEINBLUM, sous la direction de Michel Hastings Année Universitaire 2005-2006 Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont soutenu durant la rédaction de mon mémoire. Je dédie mes remerciements tout particulièrement à : Mon directeur de mémoire, Monsieur Michel Hastings pour ses conseils et pour l’aide qu’il m’a fournie dans le choix du thème de mon travail. Monsieur Paul Magnette pour ses contributions et son soutien. Hanan Frank, professeur et ancien doyen de l’université de Tel Aviv, pour les documents qu’il a bien voulu me faire parvenir. Sylvestre Delcambre pour m’avoir épaulée et encouragée. Mes parents pour leur assistance et pour l’intérêt qu’ils ont porté à mon travail. Sharuz Shalikar, étudiant à l’Université hébraïque de Jérusalem, pour les informations qu’il m’a procurées. Muriel Sacco pour ses recommandations et son aide. Table des matières Introduction ……………………………………………………………………….. p.1. Partie I. De la possibilité du maintien d’une démocratie dans un état d’urgence…. p.6. Préambule…………………………….…………………………….………………. p.6. Chapitre I. Démocratie et état d’urgence: vers l’ « État d’exception » ?.................... p.12. 1. Démocratie et état d’exception, deux concepts incompatibles?.......... p.12. a. L’état d’exception dans le droit et la philosophie………………… p.12 b. L’encadrement de l’état d’exception dans l’État de droit………… p.16 2. L’état d’exception prolongé : vers une érosion de la démocratie ?..... -

ISRAEL and the GAZA STRIP: WHY ECONOMIC SANCTIONS ARE NOT COLLECTIVE PUNISHMENT Israel and the Gaza Strip: Why Economic Sanctions Are Not Collective Punishment
JERUSALEM CENTER FOR PUBLIC AFFAIRS ISRAEL AND THE GAZA STRIP: WHY ECONOMIC SANCTIONS ARE NOT COLLECTIVE PUNISHMENT Israel and the Gaza Strip: Why Economic Sanctions Are Not Collective Punishment Justus Reid Weiner1 Gilad Lindenfeld2 Ilia Binyamin3 Matityahu Wanderman4 Jennifer Lang5 Cover Photos: Israel Defense Forces transferring goods and medical supplies into Gaza through Kerem Shalom Crossing, July 19, 2014. (IDF/Flickr) © 2015 Jerusalem Center for Public Affairs Jerusalem Center for Public Affairs 13 Tel Hai Street, Jerusalem, Israel Tel. 972-2-561-9281 Fax. 972-2-561-9112 Email: [email protected] www.jcpa.org Graphic Design: Darren Goldstein ISBN: 978-965-218-123-7 Table of Contents E xEcutivE Summary 4 I. IntroductIon 5 II. collectIve PunIshment and economIc sanctIons In InternatIonal law 5 a. Collective Punishment in International Law 5 B. Definition and Different Types of Economic Sanctions 7 C. IHL Norms Governing the Use of Economic Sanctions 8 1. Armed Conflict According to the UN Charter 8 2. Israeli ‘Occupation’ under Article 43 of the Hague Convention of 1907 9 D. Do Israeli Economic Sanctions Constitute Collective Punishment? 11 III. the legal Framework For the ImPosItIon oF IsraelI economIc sanctIons 13 A. The History of Israeli Economic Sanctions 14 1. September 2005 – June 2007 14 2. June 2007 – June 2010 16 3. June 2010 – Present 19 B. Occupation 20 1. Laws of Occupation 20 2. Egypt 23 C. The Situation in Gaza 23 Iv. economIc PersPectIves regardIng the sItuatIon In gaza 25 A. Hamas 25 B. Palestinian Authority 27 C. International Opinion: UN, U.S., EU, Arab League, Turkey 28 D. -

Download the Full Report
ISRAEL: A SOCIAL REPORT 2012 Dr. Shlomo Swirski | Etty Konor Attias ||| December 2012 2 Israel: A Social Report 2012 مركزأدفا Board of Directors Dr. Yossi Dahan, Chair This report was made possible Gilbert Finkel (M.A.), Treasurer by generous grants from: Professor Ismail Abu-Saad Ford Israel Foundation Dr. Nitza Berkovitch MAZON: A Jewish Response to Hunger Professor Dani Filc Professor Rachel Kallus Professor Hubert Law-Yone Professor Uri Ram The Adva Center is supported by the following: Dr. Yitzhak Saporta Jacob & Hilda Blaustein Foundation Professor Rivka Savaiya Heinrich Boell Foundation Professor Oren Yiftachel CORDAID Professor Yossi Yona European Union Friedrich Ebert Stiftung Audit Committee FordIsrael Fund Attorney Ovadia Golestany Ms. Ruti Gur Hadassah Foundation Mr. Howard Horowitz and Ms. Alisse Waterston Staff Members Jewish Women’s Foundation of New York Barbara Swirski, Executive Director MAZON: A Jewish Response to Hunger Shlomo Swirski, Academic Director National Council of Jewish Women Etty Konor-Attias, Research Coordinator New Israel Fund Adi Sofer, Economist Rosa Luxemburg Foundation Safa Agbaria, Economist Zabar Family Attorney Noga Dagan-Buzaglo, Researcher Yael Hasson, Researcher and Coordinator, Women’s Budget Forum Valeria Seigelshifer, Advocacy Director Shira Pinhas, Community Social Worker Ariane Ofir, Statistician Yaron Dishon, Outreach Coordinator Mira Oppenheim, Office Manager and Press Liaison 3 INTRODUCTION This annual update of the Social Report appears at the height of the Israeli election season, held early because of government fears that it would not be able to mobilize a majority to pass a budget bill that called for harsh cuts in the social services. Election campaigns tend to highlight the issues that capture media headlines.