Rapporto Pendolaria 2012
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
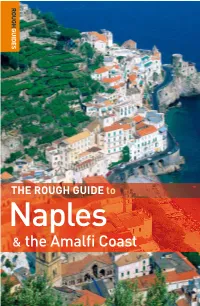
The Rough Guide to Naples & the Amalfi Coast
HEK=> =K?:;I J>;HEK=>=K?:;je CVeaZh i]Z6bVaÒ8dVhi D7FB;IJ>;7C7B<?9E7IJ 7ZcZkZcid BdcYgV\dcZ 8{ejV HVc<^dg\^d 8VhZgiV HVciÉ6\ViV YZaHVcc^d YZ^<di^ HVciVBVg^V 8{ejVKiZgZ 8VhiZaKdaijgcd 8VhVaY^ Eg^cX^eZ 6g^Zcod / AV\dY^EVig^V BVg^\a^Vcd 6kZaa^cd 9WfeZ_Y^_de CdaV 8jbV CVeaZh AV\dY^;jhVgd Edoojda^ BiKZhjk^jh BZgXVidHVcHZkZg^cd EgX^YV :gXdaVcd Fecf[__ >hX]^V EdbeZ^ >hX]^V IdggZ6ccjco^ViV 8VhiZaaVbbVgZY^HiVW^V 7Vnd[CVeaZh GVkZaad HdggZcid Edh^iVcd HVaZgcd 6bVa[^ 8{eg^ <ja[d[HVaZgcd 6cVX{eg^ 8{eg^ CVeaZh I]Z8Vbe^;aZ\gZ^ Hdji]d[CVeaZh I]Z6bVa[^8dVhi I]Z^haVcYh LN Cdgi]d[CVeaZh FW[ijkc About this book Rough Guides are designed to be good to read and easy to use. The book is divided into the following sections, and you should be able to find whatever you need in one of them. The introductory colour section is designed to give you a feel for Naples and the Amalfi Coast, suggesting when to go and what not to miss, and includes a full list of contents. Then comes basics, for pre-departure information and other practicalities. The guide chapters cover the region in depth, each starting with a highlights panel, introduction and a map to help you plan your route. Contexts fills you in on history, books and film while individual colour sections introduce Neapolitan cuisine and performance. Language gives you an extensive menu reader and enough Italian to get by. 9 781843 537144 ISBN 978-1-84353-714-4 The book concludes with all the small print, including details of how to send in updates and corrections, and a comprehensive index. -

Breakthrough Ceremony for Monte Olibano Tunnel on the Cumana Railway Line
BREAKTHROUGH CEREMONY FOR MONTE OLIBANO TUNNEL ON THE CUMANA RAILWAY LINE The tunnel, built by Astaldi Group, allows for the upgrading and expansion of a strategic transport infrastructure for the metropolitan area of Naples and for the whole Phlegrean catchment area Naples, 2 July 2020 – The breakthrough ceremony for Monte Olibano tunnel, which forms part of the project to upgrade and expand the Cumana Railway, was held this morning in Naples and was attended by Vincenzo De Luca , President of Campania Region , Vincenzo Figliolia , Mayor of Pozzuoli , Umberto De Gregorio, Chairman of EAV , as well as Paolo Astaldi , Chairman of Astaldi Group , and Filippo Stinellis , CEO of Astaldi Group. The new tunnel forms part of the project to double the Cumana Railway line along a section measuring approximately 5 km and includes, inter alia, works to adjust the route of the old single-track Monte Olibano tunnel, construction of new stations in Pozzuoli and Cantieri, updating of Gerolomini station and works to double the railway track for the Dazio- Cantieri section. Performance of these works will make it possible to finally complete doubling of the railway line, allowing for an underground-style transport service on the complete Cumana line, with a high frequency of trains and high safety standards. Completion of the planned upgrading and expansion of the railway is scheduled for June 2023. The network, which comprises the Cumana and Circumflegrea lines and 33 stations, serves the whole of the western part of the Naples metropolitan area and the Phlegrean catchment area, a highly-populated area that is set to expand even further as a result of the constant growth of housing and tourism. -

Research Article the Impact of Urban Transit Systems on Property Values: a Model and Some Evidences from the City of Naples
Hindawi Journal of Advanced Transportation Volume 2018, Article ID 1767149, 22 pages https://doi.org/10.1155/2018/1767149 Research Article The Impact of Urban Transit Systems on Property Values: A Model and Some Evidences from the City of Naples Mariano Gallo Dipartimento di Ingegneria, Universita` del Sannio, Piazza Roma 21, 82100 Benevento, Italy Correspondence should be addressed to Mariano Gallo; [email protected] Received 9 October 2017; Revised 30 January 2018; Accepted 21 February 2018; Published 5 April 2018 Academic Editor: David F. Llorca Copyright © 2018 Mariano Gallo. Tis is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. A hedonic model for estimating the efects of transit systems on real estate values is specifed and calibrated for the city of Naples. Te model is used to estimate the external benefts concerning property values which may be attributed to the Naples metro at the present time and in two future scenarios. Te results show that only high-frequency metro lines have appreciable efects on real estate values, while low-frequency metro lines and bus lines produce no signifcant impacts. Our results show that the impacts on real estate values of the metro system in Naples are signifcant, with corresponding external benefts estimated at about 7.2 billion euros or about 8.5% of the total value of real estate assets. 1. Introduction lower environmental impacts produced by less use of private cars, investments in transit systems, especially in railways Urban transit systems play a fundamental role for the social and metros, may generate an appreciable increase in property and economic development of large urban areas, as well as values in the zones served; this beneft should be explicitly signifcantly afecting the quality of life in such areas. -

Albo-AEC-PIETRANGELI-18-02-2019
Associazione Europea Ferrovieri – Italia ALBO DELLE ASSOCIAZIONI FERROVIARIE E CULTURALI DELL’AREA DELLE FERROVIE TURISTICHE a cura di: Mario Pietrangeli Con il patrocinio di: _____________________________________________________________________________ Pubblicazione prodotta sotto l’egida della: Edizione: febbraio 2019 2 PREFAZIONE Il 16 settembre 2017 si costituisce a Pesaro – nell’ambito delle iniziative degli Stati Generali della Mobilità Nuova - l’Alleanza per la Mobilità Dolce. Essa nasce dal desiderio delle più importanti Associazioni Nazionali, impegnate sul tema, di collaborare per promuovere e far crescere la mobilità dolce, attraverso una serie di azioni e attività da sviluppare congiuntamente. La rete sul territorio per la mobilita dolce promuove il piacere del viaggio a bassa velocità e la mobilità attiva, integrando percorsi ciclabili, reti di cammini, ferrovie turistiche, linee ferroviarie locali, riutilizzando e qualificando il patrimonio esistente, in una visione integrata con il trasporto collettivo: una rete dolce, semplice da utilizzare da parte di tutti. Obiettivo principale è la promozione, di una Rete Nazionale (nel futuro si pensa di estendere tale promozione anche a livello Europeo) di Mobilità Dolce e Sostenibile (Integrata con le realtà Turistiche, Artistiche, Gastronomiche delle Località e dei Piccoli Borghi Attraversati) che abbia come requisiti fondamentali: il recupero delle infrastrutture territoriali dismesse (ferrovie, infrastrutture ferroviarie, funivie, canali e vie fluviali, strade arginali, percorsi -

Rete Metropolitana Napoli 1.Pdf
aversa piedimonte matese benevento caserta caserta formia frattamaggiore casoria cancello afragola acerra casalnuovo di napoli botteghelle volla poggioreale centro direzionale underground and railways map madonnelle argine palasport salvator gianturco rosa villa gianturco visconti formia vesuvio barra de meis duomo san ponticelli giovanni porta nolana san s. maria giovanni del pozzo bartolo longo licola quarto quarto torregaveta centro san pietrarsa giorgio cavalli di bronzo bellavista portici ercolano pompei castellammare sorrento pompei salerno pozzuoli capolinea autobus edenlandia bus terminal kennedy linea 1 ANM linea 2 Trenitalia collegamento marittimo torregaveta agnano line 1 line 2 sea transfer pozzuoli gerolomini linea 6 ANM parcheggio metrocampania nordest EAV parking line 6 metrocampania nordest line bagnoli ospedale cappuccini dazio funicolari ANM hospital funicolars linea circumvesuviana EAV circumvesuviana railway museo stazione museum station linea circumflegrea EAV castello stazione dell’arte circumflegrea railway castle art station linea cumana EAV università stazione in costruzione cumana railway university station under construction stadio scale mobili rete ferroviaria Trenitalia stadium escalators regional and national railway network mostra d’oltremare nodi di interscambio collegamento aeroporto interchange station airport transfer ostello internazionale Porto - Stazione Centrale - Aeroporto hostelling international APERTURA CHIUSURA PUOI ACQUISTARE I BIGLIETTI PRESSO I open closed DISTRIBUTORI AUTOMATICI O NEI RIVENDITORI -

Rapporto-Pendolaria-2013.Pdf
Sono tempi difficili per quei cittadini italiani che ogni giorno prendono il treno per andare a lavorare o a studiare. Una condizione di disagio che nelle grandi città dipende dal “successo” di frequentazione dei treni, sempre più stracolmi, mentre sulle altre linee frequentate dai pendolari la situazione è di disperazione per la riduzione dei collegamenti avvenuta negli ultimi anni. Dei problemi di questi cittadini, sono quasi tre milioni, non si occupa nessuno. Persino di fronte a tagli clamorosi di risorse come quelli avvenuti negli ultimi anni, una questione che è evidentemente di interesse generale non riesce a trovare spazio. Nel dibattito pubblico e nell'attenzione politica questi problemi compaiono per alcune settimane all'anno, quando i problemi sono tali da catturare l'attenzione per via di proteste o incidenti. Eppure guardare ai problemi dei pendolari è oggi una chiave imprescindibile per capire non solo la domanda di mobilità delle persone, ma più in generale il Paese, soprattutto in un momento così difficile per le famiglie, il lavoro, l’economia. Per cominciare a occuparsi della questione pendolari occorre guardare con attenzione a quanto sta accadendo sulla rete ferroviaria italiana e ad alcuni cambiamenti recenti. Il primo cambiamento avvenuto nel 2013 riguarda il numero totale dei passeggeri sulle linee regionali, che ha avuto una leggera riduzione dell’1,4%. E’ la prima volta che succede da dieci anni e la ragione sta nel “crollo” del numero dei viaggiatori in alcune Regioni. Ossia quelle dove in questi anni sono stati effettuati i maggiori tagli al servizio. In Campania sono stati effettuate riduzione complessive del servizio pari al 19% dal 2010 ad oggi con punte di -50% dei treni in circolazione su alcune linee. -
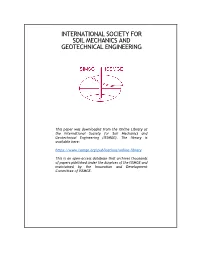
International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
INTERNATIONAL SOCIETY FOR SOIL MECHANICS AND GEOTECHNICAL ENGINEERING This paper was downloaded from the Online Library of the International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE). The library is available here: https://www.issmge.org/publications/online-library This is an open-access database that archives thousands of papers published under the Auspices of the ISSMGE and maintained by the Innovation and Development Committee of ISSMGE. Geotechnical Aspects of Underground Construction in Soft Ground – Viggiani (ed) © 2012 Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-0-415-68367-8 Modelling and monitoring of a urban underground excavation A. Cantone Department of Civil Engineering, II University of Naples, Italy R. Fico Structural & Geotechnical Designer Collaborator, Naples, Italy F. Cavuoto Structural & Geotechnical Designer, Naples, Italy A. Mandolini Department of Civil Engineering, II University of Naples, Italy ABSTRACT: The highly urbanization of the area where Montesanto Station (Naples, Italy) is located and the need to guarantee the transportation service to travellers during the works gave birth to the plan of the combined use of 3D numerical analyses and the real time monitoring of significant parameters (displacements, strain, stresses and temperature) to confirm the set of design criteria assumed and calibrate the design parameters affecting the problem faced. The 3D analyses simulated the step by step excavation predicting the stress-strain behaviour; hence the comparison of the analytical predictions with the corresponding values derived through the monitoring (238 points being monitored) allowed to calibrate the model as the excavation advanced, thus refining the analysis itself and improving the safety level. 1 INTRODUCTION adopted, an intensive monitoring activity was planned under the supervision of the Civil The Montesanto Station of Cumana Railway Line, Engineering Department (DIC) of the Second owned by S.E.P.S.A. -

Verso NAPOLI CITTÀ METROPOLITANA
verso NAPOLI CITTÀ METROPOLITANA Questi appunti sono un invito a riflettere sul futuro di “Napoli Città Metropolitana”: sulla necessità di riformarne l’assetto istituzionale e di delineare processi di trasformazione ambientali e urbanistici che l’aiutino ad abbandonare posizioni di coda nelle classifiche per qualità della vita. I dati raccolti non sono certo esaurienti: sono i minimi sufficienti a evidenziare vistose anomalie o contraddizioni che spingono a suggerire come abbandonare “l’era dell’ignoranza ingiustificata” e come delineare una idonea riorganizzazione istituzionale e urbanistica. Sempre in forma sintetica documentano come proprio a Napoli -con il Piano Quadro delle Attrezzature (1974/75)- sia stata formulata una prima organica proposta a scala urbana di quanto verrà poi verso felicemente teorizzato nel 2003 in “Five NAPOLI Minutes City” dando luogo a principi ed a tecniche, prima del tutto sporadiche, che - dal 2017- cominciano a diffondersi un po’dovunque, dal Canada all’Australia e CITTÀ anche in Europa. Nelle pagine finali, primi appunti di queste logiche in alcuni e fra loro molto © Civilizzare l’Urbano ETS differenti ambiti del territorio di “Napoli Posillipo 176 / via Petrarca 38, 80123 - Napoli METROPOLITANA Città Metropolitana”. prima edizione 2021* www.pcaint.eu/civilizzare ISBN 978-88-944192-3-8 Varie immagini sono inedite ed elaborate per questa editing: Francesco Damiani (Pica Ciamarra Associati) pubblicazione, altre sono tratte dall’archivio di “Civilizzare l’urbano - ETS”. Per quelle da pubblicazioni reperibili su Internet sono riportati i ETS link di riferimento. CIVILIZZARE L’URBANO ETS premessa con intento di sintesi 05 33 1. riassetto istituzionale 35 2. integrare conoscenze per velocizzare le azioni 39 3. -
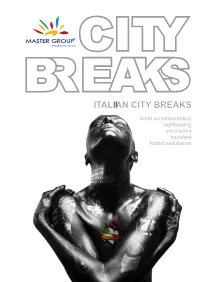
Reggio Calabria from East, A16 Highway ‘Autostrada Dei Due Mari’ by Ship
a short but perfect break... many cities to embrace each possible interest index Venice Milan Florence 6 14 26 getting there getting there getting there moving around moving around moving around Venetian Classic Art and history in Milan Art and history in Florence Appointment in Venice Milan Fashion Parks and Gardens: the Sky, land and lagoon Milan Surroundings green Florence. Florentine days 8 hotels 16 hotels 28 hotels index Reggio Rome Naples Calabria 36 56 68 getting there getting there getting there moving around moving around moving around Imperial Rome: Archeolo- The heart of Naples: The Sea way gical Areas. “Spaccanapoli” and the inner ancient city. The city of the Bronzes Between Renaissance and Baroque From “Maschio Angioino” The old town to Reggia di Capodimonte Underground Rome: Reggio living... the Catacombs and the The blu way: from Castel Mithraeum. dell’Ovo to Posillipo. Moderne and Contempo- Tasting Naples rary Rome Parks and Mansions Rome surroundings 38 hotels 58 hotels 70 hotels key Master Group Master Group Master Group SPECIAL CULT LIGHT structure, type and locationn Hotel Town centre Near motorway Old mansion Near seaside Near exhibition area Bed & Breakfast Business centre Near airport Romantic hotel Semi-central area Near public transports Quiet hotel Suburban area Near railway station Business hotel At the seaside Near port Castle Historical building general services in your room Disable-friendly Park/Garden Air conditioned rooms Groups welcome Night porter Hairdrier Lift Internet point Safe Bar Restaurant Minibar Garage Credit cards welcome Pay TV Carpark WIFI service Phone TV Sat TV leisure time business Berth Indoor swimming pool Conference room Wellness centre Swimming pool Meeting room Fitness/Gym Tennis Venice the city on the water, the winged lion, the film Venice festival, the “Biennale”, the flight of the Angel.. -

Entrepreneurial Culture, Corporate Responsibility and Urban Development
1 INTERNATIONAL CONFERENCE ISSUES OF LEGITIMACY: Entrepreneurial Culture, Corporate Responsibility and Urban Development Mostra d’Oltremare, Naples, Italy – 10-14 September 2012 Convened by: The IUAES Commissions on Urban Anthropology and on Enterprise Anthropology With the Collaboration of: Media Group Il Denaro; University of Naples Federico II; University of Naples 2; Brazilian Anthropological Association; Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México (CIESAS); China Union of Anthropological and Ethnological Sciences Colegio de Etnólogos y Antropologos Sociales, México; Indian Anthropological Association; International Association of Southeast European Anthropology (InASEA); IUAES Commission on Anthropology of Women; IUAES Commission on Human Rights Anthropologists are the promoters of this Conference because the anthropological study of economic systems addresses empirically the relationship between economic institutions and the broader society - that is political, legal and cultural institutions, as well as ordinary people. Committed to ethnographic field research, anthropologists offer an in-depth understanding of economic institutions and of individual and collective economic behaviours. This Conference aims to provide a platform for anthropologists to share their findings with scholars from other relevant disciplines and with practitioners (in the fields of finance, business, legislation and policy-making) in order to contribute to the promotion of economic activities that benefit the broader society. Therefore, this event includes both academic sessions and a round-table discussion involving academics and non-academics, to stimulate debate on the contribution of academic research and reflection on policies and practices in different countries. Naples, a major European city, encapsulates complex economic difficulties and potentialities which, in various degrees, mark today’s world-wide scenario, and a key part of which this Conference aims to address. -

Risk Management Planning. Phlegrean Area and the Case Study of Bacoli
Risk Management Planning. Phlegrean area and the case study of Bacoli Giuseppe GUIDA,1 Giovanni BELLO2 (1) PhD - Department of Architecture and Industrial Design, Second University of Naples, Italy E-mail [email protected] (2) Urban Planner - Department of Architecture, University of Naples Abstract The coastal region from Bacoli to Sorrento Coast contains, besides an alternation of fine landscapes and large areas of unplanned urban sprawl, different natural risk elements, object of planning tools that affect substantially urban policies and urban plans In fact, if a Civil Protection and Emergency Plan is a project of all activities and procedures that need to be adopted to deal with an expected disaster in a region, it is evident that the coordination with urban planning is fundamental, especially in sensitive areas such as the coastal ones. In the article, using the case study of the Italian city of Bacoli (near Naples), I’ll explore the possibilities offered, in the emergency planning, by the sea as a specific escape route in case of natural disaster. The reflection starts from an examination of the particular orography and geography of the Phlegraean coast, the area topography, the level of interconnections and infrastructures. The strategies developed during the preparation of the emergency and civil protection plan, from which this article starts, identify in the waterfront, especially adapted, infrastructured and safe, a fundamental option in the management of major emergencies of the Phlegraean area. Keywords: safety & security, -

Facts & Figures
High–1 lights Facts & Figures 2020 High–2 lights DOWNLOAD WEBUILD CORPORATE APP SELECT THE AUGMENTED REALITY TOOL AND AIM AT THE PAGES WITH OUR MARKER DISCOVER EXCLUSIVE CONTENTS AIM AT THE MARKER TO DOWNLOAD THE DIGITAL COPY OF THIS BROCHURE High– lights Facts & Figures 2 WHO WE ARE Webuild (previously globally known as Recognized by the Engineering News- Salini Impregilo) is a leading global player Record (ENR) as one of the top in the construction of large, complex contractors in the water sector, it is also projects for sustainable mobility, clean a global leader in sustainable mobility hydro energy, clean water, green buildings, as well as one of the top 10 contractors supporting clients in achieving the UN in the environment sector. Sustainable Development Goals (SDGs). KEY STRENGTHS Operational excellence Solid financial structure Responsible behaviour: robust ESG standards Significant geographical diversification Efficient organization, change management, innovation SHAREHOLDERS COMPOSITION Shareholder Number of Shares % of the Share Capital Salini Costruttori S.p.A. 401,394,591 44.99 CDP Equity S.p.A. 166,666,666 18.68 Intesa San Paolo S.p.A. 47,067,400 5.28 Unicredit S.p.A. 47,976,218 5.38 Banco BPM S.p.A. 6,000,000 0.67 Treasury shares 1,330,845 0.15 Free float 221,736,971 24.85 Total number of ordinary shares 892,172,691 100 3 KEY FIGURES* 114 years of engineering and construction €40.3 bn total backlog (Webuild+Astaldi) as at 30.6.2020 €34 bn construction backlog (Webuild+Astaldi) as at 30.6.2020 88% construction backlog from