A T T I Della
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Fauna of Longicorn Beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of Mordovia
Russian Entomol. J. 27(2): 161–177 © RUSSIAN ENTOMOLOGICAL JOURNAL, 2018 Fauna of longicorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of Mordovia Ôàóíà æóêîâ-óñà÷åé (Coleoptera: Cerambycidae) Ìîðäîâèè A.B. Ruchin1, L.V. Egorov1,2 À.Á. Ðó÷èí1, Ë.Â. Åãîðîâ1,2 1 Joint Directorate of the Mordovia State Nature Reserve and National Park «Smolny», Dachny per., 4, Saransk 430011, Russia. 1 ФГБУ «Заповедная Мордовия», Дачный пер., 4, г. Саранск 430011, Россия. E-mail: [email protected] 2 State Nature Reserve «Prisursky», Lesnoi, 9, Cheboksary 428034, Russia. E-mail: [email protected] 2 ФГБУ «Государственный заповедник «Присурский», пос. Лесной, 9, г. Чебоксары 428034, Россия. KEY WORDS: Coleoptera, Cerambycidae, Russia, Mordovia, fauna. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Coleoptera, Cerambycidae, Россия, Мордовия, фауна. ABSTRACT. This paper presents an overview of Tula [Bolshakov, Dorofeev, 2004], Yaroslavl [Vlasov, the Cerambycidae fauna in Mordovia, based on avail- 1999], Kaluga [Aleksanov, Alekseev, 2003], Samara able literature data and our own materials, collected in [Isajev, 2007] regions, Udmurt [Dedyukhin, 2007] and 2002–2017. It provides information on the distribution Chuvash [Egorov, 2005, 2006] Republics. The first in Mordovia, and some biological features for 106 survey work on the fauna of Longicorns in Mordovia species from 67 genera. From the list of fauna are Republic was published by us [Ruchin, 2008a]. There excluded Rhagium bifasciatum, Brachyta variabilis, were indicated 55 species from 37 genera, found in the Stenurella jaegeri, as their habitation in the region is region. At the same time, Ergates faber (Linnaeus, doubtful. Eight species are indicated for the republic for 1760), Anastrangalia dubia (Scopoli, 1763), Stictolep- the first time. -

Turkish Red List Categories of Longicorn Beetles (Coleoptera: Cerambycidae) Part Viii – Subfamily Cerambycinae: Anaglyptini and Clytini
____________Mun. Ent. Zool. Vol. 9, No. 2, June 2014_________ 687 TURKISH RED LIST CATEGORIES OF LONGICORN BEETLES (COLEOPTERA: CERAMBYCIDAE) PART VIII – SUBFAMILY CERAMBYCINAE: ANAGLYPTINI AND CLYTINI Hüseyin Özdikmen* * Gazi University, Faculty of Science, Department of Biology, 06500 Ankara, TURKEY. E- mail: [email protected] [Özdikmen, H. 2014. Turkish Red List Categories of Longicorn Beetles (Coleoptera: Cerambycidae) Part VIII – Subfamily Cerambycinae: Anaglyptini and Clytini. Munis Entomology & Zoology, 9 (2): 687-712] ABSTRACT: The aim of this study is to create a Turkish Red List of the longicorn beetles. Moreover, presence such a Red List is necessary for Turkey. Even governmental evaluations could cause some erroneous decisions due to absence such a Red List. Since, governmental evaluations at the present time are based on the works that are realized with respect to the European Red List. Furthernore, Turkey appears a continental property changeable in very short distances in terms of climatical features and field structures. So, the status of European fauna and the status of Turkish fauna are not the same. Clearly, there is no any work that subjected to create a Turkish Red List except Parts I-VII. Hence, a series work is planned with this purpose. This type of study is the eighth attempt for Turkey. KEY WORDS: Red List, Conservation, Cerambycidae, Turkey. The purpose of the current study was to create a Turkish Red List of longicorn beetles similarly to “European Red List of Saproxylic Beetles” that was compiled by Ana Nieto & Keith N. A. Alexander and published by IUCN (International Union for Conservation of Nature) in collaboration with the European Union in 2010. -

Coleópteros Saproxílicos De Los Bosques De Montaña En El Norte De La Comunidad De Madrid
Universidad Politécnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos Coleópteros Saproxílicos de los Bosques de Montaña en el Norte de la Comunidad de Madrid T e s i s D o c t o r a l Juan Jesús de la Rosa Maldonado Licenciado en Ciencias Ambientales 2014 Departamento de Producción Vegetal: Botánica y Protección Vegetal Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos Coleópteros Saproxílicos de los Bosques de Montaña en el Norte de la Comunidad de Madrid Juan Jesús de la Rosa Maldonado Licenciado en Ciencias Ambientales Directores: D. Pedro del Estal Padillo, Doctor Ingeniero Agrónomo D. Marcos Méndez Iglesias, Doctor en Biología 2014 Tribunal nombrado por el Magfco. y Excmo. Sr. Rector de la Universidad Politécnica de Madrid el día de de 2014. Presidente D. Vocal D. Vocal D. Vocal D. Secretario D. Suplente D. Suplente D. Realizada la lectura y defensa de la Tesis el día de de 2014 en Madrid, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Calificación: El Presidente Los Vocales El Secretario AGRADECIMIENTOS A Ángel Quirós, Diego Marín Armijos, Isabel López, Marga López, José Luis Gómez Grande, María José Morales, Alba López, Jorge Martínez Huelves, Miguel Corra, Adriana García, Natalia Rojas, Rafa Castro, Ana Busto, Enrique Gorroño y resto de amigos que puntualmente colaboraron en los trabajos de campo o de gabinete. A la Guardería Forestal de la comarca de Buitrago de Lozoya, por su permanente apoyo logístico. A los especialistas en taxonomía que participaron en la identificación del material recolectado, pues sin su asistencia hubiera sido mucho más difícil finalizar este trabajo. -

Beetles from Sălaj County, Romania (Coleoptera, Excluding Carabidae)
Studia Universitatis “Vasile Goldiş”, Seria Ştiinţele Vieţii Vol. 26 supplement 1, 2016, pp.5- 58 © 2016 Vasile Goldis University Press (www.studiauniversitatis.ro) BEETLES FROM SĂLAJ COUNTY, ROMANIA (COLEOPTERA, EXCLUDING CARABIDAE) Ottó Merkl, Tamás Németh, Attila Podlussány Department of Zoology, Hungarian Natural History Museum ABSTRACT: During a faunistical exploration of Sǎlaj county carried out in 2014 and 2015, 840 beetle species were recorded, including two species of Community interest (Natura 2000 species): Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763) and Lucanus cervus Linnaeus, 1758. Notes on the distribution of Augyles marmota (Kiesenwetter, 1850) (Heteroceridae), Trichodes punctatus Fischer von Waldheim, 1829 (Cleridae), Laena reitteri Weise, 1877 (Tenebrionidae), Brachysomus ornatus Stierlin, 1892, Lixus cylindrus (Fabricius, 1781) (Curculionidae), Mylacomorphus globus (Seidlitz, 1868) (Curculionidae) are given. Key words: Coleoptera, beetles, Sǎlaj, Romania, Transsylvania, faunistics INTRODUCTION: László Dányi, LF = László Forró, LR = László The beetle fauna of Sǎlaj county is relatively little Ronkay, MT = Mária Tóth, OM = Ottó Merkl, PS = known compared to that of Romania, and even to other Péter Sulyán, VS = Viktória Szőke, ZB = Zsolt Bálint, parts of Transsylvania. Zilahi Kiss (1905) listed ZE = Zoltán Erőss, ZS = Zoltán Soltész, ZV = Zoltán altogether 2,214 data of 1,373 species of 537 genera Vas). The serial numbers in parentheses refer to the list from Sǎlaj county mainly based on his own collections of collecting sites published in this volume by A. and partially on those of Kuthy (1897). Some of his Gubányi. collection sites (e.g. Tasnád or Hadad) no longer The collected specimens were identified by belong to Sǎlaj county. numerous coleopterists. Their names are given under Vasile Goldiş Western University (Arad) and the the names of beetle families. -
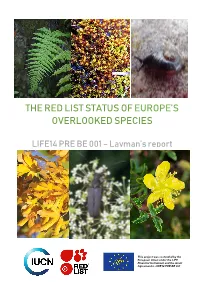
Layman's Report
THE RED LIST STATUS OF EUROPE’S OVERLOOKED SPECIES LIFE14 PRE BE 001 – Layman’s report This project was co-funded by the European Union under the LIFE Financial Instrument and the Grant Agreement n. LIFE14 PRE BE 001 About IUCN Created in 1948, IUCN represents one of the world’s largest and most diverse environmental networks. It harnesses the experience, resources and reach of more than 1,300 member organisations and the input of over 15,000 volunteer experts, organised in six commissions. IUCN is the global authority on the status of the natural world and the measures needed to safeguard it. The IUCN Global Species Programme supports the activities of the IUCN Species Survival Commission and individual Specialist Groups, as well as implementing global species conservation initiatives. It is an integral part of the IUCN Secretariat and is managed from IUCN’s international headquarters in Gland, Switzerland. What is the IUCN Red List? The European Red List The IUCN Red List of Threatened SpeciesTM is the When conducting regional or national assessments, world’s most comprehensive information source on and to ensure that the criteria are applied the extinction risk of plant and animal species. It is a appropriately at such scales, the IUCN has compilation of the conservation status of species at developed the Guidelines for Application of IUCN Red the global level, based on the best scientific List Criteria at Regional Levels.1 information available. The IUCN Red List Categories and Criteria are based on a set of quantitative criteria linked to population trends, size and structure, threats, and geographic ranges of species. -

A Reference Library of DNA Barcodes for French Saproxylic Beetles (Insecta, Coleoptera)
Biodiversity Data Journal 3: e4078 doi: 10.3897/BDJ.3.e4078 Data Paper PASSIFOR: A reference library of DNA barcodes for French saproxylic beetles (Insecta, Coleoptera) Rodolphe Rougerie‡,§, Carlos Lopez-Vaamonde§, Thomas Barnouin|, Julien Delnatte ¶, Nicolas Moulin#, Thierry Noblecourt|, Benoît Nusillard¤, Guillem Parmain¤, Fabien Soldati |, Christophe Bouget¤ ‡ Muséum national d'Histoire Naturelle, Sorbonne Universités, Institut de Systématique, Évolution, Biodiversité (ISYEB), UMR 7205 – CNRS, MNHN, UPMC, EPHE, Paris, France § INRA UR633 Zoologie Forestière, Orléans, France | Office National des Forêts (ONF), Laboratoire National d'Entomologie Forestière, Quillan, France ¶ Independent researcher, Avignon, France # Entreprise Nicolas Moulin Entomologiste, Bihorel, France ¤ IRSTEA Ecosystèmes Forestiers, Nogent-Sur-Vernisson, France Corresponding author: Rodolphe Rougerie ([email protected]) Academic editor: Axel Hausmann Received: 17 Sep 2014 | Accepted: 24 Feb 2015 | Published: 04 Mar 2015 Citation: Rougerie R, Lopez-Vaamonde C, Barnouin T, Delnatte J, Moulin N, Noblecourt T, Nusillard B, Parmain G, Soldati F, Bouget C (2015) PASSIFOR: A reference library of DNA barcodes for French saproxylic beetles (Insecta, Coleoptera). Biodiversity Data Journal 3: e4078. doi: 10.3897/BDJ.3.e4078 Abstract Saproxylic beetles – associated with dead wood or with other insects, fungi and microorganisms that decompose it – play a major role in forest nutrient cycling. They are important ecosystem service providers and are used as key bio-indicators of old-growth forests. In France alone, where the present study took place, there are about 2500 species distributed within 71 families. This high diversity represents a major challenge for specimen sorting and identification. The PASSIFOR project aims at developing a DNA metabarcoding approach to facilitate and enhance the monitoring of saproxylic beetles as indicators in ecological studies. -

A Check-List of Longicorn Beetles (Coleoptera: Cerambycidae)
Евразиатский энтомол. журнал 18(3): 199–212 © EUROASIAN ENTOMOLOGICAL doi: 10.15298/euroasentj.18.3.10 JOURNAL, 2019 A check-list of longicorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of Tyumenskaya Oblast of Russia Àííîòèðîâàííûé ñïèñîê æóêîâ-óñà÷åé (Coleoptera: Cerambycidae) Òþìåíñêîé îáëàñòè V.A. Stolbov*, E.V. Sergeeva**, D.E. Lomakin*, S.D. Sheykin* Â.À. Ñòîëáîâ*, Å.Â. Ñåðãååâà**, Ä.Å. Ëîìàêèí*, Ñ.Ä. Øåéêèí* * Tyumen state university, Volodarskogo Str. 6, Tyumen 625003 Russia. E-mail: [email protected]. * Тюменский государственный университет, ул. Володарского 6, Тюмень 625003 Россия. ** Tobolsk complex scientific station of the UB of the RAS, Acad. Yu. Osipova Str. 15, Tobolsk 626152 Russia. E-mail: [email protected]. ** Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, ул. акад. Ю. Осипова 15, Тобольск 626152 Россия. Key words: Coleoptera, Cerambycidae, Tyumenskaya Oblast, fauna, West Siberia. Ключевые слова: жесткокрылые, усачи, Тюменская область, фауна, Западная Сибирь. Abstract. A checklist of 99 Longhorn beetle species (Cer- rambycidae of Tomskaya oblast [Kuleshov, Romanen- ambycidae) from 59 genera occurring in Tyumenskaya Oblast ko, 2009]. of Russia, compiled on the basis of author’s material, muse- The data on the fauna of longicorn beetles of the um collections and literature sources, is presented. Eleven Tyumenskaya oblast are fragmentary. Ernest Chiki gave species, Dinoptera collaris (Linnaeus, 1758), Pachytodes the first references of the Cerambycidae of Tyumen erraticus (Dalman, 1817), Stenurella bifasciata (Müller, 1776), Tetropium gracilicorne Reitter, 1889, Spondylis bu- oblast at the beginning of the XX century. He indicated prestoides (Linnaeus, 1758), Pronocera sibirica (Gebler, 11 species and noted in general the northern character 1848), Semanotus undatus (Linnaeus, 1758), Monochamus of the enthomofauna of the region [Csíki, 1901]. -

Coleoptera: Cerambycidae)
© Autonome Provinz Bozen, Abteilung Forstwirtschaft, download unter www.biologiezentrum.at forest observer vol. 5 2010 31 - 152 Faunistik der Bockkäfer von Südtirol (Coleoptera: Cerambycidae) Klaus Hellrigl Abstract Faunistics of Longhorn-beetles (Coleoptera, Cerambycidae) from South Tyrol (N-Italy). A survey on the occurrence of Longhorn-beetles in the Province of South Tyrol-Bolzano is given. The first monograph of the Longhorn-beetles (Coleoptera, Cerambycidae) of the fauna of South Tyrol (N-Italy: Province Bozen-Bolzano) was published by the Author back in 1967. Over 40 years later, a current up- dated and revised edition is given, where also incisive changes and innovations on the valid actual scientific nomenclature of species that occurred since the first edition are considered. Scientific nomenclature follows the recent publications of BENSE (1995), JANIS (2001) and FAUNA EUROPAEA (2007/09) respectively. Detailed descriptions of the presence and biology of some Cerambycid species are given for the first time. Also a historical review of Cerambycid-studies in South-Tirol is given. Apart from the own recent collec- tions and observations made by the Author during the last 45 years, further considered were the findings and rearing results of five other collectors and colleagues, operating here for the last decades, like: M. Kahlen (Hall i.Tirol), W. Schwienbacher (Auer), M. Egger (Innsbruck), E. Niederfriniger (Schenna) und G. v. Mörl (Brixen). In the special faunistic section, the review of each species begins with brief indications about general geographical distribution in Europe and about ecological occurrence, and continues subsequently with a mention of the former indications given by V. M. -

Coleoptera) Edited by I
_____________Mun. Ent. Zool. Vol. 7, No. 1, January 2012__________ 109 ADDITIONS AND CORRECTIONS TO THE NEW CATALOGUE OF PALAEARCTIC CERAMBYCIDAE (COLEOPTERA) EDITED BY I. LÖBL AND A. SMETANA, 2010. PART. III. Mikhail L. Danilevsky* * A. N. Severtzov Institute of Ecology and Evolution, Russian Academy of Sciences, Leninsky prospect 33, Moscow 119071 RUSSIA. E-mail: [email protected] and [email protected] [Danilevsky, M. L. 2012. Additions and corrections to the new Catalogue of Palaearctic Cerambycidae (Coleoptera) edited by I. Löbl and A. Smetana, 2010. Part. III. Munis Entomology & Zoology, 7 (1): 109-173] ABSTRACT. More than 300 misprints, wrong combinations, wrong geographical records, wrong references, wrong status of certain names, wrong synonyms, wrong authorships and dates of certain names, wrong original combinations, wrong spelling of several names and so on are fixed. Sometimes unavailable names were published as available. Missing names, geographical data and references are added. KEY WORDS: Coleoptera, Cerambycidae, taxonomy, Palaearctic. Third part of additions and corrections to the Cerambycidae Catalog (Löbl & Smetana, 2010) continues two parts published before (Danilevsky, 2010 and 2011). Next parts are being prepared now for publication. All three parts include more than 1000 corrections, which are all shown in http://www.cerambycidae.net/catalog.html together with acceptable corrections published by A. I. Miroshnikov (2011a,b), I. Löbl & A. Smetana (2011), D. G. Kasatkin & A. I. Miroshnikov (2011) and H. Özdikmen (2011). The WEB information is updated each two months. The references to the present article include only the publications absent in the references to the Catalog (Löbl & Smetana, 2010). The references inside the text of the present article to the publications included in the references to the Catalog have same letters after the number of the year as in the Catalog. -

Distribution of Rhaphuma Gracilipes (Faldermann, 1835) (Coleoptera: Cerambycidae) in Europe
Acta entomologica silesiana Vol. 20, 2012: 65–70 ISSN 1230-7777 Bytom, December 30, 2012 Distribution of Rhaphuma gracilipes (FALDERMANN, 1835) (Coleoptera: Cerambycidae) in Europe JACEK KURZAWA ul. Sterlinga 2/10, PL 97-200 Tomaszów Mazowiecki, e-mail: [email protected] ABSTRACT. Rozmieszczenie Rhaphuma gracilipes (FALDERMANN, 1835) (Coleoptera: Cerambycidae) w Europie. New records of Rhaphuma gracilipes from Poland and Russia are given. Literature and new data from Europaean area have been verified and summarized. KEY WORDS: Coleoptera, Cerambycidae, Rhaphuma, Chlorophorus, Poland, Europe, Russia, distribution, new record. Rhaphuma gracilipes (FALDERMANN, 1835) Clytus gracilipes FALDERMANN, 1835, Mem. Acad. St. Petersb., 2: 436. Clytus angusticollis MULSANT, 1851: 123 Clytus tenuicornis FAIRMAIRE, 1888 Clytanthus sachalinensis MATSUMURA, 1911 Rhaphuma gracilipes (FALDERMANN, 1835) is a Palaearcic species widely distributed in Eastern Europe (Poland, Belarus, Russia), in Kazakhstan (KOSTIN 1973), Siberia (including Sakhalin and Kunashir Island), northern Mongolia to northern China, Korean Peninsula and Japan. In Europe it was reported from Poland (GUTOWSKI 1992), Belarus (ZAWADZKI 1937) and European Russia (PLAVILSTSHIKOV 1940). Rh. gracilipes is not recorded from Kirgizia, Uzbekistan, Tadzhikistan, Turkmenia (Republics of Central Asia), Caucasus (Republics of Transcaucasia and territories of North Caucasus from Krasnodar Region to Daghestan) and from Crimea Peninsula. The report from Turkey (ÖZDIKMEN 2011: ”Hatay prov.: Akbez (FAIRMAIRE 1884)” must be surely connected with other species. Rh. gracilipes was mistakenly listed from Spain (GANGLBAUER 1881, AURIVILLIUS 1912), based on the wrong interpretation of name ”Galicia” (PLAVILSTSHIKOV 1940). That species is common in the eastern part of its distribution area, increasing in number eastward from the Ural Mountains to Ussuri region. In the western part of its distribution area, in Poland, Belarus, and European Russia, the species is reported mainly on the base of old records from 19th and beginning of 20th century. -

Contributions on Entomology, International
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/260417793 World catalog of the family Aulacidae (Hymenoptera) Article · January 2001 CITATIONS READS 76 614 1 author: David R. Smith United States Department of Agriculture 382 PUBLICATIONS 2,740 CITATIONS SEE PROFILE Some of the authors of this publication are also working on these related projects: Insects Associated with Montana's Huckleberry Plants View project The hind coxal ovipositor guide of the parasitoid wasp family Aulacidae (Hymenoptera, Evanioidea) under morphological and phylogenetic perspectives View project All content following this page was uploaded by David R. Smith on 24 October 2015. The user has requested enhancement of the downloaded file. Contributions on Entomology, International Volume 4, Number 3, 2001 WORLD CATALOG OF THE FAMILY AULACIDAE (HYMENOPTERA) By David R. Smith Associated publishers 2001 Contributions on Entomology, lnternαtionα1 Edited by Virendra K. Gupta A wor1 d catalog of 仕le family Aulacidae (Hymenoptera) is provided. Aulacidae 訂 e parasitoids of wood-boring Hymenoptera (Xiphydriidae) and Coleoptera (especially Cerambycidae and Buprestidae) and 訂e found inall regions of the wor1d. Three valid genera, Aulacus Jurine, Pristαulaαs Kieffer, and Panaulix Benoit, and 157 valid species 訂e known. Distribution 缸ld host data are given for each species, as well as synonymies 缸ld all known references. Lists are provided glvmg the known hosts and plants with which aulacids have been associ ated. A complete list of references 缸ld an index to taxa are inc1uded. Two new names, one new synonymy, and 33 new combinations are proposed. Author: David R. Smith Systematic Entomology Laboratory Agricultural Research Service, U.S.D.A. -

A Comprehensive DNA Barcode Database for Central European Beetles with a Focus on Germany: Adding More Than 3500 Identified Species to BOLD
Molecular Ecology Resources (2015) 15, 795–818 doi: 10.1111/1755-0998.12354 A comprehensive DNA barcode database for Central European beetles with a focus on Germany: adding more than 3500 identified species to BOLD 1 ^ 1 LARS HENDRICH,* JEROME MORINIERE,* GERHARD HASZPRUNAR,*† PAUL D. N. HEBERT,‡ € AXEL HAUSMANN,*† FRANK KOHLER,§ andMICHAEL BALKE,*† *Bavarian State Collection of Zoology (SNSB – ZSM), Munchhausenstrasse€ 21, 81247 Munchen,€ Germany, †Department of Biology II and GeoBioCenter, Ludwig-Maximilians-University, Richard-Wagner-Strabe 10, 80333 Munchen,€ Germany, ‡Biodiversity Institute of Ontario (BIO), University of Guelph, Guelph, ON N1G 2W1, Canada, §Coleopterological Science Office – Frank K€ohler, Strombergstrasse 22a, 53332 Bornheim, Germany Abstract Beetles are the most diverse group of animals and are crucial for ecosystem functioning. In many countries, they are well established for environmental impact assessment, but even in the well-studied Central European fauna, species identification can be very difficult. A comprehensive and taxonomically well-curated DNA barcode library could remedy this deficit and could also link hundreds of years of traditional knowledge with next generation sequencing technology. However, such a beetle library is missing to date. This study provides the globally largest DNA barcode reference library for Coleoptera for 15 948 individuals belonging to 3514 well-identified species (53% of the German fauna) with representatives from 97 of 103 families (94%). This study is the first comprehensive regional test of the efficiency of DNA barcoding for beetles with a focus on Germany. Sequences ≥500 bp were recovered from 63% of the specimens analysed (15 948 of 25 294) with short sequences from another 997 specimens.