Adobe Photoshop
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
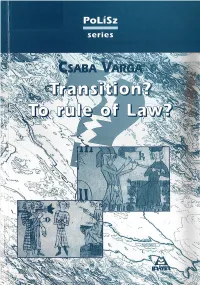
CSABA VARGA Transition? to Rule of Law? Varga Jogallami Angol Proba Tartalek Ks Korr01.Qxp 2008.01.23
PoLíSz series CSABA VARGA Transition? To rule of law? varga_jogallami_angol_proba_tartalek_ks_korr01.qxp 2008.01.23. 12:28 Page 1 CSABA VARGA TRANSITION? TO RULE OF LAW? Constitutionalism and Transitional Justice Challenged in Central & Eastern Europe varga_jogallami_angol_proba_tartalek_ks_korr01.qxp 2008.01.23. 12:28 Page 2 CSABA VARGA was born in Pécs. Since graduation in law in 1965, he has been an academic researcher at the Institute for Legal Studies of the Hungarian Academy of Sciences, since 1991 as scientific adviser. He became a Professor of Law at the metropolitan Eötvös Loránd University in the same year. By the foundation of the Faculty of Law of the Pázmány Péter Catholic University of Hungary in 1995, he founded and has also been heading its Institute for Legal Philosophy, granted by the National Accreditation Committee in 2006 the sole title “Place of Excellence” for a chair in the country. One of the founders (as its secretary between 1976–2006 and since then as its chairman) of the Hungarian National Section of the International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR); a political adviser to and a member of the Advisory Board of the first free-elected Prime Minister of Hungary (1991–1994), serving as an editorial board member of Current Legal Theory (1983–1998), Ratio Juris (1988–), Legal Theory (1993–1999), as well as of Világosság [a philosophical forum] (2003–). In 2004, he was elected as an associated member of the International Academy of Comparative Law. His bibliography is available in both http://varga.jak.ppke.hu and Theatrvm legale mvndi Symbola Cs. -

Sociology - Lithuania Vosyliūtė, Anelė
www.ssoar.info Sociology - Lithuania Vosyliūtė, Anelė Veröffentlichungsversion / Published Version Sammelwerksbeitrag / collection article Zur Verfügung gestellt in Kooperation mit / provided in cooperation with: GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Vosyliūtė, A. (2002). Sociology - Lithuania. In M. Kaase, V. Sparschuh, & A. Wenninger (Eds.), Three social science disciplines in Central and Eastern Europe: handbook on economics, political science and sociology (1989-2001) (pp. 467-483). Berlin: Informationszentrum Sozialwissenschaften. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-281219 Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer CC BY Lizenz (Namensnennung) zur This document is made available under a CC BY Licence Verfügung gestellt. Nähere Auskünfte zu den CC-Lizenzen finden (Attribution). For more Information see: Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de 467 Anelė Vosyliūtė Sociology – Lithuania Discussant: Vladas Gaidys 1. Analysis of the pre-1989 situation Lithuanian sociologists, representatives of a small scientific community, have produced few analyses of the development of their discipline and of the strengths and weaknesses of results in its different branches. A small number of authors have contributed general overviews (Gaidys and Vosyliūtė, 1995; Gaidys, 1996) or have written on some aspects of sociological investigation (Rapoportas, 1997; Valantiejus, 1995; Kraniauskas, 2001). Lithuanian sociology’s pre-war history and its several phases in Soviet times have been described (Vosyliūtė, 1996, 1998, 2000). Sociology in the socialist period During the postwar period in Lithuania, Soviet Communist doctrine rejected the scientific heritage and traditions of social sciences of the inter-war period, which were publicly labeled “bourgeois science”. -

A. A. Prof. PETRAS LEONAS. „Ne Tik Jėgas, Bet Ir Sutaupąs Tėvy Nei"
lams* s O darbas Tėvynei yra palaimintas darbas. Darbo- vertę Įprasmina ir Konstitucija, kad „Valstybę laiko ne*- T R I M I T A S paliaitjamas darbas*'. LIETUVOS ŠAULIŲ IR PATRIOTINĖS VISUOMENĖS Naujoji Konstitucija yra mūsų tautos ir valstybės LAIKRAŠTIS — ŽURNALAS. vyriausias .įstatymas, kuriuo remiasi visi mūsų gyveninio Eina XIX metai, kas savaitė. reiškiniai;'mūsų siekimai, darbai ir žygiai. Todėl Nauja Leidžia ŠAULIŲ SĄJUNGA. jai Konstitucijai įsigaliojus, mes turime įsisąmoninti^ jos Redaktorius JONAS KALNĖNAS. dėsnius, persiimti jos dvasia ir kelti tautoje jos gerbimo- PRENUMERATOS' KAINA Lietuvoje jausmą. Už didį darbą — Konstitucijos paruošimą, mū metams 5 litai, pusei metų 3 litai, mėnesiui 50 centi]. sų Vyriausybei, Seimui turime reikšti padėką, o didžiau Atskiras numeris — 20 et. sias mūsų, -dėkingumas priklauso mūsų Respublikos Pre Užsieniui — metams 10 litų, pusei metų 6 litai. zidentui Antanui Smetonai, kurio nenuilstamo darbo ir SKELBIMŲ KAINOS 60 et. už 1 cm2. Nuolatiniams skelbė kūrybos dėsniais ir jo minčių dvasia Naujoji Konstituci jams daroma nuolaidų. Už skelbimų turinį Redakcija ne ja yra pagrįsta. atsako. šauliai* žiūrėkime, kad teisingumas būtų nepažeidžia RANKRAŠČIUS Redakcija taiso savo nuožiūra. NeSuvartotų mas, o teisėtumą ir įstatymus saugosime, kaip mūsų sau rankraščių Redakcija savo lėšomis negrąžina ir nesaugo. linės pareigos reikalauja. Visi šauliai turi gerai įsiskai Už straipsnius ir nuotraukas atlyginama tik susitarus. tyti ir žinoti pagrindini Valstybės įstatymą.' REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA šiąja proga, reikšdami džiaugsmo del Naujosios Kon Kaunas, Laisvės alėja 20. Telefonas 22663. stitucijos įsigaliojimo, mes, šauliai, minutei susikaupki me del didžiojo mūsų tautos ir valstybės vyro, buv. pir mojo teisingumo ministro, vėliau vidaus reikalų ministro ir ilgamečio šaulių Sąjungos centro valdybas nario prof. -

Vmu Vytautas Magnus University Magnus Vmu Vytautas
VMU VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY MAGNUS VMU VYTAUTAS VMU VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY SITY GNUS UNIVER S MA TA AU VMU VYT VMU VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY VMU VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY budding alchemist* appears at a university, A UNIVERSITY AWhere art and science show you his way To celebrate a blend of diversity, And keep you dreaming awake. Mining for gold, you get something pure: A magic potion of knowledge and passion, So potent, so liberating, so true You feel free to pursue and to ponder... Everyone here is an aspiring mage: Turning their future into a wonder. n the modern context, an alchemist has very little in common with a reclusive scientist who’s working in a shack somewhere and trying to turn lead into gold. Today’s alchemist is a modern man, a philosopher whose Iwork and ideas transcend his own era, and who sees and perceives the world from a much wider perspective. For such a person, even “gold” has a completely different meaning: instead of the pursuit of a noble metal or elixir for eternal physical life, it signifies enlightenment and attainment of useful nuggets of wisdom. Here, gold symbolizes the highest consciousness and an extremely perceptive mind. Where can one find such people today? Indubitably, at the university. Vytautas Magnus University is the magnet which attracts talented individuals from Lithuania and all over the world. Its geographical setting is no less special than its history or mission: Kaunas is the academic and cultural capital of Lithuania. Our location is not only a comfortable vantage point for observation of the world, but also a great launching pad for reaching it. -

The Features of the History of Sociology in Lithuania
‘‘Social Transformations in Contemporary Society’’, 2013 (1) ISSN 2345-0126 (online) THE FEATURES OF THE HISTORY OF SOCIOLOGY IN LITHUANIA Aida Vaicekauskaite Kaunas University of Technology, Lithuania Abstract The purpose – is to reveal the stages of the development of history of Lithuanian sociology and its specific features. Methodology. The article is based on the survey of sources analysing the history of sociology, paying special attention to manifestations of sociology in Lithuania during various periods of time. Findings. Sociology is one of the youngest academic disciplines established as a distinct field of study in Europe only in the 19th century. Three main fields of investigation can be distinguished in the history of Lithuanian sociology: the pre-war period, the soviet period and the post-soviet period. Each period is characterised by its peculiar opportunities for sociologists’ professional expression, challenges and achievements; as well as different topics and directions for sociological research. After the review of sources dealing with the history of sociology, it must be noted that there are three main stages of the development of sociology: (1) the period of 1960- 1970, characterised by work study; (2) since the 1970s the main attention has been paid to social planning; (3) the period starting from 1989 is distinguished for the beginning of public opinion poll. Research limitations/implications. This brief review of the history of sociology in Lithuania is rather fragmentary; a thorough analysis needs more time and more comprehensive studies. Practical implications. The importance of the study shows in the fact that the research of the history of Lithuanian sociology can be helpful in analysing the issues of sociological professionalism and identity. -

Population Displacement in Lithuania in the Twentieth Century
Population Displacement in Lithuania in the Twentieth Century Experiences, Identities and Legacies Edited by Tomas Balkelis Violeta Davoliūtė LEIDEN | BOSTON For use by the Author only | © 2016 Koninklijke Brill NV <UN> Contents Preface vii Acknowledgements X List of Tables xi Notes on Contributors xii Introduction 1 Part 1 Population Displacement during World War One and Its Aftermath 1 Making the Nation: Refugees, Indigent People, and Lithuanian Relief, 1914–1920 21 Andrea Griffante 2 Forging a “Moral Community”: The Great War and Lithuanian Refugees in Russia 42 Tomas Balkelis 3 Displacement without Moving: Secession, Border Changes and Practices of Population Politics in Lithuania, 1916–1923 62 Klaus Richter Part 2 Population Displacement in the Klaipėda Region 4 Population of the Klaipėda Region and the Balance of Power in the Eastern Baltic Region, 1919–1960 91 Vasilijus Safronovas 5 Population Shifts and Displacement in the Memel Region 112 Ruth Leiserowitz For use by the Author only | © 2016 Koninklijke Brill NV <UN> vi Contents Part 3 Population Displacement during World War Two and Its Aftermath 6 Repopulating Vilnius, 1939–1949 135 Theodore R. Weeks 7 Between Poland and Lithuania: Repatriation of Poles from Lithuania, 1944–1947 160 Vitalija Stravinskienė 8 A “Forgotten” History of Soviet Deportation: The Case of Lithuanian Jews 179 Violeta Davoliūtė 9 Religious Life in a Displaced Society: The Case of Post-war Lithuania, 1945–1960 211 Arūnas Streikus 10 Lithuanian Diaspora: From Displaced Persons to Diaspora Politics 236 Daiva Dapkutė Index 259 For use by the Author only | © 2016 Koninklijke Brill NV chapter 2 Forging a “Moral Community”: The Great War and Lithuanian Refugees in Russia Tomas Balkelis Introduction By the end of the Great War, Russia’s disastrous military performance, eco- nomic collapse and growing unrest on the “home front” brought the transfor- mation of the empire into a number of shatterzones where various nationalist and revolutionary forces asserted themselves with unseen vigour. -

Seimas Pritarė Lietuvos Dalyvavimui JT Daliniuose
£11J P 4 GRfiTIS 2-tL THE. L1B RAKY OF ŪUNGRtSS KtrtkLNCL DLJ'ftRiKLNi SERIALS DIVlSluN KASHINGKiN L>C 20025 IŠEIVIJOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 TELEFONAS (312) 585-9500 2ND CLASS MAIL TELEFAKSAS (312) 585-8284 July 14, 1994 THE LITHUANIAN VVORLD-VVIDE DAILY Vol. LXXXV Kaina 35 c. KETVIRTADIENIS - THURSDAtf, LIEPA - JULY 14, 1994 Nr. 135 Seimas pritarė Rusų kariai gavo butus Lietuvos dalyvavimui Karaliaučiuje Vilnius, liepos 8 d. (AGEP) - konkrečiais darbais". Rusija pri JT daliniuose Įvažiavus į Karaliaučiaus kraš versta kol kas laikyti savo ka tą liepos 5 d. rytą, gausūs milici riuomenę Karaliaučiuje, jis sakė. Baltijos laivynas — tai Vilnius, liepos 1 d. (LR) — skubinama, retoriškai klausė: jos postai liudijo, kad vyksta karinė flotilė, su kuria susijusi „Lietuvos kariuomenės padali „Gal mūsų kariai žūti nenori?" neeiliniai įvykiai. Karaliau Rusijos istorija. Laivynas, niai gali dalyvauti tarptau Kolegą palaikė LDDP frakci čius laukė aukštų svečių iš įkurtas caro Petro I, negali būti tinėse operacijose tik vykdy jos atstovas Mindaugas Stakvi Maskvos ir Vilniaus. I krašto diskriminuojamas. Tarnaujan dami Lietuvos Respublikos levičius, kuris domėjosi, „ko sostinę atvyko Rusijos Federaci čių kariškių kiekis šiuo metu tarptautinius įsipareigojimus", kiuose karstuose grįš Lietuvos jos susirinkimo (Rusijos parla minimalus, pažymėjo Šumeika. teigiama pirmajame įstatymo žmonės, ir ar jiems jau padaryti mento aukštesniųjų rūmų) pir „Dėl Lietuvos kariuomenės da užsakymai". mininkas V. Šumeika ir Lietu Kalbą pasakė ir Lietuvos Sei lyvavimo tarptautinėse operaci vos Seimo pirmininkas Česlovas mo pirmininkas Česlovas Jur jose" projekto straipsnyje. Taikos palaikymo misijos Juršėnas. Svečiai buvo pakvies šėnas Pasidžiaugęs Šeimos atliktu darbu, visiems palinkėjo Kaip rašo „Lietuvos rytas", šį palyginti nepavojingos ti į iškilmes Šeimos įmonės pa laimės. -

Kultūrinio Liberalizmo Intencijos Tarpukario Kaune: Mokslo Ir Visuomenės Ugdymo Sanglauda
LITUANISTICA. 2021. T. 67. Nr. 2(124), p. 112–125, © Lietuvos mokslų akademija, 2021 Kultūrinio liberalizmo intencijos tarpukario Kaune: mokslo ir visuomenės ugdymo sanglauda ROMUALDAS JUZEFOVIČIUS Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Saltoniškių g. 58, 08105 Vilnius El. paštas [email protected] Straipsnyje siekiama ištirti ir įvertinti 1922 m. Kaune įsteigto Lietuvos universiteto mokslininkų ir pedagogų liberalizmo idėjų įtaką organizuojant inteligentijos švie čiamąją veiklą visuomenėje. Tiriami archyvinių ir skelbtų šaltinių duomenys apie Lietuvos universitete formuojamą demokratišką sociokultūrinę aplinką, nagrinėja mas mokslo asmenybių kultūrinio liberalizmo idėjų poveikis organizuojant Kauno gyventojų švietimą ir kultūrinį ugdymą. Šiame straipsnyje panaudoti Kaune veikusio universiteto pedagoginės ir kultūrinės veiklos dokumentai, personaliniai fondai, in telektualų įsteigtų organizacijų posėdžių protokolai, oficialūs raštai ir kita korespon dencija, periodinė spauda. Straipsnio naujumas sietinas su tuo, kad kultūrinio libe ralizmo idėjų ir edukacinės veiklos plėtojimo sanglaudos klausimai nėra specialiai išsamiau tyrinėti. Raktažodžiai: Lietuvos mokslininkai, kultūrinis liberalizmas, visuomenės švietimas, Kauno istorija ĮVADAS Lietuvos teorinėje literatūroje kultūrinio liberalizmo sampratos ir jos principų interpretacija pirmiausia siejama su lietuvių išeivijos sociologo Vytauto Kavolio analitinėmis idėjomis ir lietuvių kultūros, kūrybos raidos vertinimais. Kultūrinį liberalizmą V. Kavolis suprato kaip universalią sąmonės tendenciją, -

Nazioni E Regioni 4/2014
ISSN: 2282-5681 Nazioni Regionie Studi e ricerche sulla comunità immaginata (4)2014 CARATTERI ( )e MOBILI Direzione Dario Ansel, Fabio De Leonardis, Andrea Geniola Caporedattrice Francesca Zantedeschi Redazione Adriano Cirulli, Arcangelo Licinio, Marco Pérez, Paolo Perri, Gianluca Scroccu, Marco Stolfo Contatti [email protected] / www.nazionieregioni.it Comitato scientifico Joseba Agirreazkuenaga (Euskal Herriko Unibertsitatea), Ferran Archilés (Universitat de València), Alfonso Botti (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia), Jordi Canal (École des Hautes Études en Sciences Sociales - Paris), Guido Franzinetti (Università del Piemonte Orientale), Maarten Van Ginderachter (Universiteit Antwerpen), José Luis de la Granja Sainz (Euskal Herriko Unibertsitatea), Miroslav Hroch (Univerzita Karlova v Praze), Michel Huysseune (Vesalius College - Vrije Universiteit Brussel), James Kennedy (University of Edinburgh), Juan Carlos Moreno Cabrera (Universidad Autónoma de Madrid), Xosé Manoel Núñez Seixas (Universidade de Santiago de Compostela/Ludwig- Maximilians-Universität München), Rolf Petri (Università “Ca’ Foscari” Venezia), Daniele Petrosino (Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”), Ilaria Porciani (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna), Anne-Marie Thiesse (École Normale Supérieure - Paris), Stuart Woolf (Università “Ca’ Foscari” Venezia), Pere Ysàs (Universitat Autònoma de Barcelona) Comitato editoriale Alex Amaya Quer (CEFID - Universitat Autònoma de Barcelona), Leyre Arrieta (Deustuko Unibertsitatea), Gevorg -

Lithuanian Paths to Modernity
Lithuanian Paths to Modernity VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS Lithuanian Paths to Modernity UDK 94 Al-79 ISBN 978-609-467-236-1 (Online) © Egidijus Aleksandravičius, 2016 ISBN 978-9955-34-637-1 (Online) © Vytautas Magnus University, 2016 ISBN 978-609-467-237-8 (Print) © “Versus aureus” Publishers, 2016 ISBN 978-9955-34-638-8 (Print) To Leonidas Donskis 7 Table of Contents Preface / Krzysztof Czyżewski. MODERNITY AND HISTORIAN’S LITHUANIA / 9 Acknowledgements / 21 Part I: Before Down A Lost Vision: The Grand Duchy of Lithuania in the Political Imagination of the 19th Century / 25 Hebrew studies at Vilnius University and Lithuanian Ethnopolitical tendencies in the First part of the 19th century / 39 The double Fate of the Lithuanian gentry / 57 Political goals of Lithuanians, 1863–1918 / 69 Associational Culture and Civil Society in Lithuania under Tsarist Rule / 87 The Union’s Shadow, or Federalism in the Lithuanian Political Imagination of the late 19th and early 20th centuries / 105 Part II: The Turns of Historiography The Challenge of the Past: a survey of Lithuanian historiography / 137 Jews in Lithuanian Historiography / 155 Lost in Freedom: Competing historical grand narratives in post-Soviet Lithuania / 167 8 LITHUANIAN PATHS TO MODERNITY Part III: The Fall, Sovietization and After Lithuanian collaboration with the Nazis and the Soviets / 195 Conspiracy theories in traumatized societies: The Lithuanian case / 227 Lithuanian routes, stories, and memories / 237 Post-Communist Transition: The Case of Two Lithuanian Capital Cities / 249 Emigration and the goals of Lithuania’s foreign policy / 267 Guilt as Europe’s Borderline / 281 9 Preface Krzysztof Czyżewski MODERNITY AND HISTORIAN’S LITHUANIA I worry about ‘progressive’ history teaching… The task of the historian is to supply the dimension of knowledge and narrative without which we cannot be a civic whole.. -

Ap7-Makets-Internetam.Pdf
Introduction Journal of Turiba University No. 7 ISSN 1691-6077 Riga 2016 1 Acta Prosperitatis 7 Journal of Turiba University Acta Prosperitatis No. 7 Editor-in-Chief Assist.prof. Dr. paed. Aldis Baumanis, Turiba University, Latvia Co-editor-in-Chief Mg.sc.ing., MBA Ivars Namatēvs, Turiba University, Latvia Executive Editors Aasoc.prof., PhD Suat Begeç, University of Turkish Aeronautical Association, Turkey Prof. Dr.hab. Waldemar Dotkuś, Wroclaw University of Economics, Poland Assoc.prof. Dr.iur. Kristina Miliauskaitė, Mykolas Romeris University, Lithuania Prof. Dr.oec. Andrei Pochovyuk, Kremenchuk Mykhailo Ostrogradskyi University, Ukraine Asoc.prof. Dr.phil. Gregory Simons, Uppsala University, Sweden Prof. Dr.iur Jānis Teivāns-Treinovskis, Daugavpils Univeristy, Latvia Assist.prof. Dr.ing.sc. Ilmārs Vīksne, Riga Technical University, Latvia Assoc. prof. Dr. oec. Rosita Zvirgzdiņa, Turiba University, Latvia When quoted the reference to the issue is mandatory Publisher Turiba University, Ltd. Head of Publishing House Daiga Rugāja Literary editor Assoc.Prof. Dr.paed. Diāna Rumpīte, Riga Technical University, Latvia © SIA “Biznesa augstskola Turība”, 2016, 174 p. 2 Introduction CONTENT Introduction ............................................................................................................................................... 4 THE DOMINO EFFECT IN RISK AND CRISIS COMMUNICATION IN THE CONTEXT OF ITS LEGAL ASPECTS ........................................................................................ 7 Derkevica–Pilskunga Jolanta -

Draudžiamos Lietuviškos Spaudos Platinimas Suvalkų Gubernijoje
LITUANISTICA. 2021. T. 67. Nr. 1(123), p. 27–47, © Lietuvos mokslų akademija, 2021 Draudžiamos lietuviškos spaudos platinimas Suvalkų gubernijoje INGA STEPUKONIENĖ Vilniaus universitetas, Kauno fakultetas, Kalbų, literatūros ir vertimo studijų institutas, Muitinės g. 8, 44280 Kaunas El. paštas [email protected] Straipsnyje apžvelgiamas draudžiamos spaudos platinimo procesas Suvalkų guber- nijoje. Draudžiami lietuviški laikraščiai ir knygos šiame regione pradėti platinti iš- kart po 1863 m. sukilimo. Didžiulę įtaką šiam procesui turėjo slaptais lietuviškos tautinės savimonės žadinimo centrais tapę Marijampolės gimnazija ir Veiverių mo- kytojų seminarija. Nemenką impulsą knygnešystei Lietuvoje suteikė slaptos spaudos platintojų draugijos „Sietynas“ ir „Artojų draugija“. Raktažodžiai: draudžiama lietuviška spauda, knygnešiai, draudžiamos lietuviškos spaudos platinimo centrai ĮVADAS Pasak G. Ilgūno, lietuviškos spaudos plitimas atskiruose Lietuvos regionuose buvo skir- tingas. Didžiausias lietuviškų raštų paplitimas pastebimas vakarinėje Lietuvos dalyje, kiek mažesnis vidurio ir dar pasyvesnis rytinėje Lietuvos dalyje [8, 105]. Akivaizdu, jog Sūduvoje, XIX a. antrojoje pusėje priklausiusioje Suvalkų gubernijai, itin aktyvų knygne- šių judėjimą lėmė įvairios priežastys: carinių represijų po pralaimėto 1863 m. sukilimo poveikis, didelis veiklių, drąsių ir tautiškai susipratusių asmenybių skaičius (M. Akelaitis, P. Arminas, P. Kriaučiūnas), gana gausi išsilavinusios jaunuomenės dalis, mokiusis Marijampolės gimnazijoje ar Veiverių mokytojų