Nazioni E Regioni 4/2014
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Apprentice Strikes in Twentieth Century UK Engineering and Shipbuilding*
Apprentice strikes in twentieth century UK engineering and shipbuilding* Paul Ryan Management Centre King’s College London November 2004 * Earlier versions of this paper were presented to the International Conference on the European History of Vocational Education and Training, University of Florence, the ESRC Seminar on Historical Developments, Aims and Values of VET, University of Westminster, and the annual conference of the British Universities Industrial Relations Association. I would like to thank Alan McKinlay and David Lyddon for their generous assistance, and Lucy Delap, Alan MacFarlane, Brian Peat, David Raffe, Alistair Reid and Keith Snell for comments and suggestions; the Engineering Employers’ Federation and the Department of Education and Skills for access to unpublished information; the staff of the Modern Records Centre, Warwick, the Mitchell Library, Glasgow, the Caird Library, Greenwich, and the Public Record Office, Kew, for assistance with archive materials; and the Nuffield Foundation and King’s College, Cambridge for financial support. 2 Abstract Between 1910 and 1970, apprentices in the engineering and shipbuilding industries launched nine strike movements, concentrated in Scotland and Lancashire. On average, the disputes lasted for more than five weeks, drawing in more than 15,000 young people for nearly two weeks apiece. Although the disputes were in essence unofficial, they complemented sector-wide negotiations by union officials. Two interpretations are considered: a political-social-cultural one, emphasising political motivation and youth socialisation, and an economics-industrial relations one, emphasising collective action and conflicting economic interests. Both interpretations prove relevant, with qualified priority to the economics-IR one. The apprentices’ actions influenced economic outcomes, including pay structures and training incentives, and thereby contributed to the decline of apprenticeship. -

Heroes of Peace Profiles of the Scottish Peace Campaigners Who Opposed the First World War
Heroes of Peace Profiles of the Scottish peace campaigners who opposed the First World War a paper from the Introduction The coming year will see many attempts to interpret the First World War as a ‘just’ war with the emphasis on the heroic sacrifice of troops in the face of an evil enemy. No-one is questioning the bravery or the sacrifice although the introduction of conscription sixteen months after the start of the war meant that many of the men who fought did not do so from choice and once in the armed forces they had to obey orders or be shot. Even many of the volunteers in the early stages of the war signed up on the assumption that it would all be over in a few months with few casualties. We want to ensure that there is an alternative – and we believe more valid – interpretation of the events of a century ago made available to the public. This was a war in which around ten million young men were killed on the battlefield in four years, about 120,000 of them were Scottish. Proportionately Scotland suffered the highest number of war dead apart from Serbia and Turkey. It was described as the ‘war to end wars’ but instead it created the conditions for the rise of Hitler and the Second World War just twenty years later as a result of the very harsh terms imposed on Germany and the determination to humiliate the losing states. It also contributed to some of the current problems in the Middle East since, as part of the war settlement, Britain and France took ownership of large parts of the Ottoman Empire and divided up the territory with no reference to the identities and interests of the people. -

We Can Be Heroes Just for One Day
ASLEFJOURNAL SEPTEMBER 2019 The magazine of the Associated Society of Locomotive Engineers & Firemen We can be heroes just for one day Standing by the wall I will be king & you, you will be queen And the guns shot above our heads For ever and ever And the shame was on the other side. We can beat them... The train drivers ’ Inside: Palestine; Pride; Michael Green; and Tolpuddle 2019 union since 1880 GS Mick Whelan ASLEFJOURNAL SEPTEMBER 2019 Chaos and confusion The magazine of the Associated Society of Locomotive Engineers & Firemen E HAVE never been in the W game of having preferences in contractual negotiations for franchises, even having different standards of Mick: ‘It’s the old cap industrial relations and collar process’ within certain groups. Our issue is, and always has been, with the model. Never has this been clearer than now, when we might have expected 10 a period of calm after Mr Grayling going and Mr 12 Shapps taking over. Alas, that is not the case. Confusion reigns. News The number of questions we have had over what has been announced continues to grow. l Rail fares rise again; and steam train blues 4 Apparently, Southeastern is to be run again as l Railway Workers’ Centenary Service; and 5 the conditions aren’t right; Stagecoach and Arriva Off the Rails: Patrick Flanery; Bev Quist; can take legal action over being excluded. Then Kim Darroch; and Christopher Meyer First Trenitalia wins the former Virgin bid because it meets Williams – a report we have not yet had – Cyril Power’s Tube train pictures on show 6 l and contains element of the old cap and collar l Kevin Lindsay hails a victory in Scotland 7 process that means the franchisee cannot lose. -
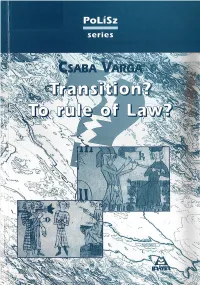
CSABA VARGA Transition? to Rule of Law? Varga Jogallami Angol Proba Tartalek Ks Korr01.Qxp 2008.01.23
PoLíSz series CSABA VARGA Transition? To rule of law? varga_jogallami_angol_proba_tartalek_ks_korr01.qxp 2008.01.23. 12:28 Page 1 CSABA VARGA TRANSITION? TO RULE OF LAW? Constitutionalism and Transitional Justice Challenged in Central & Eastern Europe varga_jogallami_angol_proba_tartalek_ks_korr01.qxp 2008.01.23. 12:28 Page 2 CSABA VARGA was born in Pécs. Since graduation in law in 1965, he has been an academic researcher at the Institute for Legal Studies of the Hungarian Academy of Sciences, since 1991 as scientific adviser. He became a Professor of Law at the metropolitan Eötvös Loránd University in the same year. By the foundation of the Faculty of Law of the Pázmány Péter Catholic University of Hungary in 1995, he founded and has also been heading its Institute for Legal Philosophy, granted by the National Accreditation Committee in 2006 the sole title “Place of Excellence” for a chair in the country. One of the founders (as its secretary between 1976–2006 and since then as its chairman) of the Hungarian National Section of the International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR); a political adviser to and a member of the Advisory Board of the first free-elected Prime Minister of Hungary (1991–1994), serving as an editorial board member of Current Legal Theory (1983–1998), Ratio Juris (1988–), Legal Theory (1993–1999), as well as of Világosság [a philosophical forum] (2003–). In 2004, he was elected as an associated member of the International Academy of Comparative Law. His bibliography is available in both http://varga.jak.ppke.hu and Theatrvm legale mvndi Symbola Cs. -

SLR I15 March April 03.Indd
scottishleftreview comment Issue 15 March/April 2003 A journal of the left in Scotland brought about since the formation of the t is one of those questions that the partial-democrats Scottish Parliament in July 1999 Imock, but it has never been more crucial; what is your vote for? Too much of our political culture in Britain Contents (although this is changing in Scotland) still sees a vote Comment ...............................................................2 as a weapon of last resort. Democracy, for the partial- democrat, is about giving legitimacy to what was going Vote for us ..............................................................4 to happen anyway. If what was going to happen anyway becomes just too much for the public to stomach (or if Bill Butler, Linda Fabiani, Donald Gorrie, Tommy Sheridan, they just tire of the incumbents or, on a rare occasion, Robin Harper are actually enthusiastic about an alternative choice) then End of the affair .....................................................8 they can invoke their right of veto and bring in the next lot. Tommy Sheppard, Dorothy Grace Elder And then it is back to business as before. Three million uses for a second vote ..................11 Blair is the partial-democrat par excellence. There are David Miller two ways in which this is easily recognisable. The first, More parties, more choice?.................................14 and by far the most obvious, is the manner in which he Isobel Lindsay views international democracy. In Blair’s world view, the If voting changed anything...................................16 purpose of the United Nations is not to make a reasoned, debated, democratic decision but to give legitimacy to the Robin McAlpine actions of the powerful. -

Sociology - Lithuania Vosyliūtė, Anelė
www.ssoar.info Sociology - Lithuania Vosyliūtė, Anelė Veröffentlichungsversion / Published Version Sammelwerksbeitrag / collection article Zur Verfügung gestellt in Kooperation mit / provided in cooperation with: GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Vosyliūtė, A. (2002). Sociology - Lithuania. In M. Kaase, V. Sparschuh, & A. Wenninger (Eds.), Three social science disciplines in Central and Eastern Europe: handbook on economics, political science and sociology (1989-2001) (pp. 467-483). Berlin: Informationszentrum Sozialwissenschaften. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-281219 Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer CC BY Lizenz (Namensnennung) zur This document is made available under a CC BY Licence Verfügung gestellt. Nähere Auskünfte zu den CC-Lizenzen finden (Attribution). For more Information see: Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de 467 Anelė Vosyliūtė Sociology – Lithuania Discussant: Vladas Gaidys 1. Analysis of the pre-1989 situation Lithuanian sociologists, representatives of a small scientific community, have produced few analyses of the development of their discipline and of the strengths and weaknesses of results in its different branches. A small number of authors have contributed general overviews (Gaidys and Vosyliūtė, 1995; Gaidys, 1996) or have written on some aspects of sociological investigation (Rapoportas, 1997; Valantiejus, 1995; Kraniauskas, 2001). Lithuanian sociology’s pre-war history and its several phases in Soviet times have been described (Vosyliūtė, 1996, 1998, 2000). Sociology in the socialist period During the postwar period in Lithuania, Soviet Communist doctrine rejected the scientific heritage and traditions of social sciences of the inter-war period, which were publicly labeled “bourgeois science”. -

A. A. Prof. PETRAS LEONAS. „Ne Tik Jėgas, Bet Ir Sutaupąs Tėvy Nei"
lams* s O darbas Tėvynei yra palaimintas darbas. Darbo- vertę Įprasmina ir Konstitucija, kad „Valstybę laiko ne*- T R I M I T A S paliaitjamas darbas*'. LIETUVOS ŠAULIŲ IR PATRIOTINĖS VISUOMENĖS Naujoji Konstitucija yra mūsų tautos ir valstybės LAIKRAŠTIS — ŽURNALAS. vyriausias .įstatymas, kuriuo remiasi visi mūsų gyveninio Eina XIX metai, kas savaitė. reiškiniai;'mūsų siekimai, darbai ir žygiai. Todėl Nauja Leidžia ŠAULIŲ SĄJUNGA. jai Konstitucijai įsigaliojus, mes turime įsisąmoninti^ jos Redaktorius JONAS KALNĖNAS. dėsnius, persiimti jos dvasia ir kelti tautoje jos gerbimo- PRENUMERATOS' KAINA Lietuvoje jausmą. Už didį darbą — Konstitucijos paruošimą, mū metams 5 litai, pusei metų 3 litai, mėnesiui 50 centi]. sų Vyriausybei, Seimui turime reikšti padėką, o didžiau Atskiras numeris — 20 et. sias mūsų, -dėkingumas priklauso mūsų Respublikos Pre Užsieniui — metams 10 litų, pusei metų 6 litai. zidentui Antanui Smetonai, kurio nenuilstamo darbo ir SKELBIMŲ KAINOS 60 et. už 1 cm2. Nuolatiniams skelbė kūrybos dėsniais ir jo minčių dvasia Naujoji Konstituci jams daroma nuolaidų. Už skelbimų turinį Redakcija ne ja yra pagrįsta. atsako. šauliai* žiūrėkime, kad teisingumas būtų nepažeidžia RANKRAŠČIUS Redakcija taiso savo nuožiūra. NeSuvartotų mas, o teisėtumą ir įstatymus saugosime, kaip mūsų sau rankraščių Redakcija savo lėšomis negrąžina ir nesaugo. linės pareigos reikalauja. Visi šauliai turi gerai įsiskai Už straipsnius ir nuotraukas atlyginama tik susitarus. tyti ir žinoti pagrindini Valstybės įstatymą.' REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA šiąja proga, reikšdami džiaugsmo del Naujosios Kon Kaunas, Laisvės alėja 20. Telefonas 22663. stitucijos įsigaliojimo, mes, šauliai, minutei susikaupki me del didžiojo mūsų tautos ir valstybės vyro, buv. pir mojo teisingumo ministro, vėliau vidaus reikalų ministro ir ilgamečio šaulių Sąjungos centro valdybas nario prof. -

Vmu Vytautas Magnus University Magnus Vmu Vytautas
VMU VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY MAGNUS VMU VYTAUTAS VMU VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY SITY GNUS UNIVER S MA TA AU VMU VYT VMU VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY VMU VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY budding alchemist* appears at a university, A UNIVERSITY AWhere art and science show you his way To celebrate a blend of diversity, And keep you dreaming awake. Mining for gold, you get something pure: A magic potion of knowledge and passion, So potent, so liberating, so true You feel free to pursue and to ponder... Everyone here is an aspiring mage: Turning their future into a wonder. n the modern context, an alchemist has very little in common with a reclusive scientist who’s working in a shack somewhere and trying to turn lead into gold. Today’s alchemist is a modern man, a philosopher whose Iwork and ideas transcend his own era, and who sees and perceives the world from a much wider perspective. For such a person, even “gold” has a completely different meaning: instead of the pursuit of a noble metal or elixir for eternal physical life, it signifies enlightenment and attainment of useful nuggets of wisdom. Here, gold symbolizes the highest consciousness and an extremely perceptive mind. Where can one find such people today? Indubitably, at the university. Vytautas Magnus University is the magnet which attracts talented individuals from Lithuania and all over the world. Its geographical setting is no less special than its history or mission: Kaunas is the academic and cultural capital of Lithuania. Our location is not only a comfortable vantage point for observation of the world, but also a great launching pad for reaching it. -

The Features of the History of Sociology in Lithuania
‘‘Social Transformations in Contemporary Society’’, 2013 (1) ISSN 2345-0126 (online) THE FEATURES OF THE HISTORY OF SOCIOLOGY IN LITHUANIA Aida Vaicekauskaite Kaunas University of Technology, Lithuania Abstract The purpose – is to reveal the stages of the development of history of Lithuanian sociology and its specific features. Methodology. The article is based on the survey of sources analysing the history of sociology, paying special attention to manifestations of sociology in Lithuania during various periods of time. Findings. Sociology is one of the youngest academic disciplines established as a distinct field of study in Europe only in the 19th century. Three main fields of investigation can be distinguished in the history of Lithuanian sociology: the pre-war period, the soviet period and the post-soviet period. Each period is characterised by its peculiar opportunities for sociologists’ professional expression, challenges and achievements; as well as different topics and directions for sociological research. After the review of sources dealing with the history of sociology, it must be noted that there are three main stages of the development of sociology: (1) the period of 1960- 1970, characterised by work study; (2) since the 1970s the main attention has been paid to social planning; (3) the period starting from 1989 is distinguished for the beginning of public opinion poll. Research limitations/implications. This brief review of the history of sociology in Lithuania is rather fragmentary; a thorough analysis needs more time and more comprehensive studies. Practical implications. The importance of the study shows in the fact that the research of the history of Lithuanian sociology can be helpful in analysing the issues of sociological professionalism and identity. -

Population Displacement in Lithuania in the Twentieth Century
Population Displacement in Lithuania in the Twentieth Century Experiences, Identities and Legacies Edited by Tomas Balkelis Violeta Davoliūtė LEIDEN | BOSTON For use by the Author only | © 2016 Koninklijke Brill NV <UN> Contents Preface vii Acknowledgements X List of Tables xi Notes on Contributors xii Introduction 1 Part 1 Population Displacement during World War One and Its Aftermath 1 Making the Nation: Refugees, Indigent People, and Lithuanian Relief, 1914–1920 21 Andrea Griffante 2 Forging a “Moral Community”: The Great War and Lithuanian Refugees in Russia 42 Tomas Balkelis 3 Displacement without Moving: Secession, Border Changes and Practices of Population Politics in Lithuania, 1916–1923 62 Klaus Richter Part 2 Population Displacement in the Klaipėda Region 4 Population of the Klaipėda Region and the Balance of Power in the Eastern Baltic Region, 1919–1960 91 Vasilijus Safronovas 5 Population Shifts and Displacement in the Memel Region 112 Ruth Leiserowitz For use by the Author only | © 2016 Koninklijke Brill NV <UN> vi Contents Part 3 Population Displacement during World War Two and Its Aftermath 6 Repopulating Vilnius, 1939–1949 135 Theodore R. Weeks 7 Between Poland and Lithuania: Repatriation of Poles from Lithuania, 1944–1947 160 Vitalija Stravinskienė 8 A “Forgotten” History of Soviet Deportation: The Case of Lithuanian Jews 179 Violeta Davoliūtė 9 Religious Life in a Displaced Society: The Case of Post-war Lithuania, 1945–1960 211 Arūnas Streikus 10 Lithuanian Diaspora: From Displaced Persons to Diaspora Politics 236 Daiva Dapkutė Index 259 For use by the Author only | © 2016 Koninklijke Brill NV chapter 2 Forging a “Moral Community”: The Great War and Lithuanian Refugees in Russia Tomas Balkelis Introduction By the end of the Great War, Russia’s disastrous military performance, eco- nomic collapse and growing unrest on the “home front” brought the transfor- mation of the empire into a number of shatterzones where various nationalist and revolutionary forces asserted themselves with unseen vigour. -

Adobe Photoshop
Fondazione “Venezia per la ricerca sulla pace” Quaderno – 5 Fondazione “Venezia per la ricerca sulla pace” CONSIGLIO SCIENTIFICO Membri emeriti RICHARD N. LEBOW, King’s College Londra RAIMON PANIKKAR, maestro di dialogo per la pace (†) Membri UMBERTO ALLEGRETTI, Università di Firenze LORENZA CARLASSARE, Università di Padova GIAN ANTONIO DANIELI, Istituto Veneto di SS.LL.AA. IGNAZIO MUSU, Università Ca’ Foscari di Venezia MASSIMO RAVERI, Università Ca’ Foscari di Venezia DIREZIONE EDITORIALE MARIA LAURA PICCHIO FORLATI, s.c. Istituto Veneto di SS.LL.AA. MASSIMO RAVERI, Università Ca’ Foscari di Venezia REDAZIONE SIMONA PINTON, Università Ca’ Foscari di Venezia L’Europa a cent’anni dalla prima guerra mondiale storia, politica, diritto a cura di Rolf Petri e Maria Laura Picchio Forlati G. Giappichelli Editore © Copyright 2020 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100 http://www.giappichelli.it ISBN/EAN 978-88-921-3429-4 ISBN/EAN 978-88-921-8842-6 (ebook - pdf) La pubblicazione è stata oggetto di doppia blind peer review, secondo il procedi- mento concordato per la Collana con l’Editore, che conserva la relativa documen- tazione. Stampa: LegoDigit s.r.l. - Lavis (TN) Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/ fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail [email protected] e sito web www.clearedi.org. -

Seimas Pritarė Lietuvos Dalyvavimui JT Daliniuose
£11J P 4 GRfiTIS 2-tL THE. L1B RAKY OF ŪUNGRtSS KtrtkLNCL DLJ'ftRiKLNi SERIALS DIVlSluN KASHINGKiN L>C 20025 IŠEIVIJOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 TELEFONAS (312) 585-9500 2ND CLASS MAIL TELEFAKSAS (312) 585-8284 July 14, 1994 THE LITHUANIAN VVORLD-VVIDE DAILY Vol. LXXXV Kaina 35 c. KETVIRTADIENIS - THURSDAtf, LIEPA - JULY 14, 1994 Nr. 135 Seimas pritarė Rusų kariai gavo butus Lietuvos dalyvavimui Karaliaučiuje Vilnius, liepos 8 d. (AGEP) - konkrečiais darbais". Rusija pri JT daliniuose Įvažiavus į Karaliaučiaus kraš versta kol kas laikyti savo ka tą liepos 5 d. rytą, gausūs milici riuomenę Karaliaučiuje, jis sakė. Baltijos laivynas — tai Vilnius, liepos 1 d. (LR) — skubinama, retoriškai klausė: jos postai liudijo, kad vyksta karinė flotilė, su kuria susijusi „Lietuvos kariuomenės padali „Gal mūsų kariai žūti nenori?" neeiliniai įvykiai. Karaliau Rusijos istorija. Laivynas, niai gali dalyvauti tarptau Kolegą palaikė LDDP frakci čius laukė aukštų svečių iš įkurtas caro Petro I, negali būti tinėse operacijose tik vykdy jos atstovas Mindaugas Stakvi Maskvos ir Vilniaus. I krašto diskriminuojamas. Tarnaujan dami Lietuvos Respublikos levičius, kuris domėjosi, „ko sostinę atvyko Rusijos Federaci čių kariškių kiekis šiuo metu tarptautinius įsipareigojimus", kiuose karstuose grįš Lietuvos jos susirinkimo (Rusijos parla minimalus, pažymėjo Šumeika. teigiama pirmajame įstatymo žmonės, ir ar jiems jau padaryti mento aukštesniųjų rūmų) pir „Dėl Lietuvos kariuomenės da užsakymai". mininkas V. Šumeika ir Lietu Kalbą pasakė ir Lietuvos Sei lyvavimo tarptautinėse operaci vos Seimo pirmininkas Česlovas mo pirmininkas Česlovas Jur jose" projekto straipsnyje. Taikos palaikymo misijos Juršėnas. Svečiai buvo pakvies šėnas Pasidžiaugęs Šeimos atliktu darbu, visiems palinkėjo Kaip rašo „Lietuvos rytas", šį palyginti nepavojingos ti į iškilmes Šeimos įmonės pa laimės.