Le Cavità Ipogee Della Valle Camonica: Aggiornamento Delle Conoscenze
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
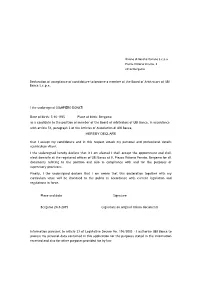
Declaration of Acceptance of Candidature to Become a Member of the Board of Arbitrators of UBI Banca S.C.P.A
Unione di Banche Italiane S.c.p.a Piazza Vittorio Veneto, 8 24122 Bergamo Declaration of acceptance of candidature to become a member of the Board of Arbitrators of UBI Banca S.c.p.a. I the undersigned GIAMPIERO DONATI Date of birth: 5-10-1935 Place of birth: Bergamo as a candidate to the position of member of the Board of Arbitrators of UBI Banca, in accordance with article 51, paragraph 3 of the Articles of Association di UBI Banca, HEREBY DECLARE that I accept my candidature and in this respect attach my personal and professional details (curriculum vltae). I the undersigned hereby declare that if I am elected I shall accept the appointment and shall elect domicile at the registered offices of UBI Banca at 8, Piazza Vittorio Veneto, Bergamo for all documents relating to the position and also in compliance with and for the purposes of supervisory provisions. Finally, I the undersigned declare that I am aware that this declaration together with my curriculum vitae will be disclosed to the public in accordance with current legislation and regulations in force. Place and date Signature Bergamo 24-3-2015 (signature on original Italian document) Information pursuant to article 23 of Legislative Decree No. 196/2003 - I authorise UBI Banca to process my personal data contained in this application for the purposes stated in the information received and also for other purposes provided for by law. CURRICULUM VITAE AVV. GIAMPIERO DONATI Admitted to the Milan bar Association in 1962, I still practice as a lawyer today. I became a member of the Board of Arbitrators of Banca Popolare di Bergamo in 1978 and subsequently Chairman of that board and then Chairman of the Board of Arbitrators of BPU Banca and then of UBI Banca. -

Comune Di Darfo Boario Terme
REGIONE LOMBARDIA (D.G.R. n° XI/4177 del 30 dicembre 2020) Comune di Darfo Boario Terme – Provincia di Brescia Capofila dell’Ambito Territoriale di Valle Camonica, comprendente i Comuni di: Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Losine, Lozio, Malegno, Malonno, Monno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paisco Loveno, Paspardo, Pian Camuno, Piancogno, Pisogne, Ponte di Legno, Saviore dell'Adamello, Sellero, Sonico, Temù, Vezza d'Oglio, Vione AVVISO PUBBLICO per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell’Ambito Territoriale di Valle Camonica - PIANO 2021 Localizzate nei Comuni di: BERZO INFERIORE, BIENNO, BRENO, CAPO DI PONTE, CEDEGOLO, CETO, DARFO BOARIO TERME, EDOLO, ESINE, PIAN CAMUNO, PIANCOGNO, TEMÙ Di proprietà dei Comuni di: BERZO INFERIORE, BRENO, CAPO DI PONTE, EDOLO, PIANCOGNO, TEMÙ, nonché dell’ALER di Brescia-Cremona-Mantova PERIODO APERTURA E CHIUSURA DELL’AVVISO dalle ore 9:00 del 7 maggio 2021 alle ore 16:00 del 30 giugno 2021 1. INDIZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO 1.1. Ai sensi della D.G.R. del 30 dicembre 2020 n° XI/4177 è indetto l’avviso pubblico per l’assegnazione delle unità abitative disponibili destinate ai servizi abitativi pubblici. 1.2. Le unità abitative di cui al presente avviso pubblico si distinguono in: a) Numero 28 unità abitative immediatamente assegnabili; b) Numero 0 unità abitative che si rendono assegnabili nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente avviso e la scadenza del termine per la presentazione delle domande di assegnazione; c) Numero 0 unità abitative nello stato di fatto non immediatamente assegnabili per carenze di manutenzione, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento regionale n. -

Bresciaeprovincia
I S T I T U Z I O N I S C O L A S T I C H E S T A T A L I - B R E S C I A E P R O V I N C I A - A.S. 2019 2020 COMUNE INDIRIZZO COD. MECCAN. TELEFONO-FAX-EMAIL PLESSI - CODICI INDIRIZZI D.S.G.A. DIRIGENTE SCOL. ISTITUTO COMPRENSIVO 0307356669 Sc. Infanzia Adro Bosio Elida Poli Giampietro 0307356653 Sc. Primaria Adro (Ass. Amm.) 1 ADRO Via Nigoline, 16 Sc. Sec. 1° Adro 25030 Adro BSIC835008 [email protected] ISTITUTO COMPRENSIVO 0364591528 Sc. Infanzia Beata Polimeni Valeria Marafante Simonettta 0364599060 Sc. Primaria Artogne-Piancamuno-Beata-Vissone (3 fascia) 2 ARTOGNE Via C. Golgi, 1 Sc. Sec. 1° Artogne 25040 Artogne BSIC80800X [email protected] ISTITUTO COMPRENSIVO 0309747012 Sc. Infanzia Capriano d/C Caprio Gina Festa Federica 0309748870 Sc. Primaria Azzano M.-Capriano d/C-Fenili B.-Mairano 3 AZZANO MELLA Via Paolo VI, 1 Sc. Sec. 1° Azzano 25020 Azzano Mella BSIC89000R [email protected] ISTITUTO COMPRENSIVO 0306821272 Sc. Infanzia Zona Est-Zona Ovest Speranza Eleonora Scaglia Rita Sc. Primaria Via 26 aprile-Via Bellavere (Ass. Amm.) 4 BAGNOLO MELLA Viale Europa, 15 Sc. Sec. 1° Bagnolo M. 25021 Bagnolo Mella BSIC844003 [email protected] ISTITUTO COMPRENSIVO 036599190 - 0365903868 Sc. Infanzia Idro-Anfo-Treviso B. Vaglia Daria Mattina Aristo Pietro Andus 036599121 Sc. Primaria Bagolino-Ponte Caffaro-Idro-Capovalle-Treviso B. (Ass. Amm.) (Reggente) 5 BAGOLINO Via Lombardi, 18 Sc. Sec. 1° Bagolino-Ponte Caffaro-Idro 25072 Bagolino BSIC806008 [email protected] ISTITUTO COMPRENSIVO 030674036 Sc. -

Un Tesoro Sepolto – Le Antiche Miniere Dell'alta Val Grigna.Pdf 5253.26Kb
L’AREA VASTA VALGRIGNA 6 | I quaderni di Valgrigna Il comprensorio definito “Area Vasta Valgrigna” si estende per circa 20.000 ettari, a cavallo tra la bassa Valle Camonica e l’alta Valle Trompia ed è caratterizzato da morfologie di media montagna e da un patrimonio culturale, storico ed etnografico unico, attestato da importanti testimonianze del passato legate allo sfruttamento delle miniere, dei boschi e dei pascoli. Si tratta di un’area montana tra le più preservate dell’intera Regione Lombar- dia, al centro della quale si colloca la proprietà regionale denominata “Foresta di Lombardia Valgri- gna”, della superficie di 2.847 ettari, ricadente nei comuni di Bienno, Berzo Inferiore, Bovegno, Esine e Gianico e gestita da ERSAF, l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste. In considerazione delle notevoli potenzialità di questo territorio sotto il profilo dello sviluppo eco-compatibile, ERSAF, in attuazione degli im- pegni della Carta delle Foreste di Lombardia, ha ritenuto di promuovere un intervento innovativo di valorizzazione integrata, non solo dell’area della foresta regionale, ma anche del territorio montano circostante, riguardante i comuni sopracitati non- ché quelli limitrofi di Collio, Artogne e Prestine. Unt esoro Per saperne di più: sepolto Le antiche miniere dell’alta Val Grigna 25043 BRENO (Brescia) - Piazza Tassara, 3 Telefono 0364.322341 - Fax 0364.322359 www.montagnedivalgrigna.it Percorso archeo-minerario e siti di ricerca dell’alta Val Grigna Coordinamento editoriale Biagio Piccardi Andrea Richini Val -

Docs Printing
SENATO DELLA REPUBBLICA Pico, Bubbio, Fantoni, Lepore, Lodato, Ma• I COMMISSIONE stino, Merlin Umberto, Minio, Mole Salvatore, (Affari della Presidenza del Consiglio Raffeiner, Riccio, Rizzo e Sacco. e dell'interno) Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa del senatore Cemmi: « Ricostitu• RIUNIONE DEL 9 FEBBRAIO 1949 zione dei comuni di Braone, Losine e Niardo (Brescia) » (N. 233). (8a in sede deliberante) PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa Presidenza del Presidente MERLIN UMBERTO del senatore Cemmi: « Ricostituzione dei co• rnai ni di Braone, Losine e Niardo (Brescia) >\ INDICE Dichiaro aperta la discussione generale. Ha iacoltà di parlare il relatore, senatore Disegni di legge : Bubbio. (Discussione e approvazione) BUBBIO, relatore. Non credo sia più il « Ricostituzione dei comuni di Braone, Lo- caso di esaminare in via pregiudiziale se, di sine e Niardo (Brescia) » (N. 238): Ironte all'articolo 133 della Costituzione, che PRESIDENTE Par/. 29, 3] addimanda alle Regioni la costituzione di BUBBTO, relatore 29, 31 nuovi comuni, si possa provvedere sia in base RICCIO 31 all'iniziativa parlamentare sia con provvedi• FANTONI 31 mento governativo alla ricostituzione dei co• (Discussione) muni soppressi, dappoiché anche la nostra « Aumento delle indennità agli appartenenti Commissione, in seduta 2 febbraio u. s., ap• al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza per provando il disegno di legge del deputato Lu- piantonamento in luoghi di cura dei dete• nuti provenienti dagli stabilimenti carcerari » cifredi per la ricostruzione del comune di (N. 202) (Approvato dalla Camera dei deputati): Armo (Imperia), ha fatto suo l'ordine del PRESIDENTE 32, 33 giorno votato a questo riguardo dalla Com• BARACCO, relatore 32, 33 missione dell'interno della Camera dei de• Rizzo 33 putati. -

Allegati Informativa
Comune di Niardo Provincia di Brescia P.zzale Donatori di Sangue, 1 - 25050 (BS) Tel 0364/330123 Fax 0364/330254 Codice fiscale 81002370179 - P.I. 00723580981 Mail: [email protected] Pec: [email protected] SERVIZIO SCUOLABUS Anno Scolastico 2021/2022 INFORMATIVA E NORME REGOLAMENTARI PER L’UTILIZZO La presente informativa si rivolge ai genitori dei fruitori del servizio scuolabus, residenti e non, affinché gli stessi abbiano un quadro preciso di come il servizio si svolge. Requisito essenziale per l’ammissione all’utilizzo del servizio di trasporto scolastico è la regolare iscrizione, da inoltrare al competente ufficio in forma scritta su apposito modulo che si allega alla presente, da presentare al Comune entro e non oltre venerdì 16 luglio 2021. Si precisa che iscrizioni pervenute in data successiva saranno accolte solo previa verifica dell’effettiva disponibilità di posto a sedere sul mezzo adibito al trasporto. Per la SCUOLA DELL’INFANZIA: il servizio si articola su due corse: quella del mattino, con arrivo presso la scuola entro le nove, e quella del pomeriggio, con partenza dalla scuola alle ore 15.45, mediante l’utilizzo di un minibus riservato evitando così la compresenza di ragazzi molto più grandi e con la presenza di un accompagnatore che aiuterà i bambini nella fase di salita e discesa dal mezzo. Sono previste fermate sul solo territorio del Comune di Niardo. Per le SCUOLE PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO: Per quanto riguarda la sola andata il servizio prevede due corse: con la prima corsa lo scuolabus raccoglierà i ragazzi lungo il tragitto Braone-Ceto-Cerveno-Losine- frazione Crist fino alla fermata utilizzata dalle Ferrovie Nord Milano (compresa) in località Gera in una prima corsa (in questo modo i ragazzi arriveranno presso la scuola media attorno alle ore 07.40, mentre gli alunni della scuola primaria resteranno sullo scuolabus). -

S En a T O D E L L a R E P U B B L I
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 464 D I S E G N O D I L E G G E d’iniziativa del senatore GERMANÀ COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 1996 Istituzione della provincia di Vallecamonica TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700) Atti parlamentari–2– Senato della Repubblica – 464 XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ONOREVOLI SENATORI. – Nel corso della XII ci e guerreschi a cui prese parte per il valo- legislatura veniva presentato dal senatore re e la fermezza del suo popolo. Luciano Garatti il disegno di legge per la È la valle più estesa d’Italia e nella sua «istituzione della provincia di Vallecamoni- lunghezza di circa 85 chilometri è solcata ca», disegno di legge recante il n. 922 e co- dal fiume Oglio che la divide in due metà e, municato alla Presidenza del Senato in data comprendendo la Val di Scalve, è circoscrit- 29 settembre 1994. Nel frattempo alcune ta dalle montagne che discendono dal Passo amministrazioni comunali interessate per la del Tonale (a 1883 metri di altitudine) fino nuova istituzione provinciale hanno adotta- al lago d’Iseo. Suoi confini naturali sono il to deliberazioni favorevoli all’iniziativa ed Trentino, la Valtellina, la Valtrompia, la esattamente trattasi delle amministrazioni Valcavallina ed il lago d’Iseo. dei comuni di: Artogne, Berzo Inferiore, La nuova provincia, ricavata dall’area del- Berzo Demo, Breno, Corteno Golgi, Darfo le tre comunità montane: Vallecamonica, Boario Terme, Lozio, Pian Camuno, Rogno, Alto Sebino e Valle di Scalve; per la vastis- Vione. -

Rankings Municipality of Berzo Inferiore
10/2/2021 Maps, analysis and statistics about the resident population Demographic balance, population and familiy trends, age classes and average age, civil status and foreigners Skip Navigation Links ITALIA / Lombardia / Province of Brescia / Berzo Inferiore Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH ITALIA Municipalities Powered by Page 2 Acquafredda Stroll up beside >> L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Esine AdminstatAdro logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Fiesse Agnosine ITALIA Flero Alfianello Gambara Anfo Gardone Riviera Angolo Terme Gardone Val Artogne Trompia Azzano Mella Gargnano Bagnolo Mella Gavardo Bagolino Ghedi Barbariga Gianico Barghe Gottolengo Bassano Gussago Bresciano Idro Bedizzole Incudine Berlingo Irma Berzo Demo Iseo Berzo Inferiore Isorella Bienno Lavenone Bione Leno Borgo San Giacomo Limone sul Garda Borgosatollo Lodrino Borno Lograto Botticino Lonato del Bovegno Garda Bovezzo Longhena Brandico Losine Braone Lozio Breno Lumezzane Brescia Maclodio Brione Magasa Caino Mairano Calcinato Malegno Calvagese della Malonno Riviera Manerba del Calvisano Garda Powered by Page 3 Capo di Ponte Manerbio L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Capovalle Marcheno Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Capriano del MarmentinoITALIA Colle Marone Capriolo Mazzano Carpenedolo Milzano Castegnato Moniga del Castel Mella Garda Castelcovati Monno Castenedolo Monte Isola Casto Monticelli Brusati Castrezzato Montichiari Cazzago San -

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO Legge Regionale 12/2005
COMUNE DI ESINE Provincia di Brescia PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO Legge Regionale 12/2005 PIANO DEI SERVIZI RELAZIONE (Marzo 2010) Testo modificato ed integrato a seguito dell’accoglimento delle osservazioni e del parere della Provincia di Brescia (Agosto 2010) STUDIO AMBIENTE Dott. Arch. GIACOMINO AMADEO Via San Carlo Borromeo, 1 20031 CESANO MADERNO (MB) Tel. +39 03621794210 Fax +39 03621794211 [email protected] Progetto Dott. Arch. GIACOMINO AMADEO Gruppo di lavoro Dott. Arch. PAOLA DONATI Dott. Urb. PAOLO GARIBOLDI Dott. Arch. VALENTINA MONTEMURRI e per gli aspetti socioeconomici Dott.ssa DANIELA DALLE FUSINE per gli aspetti naturalistici Dott. ATTILIO SELVA per gli aspetti ambientali Dott.ssa MARTA RONCHI ESINE-REL-PS-DEF-03-10 Pagina 2 di 66 Indice 1. Introduzione PARTE I Il quadro conoscitivo 2. - Catalogazione dei servizi per tipologie 2.1 - La domanda di servizi - Coordinate demografiche - Istruzione - Sanità 2.2 - L’offerta di servizi - Il sistema educativo - Sanità ed area della salute - Servizi alla persona, alla famiglia e di solidarietà sociale - Cultura, solidarietà, sport ed associazionismo - Altri servizi 2.3 - Localizzazione e accessibilità 2.4 - Diagnosi dello stato dei servizi offerti in rapporto alla domanda PARTE II Obiettivi e strategie di intervento 3. - Opportunità, criticità e linee di azione 3.1 - Strategie di attuazione 3.2 - Soggetti attuatori e gestori 3.3 - Parametri qualitativi delle attrezzature e dei servizi PARTE III Azioni e progetti 4. - L’assetto del Piano dei Servizi 4.1 - Identificazione e verifica degli standard urbanistici 5. - Programma di intervento 5.1 - Priorità di intervento 5.2 - Acquisizione delle aree 5.3 - Costi di intervento 5.4 - Programma triennale delle opere Pubbliche 5.5 - Verifica di sostenibilità economico - finanziaria 6. -

Allegati Catasto Sentieri
CATASTO SENTIERI DI VALLE CAMONICA NUOVA VECCHIA NUMERAZIONE NUMERAZIONE NOME SENTIERO COMUNI LUNGHEZZA 100 100 Borno-Avendrino-Malga Zumella-Rifugio San Fermo Borno 4614,53 101 101 Croce di Salven-Pendrizza-Malga Zumella Borno 3839,19 102 2 Alta Via Camuna Vezza d'Oglio 41687,38 Ponte di Legno Valfurva 103 103 Lova Chalet-Colle Mignone-Monte Mignone-Agol-Averta-Colle Mignone Borno 6652,42 Ossimo 104 3 Villa Dalegno-Val Canè-Premia-Borom-Val Grande-Val Bighera-Malga Salina Incudine 19016,28 Vezza d'Oglio Vione Temù 105 5 Ogne-Triangolo-Dosso di Corvino-Restei-Pozze Val Sorda Piancogno 4667,89 Borno Borno-Lova-Rifugio San Fermo-sentiero alto-Rifugio Laeng-Bivacco Corini-Passo 106 6 di Baione-Rifugio Iseo-Parzaniga-Pescarzo Borno 30189,92 Ossimo Lozio Cerveno Ono San Pietro Capo di Ponte 107 7 Sentiero 4 Luglio Corteno Golgi 32247,00 Paisco Loveno Malonno Paisco Loveno Malonno Edolo 108 2a Sentiero del Pastore-Sentiero dell'Asino Vezza d'Oglio 14431,86 109 A (nuovo) Navertino-Socol-Diga Lova-Chalet Lova Borno 3025,49 110 B (nuovo) Colle Mignone-Pozza-Torana-Monte Arano Borno 1753,62 111 111 Passo Tonale-Malga Valbiolo-Passo Contrabbandieri-Rifugio Bozzi-Montozzo- Ponte di Legno 2156,04 Vermiglio Vermiglio 112 2 Borno-Corna Rossa-Pizzoli-Balestrini Borno 3998,52 Piancogno 113 3 Borno-Corna Rossa-Plai-Malga-Pian d'Aprile-Monte Altissimo Borno 5097,85 Piancogno Darfo Boario Terme Angolo Terme 114 4 Dosso di Plai-Pradazzo-Malga Guccione Piancogno 1702,10 115 115 San Zenone-Piana Paghera-Centrale Paisco-Vasca Enel-Carbonil Capo di Ponte 15824,07 -

ATS DISTRETTO CODICE AZIENDA COMUNE DISTANZA 007BS079 Focolaio 007BS079 Artogne Termine Restrizioni Per Territorio Con Circolazi
focolaio 007BS079 Artogne termine restrizioni per territorio con circolazione virale in atto: 12 febbraio 2017 ATS DISTRETTO CODICE AZIENDA COMUNE DISTANZA_007BS079 ATS MONTAGNA Valcamonica 007BS075 ARTOGNE 81,94 ATS MONTAGNA Valcamonica 007BS150 ARTOGNE 115,8 ATS MONTAGNA Valcamonica 007BS065 ARTOGNE 560,53 ATS MONTAGNA Valcamonica 007BS155 ARTOGNE 565,8 ATS MONTAGNA Valcamonica 007BS027 ARTOGNE 671,05 ATS MONTAGNA Valcamonica 007BS137 ARTOGNE 671,8 ATS MONTAGNA Valcamonica 007BS028 ARTOGNE 698,65 ATS MONTAGNA Valcamonica 007BS151 ARTOGNE 703,68 ATS MONTAGNA Valcamonica 007BS146 ARTOGNE 717,75 ATS MONTAGNA Valcamonica 007BS090 ARTOGNE 744,64 ATS MONTAGNA Valcamonica 007BS216 ARTOGNE 809,6 ATS MONTAGNA Valcamonica 007BS149 ARTOGNE 818,85 ATS MONTAGNA Valcamonica 007BS154 ARTOGNE 859,98 ATS MONTAGNA Valcamonica 007BS225 ARTOGNE 861,16 ATS MONTAGNA Valcamonica 007BS086 ARTOGNE 881,11 ATS MONTAGNA Valcamonica 007BS062 ARTOGNE 981,41 ATS MONTAGNA Valcamonica 007BS194 ARTOGNE 986,02 ATS MONTAGNA Valcamonica 007BS223 ARTOGNE 999,21 ATS MONTAGNA Valcamonica 007BS171 ARTOGNE 1008,87 ATS MONTAGNA Valcamonica 007BS025 ARTOGNE 1014,65 ATS MONTAGNA Valcamonica 007BS125 ARTOGNE 1028,16 ATS MONTAGNA Valcamonica 007BS193 ARTOGNE 1067,05 ATS MONTAGNA Valcamonica 007BS033 ARTOGNE 1081,93 ATS MONTAGNA Valcamonica 007BS060 ARTOGNE 1082,53 ATS MONTAGNA Valcamonica 007BS206 ARTOGNE 1107,13 ATS MONTAGNA Valcamonica 007BS093 ARTOGNE 1119,39 ATS MONTAGNA Valcamonica 007BS024 ARTOGNE 1187,07 ATS MONTAGNA Valcamonica 007BS195 ARTOGNE 1188,65 ATS MONTAGNA Valcamonica -

COMUNE CONTAGIATI Acquafredda 17 Adro 34 Agnosine 14 Alfianello
COMUNE CONTAGIATI Acquafredda 17 Adro 34 Agnosine 14 Alfianello 28 Anfo 30 Angolo Terme 12 Artogne 23 Azzano Mella 18 Bagnolo Mella 117 Bagolino 12 Barbariga 30 Barghe 4 Bassano Bresciano 17 Bedizzole 46 Berlingo 16 Berzo Demo 12 Berzo Inferiore 13 Bienno 29 Bione 8 Borgo San Giacomo 79 Borgosatollo 94 Borno 27 Botticino 59 Bovegno 5 Bovezzo 44 Brandico 9 Braone 5 Breno 42 Brescia 1183 Brione 4 Caino 6 Calcinato 61 Calvagese della Riviera 7 Calvisano 44 Capo di Ponte 15 Capovalle 1 Capriano del Colle 28 Capriolo 75 Carpenedolo 94 Castegnato 59 Castelcovati 31 Castel Mella 68 Castenedolo 65 Casto 16 Castrezzato 38 Cazzago San Martino 68 Cedegolo 7 Cellatica 27 Cerveno 5 Ceto 17 Cevo 13 Chiari 136 Cigole 23 Cimbergo 2 Cividate Camuno 15 Coccaglio 64 Collebeato 26 Collio 2 Cologne 40 Comezzano-Cizzago 21 Concesio 104 Corte Franca 36 Corteno Golgi 11 Corzano 20 Darfo Boario Terme 102 Dello 42 Desenzano del Garda 114 Edolo 32 Erbusco 51 Esine 47 Fiesse 8 Flero 37 Gambara 23 Gardone Riviera 17 Gardone Val Trompia 59 Gargnano 7 Gavardo 81 Ghedi 102 Gianico 22 Gottolengo 39 Gussago 119 Idro 8 Incudine 1 Irma Iseo 69 Isorella 29 Lavenone 1 Leno 99 Limone sul Garda Lodrino 10 Lograto 27 Lonato del Garda 77 Longhena 8 Losine 2 Lozio 2 Lumezzane 79 Maclodio 7 Magasa Mairano 15 Malegno 20 Malonno 21 Manerba del Garda 17 Manerbio 136 Marcheno 14 Marmentino 2 Marone 11 Mazzano 45 Milzano 8 Moniga del Garda 15 Monno 1 Monte Isola 10 Monticelli Brusati 27 Montichiari 170 Montirone 53 Mura 4 Muscoline 8 Nave 58 Niardo 10 Nuvolento 7 Nuvolera 15 Odolo 3