Rel Generale Dissesti 1997
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
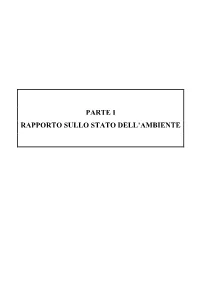
PARTE I RSA Riva Fonteno
PARTE I RAPPORTO SULLO STATO DELL’AMBIENTE Parte 1 RAPPORTO SULLO STATO DELL’AMBIENTE PARTE I – RAPPORTO SULLO STATO DELL’AMBIENTE Il modello di riferimento proposto per la redazione del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente è lo schema DPSIR (Driving Forces, Pressures, States, Impacts, Responses). Tale schema, sviluppato in ambito EEA ed adottato dall’ANPA per lo sviluppo del sistema conoscitivo e dei controlli in campo ambientale, si basa su una struttura di relazioni causali che legano tra loro i seguenti elementi: • Determinanti (settori economici, attività umane). • Pressioni (emissioni, rifiuti). • Stato (qualità fisiche, chimiche, biologiche). • Impatti (su ecosistemi, salute, funzioni, fruizioni, ecc.). • Risposte (politiche ambientali e settoriali, iniziative legislative, azioni di pianificazione, ecc.). Schema DPSIR (Fonte: Linee guida per la valutazione ambientale strategica per i fondi strutturali, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) Lo schema DPSIR, pur mantenendo la necessaria semplicità, comprende le retroazioni degli interventi di risposta e lega gli elementi in un rapporto che ben rappresenta la circolarità delle interazioni tra fenomeni tipica degli ecosistemi. Gli indicatori che definiscono lo stato dell’ambiente descrivono quantitativamente e qualitativamente la condizione degli elementi di definizione del sistema territoriale considerato (es. aria, acqua, suolo, ecc.) per poi arrivare a comprendere gli impatti sull’ecosistema. Gli indicatori di pressione descrivono tutti gli elementi immessi -

Comune Di Tavernola Bergamasca
COMUNE DI CHIUDUNO PROVINCIA DI BERGAMO SETTORE TECNICO – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ESITO DI GARA PROCEDURA NEGOZIATA INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO INFORMA che con determinazione a contrattare del Settore Tecnico numero 62 in data 14.07.2010, è stata indetta la procedura negoziata per l’affidamento d’incarico professionale per la redazione del Piano Regolatore dell’Illuminazione Pubblica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2, e 57, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con invito a non meno di 5 (cinque) operatori economici qualificati; che il criterio per l’aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006; che è stata predisposta apposita lettera di invito alla procedura negoziata, prot. 6115 in data 14.07.2010; che la predetta lettera di invito è stata inviata ai seguenti operatori economici: n. invitato sede Via Solferino,3/a 1 Ecogestioni srl 25122 Brescia Via dell’Indusria,14 2 Energeco 25030 Erbusco - Bs Via C. Battisti,18 3 Tecno Plus srl 24060 Rogno - Bg M.A. Group Via M.F. Bibaculo 2/b 4 26100 Cremona Via XXV Aprile,18 5 Cogeme spa 25038 Rovato – Bs Via A.Moro, n.1 6 Consulenze Ambientali spa 24020 Scanzorosciate – Bg che entro il termine perentorio risultano pervenuti a questa stazione appaltante numero 4 (quattro) plichi per l'offerta, presentati dai seguenti offerenti: n. offerente giorno prot. 1 Consulenze Ambientali spa 09.08.2010 6749 Largo Europa, 3 24060 Chiuduno (Bg) Tel. -

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI Riconoscendo Un Contributo Regionale Massimo Complessi- D.G.R
Bollettino Ufficiale – 3 – Serie Ordinaria n. 52 - Lunedì 21 dicembre 2020 sercizio 2020, a valere sul capitolo di spesa 18.01.203.8443, C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI riconoscendo un contributo regionale massimo complessi- D.g.r. 14 dicembre 2020 - n. XI/3977 vo di euro 600.000,00 per ogni Comune che prende parte Accordo quadro di sviluppo territoriale per il rilancio, la all’Accordo; riqualificazione, la valorizzazione e la promozione dell’area Richiamate altresì: del Sebino. Modifica e integrazione alla d.g.r. n. 211 dell’11 giugno 2018, alla d.g.r n. 1598 del 7 maggio 2019 e alla d.g.r. • la d.g.r. n. 211 del 11 giugno 2018 con la quale è stato ap- n. 2580 del 2 dicembre 2019 provato lo schema di AQST per il rilancio, la riqualificazione, la valorizzazione e la promozione dell’area del Sebino, sot- LA GIUNTA REGIONALE toscritto digitalmente da parte di tutti i soggetti interessati e Richiamati: pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 31 del 3 agosto 2018; • la legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare l’art. • la d.g.r. n. 1598 del 7 maggio 2019 con la quale è stata 3 che disciplina l’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale modificata e integrata la citata d.g.r. n. 211 dell’11 giugno (di seguito denominato AQST), strumento di programma- 2018, modificando l’AQST per il rilancio, la riqualificazione, zione negoziata regionale; la valorizzazione e la promozione dell’area del Sebino, se- condo le decisioni assunte nel Comitato di Coordinamento • il regolamento regionale 12 agosto 2003 n. -

Comune Di Tavernola Bergamasca
Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Piano di emergenza Comune di Tavernola Bergamasca Inquadramento Territoriale Il Comune di Tavernola Bergamansca è ubicato in provincia di Bergamo, nel Basso Sebino e Monte Bronzone, al confine con Iseo (BS), Monte Isola (BS), Parzanica, Predore, Vigolo. Il territorio comunale comprende oltre al capoluogo le frazioni di: Bianica, Cambianica, Gallinarga. Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Piano di emergenza Tavernola B.sca 1 Aggiornamento: marzo 2016 Ing. Mario Stevanin Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Piano di emergenza INQUADRAMENTO DEL COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA Provincia Bergamo CAP 24060 Capoluogo Tavernola Bergamasca Superficie territoriale 11,17 km2 Latitudine 45°43'00''N Longitudine 10°03'00''E Altitudine 191 m s.l.m. disabili/ non Località n. abitanti 0-14 15-64 65 e più autosuff. Tavernola Bergamasca 2119 262 1378 479 RIFERIMENTI UFFICI COMUNALI Tel. 035/931004- Comune di Tavernola Indirizzo – via Fax 035/932611- Bergamasca Roma, 44 PEC [email protected] bergamasca.bg.it Il Comune rientra nel COM 7A a cui appartengono i seguenti comuni: Parzanica, Tavernola Bergamasca, Predore, Vigolo, Adrara San Rocco, Adrara San Martino, Viadanica, Foresto Sparso, Villongo, Sarnico, Gandosso, Credaro. Il Comune fa parte dell’Aggregazione dei Servizi sulla funzione Protezione Civile Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi. Nel Comune di Bossico sono presenti solo alcune situazioni di rischio di tipo idrogeologico determinate principalmente da fenomeni conseguenti alle dinamiche del reticolo minore ed a singoli fenomeni franosi. Si possono identificare così i seguenti scenari. Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Piano di emergenza Tavernola B.sca 2 Aggiornamento: marzo 2016 Ing. Mario Stevanin Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Piano di emergenza Eventi connessi con le dinamiche del Fiume Oglio Il Comune di Tavernola Bergamasca non risente delle possibili piene del Fiume Oglio. -

DELIBERAZIONE N° XI / 4430 Seduta Del 17/03/2021
DELIBERAZIONE N° XI / 4430 Seduta del 17/03/2021 Presidente ATTILIO FONTANA Assessori regionali LETIZIA MORATTI Vice Presidente GUIDO GUIDESI STEFANO BOLOGNINI ALESSANDRA LOCATELLI DAVIDE CARLO CAPARINI LARA MAGONI RAFFAELE CATTANEO ALESSANDRO MATTINZOLI RICCARDO DE CORATO FABIO ROLFI MELANIA DE NICHILO RIZZOLI FABRIZIO SALA PIETRO FORONI MASSIMO SERTORI STEFANO BRUNO GALLI CLAUDIA MARIA TERZI Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini Su proposta dell'Assessore Pietro Foroni Oggetto CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA, ALLA COMUNITÀ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI, ALLA COMUNITÀ MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO E ALL’AUTORITÀ DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D’ISEO, ENDINE E MORO A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE CONNESSE CON L’EMERGENZA CONSEGUENTE AL MOVIMENTO FRANOSO IN ATTO SUL VERSANTE DEL MONTE SARESANO IN COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA (BG) Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014: Il Direttore Generale Roberto Laffi Il Dirigente Dario Fossati L'atto si compone di 7 pagine di cui / pagine di allegati parte integrante VISTI: ● il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali” e, in particolare l’art. 108, che definisce le competenze in capo agli Enti territoriali in materia di Protezione Civile; ● il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 61 che definisce le competenze delle Regioni in materia di difesa del suolo; ● il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”, ed in particolare: − l’art. -
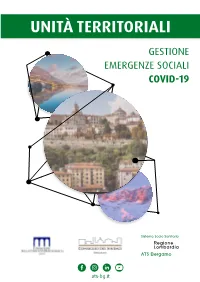
Unità Territoriali
UNITÀ TERRITORIALI GESTIONE EMERGENZE SOCIALI COVID-19 ats-bg.it UNITÀ TERRITORIALI PER L’EMERGENZA SOCIALE COVID-19 CHE COSA SONO Le UTES sono realtà sovra comunali nate nella provincia di Bergamo per supportare i servizi sociali comunali nella gestione dell’attuale situazione di emergenza sociale correlata al Covid-19. Nella bergamasca sono attive 14 UTES, la cui gestione è affidata alle Assemblee dei Sindaci degli Ambiti distrettuali/Territoriali e ai loro Uffici di Piano, strutture istituzionali e tecniche già da vent’anni strutturate in dimensione sovra comunale per la programmazione sociale in forma associata nei Piani di Zona, in virtù della Legge 328/00 e della Legge regionale 3/2008. Le UTES sono coordinate da Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e da ATS Bergamo, per il tramite dell’Ufficio Sindaci. ll progetto è finanziato con risorse pubbliche e private raccolte grazie all’impegno della Fondazione della Comunità Bergamasca, tra cui il Fondo corrente della Conferenza dei Sindaci. CHE COSA FANNO Attività di informazione Attraverso l’attivazione di un call center e la messa in rete dei contatti dei singoli Comuni, viene attivato un servizio telefonico di ascolto e informazione ai cittadini, per le esigenze sociali (anche in lingua straniera e durante il week end); Sostegno alla fragilità Presa in carico e gestione dei bisogni sociali delle persone Covid-19 dimesse dagli ospedali e gestione di un servizio domiciliare sociale di supporto per la persona e la sua famiglia, in particolare per le situazioni di estrema fragilità (assistenza domiciliare, consegna pasti, spesa e farmaci a domicilio, acquisto di generi alimentari per le persone in difficoltà economica, trasporto sociale…); Supporto alla Logistica Distribuzione dei Dispositivi di Protezione individuale (DPI) alle persone in isolamento domiciliare obbligatorio, agli operatori sociali e di volontariato impegnati nell’assistenza sociale alle persone. -

COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA Provincia Di Bergamo ______Via Roma , 44 – 24060 Tavernola Bergamasca Tel
COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA Provincia di Bergamo _________ Via Roma , 44 – 24060 Tavernola Bergamasca Tel. 035/931004- 932612 – Fax 035/932611 Codice Fiscale e Partita IVA: 00547770164 COPIA N. 18 SERVIZIO COMPETENTE: SGT/13 UFFICIO LAVORI PUBBLICI DETERMINAZIONE N. 18/SGT/13 DEL 10.02.2017 OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E RESTAURO FACCIATE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - CUP: B89G16000660004 - CIG:6974085CFE. L’anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di febbraio IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 30.04.2016, esecutiva, di conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio Gestione Territorio e sue Risorse al Sindaco Filippo Colosio; DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile di Servizio è soggetto pertanto abilitato all'assunzione della presente determinazione in attuazione delle proprie competenze e attribuzioni gestionali RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Comune di Tavernola Bergamasca: delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 24.06.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione triennale 2016-2018; delibera di Giunta Comunale n. 57 del 20.07.2016, esecutiva, avente ad oggetto: “Approvazione ed assegnazione ai Responsabili di Servizio degli obiettivi e dei mezzi finanziari - Piano delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.) esercizio 2016” ; delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 28.11.2016 avente oggetto: “Approvazione prima variazione di bilancio di previsione finanziario 2016-2018 ai sensi dell’art. 175 D.Lgs. n. 267/2000” con la quale è stato variato, fra l’altro, il Piano triennale degli investimenti e delle opere pubbliche prevedendo l’adeguamento dello stanziamento economico già iscritto nel documento contabile per la realizzazione dei lavori del polo scolastico CORPO A; Determinazione n. -

Indirizzi Delle Sedi Distrettuali Dell'asl Di
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo Via Gallicciolli, 4 - 24121 Bergamo - C.F. e P.I. 02584740167 INDIRIZZI DELLE SEDI DISTRETTUALI DELL’ASL DI BERGAMO E ELENCO COMUNI DEL TERRITORIO CON RELATIVI AMBITI DI ZONA E DISTRETTUALI Asl della Provincia di Bergamo Indirizzi Sedi DISTRETTO SOCIO SANITARIO Distrettuali DELLA VALSERIANA E VAL DI SCALVE SEDE DI ALBINO Viale Stazione, 26/a DISTRETTO SOCIO SANITARIO Tel. 035/759704 DI BERGAMO Fax 035/774304 SEDE DI BORGO PALAZZO Via Borgo Palazzo, 130 SEDE DI CLUSONE Tel. 035/2270317 – 351 Via Matteotti, 11 Fax 035/2270637 TEL. 0346/89042 Fax 0346/89027 DISTRETTO SOCIO SANITARIO DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI DALMINE SEDE DI DALMINE DELLA VALBREMBANA E Viale Betelli,1 VALLE IMAGNA Tel. 035/378119-131 SEDE DI ZOGNO Fax 035/562117 Via Paolo Polli Tel. 0345/59119 DISTRETTO SOCIO SANITARIO Fax 0345/94478 DELL’ EST-PROVINCIA SEDE DI VILLA D’ALMÈ SEDE DI SERIATE Via Roma, 16 Via Paderno, 40 Tel. 035/634611-612 Tel. 035/3235054/055 Fax 035/544509 Fax 035/3235059 SEDE DI GRUMELLO DISTRETTO SOCIO SANITARIO Via Nembrini, 1 DELL’ ISOLA BERGAMASCA Tel. 035/8356330-320 SEDE DI PONTE SAN PIETRO Fax 035/4420339 Via Caironi, 7 Tel. 035/603247 - 603312 SEDE DI TRESCORE Fax 035/603343 Via Mazzini, 13 Tel. 035/955423 DISTRETTO SOCIO SANITARIO Fax 035/944552 DELLA BASSA BERGAMASCA SEDE DI SARNICO SEDE DI TREVIGLIO Via Libertà, 37 Via Matteotti, 4 TEL. 035/911038 Tel. 0363/424228 Fax 035/910638 Fax 0363/305423 SEDE DI LOVERE SEDE DI ROMANO Piazzale Bonomelli Via Balilla, 25 Tel. -

L'andamento Dei Contagi
per mille abitanti ultimiIncremento 7 giorni L’andamento dei contagi Incremento CONTAGI NELL’ULTIMA SETTIMANA OGNI MILLE ABITANTI LEGENDA Misano di Gera d'Adda 9 3,0 Moio de' Calvi 0 0,0 3,3-10 Monasterolo del Castello 4 3,2 1,18-3,3 Montello 3 0,9 Morengo 5 1,9 0,18-1,18 Mornico al Serio 7 2,3 0 Mozzanica 8 1,8 Mozzo 11 1,5 Settimana 18-24 novembre Nembro 15 1,3 Olmo al Brembo 0 0,0, Oltre il Colle 0 0,0 Oltressenda Alta 1 7,1 Oneta 1 1,8 Onore 0 0,0 Orio al Serio 1 0,6 Ornica 0 0,0 Osio Sopra 7 1,3 Osio Sotto 19 1,4 Pagazzano 3 1,4 Paladina 3 0,7 Palazzago 4 0,9 Palosco 9 1,5 Parre 0 0,0 Parzanica 0 0,0 Pedrengo 7 1,1 Peia 3 1,7 Pianico 1 0,7 Piario 0 0,0 Piazza Brembana 0 0,0 Piazzatorre 0 0,0, Piazzolo 0 0,0 Pognano 2 1,2, Ponte Nossa 0 0,0 Comuni che hanno fatto registrare zero positivi Ponte San Pietro 21 1,7 nella settimana 18-24 novembre Ponteranica 6 0,9 Pontida 1 0,3 Pontirolo Nuovo 8 1,5 3 0,6 per mille abitanti per mille abitanti Pradalunga ultimiIncremento 7 giorni ultimiIncremento 7 giorni 4 2,1 Incremento Incremento Predore Premolo 0 0,0 Presezzo 4 0,8 Pumenengo 0 0,0 Ranica 8 1,3 Ranzanico 1 0,8, Adrara San Martino 1 0,4 Cene 2 0,5 0 0,0 1 1,2 0 0,0 Riva di Solto Adrara San Rocco Cerete Rogno 3 0,7 Albano Sant'Alessandro 8 0,9 Chignolo d'Isola 12 3,4 35 1,6 9 0,5 12 1,9 Romano di Lombardia Albino Chiuduno Roncobello 0 0,0 0 0,0 23 3,5 Roncobello Algua Cisano Bergamasco Roncola 1 1,3 4 0,7 19 3,3 Roncola Almè Ciserano Rota d'Imagna 1 1,1 10 1,5 6 1,2 Rota d'Imagna Almenno San Bartolomeo Cividate al Piano Rovetta 3 0,7 10 -

Costa Volpino Dintorni
Costa Volpino Dintorni Localita vicine a Costa Volpino F Songavazzo Lago d'Iseo: laghi vicino a Costa Volpino Il lago d'Iseo si trova in Lombardia ed è lungo 25 Km, largo 4,7 Km con una profondità massima di 251 metri. Si tratta di un lago di origine glaciale, il grande ghiacciaio dell'Oglio ha lasciato, ancora oggi, i segni della sua presenza rappresentati da grigi massi di arenaria sparsi sul territorio. E'lo stesso fiume Oglio che funge da immissario ed emissario del lago. Nella parte centrale del lago troviamo l'isola di Siviano, detta comunemente Monte Isola, la più vasta tra le isole lacuali della penisola e gli isolotti di Loreto e San Paolo. Il fascino dell'ambiente lacustre, la prealpe operosa, i meravigliosi paesaggi e la pittura (troviamo molte opere venete nella galleria di Lovere), numerosi sono i motivi d'interesse di questo itinerario. Il lago venne dichiarato "il più industriale" d'Italia: la Valcamonica, solcata dal fiume Oglio, è un mondo prealpino ricoperto da vigneti e castagni che scendono dolcemente sui coltivi del fondovalle; le località intorno alla gola del Dezzo offrivano grandi quantità di ferro che diedero avvio all'industrializzazione della zona. Un lago dunque, che al fascino dell'ambiente unisce interessanti centri e località turistiche e industriali famose in tutta la penisola, un itinerario da non perdere. Come arrivare: Autostrada A4: da Milano direzione Venezia uscita Palazzolo Autostrada A4: da Verona direzione Milano uscita Rovato o Palazzolo Località posizionate sulla mappa A Bossico B Lovere D Pisogne -

Elenco Dei Porti E Approdi
28 IL LAGO E I SUOI PORTI Elenco dei porti e approdi Provincia di Brescia Provincia di Bergamo ● 1 - Paratico - Pontili M.A.S. ● 30 - Costa Volpino - Porto Pizzo ● 2 - Paratico - Pontili Cantieri N. Basso Sebino ● 31 - Costa Volpino - Porto Bersaglio ● 3 - Paratico - Darsena Nautica Bertelli ● 32 - Lovere - Porto Caserma ● 4 - Paratico - Pontili Tengattini ● 33 - Lovere - Pontile Tadini ● 5 - Iseo - Darsena Nautica Bellini ● 34 - Lovere - Porto Tigli ● 6 - Iseo - Porto Giani Filanda ● 35 - Lovere - Porto Turistico Cornasole ● 7 - Iseo - Porto Centrale Punta ● 36 - Castro - Porto Vecchio ● 8 - Iseo - Porto Molino ● 37 - Castro - Porto Nuovo ● 9 - Iseo - Porto Sassabanek ● 38 - Riva di Solto - località Gre ● 10 - Iseo - Porto Industriale Base Nautica Barro e Sportaction ● 11 - Iseo - Porto Salmister ● 39 - Riva di Solto - Porto Chiesa ● 12 - Iseo - Porto Gabriele Rosa ● 40 - Riva di Solto - Porto Martinoni ● 13 - Iseo - Porto Garibaldi ● 41 - Riva di Solto - Porto Duane ● 14 - Iseo - Porto Pezzotti Giacomo ● 42 - Tavernola Bergamasca - Porto Centrale ● 15 - Iseo - Porto Nautica Pezzotti Antonio ● 43 - Predore - Porto San Rocco ● 16 - Sulzano - Base Nautica ANS ●● 44 - Predore - Porto Ponecla ● 17 - Sulzano - Porto Vertine ● 45 - Predore - Pontili Campitino ● 18 - Sulzano - Porto Vecchio ● 46 - Sarnico - Pontili Cantiere Riva ● 19 - Sulzano - Porto Chiesetta ● 47 - Sarnico - Circolo Velico Sarnico ● 20 - Sulzano - Porto Cadorna ● 48 - Sarnico - Pontili Lungolago ● 21 - Sulzano - Porto Nuovo ● 49 - Sarnico - Porto Lungolago Garibaldi ● 22 -

Elenco Fornitori
ELENCO FORNITORI FORNITORI CodiceFiscale PartitaIVA Comune i Due Angeli" AGRITURISMO" MSTGPP69E05Z133 2229560988 OME (BS) 4G Retail S.r.l 10681830153 10681830153 ERBUSCO (BS) A.M.G. SERVICE SRL 1844300036 1844300036 A.R.O. s.r.l. 2082560174 682670989 LENO (BS) A.S.D. Gruppo Sub Vallecamonica 3182100176 PISOGNE (BS) A.S.D. Ysei Sub Diveng Club 98120880178 ISEO (BS) A2A Energia S.p.A. 12883420155 12883420155 MILANO (MI) ACCA SOFTWARE SPA 1883740647 1883740647 MONTELLA (AV) ACERBIS GARDEN S.N.C 2424220164 2424220164 SARNICO (BG) ACI 12345678902 12345678902 ACQUATICA S.p.A. 2664460165 2664460165 COLOGNE (BS) Adobe System Italia SRL 3284020967 3284020967 AGRATE BRIANZA (MI) Adobe system software Ireland Ldt IE6364992H0 IE6364992H0 DUBLINO (DU) aesys S.p.A. 2052370166 2052370166 SERIATE (BG) Agenzia delle Entrate 13579135791 13579135791 ROMA (RM) AGENZIA SEBINO DI VOLPI GIOVANNI VLPGNN46B10L827Z 513020164 SARNICO (BG) AGRISERVICE di FACCHI ROBERTO FCCRRT72M12I437O 3328520170 CAPRIOLO (BS) Agriturismo I CANTONI di Cantoni Guido CTNGDU54D09G361Z 3394640175 AIRONE SRL 3313620175 3313620175 Al Porto s.r.l. Ristorante Pizzeria Las Vegas 3058590179 3058590179 CLUSANE SUL LAGO (BS) ALARI EFRANO Install. imp. elettrici civili e industriali LRAFRN54A22I437G 486060163 SARNICO (BG) Albergo Stazione 2062070178 2062070178 PARATICO (BS) ALL PAV s.r.l 3004220160 3004220160 TRESCORE BALNEARIO (BG) Antico Eden Trattoria in Pilzone d'Iseo 1951030178 1951030178 ISEO (BS) AOB2 Acque Ovest Bresciano Due S.r.l. 2944230982 2944230982 ROVATO (BS) APB CAR SERVICE S.r.l. 8027760019 8027760019 TORINO (TO) ARCHETTI ASFALTI S.R.L. 3059170179 3059170179 ISEO (BS) ARCHETTI S.r.l. 949590178 949590178 CAZZAGO SAN MARTINO (BS) AREA DI SERVIZIO TAMOIL 2993280169 ISEO (BS) ARMATI S.r.l.