Convegno Poschiavo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Köche Von Morgen Zu Gast in Der Küche Des Hotel Suvretta House Chefs De Cuisine and Tomorrow’S Celebrity Chefs As Guests in the Suvretta House Kitchen
SUVR20172017 EE TTA TTA MAGAZINEMAGAZINE SUVRETTASUVRETTA HOUSEHOUSE MAGAZINEMAGAZINE 1 10.10.2016 /965 SUVRETTA HOUSE MAGAZINE / DEZEMBER Sujet: 226 HIL3 FORMAT: 488 x 330 mm PDF MAIL PAGE GAUCHE Badrutt’s Palace,Via Serlas, Badrutt’s CHOPARD BOUTIQUE ST. MORITZ BOUTIQUE ST. CHOPARD IMPERIALE +41 (0)81834 9450 10.10.2016 /965 SUVRETTA HOUSE MAGAZINE / DEZEMBER Sujet: 226 HIL3 FORMAT: 488 x 330 mm PDF MAIL PAGE DROITR 4 Editorial 9 Wein / Wine Der Zauberberg — Der Zauberberg 16 Kulinarik / Cuisine Küchenchefs und Sterneköche von morgen zu Gast in der Küche des Hotel Suvretta House Chefs de Cuisine and tomorrow’s celebrity chefs as guests in the Suvretta House kitchen 26 Reisen / Travel Puschlav – Von Pionieren und Palästen Poschiavo Valley – Of Pioneers and Palaces 50 Sport Fliegenfischen — Fly fishing 60 Kunst / Art Birdhead – Shanghai meets Sils Maria 62 Event Besuch vom Geissenpeter persönlich A visit by Peter the goatherd in the flesh 72 Kunst / Art Galerie Andrea Caratsch – Giacometti Hodler Segantini IMPRESSUM 80 Konzept, Redaktion und Verkauf: Edition Stephan Witschi, Zürich, Literatur / Literature Telefon +41 (0)44 242 37 27, [email protected] Grafik: l’équipe [visuelle], Luzern, www.lequipe-visuelle.ch Bettina Spoerri – Der ideale Zuhörer Druck: Memminger MedienCentrum, www.mm-mediencentrum.de Bettina Spoerri – The ideal listener Texte: André Behr, Marina U. Fuchs, Barbara Liebster, Anka Refghi, Bettina Spoerri, Jacqueline Vinzelberg Fotografien: Peter Egli, Heidiland Tourismus, Felix Jungo, Daniel 92 Martinek, Jacqueline Vinzelberg Kunst / Art Bildbearbeitung: Fotosatz Amann, D-Memmingen Alberto Giacometti – Auf der Suche nach Übersetzung: Translate-ME, Marcus R. A. Endres, www.translate-me.info einem neuen Menschenbild Chef-Akquisiteur: Marcel Haueter, Telefon +41 (0)79 668 18 80 Alberto Giacometti – Quest for a new Herausgeber: Suvretta House, St. -

Wandering Suggestions
Wandering suggestions Tip 1 Cavaglia - Selva - Poschiavo (high-altitude pat) Approach: by train (RhB) to Cavaglia Route: Cavaglia (1703m)-Braita (1820m)-Urgnasch-Selva (1458m)-Poschiavo (1014m) Time: approx. 5 hours Return: by train (RhB) from Poschiavo Hints: wonderful views of the Vally of Poschiavo. Restaurants at Cavaglia and Selva. Possibility of accommodation in Cavaglia and Selva. Tip 2 Poschiavo - San Romerio - Brusio Approach: by train (RhB) to Poschiavo Route: Poschiavo (1014m)-Cologna-Val Terman (1412m)-San Romerio (1794m)- Viano (1281m) Time: approx. 5 hours Return: by train (RhB) from Brusio. Mini-coach from Viano to Brusio on request. Hints: eventful wandering to the pilgrimage church of San Romerio (12th century). Restaurant and lodging possibilities at San Romerio and Viano. Splendid panoramic views. Tip 3 Brusio - Viano - Tirano (smugglers’path) Approach: by train (RhB) to Brusio. Mini-coach from Brusio to Viano upon request. Route: Viano (1281m)-Sass dal Gal-Baruffini-Tirano (448m) Time: approx. 2 hours Return: by train (RhB) form Tirano Hints: panoramic view of Brusio and its characteristic round viaduct. Descent to Tirano through typical terraced vineyards. Don’t forget identity card or passport! Tip 4 Poschiavo - Le Prese - Miralago Approach: by train (RhB) to Poschiavo Route: Poschiavo-Annunziata-Le Prese-Cantone-Miralago Time: approx. 1 ½ hours Return: by train (RhB) from Miralago Hints: wonderful nice and even walking along the river and the left side shore of the lake to Miralago. Restaurants with sunny terrace at Le Prese and Miralago. Tip 5 Ospizio Bernina - Alp Grüm Approach: by train (RhB) to Ospizio Bernina Route: Ospizio Bernina (2253m)-Sassal Mason (2355m)-Belvedere-Alp Grüm (2091m) Time: approx. -

Switzerland 4Th Periodical Report
Strasbourg, 15 December 2009 MIN-LANG/PR (2010) 1 EUROPEAN CHARTER FOR REGIONAL OR MINORITY LANGUAGES Fourth Periodical Report presented to the Secretary General of the Council of Europe in accordance with Article 15 of the Charter SWITZERLAND Periodical report relating to the European Charter for Regional or Minority Languages Fourth report by Switzerland 4 December 2009 SUMMARY OF THE REPORT Switzerland ratified the European Charter for Regional or Minority Languages (Charter) in 1997. The Charter came into force on 1 April 1998. Article 15 of the Charter requires states to present a report to the Secretary General of the Council of Europe on the policy and measures adopted by them to implement its provisions. Switzerland‘s first report was submitted to the Secretary General of the Council of Europe in September 1999. Since then, Switzerland has submitted reports at three-yearly intervals (December 2002 and May 2006) on developments in the implementation of the Charter, with explanations relating to changes in the language situation in the country, new legal instruments and implementation of the recommendations of the Committee of Ministers and the Council of Europe committee of experts. This document is the fourth periodical report by Switzerland. The report is divided into a preliminary section and three main parts. The preliminary section presents the historical, economic, legal, political and demographic context as it affects the language situation in Switzerland. The main changes since the third report include the enactment of the federal law on national languages and understanding between linguistic communities (Languages Law) (FF 2007 6557) and the new model for teaching the national languages at school (—HarmoS“ intercantonal agreement). -

Lago Bianco»
COMUNE DI POSCHIAVO MESSAGGIO per la votazione comunale del 31 ottobre 2010 riguardante le concessioni “A” e “B” tra il Comune di Poschiavo e Repower AG in merito alla realizzazione del progetto «Lago Bianco» Bozza 5.10.2010 Indice 1. Premessa e politica energetica cantonale 2. Sintesi 3. Situazione iniziale e colloqui 4. Il progetto «Lago Bianco» in dettaglio 5. Concetto di sviluppo dei corsi d’acqua 6. Misure di compensazione per il progetto «Lago Bianco» 7. La concessione 8. Rafforzamento sostenibile dell’economia pubblica 9. Scadenze e prossimi passi 10. Conclusione e proposte 11. Appendice - 1 - Care concittadine e cari concittadini Ci pregiamo trasmettervi il messaggio relativo alla concessione A e B tra il Comune di Poschiavo e Repo- wer AG in merito alla realizzazione del progetto «Lago Bianco». 1. Premessa e politica energetica cantonale La realizzazione del progetto «Lago Bianco» rappresenta per la Valle, e in modo particolare per il Comune di Poschiavo, una straordinaria occasione di sviluppo, basata sull’utilizzo di un’importante risorsa naturale come l’acqua. Anche dal punto di vista del Cantone, essendo Repower l’unica società grigionese attiva su tutta la filiera del mercato energetico, l’iniziativa assume una valenza strategica. In questo senso è dunque pienamente soddisfacente quanto il Governo scrive nel rapporto esplicativo sulla revisione parziale della Legge sui dirit- ti d’acqua del Cantone dei Grigioni (LGDA) sotto “Politica Futura”; in essa, si cita testualmente, “si mira a fare in modo che siano le società insediate nel Cantone a generare la cifra d’affari per l’approvvigionamento e in particolare per il commercio. -

Verkehr Im Valposchiavo – Massnahmen Privatverkehr
Regione Valposchiavo Verkehr im Valposchiavo Massnahmen Privatverkehr September 2014 Stand 20.08.2014 Hartmann & Sauter Raumplaner & Verkehrsingenieure CH - 7002 Chur Inhalt Das Wichtigste in Kürze 1. Ausgangslage 1 2. Heutige Verkehrsaufkommen im Valposchiavo 1 3. Wichtigste Probleme beim motorisierten Individualverkehr 5 3.1 Unfallgeschehen im regionalen Strassennetz 5 3.2 Lärmbelastungen längs der Berninastrasse 9 3.3 Verkehrsbehinderungen in den Ortsdurchfahrten 11 3.4 Naturgefahren längs der wichtigsten Strassen 13 3.5 Mobilitätsverhalten gemäss Mikrozensus 2010 15 3.6 Die wichtigsten Probleme zusammengefasst 20 4. Zielsetzungen und Gewichtung 21 5. Massnahmen und Bewertung 23 5.1 Langfristige Massnahmen 25 5.2 Mittelfristige Massnahmen 31 5.3 Kurzfristige Massnahmen 37 6. Schlussfolgerungen und weiteres Vorgehen 43 Anhang Sperrungen von Kantonsstrassen im Valposchiavo seit 2007 Regione Valposchiavo: Verkehr im Valposchiavo – Massnahmen Privatverkehr Das Wichtigste in Kürze Die Aufgabe dieses Gutachtens besteht darin, auf der Grundlage einer Analyse der heutigen Situation und Probleme, der Festlegung und Gewichtung eines Zielsystems sowie der Beur- teilung von denkbaren kurz-, mittel- und langfristigen Massnahmen beim privaten Strassen- verkehr Vorschläge für die Priorisierung der Massnahmen aus gesamtregionaler Sicht zu er- arbeiten. Gemäss der durchgeführten Beurteilung empfehlen wir folgendes Vorgehen. Empfehlungen kurzfristige Massnahmen Die Region bemüht sich gleichermassen um die baldige Einührung von Tempo 30 in den Siedlungen -

Bernina-Express – St. Moritz
© www.valposchiavo.ch Bernina-Express – St. Moritz ReiseproGramm Bahnstrecke ins Val Poschiavo ist die höchste Bahn-Alpentransversale und gilt mit 70 Pro- Sonntag, 17. Juli 2016 mille als eine der steilsten Schmalspur-Bahn- Basel – St. Moritz strecken ohne Zahnstange weltweit - eine Basel - Zürich - St. Gallen - Diepoldsau – Feld- bahntechnische Meisterleistung. kirch - Bludenz - Arlberg - Landeck – Pfunds Mittagshalt im schönen Städtchen Poschiavo. - Samnaun (Mittagessen) - Scuol – Zernez - Sa- Hauptort der unverfälschten kleinen Ferien- medan - St. Moritz. welt des Val Poschiavo. Stattliche Patrizierhäu- Zimmerbezug im ****Hotel Laudinella. ser umrahmen eine italienisch anmutende © Pontresina Tourismus © Pontresina Nachtessen im Hotel. Piazza. Eine von vielen architektonischen Be- sonderheiten ist das von Emigranten erbaute Montag, 18. Juli 2016 "Spaniolenviertel" mit farbenfrohen Häusern. Bernina-Express St. Moritz – Poschiavo Am Nachmittag Weiterfahrt mit dem Bus via Nach dem Frühstück fährt uns der Bus zum Tirano – Sondrio – Morbegno – Chiavenna – Bahnhof in St. Moritz. Bergell – Maloyapass – Maloya – Silvaplaner- Wir steigen um in den Zug. Die spektaku- see nach St. Moritz. Nachtessen im Hotel. läre Fahrt mit der Rhätischen Bahn über den Berninapass von St. Moritz ins Val Poschiavo Dienstag, 19. Juli 2016 ist ein eindrückliches Erlebnis. Immer wieder Heimfahrt öffnen sich Blicke in die Gebirgswelt des Mor- Nach dem Frühstück Fahrt via - Julierpass - teratsch-Gletschers, der Diavolezza oder der Bivio - Savognin - Tiefencastel - Lenzerheide Lagalb. Von der Alp Grüm geniesst man den - Chur (Mittagshalt) - Sargans – Pfäffikon - Zü- Ausblick auf den mächtigen Palü-Gletscher rich – Basel nach Arlesheim. und zugleich öffnet sich der Blick auf den Lago di Poschiavo tief unten im Talgrund. Die © www.valposchiavo.ch TErMin 17.07. - 19.07.2016 3 Tage UnSErE LEiSTUnGEn ■■Fahrt in modernem ****Birseck-Reisebus ■■2 x Halbpension im Hotel Laudinella in St. -

5. Protection and Management of the Property
Candidature UNESCO World Heritage | Rhaetian Railway in the Albula/Bernina Cultural Landscape | www.rhb-unesco.ch 5. Protection and Management of the Property 5.a Ownership > 511 5.b Protective designation > 513 5.c Means of implementing protective measures > 535 5.d Existing plans related to municipality and region > 551 in which the proposed property is located 5.e Property management plan or other management system > 557 5.f Sources and levels of finance > 561 5.g Sources of expertise and training in conservation > 565 and management techniques 5.h Visitor facilities and statistics > 571 5.i Policies and programmes related to the presentation > 577 and promotion of the property 5.j Staffing levels > 579 Additional Information > 5. Protection and Management > Table of contents 509 Candidature UNESCO World Heritage | Rhaetian Railway in the Albula/Bernina Cultural Landscape | www.rhb-unesco.ch Albula line > The Glacier Express leaving Celerina. A. Badrutt / Rhaetian Railway Additional Information > 5. Protection and Management > 5.a Ownership 510 Candidature UNESCO World Heritage | Rhaetian Railway in the Albula/Bernina Cultural Landscape | www.rhb-unesco.ch 5.a Ownership The rail infrastructure of the Albula/Bernina line is owned by the Rhaetian Railway. The remain- ing ownership structures within the nominated World Heritage perimeter are also clearly de- fined, and the applicable terms and conditions are set out in the land register. Real property Company property The land and buildings in the core zone directly All structures in the core zone are owned by the serve rail operations and are, for the most part, Rhaetian Railway. The necessary legal basis, owned by the Rhaetian Railway. -

Explore the Stunning Swiss Alps by Rail
Explore the stunning Swiss Alps by rail Stunning scenery and spectacular views regale us as we travel by rail through the heart of the Swiss Alps on the world-famous Glacier Express. We enjoy mountain railways, charming towns and dramatic Alpine scenery on this tour through the breathtaking landscapes of Switzerland. The itinerary for your journey Tour highlights • Chur, Switzerland’s oldest town • A journey on the Bernina Express • Poschiavo • The Iconic Glacier Express • Kandersteg, a delightful mountain resort • Mountain rail excursion to Zermatt • The Matterhorn • GRJ Swiss Travel Card What's included An escorted experience and all travel arrangements • The services of a professional UK Tour Manager from start to finish • Exclusive meeting point at our dedicated Departure Office in St Pancras • Standard Class rail travel throughout • Porterage included between the station and your hotels in Chur and Kandersteg, as well as between Kandersteg and Chur Comfortable accommodation in your destination • 7 nights' hotel accommodation including 1 outbound overnight stay in Cologne, 3 nights at the Hotel Freieck in Chur and 3 nights at the Hotel Belle Epoque in Kandersteg Delicious meals included • 12 meals including 7 breakfasts and 5 dinners including a farewell dinner in Kandersteg Exciting excursions and free time to explore • Journey on the iconic Glacier Express • Full day excursion on the Bernina Express • Mountain railway excursion to Zermatt • Free time in Chur • At leisure in Poschiavo • Explore Kandersteg • GRJ Swiss Travel Card, permitting 50% discounted fares on free days for rail, boat and most mountain railway journeys Tour Itinerary Day 1 - By train to Strasbourg After meeting at our dedicated Departure Office in St Pancras, we board the Eurostar to Paris, continuing on by high-speed rail to Strasbourg, where we overnight. -

Eawag Annual Report 2011
2011 Eawag Überlandstrasse 133 Annual Report 8600 Dübendorf Switzerland Tel. +41 (0)58 765 55 11 Fax +41 (0)58 765 50 28 www.eawag.ch [email protected] Annual Report 2011 Eawag: Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology Eawag, the Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology, is The Annual Report 2011 presents only a small selection of part of the ETH Domain. This comprises the Swiss Federal Institutes of Eawag’s research, teaching and consulting activities. Technology in Zurich (ETHZ) and Lausanne (EPFL), Eawag and three other A database of all publications by Eawag researchers independent, application-oriented research institutes – the Paul Scherrer (including article summaries) is available online at: Institute (PSI), the Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape www.lib4ri.ch/institutional-bibliography/eawag.html. Research (WSL) and the Materials Science and Technology Research Insti- Open access publications can be downloaded tution (Empa). Nationally rooted and internationally networked, Eawag free of charge. If you have any queries, is concerned with concepts and technologies for the sustainable manage- please contact: [email protected]. ment of water resources and aquatic ecosystems. In cooperation with universities, other research centres, public authorities, the private sector The Annual Report is also available in German. and NGOs, Eawag strives to harmonize ecological, economic and social interests in water, providing a link between science and practical applica- tions. In total 467 staff are employed in research, teaching and consulting at the Dübendorf (Zurich) and Kastanienbaum (Lucerne) sites. Publication details Editing: Andres Jordi | Contributors: Fabio Bergamin, Atlant Bieri, Andri Bryner, Herbert Güttinger, Thomas Lichtensteiger, Beatrix Mühlethaler, Anke Poiger, Annette Ryser, Anke Schäfer, Evelin Vogler, Felix Würsten | Translation: Jeff Acheson, Bottmingen | Design: TBS Identity, Zurich | Layout: SLS Nadler, Fällanden | Printing: Mattenbach AG, Winterthur | Copyright: Eawag, April 2012. -
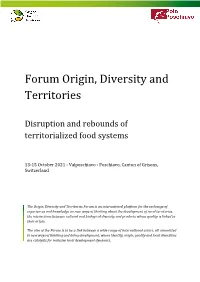
Forum Origin, Diversity and Territories
Forum Origin, Diversity and Territories Disruption and rebounds of territorialized food systems 13-15 October 2021 - Valposchiavo - Poschiavo, Canton of Grisons, Switzerland The Origin, Diversity and Territories Forum is an international platform for the exchange of experiences and knowledge on new ways of thinking about the development of rural territories, the interactions between cultural and biological diversity and products whose quality is linked to their origin. The aim of the Forum is to be a link between a wide range of international actors, all committed to new ways of thinking and doing development, where identity, origin, quality and local diversities are catalysts for inclusive local development dynamics. Wednesday 13 October Venue: Municipal School Gymnasium and Polo Poschiavo, Poschiavo 8 :00 – 9 :00 Welcome and Check-in at Municipal School Gymnasium 9 :00 – 12 :30 Visit by workshop Schedule Workshop1 Workshop2 Workshop3 Workshop4 Valposchiavo: from Azienda Bio Raselli - Valposchiavo marginal territory to Re-power: 9.00am - Aromatic and medicinal Organic Dairy Smart Valley Bio, visit hydroelectric plant 12.30pm herbs (San Carlo) and discussion (Cavaglia) (Le Prese) (Poschiavo) 12 :30 – 13 :30 Meals on site at the expense of the participants 13 :30 – 16 :30 Introduction by Guillèn Calvo, Cassiano Luminati & François Casabianca Plenary Conference • Mathew Burrows (Directeur, Foresight Strategy and Risks at The Atlantic Council of the United States) - The Ecological Crisis: Unsolvable without Global Cooperation • Serge Morand (CIRAD) - For a social ecology of health • Michel Duru (INRAE) - Revisiting territorial development through the lens of health 16 :30 – 17 :00 Coffee break 17 :00 - 18 :30 Session 1 of the parallel workshops From 19:30 Aperitif and dinner (sponsored by the Swiss Association for PDO-PGI) & Serious Games (AYNI) for all participants, presented by F. -

Pontresina. Facts and Figures the Village
Pontresina. facts and figures The village The village – fascinating history Languages in Pontresina Guests will be enchanted by the charm of the historical mountain village: lovingly restored Engadin houses from the Languages Population Population Population census 1980 census 1990 census 2000 17th and 18th centuries, palatial belle époque hotels and other architectural gems from earlier times, including the Begräb- Number Amount Number Amount Number Amount niskirche Sta. Maria (Church of the Holy Sepulchre of St Mary, German 990 57,5 % 993 61,9 % 1264 57,7 % dating back to the 11th century) with its impressive frescoes Romansh 250 14,5 % 194 12,1 % 174 7,9 % from the 13th and 15th centuries. Other sights include the pentagonal Spaniola tower (12th/13th century) and the Punt Italian 362 21,0 % 290 18,1 % 353 16,1 % Veglia Roseg and Punt Veglia Bernina bridges. The historical Total citizen 1726 1604 2191 village of Pontresina is divided into four settlements: Laret, San Spiert, Giarsun and Carlihof. Towards Samedan, there is also the more modern part of Muragl. With a total of 2,000 re- sidents, the village welcomes up to 116,000 guests every year. Pontresina Tourismus T +41 81 838 83 00, www.pontresina.ch The sorrounding GERMANY Frankfurt Munich (590 km) (300 km) Friederichshafen Schaffhausen (210 km) Basel St.Gallen (290 km) (190 km) Zurich AUSTRIA (200 km) Innsbruck (190 km) Landquart FRANCE Chur Bern Davos Zernez (330 km) Disentis Thusis Mals Andermatt Filisur Samedan Meran St.Moritz Pontresina Brig Poschiavo Bozen Chiavenna Tirano -

Graubündenpop 193,920 / AREA 7106 SQ KM / LANGUAGES GERMAN, ROMANSCH, ITALIAN
File20-graubunden-loc-swi7.dwg Book Initial Mapping Date Road Switzerland 7 Peter 21/11/11 Scale All key roads labelled?Hierarchy Hydro ChapterGraubunden Editor Cxns Date Title Spot colours removed?Hierarchy Symbols Author MC Cxns Date Nthpt Masking in Illustrator done? Kerry Christiani Book Off map Inset/enlargement correct?dest'ns BorderCountry LocatorKey A1None Author Cxns Date Notes Basefile08-geneva-loc-swi6.dwgFinal Ed Cxns Date KEY FORMAT SETTINGS New References09-geneva-loc-swi7.dwg Number of Rows (Lines) Editor Check Date MC Check Date Column Widths and Margins MC/CC Signoff Date ©Lonely Planet Publications Pty Ltd GraubündenPOP 193,920 / AREA 7106 SQ KM / LANGUAGES GERMAN, ROMANSCH, ITALIAN Includes ¨ Why Go? Chur . 267 Ask locals what it is that makes their canton special and Lenzerheide they’ll wax lyrical about how, well, wild it is. In a country & Valbella . .. 272 blessed with supermodel looks, Graubünden is all about Arosa . 274 raw natural beauty. Whether it’s wind-battered plateaux in Surselva Region . 276 Engadine where clouds roll over big-shouldered mountains, the Rhine gouging out knife-edge ravines near Flims, or the Flims, Laax & Falera . 276 brooding Alpine grandeur of the Swiss National Park, this Valsertal . 277 wonderfully remote region begs outdoor escapades. Bündner Herrschaft . 279 While you’ve probably heard about Davos’ sensational Maienfeld . 280 downhill skiing, St Moritz’s glamour and the tales of Heidi Klosters & Davos . 281 (fictionally born here), vast swaths of Graubünden remain little known and ripe for exploring. Strike into the Alps on The Engadine . 286 foot or follow the lonesome passes that corkscrew high into Unterengadin .