Atti Parlamentari
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
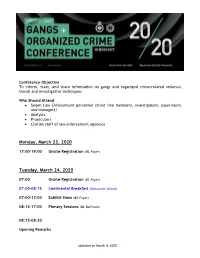
Building Trust
Conference Objective To inform, train, and share information on gangs and organized crime-related violence, trends and investigative techniques. Who Should Attend • Sworn Law Enforcement personnel (front line members, investigators, supervisors, and managers) • Analysts • Prosecutors • Civilian staff of law enforcement agencies Monday, March 23, 2020 17:00-19:00 Onsite Registration (BC Foyer) Tuesday, March 24, 2020 07:00 Onsite Registration (BC Foyer) 07:00-08:15 Continental Breakfast (Vancouver Island) 07:00-17:00 Exhibit Show (BC Foyer) 08:15-17:00 Plenary Sessions (BC Ballroom) 08:15-08:30 Opening Remarks Updated on March 4, 2020 SESSION 1 08:30-09:30 Case Study – Bolo Program – Unique Tools To Catch Canada’s Most Wanted Description On December 1, 2019, Canadian murder suspect Brandon Teixeira was apprehended in Oroville, California, following a year-long hunt led by the Integrated Homicide Investigation Team (IHIT) and Combined Forces Special Enforcement Unit of BC (CFSEU-BC). Given the tangible threat that Teixeira posed to the public, and the complexity of this fugitive investigation, IHIT and CFSEU-BC partnered with the Bolo Program, a Canadian public safety initiative encouraging citizens to be on the lookout for Canada’s most wanted suspects. In close cooperation with IHIT and CFSEU-BC investigators, the Bolo Program conducted an amplification campaign of the Teixeira wanted notice which generated millions of media, billboard and Facebook impressions, as well as over 100 tips. In cooperation with Metro Vancouver Crime Stoppers, the Bolo Program also offered a reward up to CAD $50,000 for any information leading to the arrest of the suspect. -

STRUTTURE Cosa Nostra E 'Ndrangheta a Confronto
STRUTTURE Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto Francesco Gaetano Moiraghi Andrea Zolea WikiMafia – Libera Enciclopedia sulle Mafie www.wikimafia.it Strutture: Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto, di Francesco Gaetano Moiraghi e Andrea Zolea La mafia dura da decenni: un motivo ci deve essere. Non si può andare contro i missili con arco e frecce: in queste vicende certe intemperanze si pagano duramente. Con il terrorismo, con il consenso sociale, potevi permettertele: con la mafia non è così. Nella società c’è un consenso distorto. Altro che bubbone in un tessuto sociale sano. Il tessuto non è affatto sano. Noi estirperemo Michele Greco, poi arriverà il secondo, poi il terzo, poi il quarto. Giovanni Falcone 1 www.wikimafia.it Strutture: Cosa Nostra e ‘ndrangheta a confronto, di Francesco Gaetano Moiraghi e Andrea Zolea PREMESSA Questo lavoro ha lo scopo di offrire uno sguardo d’insieme sulle articolazioni strutturali delle organizzazioni mafiose denominate Cosa nostra e ‘ndrangheta . La prima sezione, curata da Francesco Gaetano Moiraghi, si concentra sull’analisi di Cosa nostra. La seconda sezione, che sposta il focus sulla ‘ndrangheta, è curata da Andrea Zolea. Come si potrà notare, le due sezioni non sono state realizzate secondo uno stesso modello, ma analizzano le due organizzazioni con un approccio differente. Ad esempio, la parte su Cosa nostra avrà un orientamento maggiormente diacronico, diversamente da quella sulla ‘ndrangheta, basata su un approccio sincronico. Il presente testo ha infatti l’obiettivo di offrire due proposte di analisi differenti che riescano a mettere in luce le analogie e le differenze delle strutture delle due organizzazioni mafiose. -

October to December, 2015 Organized Crime in Canada: a Quarterly Summary
Osgoode Hall Law School of York University Osgoode Digital Commons Quarterly Summaries of Recent Events: Organized All Summaries Crime in Canada 12-2015 October to December 2015 Follow this and additional works at: http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/summaries Recommended Citation "October to December 2015" (2015). All Summaries. 5. http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/summaries/5 This Article is brought to you for free and open access by the Quarterly Summaries of Recent Events: Organized Crime in Canada at Osgoode Digital Commons. It has been accepted for inclusion in All Summaries by an authorized administrator of Osgoode Digital Commons. October to December, 2015 Organized Crime in Canada: A Quarterly Summary Organized Crime Activities Auto Theft Corruption Counterfeiting Cyber-Crime Drug Trafficking o Cocaine o Hashish o Marijuana Gambling Human Trafficking and the Sex Trade (Contraband) Tobacco Violence Organized Crime Genres Multi-Organizational Italian Organized Crime Nigerian Organized Crime Outlaw Motorcycle Gangs ORGANIZED CRIME ACTIVITIES Auto Theft Staff Sgt. Kristie Verheul, the head of the Calgary police economic crimes unit, says organized crime and the reorganization of police resources are factors in a 60 percent increase in car thefts during 2015. The surge in stolen vehicles began in December 2014 and affects the entire city, with about 5,000 vehicles reported stolen this year compared to about 3,000 in 2014. Police say the increase can be blamed on several factors but are primarily tied it to other crimes, including organized crime. “Vehicle crime tends to facilitate other crimes,” said Verheul. “Overall we are seeing an increase in property crimes across the board.” That means once they’re stolen, the vehicles are used for transportation – moving drugs, guns and stolen goods around – as well as committing further crimes like robberies. -

PREFACE the Influence of Organised Crime in the Balkan Area, As Is Well
PREFACE The influence of organised crime in the Balkan area, as is well known, has reached levels that have required a considerable acceleration in efforts to combat this phenomenon. Albania is involved in many initiatives set up by the international community, which are matched by efforts at national level. In 2005, the Democratic Party achieved a decisive victory in the political elections with the support of its allies, making a commitment to reduce crime and corruption in the country. This victory, and more importantly the ordered transition of power which followed it, has been regarded at international level as an important step forward towards the confirmation of democracy. Despite the active presence of organised criminal groups over the territorial area and the influence exercised by them in the country's already critical social and economic situation, Albania, recognising the need to bring its legislation up to date and to strengthen the institutions responsible for fighting crime, has moved with determination in the direction of reform. With regard to bringing the legislation into line with international standards, we should remember that in 2002 Albania ratified the United Nations Convention against Trans National Organised Crime (UNTOC) and the relative additional protocols preventing the smuggling of migrants and trafficking of human beings. In February 2008 it also ratified the third and final protocol on arms trafficking. Since 1995, Albania has been a member country of the Council of Europe; in 2001 it became a member of the Group of States Against Corruption (GRECO) and in 2006 it also ratified the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). -

Transcription De L'audience De La CEIC Du 18 Septembre 2012
LA COMMISSION D'ENQUÊTE SUR L'OCTROI ET LA GESTION DES CONTRATS PUBLICS DANS L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE FRANCE CHARBONNEAU, J.C.S., présidente M. RENAUD LACHANCE, commissaire AUDIENCE TENUE AU 500, BOUL. RENÉ- LÉVESQUE OUEST À MONTRÉAL (QUÉBEC) LE 18 SEPTEMBRE 2012 VOLUME 13 ROSA FANIZZI MARC BEEBE Sténographes officiels RIOPEL, GAGNON, LAROSE & ASSOCIÉS 215, rue St-Jacques, Bureau 2010 Montréal (Québec) H2Y 1M6 COMPARUTIONS POUR LA COMMISSION : Me SONIA LEBEL, Me ÉLIZABETH FERLAND, INTERVENANTS : Me BENOIT BOUCHER, pour le Procureur général du Québec Me DANIEL ROCHEFORT, pour l'Association de la Construction du Québec Me SYLVIE CHAMPAGNE, pour Le Barreau du Québec Me ALEXIE LAFOND-VEILLEUX, pour le Directeur général des élections Me DENIS HOULE, pour l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec Me ISABELLE PIPON, pour l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec __________________________ Volume 13 Le 18 septembre 2012 - 3 - TABLE DES MATIÈRES PAGE PRÉLIMINAIRES. 4 VALENTINA TENTI EXAMINED BY Me SONIA LEBEL.. 7 ____________________ Volume 13 Le 18 septembre 2012 - 4 - LISTE OF EXHIBITS PAGE PIÈCE 7P-119 : Rapport - Framing Mafia Infiltration in the Public Construction Industry in Italy.. 8 PIÈCE 7P-120 : Curriculum vitae de Valentina Tenti, PhD en criminologie.. 9 PIÈCE 7P-121 : Power point utilisé par madame Tenti lors de son témoignage. 182 Volume 13 PRÉLIMINAIRES Le 18 septembre 2012 - 5 - 1 L'AN DEUX MILLE DOUZE, ce dix-huitième (18e) jour 2 du mois de septembre, 3 4 PRÉLIMINAIRES 5 6 LA PRÉSIDENTE : 7 Bon matin à tous. -

900-Criminale-2.0.Pdf
A cura dell’Associazione Lapsus 2 INDICE Prefazione 6. I riti della Mafia 1. Introduzione alla mostra 7. Gli anni settanta 7.1 POLITICA, CONFLITTI E MASSONERIA: LA 2. Italia liberale ‘NDRANGHETA SI ESPANDE 2.1 LE ORIGINI DELLA ‘NDRANGHETA: LA 7.2 L’ASCESA DELLA NUOVA CAMORRA PICCIOTTERIA CALABRESE ORGANIZZATA 2.2 LA BELLA SOCIETÀ RIFORMATA 7.3 LA CONQUISTA MAFIOSA DEL NARCOTRAFFICO 2.3 LA GENESI DELLA MAFIA: UN “CRIMINOSO 7.4 LEONARDO VITALE: IL PENTITO SODALIZIO” 2.4 UN OMICIDIO ECCELLENTE IL DELITTO 8. Pentitismo e Omertà NOTARBARTOLO 9. Gli anni ottanta 2.5 LA FINE DELLA BELLA CAMORRA 9.1 IL CONSOLIDAMENTO DEL POTERE 3. Il ventennio fascista ‘NDRANGHETISTA 3.1 ‘NDRANGHETA E FASCISMO: CONFLITTO E 9.2 IL CONFLITTO TRA NUOVA FAMIGLIA E NCO INTEGRAZIONE 9.3 L’ESCALATION DELLA VIOLENZA: LA SECONDA 3.2 IL “MAGGIORE DI FERRO” GUERRA DI MAFIA 3.3 LA MAFIA AI FERRI CORTI 9.4 IL TERREMOTO DEL 1980 IN CAMPANIA E IL 3.4 SBARCO ALLEATO SISTEMA DEGLI APPALTI 9.5 GIANCARLO SIANI 4. Il dopoguerra 4.1 L’ITALIA SCOPRE LA “‘NDRANGHITA” 10. Gli anni novanta 4.2 TRA CONTRABBANDO E AGGIOTAGGIO: LA 10.1 DA SAN LUCA A DUISBURG UN PRIMATO RINASCITA DELLA CAMORRA MONDIALE 4.3 TRA CITTÀ E CAMPAGNA: IL RIASSETTO DELLA 10.2 I NUOVI EQUILIBRI IN TERRA DI CAMORRA: MAFIA L’ASCESA DEI CASALESI 4.4 LA STRAGE DI PORTELLA DELLA GINESTRA 10.3 LE STRAGI DI MAFIA E L’AVVENTO DELLA 4.5 LA MAFIA “BUONA” SECONDA REPUBBLICA 10.4 IL MAXIPROCESSO 5. -

Mafia E Libertà Di Stampa: I Giornalisti Minacciati Dalla 'Ndrangheta
Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali Corso di laurea in Giornalismo e Cultura Editoriale MAFIA E LIBERTÀ DI STAMPA: I GIORNALISTI MINACCIATI DALLA ‘NDRANGHETA Relatore: Chiar.mo Prof. Paolo Ferrandi Correlatore: Chiar.mo Prof. Marco Deriu Laureanda: Chiara Fazio matr. 271230 Anno Accademico 2017/2018 Introduzione Gran parte degli studiosi contemporanei concorda nel considerare la ‘ndrangheta l’organizzazione criminale più potente al mondo: agendo sotto traccia, riuscendo quasi a far passare inosservata la sua intrinseca pericolosità e approfittando di un clima di silenzio e di omertà, essa è stata in grado nel volgere degli ultimi due secoli di trasformarsi da fenomeno delinquenziale rurale e prevalentemente locale a «multinazionale del crimine organizzato»1, la cui potenza è oggi assimilabile a quella della camorra e della mafia. Il suo ampio spettro di interessi va dall’appalto al subappalto di opere pubbliche, alla politica, al traffico internazionale di droga, all’estorsione, al riciclaggio, all’usura: è possibile sostenere, a ragione, che non vi sia oggi un aspetto della vita pubblica immune alla presenza della ‘ndrangheta. L’obiettivo che ci si è posti con questo lavoro di ricerca, in particolare, è stato analizzare il complesso rapporto tra la ‘ndrangheta - nei territori che da essa sono permeati - e la libertà di stampa, cercando di capire se e in che misura essa rappresenti un reale ostacolo alla libera circolazione dell’informazione nel nostro Paese, e non solo, oltre che un pericolo per l’incolumità, ed in certi casi la vita, dei cronisti che se ne sono occupati e continuano ad occuparsene. Partendo dallo studio del contesto storico-culturale in cui la mafia calabrese è nata e si è sviluppata, sono state delineate le tappe della sua genesi ed evoluzione. -

Cjccj.2017-0052.R1 Sergi 1..28
What’s in a Name? Shifting Identities of Traditional Organized Crime in Canada in the Transnational Fight against the Calabrian ‘Ndrangheta1 Anna Sergi* University of Essex Les autorite´s antimafia italiennes ont pre´venu la police canadienne des risques et des pre´occupations croissantes concernant l’infiltration de clans faisant partie de la mafia calabraise, connue sous le nom de ‘ndrangheta dans l’Est canadien2. L’alerte lie´e a` l’essor de la ‘ndrangheta de´fie les paradigmes du crime organise´ traditionnel au Canada parce que la ‘ndrangheta est pre´sente´e comme e´tant non seulement traditionnelle, mais aussi novatrice et plus omni- pre´sente que d’autres groupes de type mafia. En acce´dant a` des enqueˆtes confidentielles et en interviewant des spe´cialistes cle´s a` Toronto et a` Montre´al, cet article examine la perception institutionnelle actuelle de la mafia – particulie`rement la ‘ndrangheta – au Canada compare´e aux conceptualisations italiennes. Je soutiens que les changements de narratifs au Canada peuvent eˆtre compris en lien avec des changements concernant l’identite´ italienne dans le pays, allant vers une re´gionalisation et une connaissance spe´cialise´e des diffe´rences ethniques. Mots cle´s : mafia, crime organise´ italien, police, mobilite´ de la mafia, migration italienne, crime organise´ The Italian antimafia authorities have warned Canadian law enforcement about the risks and the growing concerns for the infiltration of clans of the Calabrian mafia, known as ‘ndrangheta, in Eastern Canada3. The alarm linked to the rise of the ‘ndrangheta challenges the paradigms of traditional organized crime in Canada, because the ‘ndrangheta is presented as tradi- tional but also innovative and more pervasive than other mafia-type groups. -
Famille Rizzuto
Famille Rizzuto Le clan Rizzuto est une des principales « familles » mafieuses de Montréal. Elle fut dirigée par la famille Rizzuto à Montréal. Sa zone d'influence couvre le Québec et le sud de 1 2 l'Ontario . Le FBI considère la famille Rizzuto comme étant affiliée à la famille Bonanno , tandis que la police canadienne la considère comme une famille du crime indépendante et La Famille Rizzuto autonome. Sommaire Historique Panorama de Montréal en 2006 Création et l'ère de Vic Cotroni L'ère de Vito Rizzuto Date de 1953 La « Sixième famille » fondation Répression des autorités et assassinats en série Fondé par Nicolo Rizzuto Quelques membres Lieu Montréal Famille Rizzuto Territoire Canada Leaders Année Années 1953- Autres Membres active actuellement Activités internationales Ethnies Italo-canadiens, Italiens et Activités en Italie présentes d'autres ethnies en tant « Made in Italy » qu'associés Pont de Messine Nombre de 500 membres et une membres centaine d'associés Notes et références Activités Sources criminelles Extorsion de fonds Articles connexes Racket Prêt usuraire Historique Assassinat Blanchiment d'argent Trafic de drogue Création et l'ère de Vic Cotroni Paris et jeux clandestins La famille est créée par Carmine "Lilo" Galante en 1953, sur ordre de Joseph "Joe Bananas" Bonanno, le parrain de la famille Bonanno. L'organisation change de leadership en 1957 Alliés Bonanno, Famille avec l'arrestation de Galante. Elle est récupérée par son bras-droit, Vincenzo "Vic" Cotroni, aussi connu sous le pseudo de "The Egg" (l'œuf), devenant alors la famille Cotroni. Cette Cuntrera-Caruana, Hells organisation est alors principalement constitué de Calabrais. -

I Padrini Del Ponte. Affari Di Mafia Sullo Stretto Di Messina
Tempi moderni I Padrini del Ponte Affari di mafia sullo stretto di Messina di Antonio Mazzeo Per favorire la libera circolazione della cultura, è consentita la riproduzione di questo volume, parziale o totale, a uso personale dei lettori purché non a scopo commerciale. © 2010 Edizioni Alegre - Soc. cooperativa giornalistica Circonvallazione Casilina, 72/74 - 00176 Roma e-mail: [email protected] Analisi, notizie e commenti sito: www.edizionialegre.it www.ilmegafonoquotidiano.it Indice Prefazione. Il Ponte e le mafie: uno spaccato di capitalismo reale 7 Solo pizzi e dintorni? 7 L’inchiesta Brooklyn e il contesto mondiale 8 Avvertenza e ringraziamenti 13 Capitolo uno. Brooklyn, la mafia del Ponte 17 Premiata ditta Zappia & soci... 17 «...Il Ponte lo faccio io...» 20 Il segreto d’onore 23 L’odore dei soldi 25 Il Principe Bin d’Arabia 28 Capitolo due. Il clan dei canadesi 31 A Scilla la ’ndrangheta, a Cariddi la mafia 32 Per riscuotere dall’emiro 34 Una holding made in Siculiana 36 Ci vediamo tutti al Reggio Bar 37 L’internazionale degli stupefacenti 40 L’ascesa di don Vito 42 I nuovi manager della coca 45 L’Uomo del Colosseo 48 Capitolo tre. I Signori delle Antille 53 Tra corsari e governatori 56 Le amicizie pericolose di Trinacrialand 58 Come invecchiare all’ombra del Ponte 62 Alla fine arrivò il Pippo d’America 65 Le Terrazze sullo Stretto 68 La guerra per gli appalti 69 Il ponte riemerso di Tourist e Caronte 74 Alla conquista dell’Est 77 Campione dell’undici settembre 81 Grandi mercanti sauditi 86 Kabul-Messina la rotta dei capi dei servizi segreti 89 Moschee, dissalatori, armi.. -

Praying Against Worldwide Criminal Organizations.Pdf
o Marielitos · Detroit Peru ------------------------------------------------- · Filipino crime gangs Afghanistan -------------------------------------- o Rathkeale Rovers o VIS Worldwide § The Corporation o Black Mafia Family · Peruvian drug cartels (Abu SayyafandNew People's Army) · Golden Crescent o Kinahan gang o SIC · Mexican Mafia o Young Boys, Inc. o Zevallos organisation § Salonga Group o Afridi Network o The Heaphys, Cork o Karamanski gang § Surenos or SUR 13 o Chambers Brothers Venezuela ---------------------------------------- § Kuratong Baleleng o Afghan drug cartels(Taliban) Spain ------------------------------------------------- o TIM Criminal o Puerto Rican mafia · Philadelphia · TheCuntrera-Caruana Mafia clan § Changco gang § Noorzai Organization · Spain(ETA) o Naglite § Agosto organization o Black Mafia · Pasquale, Paolo and Gaspare § Putik gang § Khan organization o Galician mafia o Rashkov clan § La ONU o Junior Black Mafia Cuntrera · Cambodian crime gangs § Karzai organization(alleged) o Romaniclans · Serbian mafia Organizations Teng Bunmaorganization § Martinez Familia Sangeros · Oakland, California · Norte del Valle Cartel o § Bagcho organization § El Clan De La Paca o Arkan clan § Solano organization Central Asia ------------------------------------- o 69 Mob · TheCartel of the Suns · Malaysian crime gangs o Los Miami o Zemun Clan § Negri organization Honduras ----------------------------------------- o Mamak Gang · Uzbek mafia(Islamic Movement of Uzbekistan) Poland ----------------------------------------------- -

Grandeur Et Misère Du Clan Sicilien Au Québec TABLE DES MATIÈRES
André Cédilot André Noël LE LIVRE QUI A INSPIRÉ LE FILM Grandeur et misère du clan sicilien au Québec TABLE DES MATIÈRES Préface . .7 Chapitre un : Cadavres . 11 Chapitre deux : Vendetta . 28 Chapitre trois : De Cattolica Eraclea à Montréal . 48 Chapitre quatre : Siciliens contre Calabrais . 69 Chapitre cinq : Assassinats . .90 Chapitre six : Les narco-bourgeois . 110 Chapitre sept : Haschisch et cocaïne . 131 Chapitre huit : Du Venezuela à l’Italie . 150 Chapitre neuf : Opération Compote . 169 Chapitre dix : Les grands jeux financiers . 189 Chapitre onze : Le projet Omertà . 209 Chapitre douze : La conquête de l’Ontario. 233 Chapitre treize : Mafia inc. 254 Chapitre quatorze : Le parrain sous écrou . 276 Chapitre quinze : Les relations exquises . 293 Chapitre seize : Opération Colisée . 313 Chapitre dix-sept : La pieuvre . 344 Chapitre dix-huit : La débandade. 367 Épilogue . 405 Chronologie . 431 Lexique . .437 Bibliographie . .439 Index . 447 Remerciements . 461 pp 001-464.indd 463 12-05-11 4:38 PM CHAPITRE UN Cadavres es terrains vagues ont toujours attiré et attireront toujours les Lenfants. Ceux d’Ozone Park ne font pas exception. Les enfants de ce quartier de Queens, un des cinq districts de New York, ressemblent à tous les enfants du monde : ils aiment explorer les lopins de terre négligés par les grandes personnes, où les herbes folles poussent en toute liberté, dans un désordre qui stimule l’imagination. Sous les tas de gravats se cachent des trésors. Ou des cadavres. Au 19e siècle, les maraîchers cultivaient encore des légumes dans ce secteur de Long Island. Un entrepreneur y élevait des chèvres, pas tant pour le lait ou la viande que pour le cuir, dont il faisait des gants.