Alberti 2010 Web.Indd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
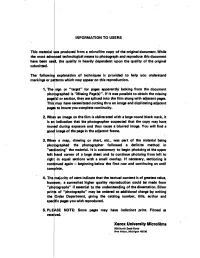
Xerox University Microfilms
INFORMATION TO USERS This material was produced from a microfilm copy o f the original document. While the most advai peed technological meant to photograph and reproduce this document have been useJ the quality is heavily dependent upon the quality of the original submitted. The followini explanation o f techniques is provided to help you understand markings or pattei“ims which may appear on this reproduction. 1. The sign or “ target" for pages apparently lacking from die document phoiographed is “Missing Page(s)". If it was possible to obtain the missing page(s) or section, they are spliced into the film along with adjacent pages. This| may have necessitated cutting thru an image and duplicating adjacent pages to insure you complete continuity. 2. Wheji an image on the film is obliterated with a large round black mark, it is ar indication that the photographer suspected that the copy may have mo1vad during exposure and thus cause a blurred image. You will find a good image of the page in the adjacent frame. 3. Wheh a map, drawing or chart, etc., was part of the material being photographed the photographer followed a definite method in 'sectioning" the material. It is customary to begin photoing at the upper left hand corner of a large sheet and to continue photoing from left to righj in equal sections with a small overlap. If necessary, sectioning is continued again - beginning below the first row and continuing on until com alete. 4. The majority of users indicate that the textual content is of greatest value, ho we ver, a somewhat higher quality reproduction could be made from "ph btographs" if essential to the understanding of the dissertation. -

The Image of States, Nations and Religions in Medieval and Early Modern East Central Europe
The Image of States, Nations and Religions in Medieval and Early Modern East Central Europe THE IMAGE OF STATES, NATIONS AND RELIGIONS IN MEDIEVAL AND EARLY MODERN EAST CENTRAL EUROPE Edited by Attila Bárány and Réka Bozzay, in co-operation with Balázs Antal Bacsa Debrecen 2018 MEMORIA HUNGARIAE 2 SeriesMEMORIA Editor: HUNGARIAEAttila Bárány 5 Series Editor: Attila Bárány Published by the Hungarian Academy of Sciences - University of Debrecen “Lendület” PublishedHungary by the Hungarian in Medieval Academy Europe ofResearch Sciences Group - University (LP-2014-13/2014) of Debrecen “Lendület” Hungary in Medieval Europe Research Group (LP-2014-13/2014) Editor-in-Chief: Attila Bárány Editor-in-Chief: Attila Bárány Sponsord by the Hungarian Academy of Sciences, Office for Research Groups Sponsored by the Hungarian Academy of Sciences, Office for Research Groups Copy-editor: Copy-editor: Balázs Balázs Antal Antal Bacsa Bacsa Desktop editing, layout and cover design by Desktop editing, layout and cover design by Anett Lapis-Lovas – Járom Kulturális Egyesület Anett Lapis-Lovas – Járom Kulturális Egyesület ISBN 978-963-508-881-2 ISBNISSN 978-963-508-833-1 2498-7794 ISSN 2498-7794 © “Lendület” Hungary in Medieval Europe Research Group, 2018 © “Lendület” Hungary ©in TheMedieval Authors, Europe 2018 Research Group, 2016 © The Authors, 2016 All rights reserved. No part of thisAll publication rights reserved. may be reproduced, stored in a retrievalNo part system,of this publication or transmitted may in be any reproduced, form or by any means, storedelectronic, in a retrieval mechanical, system, or photocopying, transmitted in recording, any form oror otherwise,by any means, electronic,without mechanical, the prior writtenphotocopying, permission recording, of the orPublisher. -

Bulletin of Scientific and Art Research
ISSN 2466-5150 SERBIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS 2018 BULLETIN OF SCIENTIFIC AND ART RESEARCH Annual Report for 2018 SASA – BULLETIN OF SCIENTIFIC AND ART RESEARCH Annual Report for RESEARCH ART AND – BULLETIN OF SCIENTIFIC SASA BELGRADE 2019 BULLETIN OF SCIENTIFIC AND ART RESEARCH Annual Report for 2018 ISSN 2466-5150 SERBIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS BULLETIN OF SCIENTIFIC AND ART RESEARCH Annual Report for 2018 BELGRADE 2019 Editorial Board Academician Vidojko Jović Academician Ivan Gutman Academician Zoran V. Popović Academician Veselinka Šušić Academician Aleksandar Loma Academician Časlav Ocić Academician Momčilo Spremić Academician Todor Stevanović Editor Academician Vidojko Jović Editor-in-Chief Academician Marko Anđelković Published and Printed Serbian Academy of Sciences and Arts Belgrade, 35 Kneza Mihaila Street www.sanu.ac.rs Translation and Editing Vera Gligorijević Natalija Stepanović Layout Kranislav Vranić 200 Copies © Serbian Academy of Sciences and Arts 2019 CONTENTS Editor’s Note . 7 DEPARTMENT OF MATHEMATICS, PHYSICS AND EARTH SCIENCES 11 EARTH SCIENCES . 11 MATHEMATICS . 20 PHYSICS AND METEOROLOGY . 27 DEPARTMENT OF CHEMICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES . 41 PHYSICAL CHEMISTRY . 41 CHEMISTRY . 42 BIOLOGY . 49 DEPARTMENT OF TECHNICAL SCIENCES. 61 DEPARTMENT OF MEDICAL SCIENCES . 73 DEPARTMENT OF LANGUAGE AND LITERATURE. 105 DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES . 119 DEPARTMENT OF HISTORICAL SCIENCES . 127 DEPARTMENT OF FINE ARTS AND MUSIC . 139 CENTRE FOR SCIENTIFIC RESEARCH OF THE SASA AND UNIVERSITY OF KRAGUJEVAC. 145 -

L'empereur Hagiographe
New Europe College – Institut d’études avancées & Institut des Études Sud-Est Européennes de l’Académie Roumaine Revue des Études Sud Est Européennes L’empereur hagiographe Culte des saints et monarchie byzantine et post-byzantine Textes réunis et prescutés par Petre Guran L’EMPEREUR HAGIOGRAPHE Culte des saints et monarchie byzantine et post-byzantine Actes des colloques internationaux « L’empereur hagiographe » (13-14 mars 2000) et « Reliques et miracles » (1-2 novembre 2000) tenus au New Europe College Textes réunis et présentés par Petre Guran avec la collaboration de Bernard Flusin 3 Image de la couverture I : l’empereur Léon VI dans la coupole centrale du narthex de l’église du monastère de Horezu (photo P. Guran, avec la permission de l’abbesse de Horezu). Série des publications RELINK du New Europe College L’empereur hagiographe Copyright © 2001 - Colegiul Noua Europã ISBN 973 – 98624 – 6 – 2 4 Auteurs Bernard Flusin, professeur des Universités à l’Université Paris IV- Sorbonne , directeur d’études à l’École pratique des Hautes Études , chaire « Christianisme byzantin ». Dumitru Nãstase, Chercheur honoraire du Centre National de la Recherche Scientifique d’Athènes , Docteur de l’Université Paris I Sorbonne , Docteur Honoris Causa de l’Université de Jassy (Roumanie) , chargé de recherche de l’Institut d’Histoire de l’Art de Bucarest , jusqu’en 1972. Bos∨ko Bojovic’ , Professeur des Universités, Directeur d’études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, Directeur de recherches à l’Institut des Études Balkaniques de l’Académie Serbe des Sciences et des Arts. Petre Guran, Élève de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales , chercheur à l’Institut des Études Sud-Est Européennes de Bucarest , Fellow RELINK of the New Europe College , Junior Fellow of the World Academy for Art and Sciences. -

1 S Blagoslovom Wegovog Preosve{Tenstva Episkopa Ni{Kog
S blagoslovom Wegovog preosve{tenstva Episkopa Ni{kog gospodina Irineja [tampawe ~asopisa Crkvene studije omogu}ilo je Ministarstvo vera Republike Srbije 1 CHURCH STUDIES Annual Journal of the Centre of Church Studies Year I Number 1 The Centre of Church Studies Ni{, 2004. 2 Godi{wak Centra za crkvene studije Godina I Broj 1 Centar za crkvene studije Ni{, 2004. 3 CRKVENE STUDIJE / CHURCH STUDIES ISSN 1820-2446 Izdava~ Centar za crkvene studije, Ni{ Redakcija Dr Angeliki Delikari (Solun), dr Vera Georgieva (Skopqe), dr Ivan Hristov (Veliko Trnovo), dr Rostislav Stankov (Sofija), dr Jon Petrulesku (Temi{var), dr Branislav Todi} (Beograd), dr Boris Brajovi} (Nik{i}), dr Predrag Mateji} (Kolumbus), dr Nenad @ivanovi} (Ni{), dr Grozdanko Grbe{a (Ni{), dr Sla|ana Risti} Gorgiev (Ni{), mr Vladimir Cvetkovi} (Ni{), sekretar Urednik Dr Dragi{a Bojovi} (Ni{) Adresa Centar za crkvene studije 18000 Ni{, Branka Radi~evi}a br. 1 (MK „Gavrilo Princip”) telefoni: 063 847 84 99 i 063 445 131 e-mail: [email protected] [email protected] `iro ra~un: 160-19684-97 Grafi~ko re{ewe naziva ~asopisa Svetozar Paji} Dijak Ilustracija na korici Zastavica u de~anskom ^etvorojevan|equ (posledwa ~etvrtina XIV veka, br. 6) Univerzalna decimalna klasifikacija Sne`ana Bojovi} i Vesna Risti} [tampa PUNTA -Ni{ Tira` 500 primeraka Radovi se recenziraju. 4 SADR@AJ Uz prvi broja ~asopisa Crkvene studije .................................................................... 9 I @an-Klod Lar{e [ta je bogoslovqe? Qu’est-ce que la théologie? ................................................................................................. 13 Valentina Gulevska ^ove~kata priroda i nejzinata sposobnost za bogopoznanie spored u~eweto na kapadokiskite otci ^ovekova priroda i wena sposobnost za bogospoznawe prema u~ewu kapadokijskih otaca ..................................................................................................... -

Editing in a Sixteenth-Century Serbian Manuscript (HM.SMS. 280) a Lexical Analysis with Comparison to the Russian Original Diss
Editing in a Sixteenth-Century Serbian Manuscript (HM.SMS. 280) A Lexical Analysis with Comparison to the Russian Original Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By !ivojin Jakovljevi", M.A. Graduate Program in Slavic and East European Languages and Literatures The Ohio State University 2011 Dissertation Committee: Dr. Daniel E. Collins, Adviser Dr. Charles Gribble Dr. Predrag Mateji" Copyright by !ivojin Jakovljevi" 2011 ABSTRACT This study encompasses an analysis of the language found in the first Serbian copy of The History of the Jewish War (HM.SMS.280) compared to its Russian original (HM.SMS.281). This research follows the clues in the colophon written by the Serbian scribe, the hieromonk Grigorije Vasilije, in which he states that the Serbian people could not understand the Russian words of the original manuscript. For this reason, Grigorije Vasilije states, he had to “translate” the unknown words into Serbian. Since the Serbian manuscript consists of a large number of folia, 255 of them, a sampling approach was used, whereby eight folia from six sections were extracted and analyzed. The results of the findings identify a number of lexical variations which were distinctive in Serbian and the Russian recensions at the end of the sixteenth century. Some of the lexemes found in the Serbian manuscript are attested for the first time, and as such they make an addition to our knowledge of medieval Serbian lexicography. The findings of this research show that many of the hard-to-understand words were very specific technical terms from military vocabulary—not words that a monk (or most laymen) could be expected to know. -

Balkan Slavic Literatures: Reading List and Bibliography Petko Ivanov Connecticut College, [email protected]
Connecticut College Digital Commons @ Connecticut College Slavic Studies Faculty Publications Slavic Studies Department 1998 Balkan Slavic Literatures: Reading List and Bibliography Petko Ivanov Connecticut College, [email protected] Follow this and additional works at: http://digitalcommons.conncoll.edu/slavicfacpub Part of the Slavic Languages and Societies Commons Recommended Citation Ivanov, Petko, "Balkan Slavic Literatures: Reading List and Bibliography" (1998). Slavic Studies Faculty Publications. 13. http://digitalcommons.conncoll.edu/slavicfacpub/13 This Article is brought to you for free and open access by the Slavic Studies Department at Digital Commons @ Connecticut College. It has been accepted for inclusion in Slavic Studies Faculty Publications by an authorized administrator of Digital Commons @ Connecticut College. For more information, please contact [email protected]. The views expressed in this paper are solely those of the author. BALKAN SLAVIC LITERATURES READING LIST AND BIBLIOGRAPHIC GUIDE Petko Ivanov Department of Slavic Languages & Literature & Department of Anthropology, University of Chicago I. Defining "Balkan Slavic" The failure of the Yugoslav idea made obvious by the collapse of Yugoslavia posed the issue of developing new paradigms by which the literary and cultural legacy of the Southern Slavs can be discussed adequately in a political context now transformed. Two such paradigms are being currently proposed: the Balkan and the Central European one. This dichotomy reflects the actual split of the Southern Slavs along a borderline that separates two cultural-cum-political zones. The distinctions between these zones are traditionally articulated in several idioms: [1] in confessional terms (Eastern Orthodoxy vs. Catholicism); [2] in terms of political history (the Ottoman vs. the Austro-Hungarian empires); [3] in geographical terms (the Balkan region vs. -

Prawosławie, Historia, Naród
PRAWOSŁAWIE HISTORIA NARÓD Miejsce kultury duchowej w serbskiej tradycji i współczesności Dorota Gil Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Publikacja finansowana przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Filologii Słowiańskiej UJ RECENZENT prof. dr hab. Maria Dąbrowska-Partyka PROJEKT OKŁADKI Marcin Bruchnalski Na okładce fragment lozy Niemanjiciów z monasteru Dečani (fotografia ze zbiorów autorki) REDAKCJA Lucyna Sadko KOREKTA Dorota Janeczko © Copyright by Dorota Gil & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2005 All rights reserved ISBN 83-233-1951-0 www.wuj.pl Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Karmelicka 27/4, 31-131 Kraków tel. (012) 423-31-87, tel./fax (012) 423-31-60 Dystrybucja: ul. Bydgoska 19 C, 30-056 Kraków tel. (012) 638-77-83, (012) 636-80-00 w. 2022 fax (012) 423-31-60, (012) 636-80-00 w. 2023 tel. kom. 0506-006-674, e-mail: [email protected] Konto: BPH PBK SA IV/O Kraków, nr 62 1060 0076 0000 3200 0047 8769 SPIS TREŚCI WSTĘP ................................................................................................................... 7 CZĘŚĆ I: U ŹRÓDEŁ TRADYCJI Świętosawski fundament kultury....................................................................... 19 Średniowieczne piśmiennictwo serbskie jako dokument stanu świadomości narodowej..................................................................................................... 43 Państwo/Naród – Cerkiew i specyfika serbskiej religijno-narodowej koncepcji diarchii ........................................................................................................ -
The Heavenly Kingdom in Serbia's Historic Destiny
The Heavenly Kingdom in Serbia’s Historic Destiny The Heavenly Kingdom in Serbia’s Historic Destiny Bishop Atanasije Jevtić he Serbian people began to formulate their spiritual This preference for spiritual values became an insepa- identity during the era of the Holy Brothers Cyril and rable part of the Serbian national soul, as well as its life- Methodius (9th century), and their five disciples who blood in the early stages of its history. The first evidence of Tfollowed (10th century). They are considered the first bap- this appeared among the Serbian saints, who through their tizers and enlighteners of the Serbs, as well as the other asceticism, virtues, and suffering were constructing a spir- Slavs. The fruit of their work, harvested for some two cen- itual ladder to the Kingdom of Heaven for their people and turies from Byzantium and Bulgaria to the Adriatic, includ- who exemplified through their lives the manner in which ed the gradual Christianization of the Serbs both nation- the world, the path of history, and man’s deeds within it ally and individually, the appearance of the first ascetics should be evaluated. and saints among the Serbs, and the first monuments of Thanks to the extraordinary personhood of Saint Sava Serbia’s spiritual and secular cultures. (1175–1235) and his labor among the Serbs, this Orthodox Starting with the time they accepted Orthodoxy and Christian choice became the inherent self-identity of the considering the subsequent history and behavior of the Serbian people. Saint Sava has been rightfully called the Serbs, it is easy to discern the basic nature of their spiritual all-Serbian “enlightener, the first enthroned, the Teacher of identity. -

The Corpus of Serbian Language CSL Was Compiled from a Sample of 11
Преглед НЦД 24 (2014), 35–42 Aleksandar Kostić Faculty of Philosophy University of Belgrade Serbia ELECTRONIC CORPUS OF SEBIAN LANGUAGE FROM 12TH TO 18TH CENTURY In the mid 1950s at the Institute for Experimental Phonetic and Speech Pathology, Prof. Đorđe Kostić, at that time the director of the Institute, initiated a project of machine translation and automatic speech and text recognition. Professor Kostić, who directed this project, was of the opinion that the problem of automatic text and speech recognition could not be solved algorithmically and that a probabilistic approach is more plausible. However, a probabilistic approach required compilation of an annotated corpus that will provide precise probability estimates of all aspects of language – from phonology to syntax. This was the impetus that brought to the compilation of the Corpus of Serbian Language. The Corpus is diachronic, encompassing the Serbian language from the 12th century to the contemporary language, with 11 million words, each word being manually annotated for its grammatical status. There were two principal aspects of this project. On the one hand, it was necessary to build up the system of annotation, while on the other hand the corpus had to be representative in order to provide reliable probability estimates. The annotation implied that each word from the corpus should be defined in terms of its grammatical (i.e. morphological status). Available grammars of the Serbian (Serbo- Croatian) language did not seem to satisfy this requirement because at some instances they could not provide a strict specification for each word from the corpus (e.g. constituents of some complex verb tenses). -

Dragoljub Marjanović (Faculty of Philosophy – Belgrade)
Ni{ i Vizantija XVI 41 Dragoljub Marjanović (Faculty of Philosophy – Belgrade) EMERGENCE OF THE SERBIAN CHURCH IN RELATION TO BYZANTIUM AND ROME1 In this paper we aim to analyze and present preliminary toughts concern- ing the multifaceted process of the emergence of the Serbian church in the 13th century, with focus on the Roman origin of the Serbian royal crown, and how such an event shaped the identity of the newly established Church in Serbia. St. Sava‘s first hagiographer - Domentijan, gave an account of a specific „Oration about the true faith“ wich was delivered before the roman-appointed king of Serbia. The Oration itself is vested in Byzantine theological tought and the heri- tage of the Ecumenical councils.2 It should also be examined whether such a text actually had its roots in previous Byzantine theological treatises composed in the 11th and 12th centuries. Literary and rhetorical shaping of such a narra- tive in St. Sava‘s Life alludes that both the kingdom and the church in Serbia worked together in establishing both poles of secular and spiritual power in the state. Moreover, taking such historical contexts into consideration the emer- gance of the Serbian church should be analyzed in its relations both towards distant centers of Byzantium (Nicaea) and Rome, but also with more focus on the neighbouring polities and ecclesiastical centeres falling under Rome‘s spiri- tual authority, in Hungary and the maritime bishoprics of Bar and Dubrovnik. From the invented story about the conversion to Orthodoxy of the Hungarian king -

Centre AIXOIS D'etudes Romanes, EA
Studii de ştiinţă şi cultură Volumul XI, Nr. 4, decembrie 2015 TRANSLATING THE CENTRE AND PERIPHERY: AN EXAMPLE OF FRENCH AND SERBIAN MEDIEVAL LITERATURE TRADUCEREA CENTRU ȘI PERIFERIE: UN EXEMPLU DE LITERATURĂ MEDIAVELĂ SÂRBEASCĂ ȘI FRANCEZĂ Diana POPOVIĆ University of Novi Sad Faculty of Philosophy Department of Romance Studies Dr Zorana Đinđića 2, 21000 Novi Sad [email protected] Tatjana ĐURIN University of Novi Sad Faculty of Philosophy Department of Romance Studies Dr Zorana Đinđića 2, 21000 Novi Sad [email protected] Abstract This research, based on the Polysystem theory suggested by Itamar Even-Zohar, deals with two main questions: a position and a role of French medieval literature as translated literature within the literary system of Serbian/Yugoslav literature, and a position of the Serbian medieval literature as translated literature within French literary system. Results of researched repertoire of those two translated literatures defy some postulates of the Polysystem theory. Nevertheless, those two literatures have positions that are expected, i. e. a central position for the system of the French medieval literature and a peripheral one for the Serbian medieval literature as translated literature within another literary system. Résumé Cette recherche, basée sur la théorie des polysystèmes suggérée par Itamar Even-Zohar, traite de deux questions principales: d’abord, la position et le rôle de la littérature médiévale française en tant que littérature traduite dans le système littéraire de la littérature serbe/yougoslave, et puis, la position de la littérature médiévale serbe en tant que littérature traduite dans le système littéraire français. Les résultats des recherches de ces deux littératures traduites semblent récuser certains postulats de la théorie des polysystèmes.