L'arte Del Primo Rinascimento
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
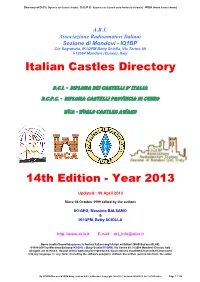
14Th Edition - Year 2013
Directory of D.C.I. Diploma dei Castelli d'Italia) - D.C.P.C. (Diploma dei Castelli della Provincia di Cuneo) - WCA (World Castles Award) A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Mondovì - IQ1BP C/o Segreteria, IK1QFM Betty Sciolla, Via Torino 89 I-12084 Mondovì (Cuneo), Italy Italian Castles Directory D.C.I. - DIPLOMA DEI CASTELLI D’ ITALIA D.C.P.C. - DIPLOMA CASTELLI PROVINCIA DI CUNEO WCA - WORLD CASTLES AWARD 14th Edition - Year 2013 Updated : 09 April 2013 Since 04 October 1999 edited by the authors IK1GPG, Massimo BALSAMO & IK1QFM, Betty SCIOLLA http://www.dcia.it E-mail: [email protected] Opera Inedita Depositata presso la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE-Sezione OLAF). ®1999-2016 by Massimo Balsamo IK1GPG e Betty Sciolla IK1QFM, Via Torino 89, I-12084 Mondovì (Cuneo), Italy All rights are reserved. No part of this work may be reproduced, disassembled, trasmitted, transcribed, translated into any language in any form (including the software program) without the written permission from the editor. By IK1GPG Max and IK1QFM Betty, Sezione A.R.I. di Mondovì, Copyright 1999-2016, Updated 09/04/2013. No.12.634 Castles Page 1 / 135 Directory of D.C.I. Diploma dei Castelli d'Italia) - D.C.P.C. (Diploma dei Castelli della Provincia di Cuneo) - WCA (World Castles Award) № DCI № WCA NAME OF CASTLES PREFIX PROVINCE DCI-AG001 I-00001 Porta di Ponte o Atenea di Agrigento IT9 Agrigento DCI-AG002 I-00002 Castello di Burgio IT9 Agrigento DCI-AG003 I-00003 Torre di Castellazzo a Camastra IT9 Agrigento DCI-AG004 I-00004 Forte -

Orsanmichele and the History and Preservation of the Civic Monument
Orsanmichele and the History and Preservation of the Civic Monument Edited by CARL BRANDON STREHLKE National Gallery of Art, Washington Distributed by Yale University Press New Haven and London Contents vii Preface ELIZABETH CROPPER ix Foreword CRISTINA ACI DI N I i Introduction CARL BRANDON STREHLKE 7 "Degno templo e tabernacol santo": Remembering and Renewing Orsanmichele DIANE FINIELLO ZERVAS 2i Orsanmichele before and after the Niche Sculptures: Making Decisions about Art in Renaissance Florence CARL BRANDON STREHLKE 3 5 Designing Orsanmichele: The Rediscovered Rule MARIA TERESA BARTOLI 53 Andrea Pisano's Saint Stephen and the Genesis of Monumental Sculpture at Orsanmichele ENRICA NERI LUSANNA 75 Giovanni di Balduccio at Orsanmichele: The Tabernacle of the Virgin before Andrea Orcagna FRANCESCO CAGLIOTI iii The Limestone Tracery in the Arches of the Original Grain Loggia of Orsanmichele in Florence GERT KREYTENBERG 125 The Trecento Sculptures in the Exterior Tabernacles at Orsanmichele ALESSANDRA GRIFFO 139 If Monuments Could Sing: Image, Song, and Civic Devotion inside Orsanmichele BLAKE WILSON 1 69 Orsanmichele: The Birthplace of Modern Sculpture ARTUR ROSENAUER 179 Restoration of the Statues in the Exterior Niches at Orsanmichele ANNAMARIA GIUSTI 187 The Fat Stonecarver MARY BERGSTEIN 197 Saint Peter of Orsanmichele LUCIANO BELLOSI 2 i 3 A More "Modern" Ghiberti: The Saint Matthew for Orsanmichele ELEONORA LUCIANO 243 Ghiberti's Saint Matthew and Roman Bronze Statuary: Technical Investigations during Restoration EDILBERTO FORMIGLI 257 Predella and Prontezza: On the Expression of Donatello's Saint George ARJAN R. DE KOOMEN 279 Scientific Investigations of the Bronze and Marble Statues of Orsanmichele MAURO MATTEINI 289 Words on an Image: Francesco da Sangallo's Sant'Anna Metterza for Orsanmichele COLIN EISLER WITH THE COLLABORATION OF ABBEY KORNFELD AND ALISON REBECCA W. -

Vol 3 Issue 2 Artistic Impression
Vol. 3, Issue 2 February, 2021 Burlington Artists League A Word from the President Dear BAL members, Welcome to the February edition of our newsletter. Our previous editor has resigned and until we can find another one, Angela Bostek is serving as our interim editor, taking on yet another responsibility. Our profound thanks, Angela. The month of February conjures up associations with the bleak mid-winter season. On the other hand, it anticipates the arrival of spring, especially if the ground-hog’s prognostications are correct. For us, it means the Small Art Contest. I am pleased that the contest this year has been a success. The entries were as fine as ever and my thanks to all participants and congratulations to the winners! Unfortunately, due to Covid restrictions, we could not have our usual reception to honor the winners. However, as usual, all entries will be on display for the month of February. Please take an hour or so during the month to drop by the gallery to admire all the art submitted for the contest. It’s quite impressive. Now we look forward to the next competition in April. Further information will be forthcoming, watch your email. We hope you will join us for our monthly business meeting by way of Zoom on Thursday, February 18, at 3 p.m. One of the main agenda items will be a discussion of possibly adding a competition at the end of the summer and your input is valuable. In the meantime, stay warm and safe. Jane ********* FEBRUARY CALENDAR OF EVENTS 1st – 28th 14th 18th Jan 22 – Feb 18 Feb. -

Bibliografia E Indici
Bibliografia e Indici Bibliografia Ci si preoccupa, in qualche caso a ragione, di verificare l’esattezza delle notizie storiche che ormai molti di noi traggono dai vari siti internet; tuttavia, ho dovuto constatare con sorpresa quante contraddizioni vi siano, su uno stesso argomento, sui libri cartacei. Ciò mi ha costretto a verificare più volte l’esattezza delle informazioni, scegliendo poi quelle che mi sembravano maggiormente sostenute da argomenti validi. I dati invece tratti dai siti internet sono stati utilizzati solo se comprovati da fonti cartacee. Ricordo comunque che, se si vuole capire la storia, non è importante conoscere con esattezza l’anno, per esempio, in cui un palazzo pubblico piuttosto che una chiesa è stata edificata, bensì cercare di cogliere lo “spirito del tempo” che sta dietro a quella decisione. Particolarmente impegnativa (ma appassionante) è stata la parte relativa alla struttura della città, sia dal punto di vista testuale che iconografico, così come non facile (ma altrettanto interessante) è stato individuare i caratteri sostanziali dell’esperienza comunale in tutte le sue varie fasi. Ho dato poi spazio a tre argomenti cruciali nella storia della città: il Risanamento, in occasione di Firenze Capitale (capitolo X); le conseguenze del bombardamento subito dalla città nella Seconda Guerra Mondiale (capitolo XI) e gli eventi relativi all’alluvione del 1966 (capitolo XII). Mi riconosco invece tributario al lavoro realizzato da vari altri autori per ciò che concerne le informazioni (ma non i giudizi) relativi alla parte dedicata alle Corporazioni Arti e Mestieri (capitolo IV) nonché al racconto della Congiura dei Pazzi (capitolo VI). Infine, per tentare di districarmi nelle vicende dinastiche, mi sono servito, rielaborandolo assai, del testo dedicato da Franco Cesati nel suo libro I Medici, Storia di una dinastia europea, al periodo compreso tra la caduta di Piero lo Sfortunato (1494) e l’avvento di Cosimo I (1537). -

Renaissance Art in Rome Giorgio Vasari: Rinascita
Niccolo’ Machiavelli (1469‐1527) • Political career (1498‐1512) • Official in Florentine Republic – Diplomat: observes Cesare Borgia – Organizes Florentine militia and military campaign against Pisa – Deposed when Medici return in 1512 – Suspected of treason he is tortured; retired to his estate Major Works: The Prince (1513): advice to Prince, how to obtain and maintain power Discourses on Livy (1517): Admiration of Roman republic and comparisons with his own time – Ability to channel civil strife into effective government – Admiration of religion of the Romans and its political consequences – Criticism of Papacy in Italy – Revisionism of Augustinian Christian paradigm Renaissance Art in Rome Giorgio Vasari: rinascita • Early Renaissance: 1420‐1500c • ‐‐1420: return of papacy (Martin V) to Rome from Avignon • High Renaissance: 1500‐1520/1527 • ‐‐ 1503: Ascension of Julius II as Pope; arrival of Bramante, Raphael and Michelangelo; 1513: Leo X • ‐‐1520: Death of Raphael; 1527 Sack of Rome • Late Renaissance (Mannerism): 1520/27‐1600 • ‐‐1563: Last session of Council of Trent on sacred images Artistic Renaissance in Rome • Patronage of popes and cardinals of humanists and artists from Florence and central/northern Italy • Focus in painting shifts from a theocentric symbolism to a humanistic realism • The recuperation of classical forms (going “ad fontes”) ‐‐Study of classical architecture and statuary; recovery of texts Vitruvius’ De architectura (1414—Poggio Bracciolini) • The application of mathematics to art/architecture and the elaboration of single point perspective –Filippo Brunellschi 1414 (develops rules of mathematical perspective) –L. B. Alberti‐‐ Della pittura (1432); De re aedificatoria (1452) • Changing status of the artist from an artisan (mechanical arts) to intellectual (liberal arts; math and theory); sense of individual genius –Paragon of the arts: painting vs. -

Notes on a Florence Visit
Notes on A Florence Visit For Great Views of Florence without the Steps Frescoes of the Last Supper in Florence Roof of the Rinascente Department store Roof of the Ospedele degli Innocenti Upper floor of the Orsanmichele Church Recectory at San Marco Piazzale Michelangelo – take the #12 or #13 bus Refectory at St. Maria del Carmine Roof of the Oblate Library – 2 blocks from Duomo Refectory of Ognissante Church Take the bus from San Marco up to Fisole Refectory at Santa Maria Novella -painted by a nun- Sister Trattoria Le Mossacce Nelli Refectory at Santa Croce Videos to View Refectory of San Salvi Refectory at Sant’Apollonia Cenacolo of Fuligno The Medicis – on Netflick Rick Ruggiero on Road Scholar’s Virtual Lecture Medici: Godfathers of the Renaissance -PBS YouTube – 3 hour walking tour of Florence Room With a View Secrets of Florence (on Hoopla) Books To Read Brunelleschi’s Dome – Ross King The Lives of the Artists – Vasari The Stones of Florence – McCarthy Birth of Venus – Dunant Looking at Painting in Florence – Paterson The Light in the Piazza - Spencer Places Not to Miss Mercato Centrale –Market, Food Court, Cooking School Grom Gelato Badia Fiorentina - for Night Vespers Duomo – inside without line – side entrance for English Mass on Sat. PM or Sun. Amici Card at the Uffizi for immediate entry Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella Ognissante Church – tomb of Botticello Giotto Crucifix Pazzi Chapel next to Santa Croce Leather School and Factory behind Santa Croce Vasari Corridor – expected to be opened this year Galileo Museum San Miniato Church Santissima Annunziata Church – painting of Mary completed by an angel Museum of Precious Stones Riccardo- Medici Palace – Chapel of the Magi San Maria dell Carmine Church -Brabcacci Chapel Santo Spirito Church – Michelangelo’s Crucifix . -

1 Santo Spirito in Florence: Brunelleschi, the Opera, the Quartiere and the Cantiere Submitted by Rocky Ruggiero to the Universi
Santo Spirito in Florence: Brunelleschi, the Opera, the Quartiere and the Cantiere Submitted by Rocky Ruggiero to the University of Exeter as a thesis for the degree of Doctor of Philosophy in Art History and Visual Culture In March 2017. This thesis is available for Library use on the understanding that it is copyright material and that no quotation from the thesis may be published without proper acknowledgement. I certify that all material in this thesis which is not my own work has been identified and that no material has previously been submitted and approved for the award of a degree by this or any other University. (Signature)…………………………………………………………………………….. 1 Abstract The church of Santo Spirito in Florence is universally accepted as one of the architectural works of Filippo Brunelleschi (1377-1446). It is nevertheless surprising that contrary to such buildings as San Lorenzo or the Old Sacristy, the church has received relatively little scholarly attention. Most scholarship continues to rely upon the testimony of Brunelleschi’s earliest biographer, Antonio di Tuccio Manetti, to establish an administrative and artistic initiation date for the project in the middle of Brunelleschi’s career, around 1428. Through an exhaustive analysis of the biographer’s account, and subsequent comparison to the extant documentary evidence from the period, I have been able to establish that construction actually began at a considerably later date, around 1440. It is specifically during the two and half decades after Brunelleschi’s death in 1446 that very little is known about the proceedings of the project. A largely unpublished archival source which records the machinations of the Opera (works committee) of Santo Spirito from 1446-1461, sheds considerable light on the progress of construction during this period, as well as on the role of the Opera in the realization of the church. -

Appunti Bernabei Su Palazzo Vecchio
ITINERARI A TEMA PER VISITARE FIRENZE con la storica dell’arte e pittrice ELISA MARIANINI Mezza giornata (circa 3 ore, massimo 4 ore) Itinerario 1 Sulle tracce dei Medici Visita del quartiere mediceo partendo da Palazzo Medici Riccardi, prima residenza della famiglia Medici dove possiamo ammirare il palazzo, la Cappella dei Magi di Benozzo Gozzoli e la Galleria degli specchi con gli straordinari affreschi barocchi di Luca Giordano. Segue la visita della Basilica di San Lorenzo, dove lavorarono Brunelleschi e Michelangelo, che ospita importanti capolavori, di Donatello, del Verrocchio, del Bronzino, del Rosso Fiorentino, oltretutto luogo di sepoltura del capostipite dei Medici nella stupenda Sagrestia vecchia, capolavoro rinascimentale del Brunelleschi. Itinerario 2 Alla scoperta del cuore religioso di Firenze Visita all’interno del Duomo fiorentino di Santa Maria del Fiore e della antica Cripta di Santa Reparata dove è sepolto anche il Brunelleschi. Salita sulla Cupola, punto più alto della città e visita del Battistero di San Giovanni. L’itinerario continua nel Museo dell’opera del Duomo recentemente restaurato e rinnovato con un allestimento innovativo, dove è possibile ammirare gli originali delle famose Porte bronzee del Battistero e le sculture di Arnolfo e di molti altri importanti artisti che ornavano l’originale facciata prima che fosse distrutta per costruire quella attuale da De Fabris a metà Ottocento in forme neogotiche. Presenti all’interno del Museo opere quali la Maddalena di Donatello, la Pietà di Michelangelo, e le Cantorie di Donatello e Luca della Robbia. 1 Itinerario 3 Alla scoperta del cuore civile e politico di Firenze Partenza da Piazza della Repubblica, il cuore della Florentia romana per conoscere le antiche origini di Firenze. -
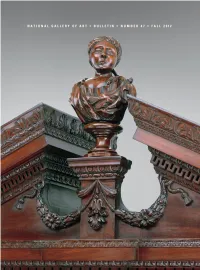
Casva Center for Advanced Study in the Visual Arts
NATIONAL GALLERY OF ART • BULLETIN 34 casva Center for Advanced Study in the Visual Arts Collaboration, Conservation, and Context n support of its mission to gener- a volume of the National Gallery of ate new research and to promote Art’s Studies in the History of Art series, discussion of the way we think which should become an important ref- Iabout and experience art, CASVA holds erence work for scholars throughout the scholarly symposia every year. These world, including Japan. are typically highly collaborative, The findings of a similarly complex engaging both curatorial and conser- set of collaborative meetings held some vation departments, as well as other six years ago appeared in another such institutions. volume this spring. Orsanmichele and Most recently, the Center collabo- the History and Preservation of the Civic rated with colleagues to arrange a Monument (Studies in the History of series of meetings in connection with Art, volume 76), edited by Carl Brandon the exhibition Colorful Realm: Bird- Strehlke, includes papers from two sym- and-Flower Paintings by Itō Jakuchū posia, one held at the Gallery in October (1716 – 1800), which featured thirty of 2005 and the other in Florence a year Jakuchū’s scrolls from the Zen monas- later. The inspiration was again an exhi- Fig. 1. Nanni di Banco, Four Crowned tery Shōkokuji, together with his trip- bition marking the completion of a long Martyr Saints, c. 1409 – c. 1417, marble tych of the Buddha Śākyamuni. These campaign of restoration, and the loans with traces of gilding, after conserva- works of art, the subjects of long and were again made in the expectation that tion, in the exhibition Monumental careful restoration, were lent to the CASVA would bring together experts to Sculpture from Renaissance Florence: National Gallery of Art by the Imperial explore the history and conservation of Household of Japan for just one month. -

Wittenberg History Journal Spring 2016
Wittenberg History Journal Spring 2016 Unexpected Tensions: Social Conflict from the Viking Age to World War II Wittenberg History Journal Spring 2016 Unexpected Tensions: Social Conflict from the Viking Age to World War II Wittenberg History Journal Contents Spring 2016 | Volume XLV Hartje Award Winner 1 Half-Peace: The Successes and Failures of the Peace Process Unexpected Tensions: Social Conflict from the Viking Age to World War II in Northern Ireland Wittenberg University Springfield, Ohio Keri Heath 2016 Editorial Board I. Renaissance Reversed: Social Conflicts Senior Editors in Florence Keri Heath ‘16 Kaitlyn Vazquez ‘16 5 The Tensions Hidden Beneath Religious Festivities and Carnivals: A Social Analysis of Public Celebrations in Renaissance Florence Junior Editors Kristen Brady Kristen Brady ‘17 Vivian Overholt ‘17 Gil Rutledge ‘17 11 From the Bottom Up: Influence on the Upper Class by the Faculty Advisor Florentine Underground in the Renaissance Joshua Paddison Keri Heath Wittenberg History Journal is affiliated with the Gamma Zeta chapter of Phi Alpha Theta. 17 The Ospedale Degli Innocente: A Microhistory The Hartje Paper Hannah Hunt The Martha and Robert G. Hartje Award is presented annually to a senior in the spring semester. The History Department determines the three or four finalists who then write a 600 to 800 word narrative II. Forgotten Stories: Cartoonists and Kings essay on an historical event or figure. The finalists must have at least a 2.7 grade point average and 26 Kings at Sea: Examining a Forgotten Way of Life have completed at least six history courses. The winner is awarded $500 at a spring semester History Department colloquium and the winner paper is included in the History Journal. -

A Proposed Narrative the Basilica of San Lorenzo Is One of the Most Intensively Studied Buildings in Florence (Figures 2-1 and 2-3)
Beyond beauty : reexamining architectural proportion in the Basilicas of San Lorenzo and Santo Spirito in Florence Cohen, M.A. Citation Cohen, M. A. (2011, November 15). Beyond beauty : reexamining architectural proportion in the Basilicas of San Lorenzo and Santo Spirito in Florence. Retrieved from https://hdl.handle.net/1887/18072 Version: Not Applicable (or Unknown) Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the License: Institutional Repository of the University of Leiden Downloaded from: https://hdl.handle.net/1887/18072 Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable). 4. The Construction History of the Fifteenth-Century Basilica of San Lorenzo: A Proposed Narrative The basilica of San Lorenzo is one of the most intensively studied buildings in Florence (Figures 2-1 and 2-3). Today the fifteenth-century core of a large religious and funerary complex that embodies over half a millennium of architectural accretion, this basilica has attracted the sustained attention of chroniclers and historians beginning even before its completion in the 1480s due to its exceptional architectural and historical significance, and to the survival of extensive archival materials pertaining to its construction and patronage.1 Most architectural historians agree that the basilica of San Lorenzo, which owes its present appearance primarily to Filippo Brunelleschi, constitutes the first fully-developed example of the Renaissance style. Questions remain, however, about the extent and chronology of Brunelleschi’s contributions, and to what extent the old Romanesque basilica of San Lorenzo that the present one replaced (hereinafter referred to as “the old basilica”) influenced the present design. -

Inter Cultural Studies of Architecture (ICSA) in Rome 2019
Intercultural Understanding, 2019, volume 9, pages 30-38 Inter Cultural Studies of Architecture (ICSA) in Rome 2019 A general exchange agreement between Mukogawa Women’s University (MWU) and Bahçeúehir㻌 University (BAU) was signed㻌 on December 8, 2008. According to this agreement, 11 Japanese second-year master’s degree students majoring in architecture visited Italy from February 19, 2019, to March 2, 2019. The purpose of “Intercultural Studies of Architecture (ICSA) in Rome” program is to gain a deeper understanding of western architecture and art. Italy is a country well known for its extensive cultural heritage and architecture. Many of the western world’s construction techniques are based, on Italy’s heritage and architecture. Therefore, Italy was selected as the most appropriate destination for this program. Based on Italy’s historic background, the students were able to investigate the structure, construction methods, spatial composition, architectural style, artistic desires based on social conditions, and design intentions of architects and artists for various buildings. This year’s program focused on “ancient Roman architecture and sculpture,” “early Christian architecture,” “Renaissance architecture, sculpture, and garden,” and “Baroque architecture and sculpture. ” Before the ICSA trip to Rome, the students attended seminars on studying historic places during their visit abroad and were asked to make a presentation about the stuff that they learned during these seminars. During their trip to Rome, the students had the opportunity to deepen their understanding of architecture and art, measure the height and span of architecture, and draw sketches and make presentations related to some sites that they have visited. A report describing the details of this program is given below.